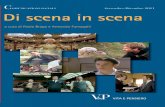L'indice in scena: argomenti, canovacci, generici
Transcript of L'indice in scena: argomenti, canovacci, generici
FABULA IN TABULAUna storia degli indici
dal manoscritto al testa elettronico
Atti del Convegno di studiodella Fondazione Ezio Franceschini
e della Fondazione IBM Italia
Certosa del Galluzzo, 21-22 ottobre 1994
a cura di
CLAUDIO LEONARDI, MARCELLO MORELLI
e FRANCESCO SANTI
CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL'ALTO MEDIOEVOSPOLETO
INDICE
CLAUDIO LEONARDI, Premessa , .
FABULA IN TABULA
Pag. VII
TULLIO GREGORY, Introduzione .
I. LA RINASCITA MEDIEVALE DEGLI INDICI
OLGA WEIJERS, Les index au Moyen Agesont-ils un genre litteraire?
MALCOLM PARKES, Folia librorum quaerere. Medieval Experienceof the Problems of Hypertext and the Index .
GIUSEPPE CREMASCOLI, « Tabulae» di lessici mediolatini .
II. INDICI, FIGURE, SCHEMI NEL TESTO
SIMONA BIANCHI, Il quadrato logico. L'uso di figure esplicativenella tradizione aristotelica .
JOSE C. SANTOS PAZ, Modo de percepci6n y modo de representa-ci6n: las tabulae del Scivias .
FRANCESCO SANTI, Mappizzazione del testa e culture teologiche .
MICHELA PEREIRA, 1£ figure alchemiche pseudolulliane: un indiceoltre il testo? ' .
RICCARDO QUINTO, Estratti e compilazioni alfabetiche da opere diautori scolastici (ca. 1250-1350) .
LETIZIA PELLEGRINI, Indici per predicare: le tavole nei manoscrittidi sermoni fra XIII e XV secolo .
»
.»
»
»
»
»
»
»
»
»
3
11
23
43
59
79
99
111
119
135
MARZIA PIERI
L'INDICE IN SCENA: ARGOMENTI, CANOVACCI, GENERICI
Le scritture degli attori professionisti che, a partire dalla metadel secolo sedicesimo, danno vita al fenomeno chiamato Commedia dell'Arte, con cui si identifichera il mercato dello spettacolo italiano fino, circa, alIa fine del Settecento, costituiscono un corpusdrammaturgico del tutto peculiare che si presta a qualche considerazione in merito alla questione di cui si occupa questa volume.
La Commedia dell'Arte, infatti, edi per se un oggetto culturaledi carattere riassuntivo, per cost dire, che acquisisce e sistematizza in un insieme di linguaggi stilizzati e molto tecnicizzati lacultura teatrale elaborata dagli intellettuali rinascimentali, la trasforma, da fatto 'artistico' e da eletto strumento di propagandasignorile, allusivo e raffinato, rivolto ad una cerchia ristretta esocialmente elevata, in una merce da vendere a un pubblico eterogeneo, prima italiano poi europeo, che, pagandosi un bigliettod'ingresso, acquista per la prima volta il diritto di fruirne, sia purein forme seriali e divulgative.
Questa profonda rivoluzione produttiva - che da origine alteatro moderno 'e alla formazione della spettatore moderno determina una serie importante di conseguenze riguardanti ilprodotto-spettacolo. Gli attori, infatti, agiscono in spazi geografici, sociali, linguistici e culturali i pili disparati: dalle piazze deimercati periferici (in cui li confina una certa agiografia tardoromantica) alle sontuose feste di corte di tutta Europa, e sono ingrado di allestire umili farse all'improvviso, come anche commedie, tragedie e pastorali letterarie premeditate, 0 grandi spettacolimelodrammatici e musicali.
192 MARZIA PIERI
Ad una tale versatilita e adattabilita (lora autentico punta diforza, grazie al fatto di agire in gruppi organizzati in gradodi coprire specializzazioni malta diverse) corrispondono vasteescursioni di stile e di identita sociale; il che alimenta poi, tra '500e '600, interminabili querelles circa la dignita del mestiere: sanaattori, infatti, slai miseri guitti e cantimpanca che agiscono inristrette compagini familiari sui banchi da fiera (magari a fiancodi cerretani e giocolieri), sia gli « onorati cornici » membri dellegrandi compagnie dei Gelosi, dei Confidenti, degli Uniti, degliAccesi, ricercati dai sovrani, sodali di nobili e di intellettuali,accolti nelle accademie piu prestigiose, impegnati in un'arduabattaglia per difendere la propria. dignita rispetto agli strali delpotere religioso (piu che mai diffidente, in epoca contrariformistica, contra le pompe corruttrici del teatra) e alla supponenza deiletterati, scalzati da una concorrenza irresistibile che rende dicolpo obsolete le lora produzioni drammatiche di dilettanti 1.
La parola scritta e pero, per lora, uno strumento acquisito,imperfetto, inadeguato, che subentra a integrare un patrimonio dicompetenze legato prevalentemente, dopo secoli di giulleria, allagestualita, alla mimica, alla musica, alla visivita in genere; ad essaricorrono in una fase cruciale della lora storia, quando, appuntoverso la meta del secolo sedicesimo, si associano in gruppi organizzati vincolati per contratto da una serie recipraca di diritti e didoveri, e iniziano la lora avventura storica.
In queste « fraternal compagnie» si associano insieme, per laprima volta, prafessionisti diversi dell'intrattenimento. prima abituati ad agire da soli, a al massimo in coppia; verso gli anni '3040 del '500 essi vedono restringersi pericolosamente i prapri spazidi manovra al cospetto di una serie di « normalizzazioni » sociologiche e culturali in cui si spengono le irrequietezze e gli sperimentalismi che avevano animato la civilta signorile di primo '500 e ildecollo turbolento della letteratura volgare: i buffoni, specialisti
1 Sui difficili rapporti fra i professionisti dello spettacolo e la circostante cultura cinque e seicentesca si rimanda a S. FERRONE, Attori mercanti corsari. La Commedia dell'Arte in Europa tra Cinque e Seicento, Torino, Einaudi, 1993 e a M. PIERI,
Il "Pastor Fido" e i comici dell'Arte, in «Biblioteca teatrale », 17, gennaio-marzo1990, pp. 1-15.
L'INDICE IN SCENA: ARGOMENTI, CANOVACCI, GENERICI 193
del comico, ultimi eredi degli antichi giullari; le «meretricihoneste» romane e veneziane, canterine e poetesse capaci diimprovvisare alla maniera petrarchesca, a cui saranno affidate leparti patetiche e amorose (e sono loro la pili eclatante e fortunatanovita che attira gli spettatori); probabilmente alcuni di queicosiddetti poligrafi, digiuni di latino ma buoni artigiani del volgare, capaci di riadattare, epitomare, divulgare per canto deglistampatori lora padroni ogni sorta di testo.
Come e perche personaggi del genere scelgano ad un certopunta di inventarsi un mestiere COSl nuovo e avventuroso e didifenderlo strenuamente da molteplici attacchi, can un'opera dipropaganda condotta senza esclusione di colpi, non e affattochiaro; probabilmente nel fenomeno si intrecciano can pari rilevanza una nascente domanda di spettacolo da parte di cetidiversi, una crisi d'occupazione in determinati settori dell'intrattenimento e un'irrequietezza intellettuale che attira verso il nomadismo della professione attorica una serie di borghesi rispettabili e spesso colti - uomini e donne -, a cui il commercia, l'avvocatura a la cura di figli e mariti appaiono all'improvviso pocoallettanti 2.
Nel quadro mosso e precario di questi esordi la scrittura e lastampa costituiscono, per la battaglia autodifensiva degli attori,uno strumento rilevante, destinato ad accreditarne strumentalmente un'immagine canonicamente culta: scrivere e pubblicarelibri, siano essi trattati teorici, raccolte poetiche a testi drammatici tradizionali, significa esibire delle referenze sicure, emanciparsi dalle oscure e infami radici della guitteria e del meretricio.Per questa le tournees pili impegnative, per esempio dei Gelosi aParigi nel 1584, sana precedute dall'uscita di vere e proprie collane di volumetti, confezionati alla mena peggio, ma - il che e ciache conta - firmati dai diversi membri della compagnia3; per questa gli attorisono abilissimi nel definire la strategia delle dedica-
2 II problema e diseusso in F. TAVIANI - M. SeRINO, Il segreto della Commedia dell'Arte. La memoria delle compagnie italiane del XVI, XVII e XVIII secolo, Firenze, laeasa Usher, 1982 e in F. MAROTTI - G. ROMEI, La Commedia dell'Arte e la societabarocca. La professione del teatro, Roma, Bulzoni, 1991.
3 Su questa offensiva eartaeea degli attori si rimanda all'Introduzione di S. FERRONE in Commedie dell'Arte, vol. 1, Milano, Mursia, 1985, pp. 5-44.
194 MARZIA PIERI
torie nobiliari, coltivano un'intensa trattatistica in difesa delmestiere e della sua storia e persino celebrano con solenni encomila morte di alcuni loro celebri colleghi, trasfigurandoli fra divismo profano e beatitudine religiosa: ogni strumento, in questabattaglia, e utilizzato con estrema disinvoltura, senza arrestarsi difronte a plagi, furti, 0 riciclaggi truffaldini 4.
Cia che interessa lora e l'esibizione dell'oggetto-libro, la suaofferta ufficiale a questa 0 a quel personaggio d'alto rango, piliche il merito del suo contenuto; nella selva tipografica e politicadell'Italia tardo-cinquecentesca, del resto, non e poi tanto difficileriproporre con poche varianti la stessa commedia 0 il medesimotrattato a protettori diversi, cambiando semplicemente il titolo ela lettera dedicatoria, come anche saccheggiare impunementetesti altrui senza soverchi rischi. Esemplare ed estremo il caso delvolume di Compositions de rethorique offerto al re di Francia dalcelebre Arlecchino Tristano Martinelli ne11600, che eonsiste, al dila di un riceo frontespizio istoriato, di una serie di pagine bianchedisseminate di rare incisioni.
Ma accanto a questa serie di testi-fantoccio, per cost dire,rivolti all'esterno, dove cia che veramente conta e la confezionetipografica, il puro paratesto, ne esiste tutto un altro gruppo,attraverso i quali gli attori si sforzano invece di conservare memoria di se e della propria arte e di trasmettere ad altri attorialcuni segreti, faticosamente imparati spesso lungo l'arco diun'intera esistenza. Un analogo impulso a farsi immortali attraverso la scrittura, a conservare traccia certa di un'arte altrimentieffimera e fugace, accompagna del resto tutta la storia del teatro:nell'Ottocento e nel Novecento i grandi mattatori hanno cercatonella letteratura un possibile strumento di legittimazione di se esi sono messi a scrivere Ie proprie memorie, esibendo spesso unamaldestra, ingenua vanita, e scadendo regolarmente nell'aneddotica pili agiografica, tanto da fondare quasi un genere a se stante,dotato di costanti strutturali e narratologiche; con 10 stesso spirito affidano oggi ai video, alla televisione, 0 magari a delle
4 Ne offre un huon esempio A. ZAZO, «La Turca» di Giovan Battista Andreini.Un casu di editoria teatrale nel Seicento, in «Duaderrri di teatro », VIn (l986), 32,pp.61-72.
L'INDICE IN SCENA: ARGOMENTI, CANOVACCI, GENERICI 195
lezioni universitarie, il racconto romanzato della propria vita edella propria arte, sempre, bisogna riconoscere, con esiti chenon rendono neanche pallidamente conto della reale qualita delloro lavoro.
Nelle scritture tecniche degli attori tardo-cinquecenteschi eseicenteschi l'elemento "forte e quello di essere, paradossalmente,dei non-testi, quasi sempre destinati a restare manoscritti pur inun'epoca di ormai diffusa affermazione della stampa, strumentidi lavoro rivolti ad una cerchia ristretta e segreta di addetti, inpossesso di strumenti tecnici molto specifici. Fermando sulla carta, in forma sintetica e allusiva, alcuni appunti relativi allavoroscenico, oppure la memoria di interi spettacoli, 0 ancora, nei casipili impegnativi, allestendo dei veri e propri manuali di recitazione (i cosiddetti «generici ») in forma di repertori di monologhi,dialoghi, 0 similitudini buoni per una determinata parte, oppuredi pezzi drammaturgici canonici da cui attingere a seconda deicasi (tipiche, in questo senso, le raccolte di prologhi), gli attorisono costretti a crearsi ex-novo una serie di codici, fissano delleconvenzioni is pirate a criteri di massima economicita ed efficienza, che derivano in gran parte dal vasto sostrato di saperilegati all'oralita e alla cultura popolare, in cui il loro ambiguomestiere affonda Ie proprie radici.
Per i primi attori dell'Arte, i pionieri della professione, l'ossessione di rispettabilita e di imrnortalita che li induceva a travestirsida letterati e persino da santi, si accompagna alla vitale esigenzadi conservare e di accumulare i risultati di un lavoro tecnicamente assai complesso, frutto di acquisizioni successive e collettive, che prevedeva, fondamentalmente, di costruire 10 spettacolocome un «concertato » di parti diverse, su cui si specializzavano isingoli membri della compagnia. E il metodo della cosiddettaimprovvisazione, che tanti equivoci ha poi alimentato, fondato suIpresupposto che esistono, come fondamentale unita di misuradello spettacolo, i personaggi, distinti in commedia fra comici, ingenere in maschera (i vecchi e i servi), e gravi, senza maschera (gliinnamorati); pili alcune parti mobili (per esempio la servetta, ilparassita 0 il capitano), che possono avere valenze diverse; per latragedia e la pastorale si trattera invece di sovrani, maghi, eroi,
196 MARZIA PIERI
pastori, ninfe ecc. 5. Ciascun attore si specializza su un personaggio 0 su una serie omologa di parti afferenti a quel personaggio,ne studia a fondo la gestualita, il costume, illinguaggio e acquisisce, attraverso un duro lavoro di memorizzazione, una serie dimateriali verbali che 10 riguardano, attingendoli dalle piu disparate fonti letterarie.
Sulla base di queste funzioni si costruisce poi 10 spettacolocome una combinazione sempre diversa di dinamiche prevedibili(giovani e vecchi, servi e padroni ecc.), su una traccia di intreccio,una sorta di sceneggiatura, fissata sinteticamente per iscritto inquello che si chiama il canovaccio, 0 scenario.
Nellavoro delle compagnie diventa quindi vitale la capacita dimemorizzare, riassumere, indicizzare illavoro svolto; un lavoro,ricordiamolo ancora, fatto a piu mani e trasmesso di generazionein generazione per via di rapporti di discepolato familiare 0 amicale in gran parte affidati ad una trasmissione orale e comunquesegreta per i non addetti: per cui, ad esempio, l'Arlecchino checonosciamo emerge dalla ricerca di tanti diversi Arlecchini, chene hanno progressivamente definito la maschera, il costume variopinto, il linguaggio, la psicologia, la postura scenica, l'immagine simbolica, fino a renderlo COS! familiare al pubblico da fameun personaggio autonomo dal teatro, protagonista del carnevale 0
della tradizione iconografica e folklorica di tutta Europa 6 •
Questa stratigrafia diacronica del lavoro attoriale, in granparte oggi perduta, e ricostruibile per lacerti discontinui, si affidasolo marginalmente alIa scrittura, rna ad una scrittura esclusivamente tecnica e manualistica, dove tutto cio che e accessorio siperde, dove non e quasi mai riconoscibile il marchio di un autorespecifico, dove non e neanche immediatamente chiaro che cosasia veramente il « testo » in oggetto.
Varie leggende accompagnano persino la trasmissione fisica
5 SuI sistema delle parti, in base al quale si costituiscono gli organici dellecompagnie, cfr, C. MOLINARf, La Commedia dell'Arte, Milano, Mondadori, 1985 e L.ZORZI, L'attore, la Commedia, it drammaturgo, Torino, Einaudi, 1990, pp. 141-153.
6 Gli esempi di questa atipica trasmissione di saperi sarebbero moItissimi; nericordiamo qui uno celebre, avvolto nella leggenda, che riguarda il rapporto maestro-allievo fra il grande Tiberio Fiorilli, in arte Scaramouche, e Jean BaptistePoquelin, detto Moliere.
L'INDICE IN SCENA: ARGOMENTI. CANOVACCI. GENERICI 197
di questi testi: sappiamo, per esempio, che gli scenari della compagnia dei Gelosi firmati da Carlo Borromeo nel1583 furono conservati con cura, passando di mana in mana fino a Settecentoinoltrato. Erano il documento tangibile di una grande battagliacombattuta e vinta dagli attori contro la Curia di Milano, chemirava ad estirpare, perragioni morali, la mala pianta delle commedie dalla citta. L'episodio e emblematico, rispetto al problemache qui ci interessa: per bloccare il loro lavoro Ie autorita religiose pretendevano furbescamente di controllare preventivamente l'ortodossia religiosa dei testi. Una richiesta a cui gli attorinon erano in grado di ottemperare, e che mirava a trattenerliindefinitamente in una logorante anticamera, fino a costringerliad andarsene.
In quella circostanza, un ex-giurista che faceva in commediala parte dell'Innamorato, il veronese Adriano Valerini, fu arteficedi una strategia difensiva abilissima, grazie alla quale rlusct a faresplodere un conflitto di competenze fra le autorita spagnole, preposte al mantenimento dell'ordine pubblico, e quindi ancheresponsabili degli spettacoli, e quelle religiose, depositarie delsolo diritto di concedere 0 non l'imprimatur, e, secondo la sualinea d'attacco, non in grado di esercitarlo per mancanza di strumenti adeguati a valutare l'onesto lavoro dei comici. II pretestotruffaldino della Curia fu rimosso per evitare guai maggiori e unvero e proprio conflitto giurisdizionale; l'arcivescovo firma di suopugno i canovacci, rinunciando, per quella volta, ad averla vinta;gli attori, compunti e trionfanti, trasformarono la storia, per iposteri, raccontando che san Carlo Borromeo li aveva protetticontro il Governatore di Milano 7.
Al di la del suo carattere pretestuoso, la vicenda riassumeesemplarmente l'antagonismo fra la retorica tradizionale, fondatasuI valore forte della parola scritta, distesa in concetti analitici,portatori di verita acquisite, e la retorica attoriale, fondata sull'oralita e sull'effimero, compendio di una realta di segni eterogenei
7 La vicenda e ricostruita in F. TAVIANI - M. SCHINO, Il segreto della Commediadell'Arte, cit., pp. 380-387. Un'ampia raccolta di documenti della Chiesa tridentinarelativi a1 teatro e agli attori e offerta da F. TAVIANI. La Commedia dell'Arte e lasocieta barocca. La [ascinazione del teatro, Roma, Bulzoni, 1969 (1991).
198 MARZIA PIERI
e anarchici, trasferibili sulla pagina solo per via mediata e allusiva. I testi che la contengono costituiscono un corpus suscettibiledi mille incrostazioni e interpolazioni, in cui certi particolaririmbalzano costanti secondo modalita di trasmissione atipiche,che hanna un implicito e molto forte spessore multimediale,rimandano sempre ad una realta visiva e acustica (spesso anchemusicale) e ricorrono costituzionalmente, per cost dire, allaforma-indice 8.
Cio che conta infatti, per chi vi si accosta, non e leggere distesamente, rna pater ricondurre il pili in fretta possibile alIa realtadella performance scenica gli appunti e gli schemi che ha dinanzisulla pagina; per questa l'elemento forte che li caratterizza sono ititoli, le partizioni, i soggettari, le rubriche, organizzati secondomodalita che ricordano molto da vicino gli schemi dell'anticamenmotecnica di cui gli attori sono gli ultimi eredi. I lora canovacci, i loro generici, e persino i lora trattati teorici, che ricic1anoin minore, in veste gnomica e discorsiva, le proposizioni aristoteliche e oraziane in difesa del teatro, non sono da leggere, rna daguardare e da ricostruire mentalmente; sono fatti di pezzi, raccolgono citazioni, reperti parziali rna pregnanti, che reagiscono soltanto alla memoria scenica concreta di chi e in possesso dell'intero ipertesto dello spettacolo da fare.
Questa specialissima attitudine compendiatrice, molto evidente negli scritti tecnici relativi al mestiere, agisce anche a livellidiversi, in ambiti di scritture propriamente memoriali, rivolte alpubblico dei lettori e dei posteri, dove subentrano invece meccanismi retorici di provenienza 'alta', e dove si riscontra unacostante attitudine ad epitomare florilegi di exempla edificanti dinatura storica e filosofica, rna anche assunti dalla cronaca pilispicciola e' quotidiana. Un esempio particolarmente felice, in que-
8 Questa specifica forma di scrittura e, naturalmente, il risultato di un metododi Iavoro, l'unico possibile per i professionisti della scena; ancora nel Settecentoun drammaturgo poco letterato come Goldoni dichiarava a pili riprese di rifarsi,tutte Ie volte che fosse necessario, a un metaforico « baule » comico in cui avevaraccolto i sempreverdi trucchi di un repertorio antico e sperimentato; e sappiamo,del resto, che egli possedeva fisicamente una raccolta di canovacci (purtroppoandata perduta insieme alla sua collezione di romanzi, altrettanto utile allo scopo), da cui attingeva spesso utili spunti creativi.
L'INDlCE IN SCENA: ARGOMENTI, CANOVACCI, GENERICI 199
sto senso, e offerto dalla Supplica. Discorso famigliare a quelli chetrattano de' comici di Niccolo Barbieri (in commedia Beltrame) 9,
un fortunato libretto che nel 1634 fissa una prima, importantetappa storiografica di questa processo nel momenta in cui si stachiudendo la fase pili gloriosa e pionieristica della vita dellecompagnie.
Con esso il Barbieri costruisce il profilo di un mito che sara dilunga durata, assemblando appunto con spregiudicatezza le tesipili comuni pro e contro il teatro, casi esemplari vissuti in primapersona, cronache tendenziose di battaglie gia vinte, considerazioni bonarie e accattivanti circa l'umanita 'borghese' degli attoritanto calunniati. Un lavoro complesso di decantazione, pili volteritoccato e ampliato dall'autore, e sempre abilmente circoscrittonei limiti di una conversevole e dimessa volonta auto-difensiva.. .
La confutazione dei demonizzatori del teatro, in realta com-plessa e impegnativa, esvolta in 57 capitoletti - ciascuno in seautonomo e compiuto, nonche provvisto di un titolo proprio - talida consentirne una fruizione anche discontinua e disimpegnatarna comunque efficace allo scopo. Non credo che tale scelta sia ilfrutto, come 10 scrivente lascia continuamente intendere, di unamodestia di mezzi espressivi e argomentativi, bensl del possessodi codici peculiari, in grado di prefigurare modalita raccorciate epili icastiche di approccio al testo, largamente precorritrici difenomeni ben al di la da venire. La fortuna della Supplica fu certolegata a questa scelta strutturale, ed e illuminante ricordare, percontrasto, la disagevole ampiezza della pili autorevole replica chene scaturi, quella del padre gesuita Gian Domenico Ottonelli che,nel 1661, ebbe bisogno di ben cinque volumi con molte centinaiadi pagine per confutare, con il trattato Della Christiana Moderatione del Theatro, le smilze proposizioni di Beltrame.
Questa attitudine a sintetizzare ed estrapolare, a ragionareper schemi, questa cultura dell'epitome costituisce il tratto fondamentale del teatro professionistico cinque, sei e settecentesco,
9 II testa e stato edito modernamente da F. TAVIANI, a Milano per i tipi del Polifilo, nel 1971.
200 MARZIA PIERI
che riassume, banalizzandolo e riadattandolo sociologicamenteverso il basso, il grande patrimonio teatrale rinascimentale. Ladrammaturgia classicistica, la scenografia vitruviana, la poeticaaristotelica diventano, nelle mani dei comici, dei fossili che conservano appena l'esile silhouette dei modelli originali: illoro e unteatro povero, fatto di scenografie minime, di suppellettili ingegnose, di titoli, di gesti pili che di parole; di intrecci e di personaggi pili che di testi, di grossolane semplificazioni di senso. Nonpili la Mandragola, l'Orbecche 0 l'Aminta, non pili il salone vasariano di palazzo Vecchio 0 il teatro Olimpico di Vicenza, rna laloro memoria, disseccata e appena allusa sui palchi improvvisati degli stanzoni in cui si entra pagando il biglietto, dove lemaschere, esse stesse sintesi e indici di intere categorie di personaggi letterari di ascendenza erudita, sono protagoniste di storieprevedibili rna sempre diverse, che riassumono la memoria dellagrande tradizione comica novellistica e cavalleresca medievale erinascimentale.
La ({ parte» diventa dunque l'unita di misura-base nello spettacolo dei comici, che si sforzano di definirne la casistica e i contenuti sia sul piano teorico che su quello propriamente tecnico.COSl, fin dalla meta del Cinquecento, troviamo ogni sorta di centoni di parti sceniche, che sono appunto dei cataloghi indicizzatidi concetti e di gerghi ricavati dalle fonti letterarie, folkloriche emusicali pili disparate. E singolare notare che, in un primotempo, per queste raccolte si studino delle confezioni esterneprese a prestito dalle scritture tradizionali: per esempio presentandole in forma di sedicenti canzonieri burleschi, di repertori madrigalistici, di testamenti alla maniera medievale, 0, pilispesso, di sillogi di lettere facete 0 serie 10. Solo quando il mestieresi e attestato con una certa fortuna gli attori sembrano uscire alloscoperto con dei libri confezionati come inequivocabili raccolte diparti: COSl nel 1607 le Bravure del Capitano Spavento divise inmolti ragionamenti in forma di dialogo di Francesco Andreini rias-
10 Molti di questi testi si possono ora leggere in F. MAROTTI - G. ROMEI, La Commedia dell'Arte e la societa barocca. La professione del teatro, cit., rna e ancora utile(pur se filologicarnente pOCO rigoroso) V. PANDOLFI, La Commedia dell'Arte. Storia etesto, voll. 6, Firenze, Sansoni, 1957-61 (reprint Firenze, Le Lettere, 1988).
L'INDICE IN SCENA: ARGOMENTI, CANOVACCI, GENERICI 201
sumono un'imponente serie di materiali verbali relativi alIa tracotanza cavalleresca di un guerriero dai tratti spagnoleschi che sipavoneggia con il suo servo Trappola, e diventano il manuale diriferimento per i molti capitani che verranno; mentre Ie Lettere disua moglie Isabella, estremo compendia prosastico di parecchisecoli di letteratura amorosa - dall'Elegia di madonna Fiammettaal Canzoniere di Petrarca all'intera tradizione lirica cinquecentesea - fondano il repertorio-base per l'amorosa; 0 ancora, ne11623,Ie Fatiche comiche di Domenico Bruni riuniscono parecchiedecine di prologhi in prosa e in versi, adatti ad ogni circostanza ericavati dalle piu disparate fonti letterarie.
II genere si attesta con straordinaria fortuna lunge tutto il Seicento; ai cataloghi distesi si affiancano ben presto Ie sintesi teoriche, di cui possiamo indicare i due estremi ideali, da una partenell'opera di Pier Maria Cecchini, che tenta (Discorso sopra l'artecomica, 1608, e Frutti delle moderne comedie, 1628) di definire unaprecisa teoria della recitazione rubricando con estrema minuzia eprecisione sia Ie partizioni tecniche del linguaggio recitativo(caratteristiche fisiche dell'interprete, gesto, intonazione, articolazione delle parole ecc.), sia la fenomenologia delle parti e la 10ro classificazione stilistica e contenutistica in «serie », «gravi» e«riapoletane ». AlIa lucidita e alIa stringatezza del Cecchini, interessato a fissare in tutti i particolari l'identita professionale e giuridica del mestiere dell'attore (rna in questa sua solitaria battagliasara alIa fine sconfitto), fa riscontro, a fine secolo la lutulenza diun pur appassionato amatore di teatro, Andrea Perrucci, chededica il suo Dell'arte rappresentativa premeditata e all'improvviso«non solo a chi si diletta di rappresentare; rna a' predicatori,oratori, accademici e curiosi ». Per costoro egli confeziona unmassiccio centone di «regole » che e ormai che un florilegiodi sentenze pedantescamente accumulate senza piu alcun criterio riconoscibile 11.
Questa dicotomia profonda fra la memoria tecnica e selettivadegli attori e la memoria quantitativa e disordinata dei dilettanti
II Cfr. A. PERRUCCI, Dell'arte rappresentativa premeditata e all'improvviso, a curadi A. G. BRAGAGLIA, Firenze, Sansoni, 1961.
202 MARZIA PIERI
letterati si ripropone in maniera identica a proposito dei canovacci, i documenti pili originali e specifici che ci restano intornoal lavoro dei comici. II canovaccio e un oggetto del tutto peculiare: 10 potremmo definire un abstract della spettacolo da fare,costruito sulla base di una serie di spettacoli gia fatti; e molto dipili di una sceneggiatura: e uno strumento indispensabile alIacompagnia per rimettere insieme in qualsiasi momento, e nelminor tempo, una qualsiasi rappresentazione comica, tragica 0pastorale. Gli attori, infatti, devono garantirsi la massima economicita e velocita di produzione senza venir meno alIa necessita,sempre urgente e cogente, di variare il repertorio per far frontealIa continua domanda di novita degli spettatori. II canovaccio equindi un indice di spettacoli gia fatti che ha la funzione di conservarne la memoria concentrata per poterli riprodurre il pilifacilmente possibile.
Guardiamone dunque da vicino la forma-tipo, ricordandopero che, in pili di due secoli distoria, soltanto un attore, Flaminio Scala, ha scelto, ne11611, di rendere pubblici ipropri ferri delmestiere, e 10 ha fatto in virtu di una precisa poetica che 10 induceva ad identificare nella sceneggiatura dello spettacolo, nellaregia potremmo dire modernamente, e non nelle singole parti,l'autentica struttura forte, e quindi nel drammaturgo-capocomicoil vero autore della rappresentazione. II problema si riproporra infasi storiche successive, quando si discutera anche aspramente(con importanti implicazioni per esempio di tipo economico) suchi sia l'autore vero di una rappresentazione teatrale: se l'interprete che la recita, se il drammaturgo che ha scritto Ie parole deltesto, se, infine, come si riconoscera dopo la dura battaglia delleavanguardie di primo Novecento, il regista che padroneggia eorienta tutti i linguaggi dello spettacolo.
oNel 1611, dunque, Flaminio Scala, capocomico dei Confidenti, da in luce a Venezia il suo Teatro delle favole rappresentativeavera la Ricreatione Comica, Boscareccia, e Tragica. Divisa in cinquanta giornate: al di la di un titolo COS! impegnativo si trattasemplicemente di una raccolta di cinquanta scenari, dove il riferimento aile cinquanta giornate non e che un estrinseco omaggioad una strutturazione di ascendenza decameroniana ormai puramente nomenclatoria. Manca, infatti, una qualsiasi parvenza di
L'INDICE IN SCENA: ARGOMENTI, CANOVACCI, GENERICI 203
cornice ed i testi sana semplicemente allineati in un ordine diprogressiva complessita e altezza stilistica, dal registro 'basso' ecomico della prima giornata, Li duo vecchi gemelli. Comedia , aquello alto e tragico della cinquantesima, La fortuna di Forestaprencipessa di Moscovia. Opera regia. Per confezionare in forma dilibra stampato i suoi appunti di lavoro, proponendoli a futuri imitatori come tracce di spettacoli possibili, Flaminio Scala deveinventare, letteralmente, la forma del testa in sensa grafico, strutturale, tipografico, e 10fa realizzando un pastiche fra memorie letterarie e istanze fortemente tecniche; l'uso previsto eduplice: unasemplice lettura per gli amatori di teatro, ai quali anche ambiscedi rivolgersi, ed una vera e propria consultazione professionaleper gli attori. COS! la macrostruttura e quella classicistica tradizionale: per ogni pezza ci sana un titolo, una etichetta drammaturgica (commedia, opera reale, pastorale. opera regia, operaeroica, tragedia), un argomento, una lista di personaggi, a cui siaggiunge quella delle « robbe» necessarie per l'allestimento (inesistente nella drammaturgia erudita); soltanto una scarna annotazione specifica l'ambiente scenico, che pub essere una qualunquecitta, ma anche un'isola felice, le selve di Persia a magari Arcadia;il testa e suddiviso in atti (tre e non pill cinque).
L'argomento riassume l'antefatto della vicenda, assolvendo lafunzione propria del prologo, ma soprattutto fornisce immediatamente un colpo d'occhio sulla vicenda, orientando la consultazione e la scelta; seguono, allineati a meta pagina in colonneparallele come in una sceneggiatura cinematografica moderna, lalista dei personaggi e delle robbe, organizzata in modo da forniresubito in sintesi i riferimenti indispensabili per orientarsi all'interno di intrecci spesso assai intricati e romanzeschi, secondo ilgusto barocco dell'epoca, e che sarebbe veramente arduo riassumere per via narrativa.
Ci si serve allora di convenzioni visive: ciascun personaggio etipologicamente definito per via di essenziali connotazioni socioeconomiche a di riferimento agli altri personaggi (nobile, servo,soldato, francese, re di Persia; oppure: figlia, fratello, padre, consigliere del principe ecc.; ma anche « Brandino creduto figlio »,
« Flaminia creduta sua figlia » e persino, per non fare confusioni,« Isabella da uomo, figlia di Cassandro Aretusi bolognese qual non
204 MARZIA PIERI
si vede »): i loro nomi sono raggruppati tipograficamente perlegami familiari 0 per affinita drammaturgiche. Nell'elenco si hacura di specificare - e l'informazione e utile come sempre perlavorare meglio - se ad alcuni di essi sono richiesti interventi seenici minimi (per esempio « servitore che parla »), 0 magari la solapresenza fisica t~( sbirri che non parlano»). Altrettanto specifica efunzionale la lista delle robbe, dove emerge tutto l'empirismomaterialistico proprio del mestiere: non solo, infatti, si indicaquello che occorre, rna anche come dovra funzionare e come 10 sipossa reperire pili facilmente (<< vescica con sangue », «quattrotorce accese », «una luna finta che tramonti», «bastoni da bastonare, «un bel palazzo in prospettiva della seena, col suo colonnato, e la sedia da una parte ») 12.
A questa punto, in neanche due pagine, gli elementi necessaria fare 10 spettacolo ci sono gia tutti. Ouello che segue e una traccia dell'azione, spaziata sulla pagina in modo da restituire conimmediatezza, ad una semplice occhiata, l'avvicendarsi delleentrate e delle uscite; il testa e ripartito, infatti, in blocchi graficiche rimandano alle singole scene (quelle che, nei testi distesi,sarebbero contrassegnate da un numero progressivo con indicazione in capopagina degli interlocutori presenti in ciascuna). SuIlato sinistro sono evidenziati i personaggi che di volta in voltasopraggiungono e che parlano; se sono presenti in scena, rna insilenzio (per esempio per essere soltanto bastonati) illoro nome eracchiuso fra parentesi quadra. Mancano naturalmente le paroledei dialoghi, affidati all'improvvisazione memorizzata degliattori; il resto consiste in una sorta di ininterrotta didascalia cherimanda alle azioni principali (entrate, uscite, botte, risate, meraviglie, inseguimenti, saluti ecc.), di cui si ha cura di fissare ilritmo con estrema precisione, alludendo in modo soltanto sommario al contenuto delle battute. Rari inserti di discorso direttoritmano alcuni passaggi cruciali; per esempio, durante un'agnizione decisiva: «Graziano dice: "Chi fad fede di questo?" Cintiodice: "10 ne faro fede che le son fratello" »,
12 Cfr, F. SCALA, Il teatro delle Favale rappresentative, voll. 2, a cura di F. MAROTTI,
Milano, il Polifilo, 1976.
L'INDICE IN SCENA: ARGOMENTI, CANOVACCI, GENERICI 205
11 testo e ridotto ai minimi termini grazie ad una veloce metascrittura di andamento paratattico che si affida a sintetici formulari, tali da sottintendere il pili possibile i passaggi descrittivi (<< inquello », «via», «fanno scena amorosa »), oppure vi alludono conampi spazi bianchi; un sistema interpuntivo costruito ad hoc,regolarizzando l'incertaprassi dell'epoca, fissa una gerarchia difunzioni grafiche collegate all'andamento dell'azione scenica: lavirgola divide sequenze minime interne al parlato 0 all'azione diuno stesso personaggio; il punto e virgola segnala invece un passaggio interlocutorio con l'intervento di un nuovo parlante; i duepunti, pili forti, indicano una svolta dell'azione all'interno di unamedesima scena, mentre il punta fermo introduce una sequenzacompletamente diversa. A centro pagina, 0 in maiuscoletto, sonoevidenziate citazioni indispensabili da imparare a memoria, mentre altri espedienti, per esempio le parentesi graffe che raggruppano personaggi affini chiarendone i reciproci rapporti in casi disequenze particolarmente affollate, contribuiscono a salvaguardare questa spessore metaletterario e riassuntivo P.
Resta il problema degli sketches comici pili complessi tecnicamente, che presuppongono esecuzioni insieme verbali e mimicheo acrobatiche, e la messa in campo di trucchi e invenzioni specifiche; sappiamo che essi costituivano l'elemento forse pili eclatantee celebrato della recitazione dei comici dell'Arte, rinomati e ricercati in tutta Europa per questa straordinaria capacita di recitazione totale, stilizzata ai limiti del virtuosismo ballettistico, taleda essere comprensibile a pubblici diversi per lingua, cultura edestrazione sociale. Impossibile sintetizzare in forma scritta questo linguaggio corporeo: per ricostruirlo ci dobbiamo semmaiaffidare ai documenti iconografici, da cui emerge con molta chiarezza l'artificiosita delle lora posture sceniche. I canovacci, inmateria, tacciono e si limitano a richiamare il termine tecnico«Iazzo » (dall'incerta etirnologia forse connessa con la radice diagere), talvolta con una didascalia per noi in genere oscura:
13 Cfr. il mio Fra scrittura e scena: la cinquecentina teatrale, in Storia e teoriadell'interpunzione. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Firenze 19-21 maggio 1988, a cura di E. CRESTI, N. MARASCHIO, L. TOSCHI, Roma, Bulzoni, 1992, pp.245-267.
206 MARZIA PIERI
« qui fanno lazzi» vuoldire pin 0 meno « qui sta una scena comica di tipo mimico 0 acrobatico », che puo essere anche specificata: lazzo del braccio, lazzo del pianto, dell'io, alIa muta, dell'affamato, lazzo in quarto, degli spiriti, della buona religione,di bravura 14.
II rimandoresta, in questa caso, totalmente implicito e riferito ad una sapienza attoriale pertinente alIa tradizione orale, carnevalesca e popolare quasi totalmente perduta (che a sua voltariassume antiche gags corniche talvolta trapassate nella culturaletteraria, per esempio nel genere della novella 0 della facezia),per cui dei lazzi dei comici dell'Arte italiani possiamo oggi stendere, al massimo, un catalogo di titoli.
La geniale invenzione grafico-scrittoria di Flaminio Scalaresta unica nel suo genere, frutto di un compromesso utopisticoche pensava di poter coniugare il laboratorio recitativo e Ie esigenze del mercato letterario. Non abbiamo canovacci a stampa dialtri attori professionisti, fino a Settecento inoltrato, rna ci restaun imponente corpus di qualche centinaio di canovacci manoscritti, opera di dilettanti, spesso legati a delle accademie, affascinati dalle performances dei tanto vituperati mercenari delle scene,di cui si sforzavano di imitare Ie invenzioni nei loro allestimentiprivati. Per un paradosso della storia e aIle testimonianze tantoparziali di costoro che dobbiamo in gran parte affidarci per ricostruire questa vicenda; ebbene, dal punta di vista che qui ci interessa, e singolare notare che, nelle loro mani, la memoria riassuntiva dello spettacolo perde la stringata efficacia - che abbiamochiamato multimediale - propria del grande Flaminio Scala, perscadere spesso ad un mero riassunto della vicenda, sordo ai valoridel ritmo e del meccanismo scenico, dove si sottolineano di preferenza gli: elementi piu grossolanamente farseschi 0 osceni del teatro delle maschere. La calibratura riassuntiva degli attori dimestiere, interessati all'effettiva memoria 'materiale' dell'allestimento e alIa sua esatta riproducibilita, si riduce ad un banaleriassunto delle trame degli spettacoli, che e tutt'altra cosa.
Questo fatto e gia evidente, per esempio, in un personaggio
14 Cfr. L. ZORZI, L'attore, la Commedia, il drammmaturgo, cit., pp. 199-221.
L'INDICE IN SCENA: ARGOMENTI, CANOVACCI, GENERICI 207
pur di tutto rispetto come Galileo Galilei, autore di una traccia dicommedia che consiste semplicemente in una trasposizione informa indiretta della traccia dei dialoghi 15. Nelle successive raecolte di Basilio Locatelli, di Ciro Monarca e di altri il fenomeno siaccentua progressivamente, finche, in pieno Settecento, quandoormai la bravura degli attori di mestiere si e molto abbassata, e lalora creativita si e ridotta alla coltivazione di stereotipi recitativisempre pili seriali e scontati (la « vile» commedia dell'Arte controcui combatte Goldoni) anche le loro, ormai rare, scritture denunciano la perdita di questo insieme di saperi.
Una raccolta di canovacci della meta del secolo conservati aDresda e a Varsavia, sedi della corte di Sassonia, presso cui lavoravano regolarmente i comici italiani, ci conferma come, all'inerzia tecnica subentrata nel modo di recitare, corrisponda un'attitudine riassuntiva dello spettacolo attenta solo aIle grandi lineedell'intreccio, tanto che si ritiene utile distribuire agli spettatori latraccia di quello che certo non e pili un canovaccio come unasorta di programma di sala, in italiano e in tedesco 16,
Fa eccezione il caso di un altro grande capocomico, Luigi Riccoboni, che dirige a Parigi la Comedie Italienne in collaborazionecon Marivaux, e che, per il suo passato di arcade legato a ScipioneMaffei, e molto sensibile aIle ragioni di una riforma del teatracomico, rna anche alla necessita (che sfuggiva completamente ailetterati riformatori) di salvaguardare il patrimonio tecnico erecitativo di cui erano ancora in possesso gli attori italiani. Perquesta egli cerea - invano perche nessuno gli da retta e nessunostampatore si dimostra disponibile all'impresa - di pubblicare,ancora una volta, dei canovacci, destinati pero, questa volta, aisuoi colleghi comici: la sua speranza e che costoro possanoapprendervi un modo pili disciplinato e plausibile di costruire 10spettacolo, senza tradire, pero, Ie ragioni del ritmo scenico e deldivertimento, in cui restano i massimi esperti. Con questa preva-
15 II testo si puo leggere nell'Appendice III dell'edizione, gia citata, del Teatrodelle[avole rappresentative, vol. I, pp. LXXVI-XC.
I Cfr. M. KLIMOWICZ - W. ROSZKOWSKA, La Commedia dell'Arte alla corte di Augusto III di Sassonia (I 748-1756), Memorie dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere edArti. Classe di Scienze Morali, Lettere ed Arti, vol. XLI, fasc. 1, Venezia, 1988:
208 MARZIA PIERI
lente attenzione al valore dell'intreccio, che, secondo il gusto dell'epoca dovra essere ora il pili possibile verosimile e morale, Riccoboni confeziona un tipo di canovaccio abbastanza diverso daquelli di Flaminio Scala: l'argomento (ora chiamato pili letterariamente proemio) diventa ampio e discorsivo, accogliendo una serieesplicita di considerazioni critiche e di raccomandazioni pratiche( « Ho fatti i servi attaccati a l'interesse de' lora padroni, ne puntomaliziosi 0 infedeli, e cio a bello studio, avendo voluta l'ationemia tutta semplice, perche dal solo motivo della gelosia nenaschino tutti gli accidenti dela Comedia » 17; il numero dei personaggi si riduce e i loro rapporti si semplificano; resta minuziosa eprecisa, rna assai pili vicina alla quotidianita, la lista delle robbe;diventa pili dettagliata l'indicazione scenografica «( il loco dellascena e Milano, parte in una camera della casa di Lelio, e partenella strada davanti la stessa casa » 18.
La vera e propria traccia della sceneggiatura si arricchisce dididascalie (simili ormai a quelle del teatro ottocentesco) separateora dal corpo del testo; torna, cioe, a prevalere drammaturgicamente l'elemento-parola, come si evince dalla scrittura del canovaccio; tuttavia l'attore-arcade, COS! preoccupato degli equilibriunitari dell'intreccio, non si dimentica di specificare con estremaprecisione la posizione di ciascun attore in scena, e la sequenzaminuziosa degli interventi parlati edei gesti da compiere. La suamemoria dello spettacolo prevede gerarchie diverse e un gustodiverso, rna e altrettanto multimediale di quella del suo anticocollega Flaminio Scala 19.
Pili tardi questa sensibilita si smarrisce; i testi teatrali scrittidai letterati (con la sola eccezione di Goldoni, capace di conferireaIle battute tutto 10 spessore della lora realizzazione scenica) sispogliano di significativi riferimenti allo spettacolo, diventano
17 L. RICCOBONI, La moglie gelosa, in Discorso della commedia all'improvviso escenari inediti, a cura di I. MAMCZARZ, Milano, il PoIifilo, 1973, p. 40.
18 lvi.19 Ancora una volta e illuminante, per contrasto, il confronto con un dilettante
di teatro, quasi contemporaneo, il marchese Francesco Albergati Capacelli, estensore di scenari assai pili stancamente 'narrativi' di quelli di Riccoboni; CIT. R. TROVATO, Francesco Albergati Capacelli: scenari inediti della Commedia dell'Arte, in C( IIcastello di Elsinore", IV (1991), 11, pp. 89-136.
L'INDICE IN SCENA: ARGOMENTI, CANOVACCI, GENERICI 209
nudi scheletri di parole, spesso, nel caso almeno della tradizioneitaliana, assai poveri di teatralita: la dicotomia fra teatro e letteratura, fra parole e gesti, fra intrattenimento e cultura si allargaprogressivamente, con effetti reciprocamente perversi per l'uno eper l'altro fronte. La cultura attoriale si sottrae nuovamente alletentazioni della scrittura (0 si piega a scritture posticce comequelle memorialistiche); il copione teatrale resta, per molti decenni a venire, subalterno alIa realta della rappresentazione, mero ebistrattato strumento di lavoro nelle mani dei mattatori ottocenteschi, che 10 manipolano con spietata disinvoltura; una dura battaglia per la difesadel diritto d'autore riportera in primo piano lafigura del drammaturgo alIa fine del secolo; rna a aquel punto ilteatro e diventato cosa ben diversa.
Nella sua storia successiva non si riproporra piu un fenomenosimile a quello che abbiamo descritto, e bisognera aspettare lanascita del cinema, 0 meglio la sua emancipazione dalla letteratura come arte autonoma, per ritrovare l'invenzione di linguaggi,le sceneggiature e gli appunti di regia, di analoga, implicita pregnanza espressiva.
APPENDICE
Alleghiamo, come supporto esemplificativo, alcuni campioni di scritture diattori (Flaminio Scala, Francesco e Isabella Andreini, Domenico Bruni, Luigi Riccobon i) e di analoghe scritture di letterati (Galileo Galilei, Andrea Perrucci), di cuisi e discusso nel testo.
1. ISABELLA ANDREINI, Lettere (1607)
Tavola di tutte le lettere che sono nell'opera
Di quanta pregio sia l'onoreDella servitu infruttuosaDelIo splendore della LunaDelle percosse della FortunaSegni di perfetto amoreDella bellezza umanaLodi della bellezzaDella forza dell'ira
210 MARZIA PIERI
Del dispregio de gli amantiQuerele contra AmoreDello sdegnoDel medesimoDella pallidezza de gli amanti'Della forza dell'amiciziaDella disperazionePreghiere amoroseDella contentezza delle donneDell'incendio d'amore
Preghiere amorosePreghi d'onesto amanteDel nascimento della donnaPreghiere amoroseDella bellezzaBiasimo de i vecchi innamoratiDella forza d'AmoreDel medesimoDell'istessoDell'infermita del corpo e dell'animoDelle lettere che si scrivonoDella volubiltaDell'adulazioneDelle difese d'uno amanteDelle comparazioni naturaliDel prender moglieDell'istessoScherzi piacevoli ed onestiScherzi d'onesto amoreDell'audaciaDella Iiberta dell'uomoDella gioventuDel pensieroDell'istessoDel di~simulareDel medesimoDe i prieghi amorosiDella gelosiaDella medesimaDella volontaDell'intellettoDelle umane miserieDella mutazione de i luoghiScherzi amorosi onesti
L'INDICE IN SCENA: ARGOMENTI, CANOVACCI, GENERICI 211
SimiliSimiliSimiliDel tardo soccorsoChe illuogo non cangia pensiero
Del pianger l'umane miserieScherzo amorosoDe i pensieriDel viver tra molti contrariiScherzi piacevoli ed onestiDell'ostinazioneScherzi amorosi ed onoratiSimiliDella lontananzaDelle passioni d~ll'animoScherzi amorosi civiliSimiliDel pensieroDel desiderioScherzi amorosi onestiSimiliDe i pensieriDel servire in CortePensieri amorosiScherzi amorosi e civiliDella milizia e d'amoreScherzi d'amore onestoSimiliDella gelosia feminileDe i doni che si fannoDella pudiciziaDella volubilita feminileDella sospezzioneDono amoroso 'Della pudicizia della donnaScherzi d'onesto amanteSimiliSimiliSimili[...J
(F. MAROTTI - G. RaMEl, La commedia dell'Arte e la societa barocca. La professionedel teatro, Roma, Bulzoni, 1991, pp. 197-199)
212 MARZIA PIERI
2. FRANCESCO ANDREINI, Le Bravure del Capitano Spavento (1607)
Tavola di tutti i ragionamenti ehe si eontengono nell'opera, tra la persona del Capitano Spavento e la persona di Trappola suo servitore
Nel Primo ragionamento, il Capitano Spavento racconta al suo servitore l'esser suo, edella mostra generale della gente a cavallo.
Nel Secondo, della guerra fatta a Giove, e come 10 facessi suo prigio-niero.
Nel Terzo, del giuoco del Pallone, del giostrare e del correre all'anello.Nel Quarto, della caccia del Cervo, del Cinghiale e dell'Orso.Nel Quinto, de' suoi figli bastardi, e del contrasto avuto con Giano.Nel Sesto, della sua abitazione, della sua servitu, della sua spada e
della sua Galera.Nel Settimo, del suo natale, e del banchetto fatto al Diavolo ed alla
Morte.Nell'Ottavo, come fusse fatto prigioniero d'Amore, come si liberassi, e
d'una lettera stravagante scritta alla sua Donna.Nel Nono, della partita al Pallone fatta con diverse Delta.Nel Decimo, de i Fulmini, del Caos e del suo barbiero.Nel Decimoprimo, del peso della sua gloria pesata da Giove.Nel Decimosecondo, del giuoco del pallamaglio, e della strage fatta
nell'lnferno.Nel Decimoterzo, della caccia delle Quaglie, delle Starne e de'
Fagiani.Nel Decimoquarto, della cucina del Sole e de i Comici Gelosi.Nel Decimoquinto, dell'abbattimento con Rodomonte nell'lnferno..Nel Decimosesto, della divisione del mare, e della riforma dell'anno.Nel Decimosettimo, dell'albergo dato a Cupido ed alla Morte, e de i
vini bevuti, vini stravagantissimi.Nel Decimottavo, del banchetto fattoli da Nettuno e d'una procella
maritima.Nel Decimonono, del giuoco de i Caroselli, e del guidare u'carro del
Sole.Nel Ventesimo, delle sue nozze con Megera, e sopra il matrimonio.Nel Ventesimoprimo, dell'amor della sua Dama, edelle Donne in
generale.Nel Ventesimosecondo, dell'esser fatto Imperator de' Turchi, e sopra
le cortigiane.Nel Ventesimoterzo, come venisse al Mondo, la guerra contro le
saette, e della gloria e dell'onore.Nel Ventesimoquarto, del viaggio fatto in Persia, ed in Costantinopoli,
viaggio stravagante.Nel Ventesimoquinto, del giuoco della primiera, del giuoco delle carte
e de i dadi, del biasimo e del giuoco del Calcio alla Fiorentina.
L'INDICE IN SCENA: ARGOMENTI, CANOVACCI, GENERICI 213
Nel Ventesimosesto, della battaglia avuta nei i campi Elisii e dellemolte mogli offertole da gli Dei.
Nel Ventesimosettimo, de gli ordini di bravura, del banchetto diMarte e della contesa sopra del tirar dell'arco,
Nel Ventesimottavo, della congiura de gli Dei e del cereare Amore pertutti i globi.
Nel Ventesimonono, del-correr la posta verso gli Antipodi e della giornata fatta tra Giove e Plutone.
Nel Trentesimo, della giostra nell'lnferno per le nozze di Megera.Nel Trentesimoprimo, del far sorger nuovi Regni nel Mondo, e della
buona ed avversa Fortuna.[... ]
(F. MAROTTI - G. ROMEI, La professione del teatro, cit., pp. 220-21)
3. DOMENICO BRUNI, Praloghi (post 1623)
Tavola de' praloghi
I
IIIIIV
VIVIIVIIIVIllIX
XIXIIXIIIXlIIIXVXVI
XVIIXVIIIXIXXX
XXI
XXIIXXIII
Caminante di notteGratitudineLa comedia vero rimedio contra dell'ozioChe si deve ridere d'ogni cosa - da PantaloneLode delle donne dove siano donneOgni cosa nella comediaLode degli sbarbatiMiserie de' comici - da FantescaLa Fantesca grassaDifinizioni - da GrazianoQualche cosa - da PantaloneAl Cristianissimo Luigi XIIIParlareTutto il mondo comedia - da FantescaAll'Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor Don Emanuelledi SavoiaCamera locante - da FantescaComplimenti per un principianteLo studio supera le difficulta dell'arteCinzia a BolognaMarte nella MontagneseServire la Serenissima casa d'Este meglio eche dominareRettorica - Prologo da Graziano
214
XXIV
XXV
XXVI
XXVlI
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIIII
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XXXX
MARZIA PIERI
In lode di Sicilia11 ritornoRicominciamento di servitaImitazioneLo specchioLa Fortuna, perche di vetroOgnlcosa si biasima e si lodaAmore del proprio essercizioContento di servire chi meritaPrimo Prologo per Donna11 filare - da Fantesca
Incomodi di chi camina il mondoLa ruffiana fantescaTuo e mio - da Pantalone11 non avere materia, emateria di PrologoIncostanzaDa Coralin, spropositi
(F. MAROTTI - G. ROMEl, Laprofessione del teatro, cit., pp. 373-74)
4. ANDREA PERRUCCI, Dell'arte rappresentativa premeditata e all'improvviso(1699)
Procuri dunque ogn'uno d'avere la robba accomodata allo stile dellasua lingua, e della sua abilita, accioche non gli rinfacci Orazio,
Parturient montes, & nascetur ridiculus Mus.
I concetti che si deve apparecchiare per servirsene nell'occasione,devono essere raccolti in un libro con titolo di Cibaldone Repertorio, 0 asuo beneplacito, "co i titoli, d'Amor corrisposto, disprezzo, priego, scaccia,sdegno, gelosia, pace, amicizia, merito, partenza, ed altro.
I concetti, disse il Tasso, non son altro, che I; Imagini delle cose, le qualinon hanno soda, e reale consistenza in se stesse, come le cose, ma nell'animenostre hanno un certo loro essere imperfetto, e quivi dall'imaginazione sonformate e figurate. Da' concetti poi, secondo 10stesso nasce la loquzione. Iconcetti pero da rappresentare non son altro, che una loquzione brevefigurata; e di ogni uno de' principali di essi ne daro un'esempio,
1 Poet. disc. 3.
L'INDICE IN SCENA: ARGOMENTI, CANOVACCI, GENERICI 215
CONCETTI.
D'Amor corrisposto.
Corri tutto negli occhi mio cuore per beatificarti nella vista della tuacara, e s'egli e vero, che pili vivi nell'oggetto amato, che in te anima miagioisci, rallegrati, e brilla, scorgendo chi ti da e moto, e vita.
Di Priego.
E da chi avesti illatte; gia che sei COS! barbara? Forse come Paride t'allatta un'Orsa, mentre crudele t'esperimento, 0 come Ciro, die le poppe unaCagna, mentre sempre arrabbiata meco ti mostri: 0 qual Clorinda suggestile mamme di Tigre Ircana se non posso con le lusinghe domesticarti?
Di Scaccia.
Il mio cuore e d'incudine per resistere al colpo di martello della vostraostinazione, il mio petto e di marmo, anzi di pietra Agate per resistere alvostro fuoco; Il mio seno di ghiaccio rna di ghiaccio COS! duro, che saraImpossibile di Iiquefarsi aIle vostre fiamme, e per me siete una Furia delRegno amoroso, per tormentarmi.
Di Sdegno.
Chi avrebbe mai creduto all'esternol mostrava costei un volto di Primavera, rna tra quei fiori eran gli Aspidi: un'Idea Celeste, e pure accogliele Furie: una tranquillita di genio, e pur non mormora che tempeste.Maledico quei fiori ch'allettano per tradire, quel Cielo, che maschera IeFurie, e quel Mare tranquillo, che invita per sommergere.
Di Gelasia.
10 son Geloso perche sono amante, 0 strana antiparistasi! il focod'amore e COS! al gelo della Gelosia congiunto, che fanno un misto atto atormi la vita, e la mia passione per questi due barbari e una infermita, chefa, ch' io geli nell'esterno, quando una violentissima, ed ardente febre miconsuma le viscere.
Di Pace.
E chi potea risanare il mio core morsicato dalla Serpe velenosa dellaGelosia altro che il balsamo dell'amorosa corrispondenza? e quanta fupili pericoloso il morso, tanto pili cara m' e la restituita salute: ondesospendero il cuore in voto al Tempio della tua Fede, che m' ha tolto dalleFauci di morte.
D'Amicizia.
Deita pili riverita dell'Amicizia appena si ritrova tra Ie Sfere: quindi ilPrincipe de' Filosofi volle alla stessa Giustizia anteporla, essendo l'Amici-
216 MARZIA PIERI
zia quella che il Mondo sostiene; Su l'ara dunque di questa Nume vi giurainviolabil osservanza, ed eterna fede il mio cuore.
Di Merito.
Meritevole d'ogni encomio il merito istesso vi rende: e se per 10 Tempio della Virtu si passava a quello dell'Onore: se la Virtu nel vostro meritoha collocato il suotempio per esso all'immortalita del vostro nome se nepassa la Fama.
Di Partenza.
Parto 0 bella: rna con qual cuore 10 sa solo il Dio Cupido: poiche se sisvelle la piata dal natio terreno cadono i fiori, illanguidiscono le frondi,ed arido rimane; COS! il mio cuore svelto da quel seno da cui riceve l'amoroso alimento, e la vita: perde i fiori delle gioie, le frondi della speranza,ed arido diviene.
A i concetti si deve rispondere a proposito, ed aver giudizio d'attaccarvi il suo per risposta, e non far come certi tali, che facendo il confabulatore un concetto, v. g. di paragonare l'Amicizia al Sole, gli risponda conparagonarla alla Calamita, e COS! vengono a fare una sconnessione COS!
grande, che stomaca; navigando uno per Levante, e l'altro per Ponente seuno dunque COS! proponesse.
L'Amicizia e un'albero, che produce i frutti d'uri amabile gratitudine: sirisponda se e albero, sara di alloro che vanta per pregio esser simbolo dell'immortalita; gia che per fredda staggione foglia non perde; COSl l'amiciziaper variar di fortuna il suo vigore non lascia: e COS! avranno connessione idiscorsi.
(ANDREA PERRUCCI, Dell'arte rappresentativa premeditata e all'improvviso, a curadi A. G. BRAGAGLIA, Firenze, Sansoni, 1961, pp. 164-66)
5. FLAMINIO SCALA, Il teatro delle favole rappresentative (1611)
GIORNATA III
LA FORTUNATA ISABELLA
Comedia
Argomento
Fu gia in Genova un giovane ben nato e di buona fortuna, nomatoCintio, il quale rimanendo senza padre e senza madre, una sola sorella lirimase di molta bellezza e d'onorati costumi dotata. Avvenne che il fratello (che altro desiderio non aveva che di bene accompagnarla) fece amicizia con un certo Capitano, il quale altro desiderio nonaveva che averper moglie la detta sorella; accortosi di cio, il fratello n'ebbe stretto ragio-
L'INDICE IN SCENA: ARGOMENTI, CANOVACCI, GENERICI 217
namento con la sorella, la quale mostro parimente d'aver l'animo conforme a quello del Capitano.
Cosi, contratto tra di loro matrimonio di fede e di parola, occorse cheal detto Capitano bisogno, per alcuni negozii importantissimi, insino aNapoli trasferirsi, promettendo prima di far ritorno in brevissimo tempoe di sposare Isabella, che cosi nomavasi la giovane.
Ma, dimorato in Napoli-il tempo di tre anni, e non si ricordando pilidella promessa fatta, fu cagione che il fratello pigliasse risoluzione dimaritar di nuovo e con miglior fortuna la sorella. La quale, intendendocio ch'egli far voleva, liberamente si lascio intendere che non pili maritovoleva; laonde, essendo di continuo dal fratello stimolata, fece pensierodalla patria partirsi et, in abito di serva, con un suo servo aRoma trasferirsi, Ia dove inteso aveva ritrovarsi il Capitano, che di nuovo nuovamoglie prender voleva. E cost facendo, aRoma si condusse, solo per rinfacciar la mancata fede al detto Capitano; il qual trovato, sfoga secol'animo suo e poi, per diversi accidenti, divien moglie d'altra persona, consodisfazzione dell'istesso fratello.
Personaggi della Comedia
PANTALONE venezianoFLAMINIA sua figlia
GRAZIANO DottoreORAZro e FLAVIO figlioli suoiPEDROLINO osteFRANCESCH1NA moglie
ISABELLA in abito di servaBURAITINO suo servoCAPITANO SPAVENTOARLECCHINO servoCINTIO fratello d'Isabella
Roma
Atto primo
Robbe per fa Comedia
Un baulloUna valigia grande di pelleCesto grande copertoDa vestire il Capitano
PANTALONE[ORAZro][FLAVIO]
intende dalli duo fratelli come Grazian, lor padre, essendo vecchio, vive innamorato di Franceschina, e che nonpiglia partito d'accompagnarli e dar loro moglie come siconviene. Pantalone cerca placarli, provando loro comeamore stia meglio in un vecchio che in un giovane. Flaviosi lascia intendere a Orazio, sapendo esser suo rivale, cheil padre l'ha mantenuto allo studio perche s'addottori, enon perche prenda moglie. Finalmente pregano Panta-
218
GRAZIANO
ISABELLA
[BURATIINO]
PEDROLINO
FRANCESCHINA
PANTALONE
PEDROLINO
BURATIINO
MARZIA PIERI
lone, come amico del padre, a distorlo da quella folle impresa, e partono. Pantalone rimane, dicendo essere innamorato ancor lui di Franceschina; in quello
amico di Pantalone, vien ripreso di far l'amore con Franceschina, e delle querele de' suoi figlioli. Graziano: chevuol far a suo modo, mentre che vive; e cost ridendo,vanno via insieme.
in abito di serva, con Burattino, partitasi di Genova pertrovare il Capitano in Roma e rimproverarli la mancatafede: e d'essersi partita da Genova per non pigliare il secondo marito che gli voleva dar Cintio, suo fratello, e divolersi finger donna francese, e che la chiami Olivetta.Battono all'osteria: in quello
oste, ragiona con Olivetta, la quale ragiona seco in linguafrancese, e, burlando, entrano nell'osteria.
moglie di Pedrolino, vien di villa con un cesto in capocarico di robbe; in quello
innamorato di lei, la saluta, Ie dice l'amor suo. Ellarisponde che l'amore ne i vecchi si chiama dolore. Pantalone la prega; in quello
che ha sentito il tutto, brava Pantalone. Egli si scusa; inquello
sta a sentire Pedrolino che brava, e non s'avvede cheFranceschina sia moglie dell'oste. Franceschina in casa;in quello [... ]
(F. SCALA, Il teatro delle favole rappresentative, vol. I, Milano, II Polifilo, 1976,pp.43-45)
6. F. SCALA,'!l teatro delle favole rappresentative (1611)
GIORNATA XLIV
ROSALBAINCANTATRICEOpera eroica
Argomento
Viveva nel mare Egeo un famosissimo incantatore, chiamato Artano,Signore dell'Isola Felice, et aveva questi una figlia, detta Rosalba, laquale come il padre a gli icantesimi attendeva, et un bambino dell'eta di
L'INDICE IN SCENA: ARGOMENTI, CANOVACCI, GENERICI 219
anni quattro, Iacinto nomato. Aveva il detto Mago antica nemistade conun altro famoso Mago, detto Arimaspo, Signore dell'Isola Verde, dalquale fu ucciso, et inoltre li tolse il picciolo fanciullo, il quale allevo sinoall'eta di dieci anni, e, vedendolo cost vago, volle vedere per l'arte suaquello che del fanciullo venir deveva, e vidde e conobbe ch'egli devevaesser cagione della reconciliazione tra lui e la figlia dell'ucciso Artano;laonde fece sl ch'egli capitasse nella corte della Maga Rosalba, Signoradell'Isola Felice; et in quella corte allevandosi, fu dalla sorella, che perfratello non 10 conosceva, cordialissimamente amato et ella da lui similmente amata. Era, vicina alla detta Isola, un'altra maggiore e pill ricca,della quale ne viveva Signore un Alicandro, detto il Prencipe dell'Isoladel Sole, il cui Prencipe aveva una figlia, chiamata Nerina, alla quale inquel tempo nacque una interna malinconia, tanta e tale che non si trovava rimedio alcuno che sanar la potesse; e, ricorrendo il padre di lei alMago Arimaspo per rimedio ~ consiglio, li fu da lui risposto ch'egli dellafiglia non avrebbe mai allegrezza avuta se per alcuni giorni nella corte diRosalba et a diporto non la mandava. Piacque ad Alicandro il consiglio,e, dettolo alla figlia, mostro Nerina di cio aver gran contento, per esserdetta Maga sua carissima arnica. Inviolla il padre con bellissima compagnia alla arnica Rosalba, avendola prima avvisata per un suo buffone delsuo andare a trovarla. Viveva innamorato della Prencipessa NerinaAlmonio, figlio dell'Arimaspo incantatore, il quale era valoroso Cavaliero, et ella non 10 riamava, rna l'odiava come capital nemico, VedendoAlmonio che la donna amata da lui andava nella corte di Rosalba Maga,sua nemica, si risolse, non avendo riguardo al pericolo, volerla, sconosciuto e con un suo servo, seguire, si come fece; e non st tostoegli dallanemica Maga e veduto, ch'ella di lui s'innamora, e con l'arte del padre, eper comandamento di quello, lascia d'amar Nerina, e di Rosalba Magas'accende. Dopo molti graziosi avvenimenti si scopre chi egli sia, e dellanemica amico e marito diviene; e Nerina, subito gionta nell'Isola Felice, di Iacinto s'accende, riconosciutolo per fratello di Rosalba Maga,suo marito diviene, e per mezzo dell'arte d'Arimaspo egli col PrencipeAlicandro, Signore dell'Isola del Sole, se ne viene aIle nozze dell'uno edell'altro figlio.
Personaggi dell'Opera Eroica
ROSALBAMaga, Signora dell'Isola FeliceIACINTO suo amante, e poi suo fratelloORMONTE Capitano della guardiaGRAZIANO Maggiordomo< PAGGI >
AUCANDRO Prencipe dell'Isola del SoleNERINA figlia
Robbe per l'Opera
Una bella seggietta alla genoveseUn vasa d'argento con fuocoAcqua ardenteQuattro abiti da spiritiQuattro abiti belli da ninfeUn bel libretto per ArlecchinoAbito nobile per ArlecchinoMolti bacili d'argento con presenti dentro
220 MARZIA PIERI
PRATILDA damigellaBURATTINO servoARIMASPO Mago, Signore dell'Isola VerdeALMONIO figlio
PEDROUNO servo
ARLECCHINO servo di Nerina
MINISTRO del fuoco della veritaSERVIPASTORI sonatoriSPIRITI quattroNINFE quattroNANI quattroTROMBETTI e TAMBURI
Atto primo
Un bamboccio pieno di paglia,vestito dell'abito d'OrmonteUna bella cisterna d'acqua inscenaLanterna segretaQuattro torcie bianche acceseIsola felice
ROSALBA MAGA[IACINTOAMANTE]
[ORMONTECAPITANO][GRAZIANO
MAIORDOMO][PAGGI]
ORMONTE[ARLECCHI~O]
IACINTO
dell'Isola Felice dice a' suoi aspettar Nerina, Prencipessadell'Isola del Sole, e di volerla ricever con grandissimoonore, motteggiando con Ormonte suo Capitano, sapend'ella com'egli vive innamorato di Pratilda, sua cameriera; poi, rivoIta a Iacinto, li domanda la cagione della suamestizia. Egli risponde esser cagionata dalle molte carezze ch'ella fa ad Arlecchino. Ella di cio sorride, dicendolich'egli dimostra d'aver un bel giudicio, e di non sapersopportar questa suo nuovo amore, sapendo quello chedebbe fare, e gli aditi di segreto che riceve da lei, maravigliandosi che in un animo nobile possa cadere un coststrano pensiero; poi manda Ormonte suo Capitano achiamar Arlecchino.
conduce Arlecchino vestito nobilmente, Rosalba l'accarezza come suo amante, poi li dona un libretto incantato,per mezzo del quale avera tutto quello che sapera desiderare; li lascia Ormonte alla guardia, et ella si parte con lasua corte, e via.
avendo veduto in disparte cio che ha fatto Rosalba adArlecchino, tutto stupido si parte. Ormonte dice ad Arleechino egli essere uno spirito costretto dalla Maga in quelcorpo. Arlecchino comincia a spaventarsi, apre il libro,chiamando soccorso; in quello
L'INDICE IN SCENA: ARGOMENTI, CANOVACCI, GENERICI 221
SPIRITI
NINFE
ALMONIO
[PEDROLINO]
ROSALBA
[GRAZIANO]
[PAGGI]
ARLECCHINO
TROMBETII
SPIRITI
NINFE
TROMBETII
TAMBURI
ROSALBA
[NERINA]
infernali fuora gridando: « Comanda, comanda! »; Arleechino: che bastonino il Capitano Ormonte. Spiriti 10bastonano, poi domandano se comanda altro. Arlecchino: che li conduchino una bella seggietta, e che comparischino in forma vaga e gentile. Spiriti via. Ormontes'umilia ad Arlecchino; in quello
conducono la seggietta, Arlecchino entra dentro, si ponea sedere, e, facendosi andare Ormonte Capitano innanzi,si fa condur via.
figlio d'Arimaspo Mago, Signore dell'Isola Verde, seguitando Nerina Prencipessa, la quale deve capitar in quell'isola, essendo di lei innamorato, e come suo padre uccisegift il padre di Rosalba Maga. Pedrolino l'avvertisce delpericolo. Egli: che non stima pericoli; in quello
Maga vede Almonio, se ne innamora, domanda di suacondizione, et egli risponde esser Cavalier da ventura.Rosalba 10 conduce seco al porto, per ricever NerinaPrencipessa, e via. Pedrolino rimane dubitando del suoSignore; in quello
portato dalle ninfe nella seggietta, riconosce Pedrolino, ilquale li dice come Almonio, suo signore, e venuto dietroa Nerina, amandola, pregandolo a non 10 discoprire.Arlecchino promette; in quello
di dentro suonano. Arlecchino, per saperne la cagione,apre illibretto; in quello
fuora, dicendo: «Comanda, comanda !»; Arlecchinocomanda loro che mandino Ninfe bellissime, con bellissimi presenti da presentare la Prencipessa Nerina. Spiritivia; in quello, e subito, arrivano le
con bellissimi presenti. Arlecchino se le accommoda tutteintorno; in quello
di dentro suonano per l'arrivo di Nerina; in quello
Maga arriva, conducendo Nerina per mano. Arlecchinosubito dispensa i presenti alla Prencipessa, poi diventa
222
[ORMONTE][PRATILDA]
[IACINTO][BURATTINO]
[ALMONIO][PAGGI]
TROMBETTITAMBURRI
MARZIA PIERI
ge1oso d'Orrnonte, che vagheggia Pratilda sua innamorata, dimostrandosi sdegnato contra di lui. Rosalba dice aNerina che, nel mandarli Arlecchino suo Ambasciadore,ella l'ha privata della sua cara Iiberta. Nerina vagheggiaIacinto, e con gesti amorosi tutti entrano in palazzo.
suonano per allegrezza,
e finisce l'atto primo.
(F. SCALA, Il teatro delle favole rappresentative, cit. vol. II, pp. 457-61)
7. GALlLEO GALILEI, Argomento e traccia d'una commedia (ante 1592?)
IArgomento
Cassandro, ricco e vedovo, ha un figliuolo, chiamato Orazio, il qualeama Fiammetta, figliuola di Frosino, cittadino privato, ed e amato da lei.Detto Orazio opera di aver per moglie detta Fiammetta; il che da Cassandro, suo padre, gli vien vietato, onde per disperazione si va con Dio. Incapo a 3 0 4 anni torna con una vecchia, ed in abito di serva si pone conFrosino, e go de la figliuola amata. Frosino s'innamora di Orazio, credendolo donna, e cerca in varii modi di condurlo al suo intento, e lui 10 vacon iscuse trattenendo. Cassandro ricco, non avendo nuove d'Orazio suofigliuolo, credendo averlo perso, trovandosi di eta, chiede a Frosino la suafigliuola per moglie, il quale gliela darebbe, rna lei dice non voler quelvecchio. Cassandro prega pili volte Orazio suo figliuolo (credendo che siaserva di Fiammetta), che voglia disporla ad amarlo; ed Orazio gli daparole; e mentre che va innanzi e 'n dreto, portando ambasciate, una suasorella, detta Lucilla, innamorata di Uberto figliuolo di Frosino, 10 pregache voglia esser mezzano a portargli l'imbasciate; tal che Orazio vedel'amor di suo padre verso Fiammetta e l'amor di sua sorella verso Uberto.Finalmente Frosino si risolve una notte a andare a trovare a letto Orazio,che crede che sia donna, e 10 trova mastio: leva il romore. Orazio se glimanifesta, piglia per moglie Fiammetta, da la sorella a Uberto. Cassandro, svergognato dal figliuolo, se ne contenta.
CASSANDRO, vecchio ricco, vedovo.
LUCILLA, fanciulla, figliuola di Cassandro.
FROSINO, cittadino privato.
L'INDICE IN SCENA: ARGOMENTI, CANOVACCI, GENERICI 223
FIAMMETIA, sua figliuola.
UBERTO, figliuolo di Frosino.
VERONICA, moglie di Frosino.
MENICHETIA, serva, cio e Orazio.
Atto Primo
Scena prima
CASSANDRO soloSi lamenta della fortuna; manifesta la perdita di Orazio, suo figliuolo,
e credendolo morto, per esser passati 4 anni che non ne ha nuove, trovandosi ricco, si risolve a voler tor moglie, innanzi che vadia pili invecchiando: e perche e di eta, dice che non troverebbe una sua pari in ricchezze: pero, che chiedera a Frosino, suo molto domestico, la suafigliuola; e dice: Se Frosino sapessi che io non volsi acconsentire che Orazio, mio figliuolo, la pigliassi, arebbe ragione a non me la voler dare. Dicenon potere aspettar di maritar la sua figliuola, perche edi 13 anni, troppogiovanetta.
Scena seconda
FROSINO e CASSANDROChiede Cassandro a Frosino la figliuola per moglie. Frosino gliela pro
mette.
Scena terza
FROSINO soloRallegrasi da per se che la figliuola sia maritata, e scuopresi amante
di Menichetta, sua serva; e dice che se la figliuola gli esce di casa, potra,senza pili rispeftti], attendere alIa fante.
Scena quarta
MENICHETIA, FIAMMETIAFiammetta dalla finestra chiama Menica, che escie fuora per andare
aIle monach[e] per un colletto. Escono dell'uscio tutt'a due: parIano amorosamente, e Fiammetta dice che non 10 lascierebbe andar senza gelosiaaltrove che aIle monache.
Scena quinta
MENICA, FROSINOFrosino dice a Menichetta aver maritata Fiammetta, e gli da un
assalto; e lei gli da buone parole, per non esser cacciata via.
224 MARZIA PIERI
Scena sesta
MENICA soloManifesta se esser mastio, goder Fiammetta; si burla di Frosino: dice
che, se suo padre cerca di aver Fiammetta per moglie, potra scoprirsegli,e non g[li] potra esser negata, avendola egli medesimo chiesta, e questarispetto 1[0] facevastar celato...
(F. SCALA, Il teatro delle favole rappresentative, cit., vol. I, pp. LXXVI-LXXIX)
8. LUIGI RICCOBONI, Scenari (l713?)
LA MOGLIE GELOSA
Comedia in tre Atti
Proemio
A questa che fu la mia prima comedia do il primo loco ancora, Miaintenzione fu di correggere poco a poco la nostra Comedia. Ella e distribuita in tre atti, poiche mi conveniva esser cauto, ne dovevo tutto tentaread un colpo. Fu da me rapresentata la prima volta in Italia pili di 35 annifa, e sono certo che allora una comedia in cinque atti sarebbe stata ereduta un mostro non mai comparso su la Scena Italiana. So fin dove siestendeva a quel tempo la cognizione di Teatro nel maggior numero de'spettatori nostri.
Nella mia Gelosa avevo preso altro assunto, et ho voluto attaccare ilnemico nella parte piu debole. Ella e nuda affatto d'intrico amoroso. Eraquesti il passo pili ardito che si poteva intraprendere per correggere, 0
dare un nuovo metodo alla corrotta Italiana Comedia. 10 ho voluto farloalla prima. Nella mia Gelosa due maritati ne fanno il carattere, et il nodo.L'azione e il disinganno della gelosa, Questa passione che fa bene spessole inquietudini delle famiglie pili grandi, e talora cagiona precipitij irreparabili, e stata da me di tal modo maneggiata, che do alla gelosa tutta laragione per dubitare della fede del di lei marito, assicuratane dagli indizipiu forti, et alIa fine della Comedia in una sola occhiata facendossene 10scioglimento, si accorge ella quanta a torto abbi sospettato, e rimane dallasua confusione punita. ncarattere del marito della gelosa l'ho prefisso perun modello de l'uom d'onore, di un vero amico, e di un patiente marito.
Ho fatti i servi attaccati a I'interesse de' loro patroni, ne punta maliziosi 0 infedeli, e cio a bello studio, avendo voluta l'atione mia tutta semplice, perche dal solo motivo della gelosia ne naschino tutti gli accidentidella Comedia. Ella finisce senza matrimonij gia che gli attori principalisono maritati, ne si e trattato d'Amore in tutto il corso della favola. Pareche una tale Comedia per quanta sin ora ne ho detto debba riuscire unabuona scuola di morale, ed in tutto propria alla correzzione de' costumi,
L'INDICE IN SCENA: ARGOMENTI, CANOVACCI, GENERICI 225
rna niente adeguata per movere al riso. Per una parte ella e tale perl'apunto, potendo andar fra le mani della piu modesta gioventu ed anchede' Frati e delle Monache per farne uso come tal volta si pratica nellanostra Italia. Ma se poi sia risibile e propria per un Teatro publico dovel'impegno e di divertire ad un tempo l'inocente e la maliziosa gioventu, iol'ho provato con l'esperienza rapresentandola, e si conoscera da chiunquene esaminera la condotta.· ."
Robbe per la Comedia
Uno spechio. Un Libro. Varie Lettere. Carta e Calamaro. Tavolino esedie. Un baullo. Sottocoppa con bichiero d'acqua, Uno Stile. Scattolinocon ritratto. Un manto nero per donna per mascherare Mario da donna.Per mascherare Lelio una veste di Camera.
Persone della Favola
LELIO'
FLAMINIA, di lui Moglie
VIOLETTA, Serva di Flaminia
ARLICHINO, Servo di Lelio
MARIO, Amico di Lelio
PANTALONE, Padre di Flaminia
SILVIA, Moglie di Mario che arriva di viaggo
SCAPINO, Servo di Silvia
CAPITANO
Un fachino
II loco della scena e Milano, parte in una Camera della Casa di Lelio,e parte nella strada davanti la stessa casa.
LA MOGLIE GELOSA
Comedia in tre Atti
Atto Primo
Scena prima
Camera della Casa di Lelio quale avera due porte con usci a serraturee portiere. Una delle porte sara chiusa. Tavola con sopra gl'abiti di Lelio,spechio, perucca e quello che occorre per vestirlo.
LELIO, FLAMINIA, ARLICHINOAl aprirsi del Teatro si vede Flaminia seduta, Lelio in veste di Camera
et Arlichino in disparte in aprensione; doppo qualche momenta di silen-
226 MARZIA PIERI
tio, nel qual tempo dal passeggiare di Lelio con inquietudine e dal dispettoso contegno di Flaminia si sara compresa la loro alterazione, Lelio sivolge alla moglie chiedendole perche di sl bon mattino gli rendi visita.Flaminia dice che ben si avvede che giunge inoportuna, e che forse senzala di lei presenza egli goderebbe in quel ora una pili cara conversatione.Lelio Ie adimanda sino a quando vorra tormentarlo con l'ingiusta suagelosia. Lei, sinoa quel giorno che Ie sue maniere saranno almeno piliritenute e prudenti, che non bastava il crederlo vagabondo, se non Ieconduceva un'Inamorata sino sotto gl'occhi e nella propria casa; gia checost Ie conviene pensare, mentre da molti giorni sta chiusa la cameravicina, et in quella e negato l'ingresso non solo ad ognuno della famiglia,rna sino a lei stessa. Lelio cerca persuaderle il contrario, e senza spiegarsi dice che forse in quella stanza v'e cosa che deve nascondere a tuttoil mondo, e che il publicarlo potrebbe attirargli disonore non solo, rnaprecipizio e ruina. Flaminia dice che non soffrira tale agravio, e ne faradoglianza al padre et a' parenti. Lelio s'impazienta, e per togliersi a talnoia si fa vestire da Arlichino, e nel accomodarsi la perucca mentre ilservo gli tiene 10 specchio, Flaminia borbottando che si veste con moltaattenzione, perche va a trovare un'altra inamorata, si accosta rabbiosa, egli strapazza la perucca suI capo. Lelio sdegnato la getta in faccia alservo, e dice non voler pili sortir di casa. Flaminia, che perdera pocoavendo nella vicina stanza di che divertirsi, e dispettosa si parte. Lelio fauscire il servo, gli serra dietro la porta, e ne tira la portiera. Si accosta al'altra porta, e chiama adimandando la chiave, quale per di sotto la portagli viene data. Lelio apre.
Scena seconda
LELIO, MARIO
Viene Mario con libro alla rna no e fa sue protteste a l'amico avendointesa la passata conversatione. Lelio gli da una lettera per lui venutaglioclusa in una del suo amico di Genova. Mario posa il libro suI tavolinodicendo che non fa che leggere per solevarsi nella sua prigionia. Legge lalettera quale avisa che il Capitano et i parenti doppo la di lui fuga sidichiarano pili che mai di voler la sua perdita. Che il padre ed i parenti diSilvia sono pure nello stesso rischio, pretendendo il Capitano esser piliagravato ancora da loro, mentre doppo la parola a lui data per Ie nozze diSilvia in effetto l'hanno sposata a lui. Che il Capitano potendo sospettarech'egli si sia ricovrato in Milano si e partito a quella volta giurando divoler la sua morte. Che Silvia a tale aviso ha pure improvisamentelasciata la patria accompagnata solo da Scapino suo servo, per essere intraccia di lui, e che pero stij pili che mai nascosto ecc. Lelio fa nuove proteste a l'amico e giura un'inviolabile secretezza. Mario s'inquieta per Silvia. In tanto si sente battere alla porta, ed e la voce di Flaminia. Lelio
L'INDICE IN SCENA: ARGOMENTI"CANOVACCI, GENERICI 227
spinge subito l'amico nella sua stanza e ne chiude Ia porta ponendosi perIa fretta Ia chiave in sacoccia, poi apre l'altra porta.
Scena terza
FLAMINIA, LELIO, ARLICHINO
Entra Flaminia infuriata dolendosi che non possa quando vuoleentrare a parlare col suo marito, dice averlo inteso discorere con altrapersona, e che era una donna. Lelio nega e dice che Iegeva un libro. Flaminia dimanda ove sia illibro, si volge, e vede suI tavolino illibro Iasciatoda Mario. Lo prende, e trovando essere il Furioso de l'Ariosto, moteggia ilmarito che appunto euna Iettura da inamorato. Trova due siti segnati concarte piegate, dimanda se e quello illoco dove Ieggeva, Lelia che vede fortunatamente riparato alla bugia dice di S1. Flaminia Iegge e trova in tuttidue i siti de' versi in Iontananza de l'oggetto amato, ingelosisce di vantaggio, e dice che quando e diviso da l'inamorata si ramenta ne' versi altruigli effetti di Iontananza. Lelio non potendo soffrir di pili si finisce divestire sfogandosi contro Arlichino, che di tempo in tempo maltratta, eparte. Arlichino 10 segue. Flaminia chiama.
[...J
(L. RICCOBONI, Discorso della commedia all'improvviso e scenari inediti, a cura diI. MAMczARz, Milano, n Polifilo, 1973, pp. 39-43)