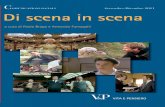Scrittoio, scena, torchio: per una mappa della produzione goldoniana, in «Problemi di critica...
Transcript of Scrittoio, scena, torchio: per una mappa della produzione goldoniana, in «Problemi di critica...
Problemi di critica goldonianadiretti da Giorgio Padoan
VII
Edito sotto gli auspicidel Centro Interuniversitario di Studi Veneti
«Problemi di critica goldoniana»è una rivista annuale
dedicata integralmente al commediografo veneziano.Redattori: Anna Scannapieco e Piermario Vescovo
Manoscritti e contributi per la pubblicazionevanno sottoposti al Centro Interuniversitario di Studi Veneti
S. Stefano 2945 - 30124 VeneziaI testi non verranno restituiti.
I contributi accolti dovranno essere possibilmente accompagnati da un dischettocon il testo memorizzato, definitivo e completo di note,
e con l’indicazione del programma usato.
ISBN 88-8063-237-X
Questo volume è stampato su carta «Palatina» Fabriano
© Copyright 2000 A. Longo Editore sncVia Paolo Costa 33 - 48100 RavennaTel. 0544.217026 Fax 0544.217554
e-mail: [email protected] rights reserved
Printed in Italy
ANNA SCANNAPIECO
Scrittoio, scena, torchio:per una mappa della produzione goldoniana
1. “Inquadrare” un corpus – 2. I difficili contorni dell’esistito – 3. Le traccelabirintiche dell’esistente: 3.1 Il filo iniziale della matassa; 3.2 Tessereall’infinito il “libro” della scena; 3.3 Trovare il bandolo? – 4. Per una map-pa della produzione goldoniana – 5. Prospetto sintetico delle edizioni gol-doniane.
Concepire un oggetto in modo chiaro e distinto significapensarlo separatamente, isolarlo, con la forza della mente,da tutto il resto. […] Quando l’oggetto si assenta da unacombinazione, vi lascia il profilo del suo vuoto come la tes-sera mancante in un mosaico. La conseguenza è che un og-getto sarà tanto più difficile da concepire quanto più grandesarà il numero di combinazioni in cui interviene1.
1. “Inquadrare” un corpus
Gli ascoltatori delle sue Commedie, e i leggitori delle medesime non possononon restare storditi da quella quantità d’invenzioni con cui ha saputo variare unainfinità di Soggetti, conservando in tutti un genio creatore lontano da qualunqueimitazione servile, e sempre intento all’utile e al dilettevole. Le sue opere tea-trali sono un arsenale di materiali comici tutti massiccj, che non ricevono no-cumento dal tempo, e fanno al confronto evidentemente conoscere la debolezzadegli altri. […] ad empire i teatri, a destar applausi, a chiamar repliche e repli-che con delle azioni semplici e famigliari […] ci vuole molto moltissimo: ed inquesto l’Autore è stato grande, originale, unico. […] Che dir non potrebbesisottoponendo ad una vista generale il quadro delle diverse tante sue azioni tea-trali, le quali resero sì gran profitto alle comiche compagnie, agli editori tipo-grafici delle medesime, e per le quali è scritto il suo nome ne’ volumidell’immortalità? L’impresa non è delle nostre forze: la rinunziamo ad ingegnipiù capaci della medesima2.
1 J. ORTEGA Y GASSET, Le due grandi metafore [1924], in Meditazioni del Chisciotte,Napoli, Guida, 1986, p. 348.
2 L’editore alli suoi leggitori benevoli, in La sposa persiana, L’Ircana in Julfa e l’Ircanain Hispaan. Commedie in versi del signor Carlo Goldoni avvocato veneziano fra gli Arcadi di
26 ANNA SCANNAPIECO
Così, sul limitare del secolo e con acutezza già retrospettiva, l’ultimo deitanti editori che avevano per cinquant’anni ricavato dalle opere di CarloGoldoni inesauribile alimento per i propri torchi, poteva sintetizzare i ter-mini della stupefacente – quanto storiograficamente problematica – produt-tività del «riformatore benemerito del Comico Italiano Teatro»3. Lo“stordimento” del lettore-spettatore settecentesco di fronte a quelli che an-cora nel secolo successivo sarebbero apparsi gli «erarii vastissimi del Gol-doniano repertorio»4 ha tratto poi dalle applicazioni critiche novecentescheulteriore motivo di approfondimento: ma, nonostante le fondamentali ini-ziative editoriali che perimetrano e innovano la prospettiva del lettore-spettatore novecentesco5, non sembrano essersi ancora espressi i termini di
Roma Polisseno Fegejo ec. ec. Raccolte per la prima volta in questo solo tomo, Venezia,Gian-Francesco Garbo, 1796, pp. II-III non numerate (il corsivo è mio).
3 Ivi, p. I. Nonostante quanto possa suggerire lo specifico di quest’ultima citazione, laprefazione del Garbo si distingue dalle tante altre che l’avevano preceduta per originalità ar-gomentativa, oltre che – come già accennato – per ampiezza prospettica (tale da sembrareanticipare alcuni dei modi con cui la riflessione ottocentesca – penso in particolare ad unCarlo Ritorni – si eserciterà attorno al motivo del “fenomeno” goldoniano). Si osservi adesempio come quest’ineludibile ricorso alla definizione di «riformatore» si esprima significa-tivamente in riferimento ad un nome che risulta «scritto […] ne’ volumi dell’immortalità» peraver recato con la sua opera «gran profitto» tanto alle «comiche compagnie» quanto agli«editori tipografici»: come venga cioè tratteggiata la fisionomia di un letterato che ha saputotradurre il proprio engagement riformistico in termini di mercato (sulla sintomatica specula-rità dei rapporti intrattenuti dal versante teatrale con quello editoriale e sulla loro spontaneacooperazione alla costruzione “anticlassica” del classicismo goldoniano, mi permetto di rin-viare a In viaggio con Todero per le scene dell’Italia ottocentesca. Appunti sulla nascita del(l’anti)classicismo goldoniano, in «Problemi di critica goldoniana» [d’ora in poi: «PCG»], V,1998, pp. 175-331 e a «…gli erarii vastissimi del Goldoniano repertorio». Per una storiadella fortuna goldoniana tra Sette e Ottocento, ivi, VI, 1999, pp. 143-238).Sull’edizione goldoniana del Garbo, cfr. infra, pp. 241-242; segnalo intanto che il volumedella trilogia di Ircana (da cui sono tratte le presenti citazioni) costituiva una pubblicazione asé stante, non prevedendo il piano dell’edizione l’accoglimento delle commedie che avevano«l’odierno discapito di essere scritte in versi Martelliani» (L’editore alli suoi leggitori bene-voli, cit., p. III).
4 «Annali del Teatro della città di Reggio. Anno 1825», Bologna, Nobili e comp., 1826,p. 42.
5 Mi riferisco naturalmente all’omnia allestita da Giuseppe Ortolani (C. GOLDONI, Tuttele opere, voll. XIV, Milano, Mondadori, 1935-1956, preceduta dalla versione maior edita dalMunicipio di Venezia – voll. 40, 1907-1960 – che era stata realizzata in collaborazione di C.Musatti ed E. Maddalena) e all’Edizione Nazionale delle Opere (Venezia, Marsilio), intrapre-sa – sotto la direzione di Sergio Romagnoli – in concomitanza (1993) con il bicentenariodella morte, forse in rapporto di calcolata simmetria con la precedente omnia novecentesca,inaugurata in quello della nascita (per una disamina delle principali caratteristiche storico-metodologiche di queste due edizioni, cfr. A. SCANNAPIECO, Carlo Goldoni, in Storia dellaletteratura italiana, dir. da E. Malato, vol. X, La tradizione dei testi, Roma, Salerno, in corso
Per una mappa della produzione goldoniana 27
«una vista generale» che sappia restituire «il quadro delle diverse tante sueazioni teatrali».
A inibire la definizione di un pertinente focus prospettico concorrononaturalmente la complessità e al tempo stesso, come vedremo, la lacunositàdella tradizione testuale, ma anche la reticenza della memoria autobiografi-ca (resa ancora più impenetrabile dal disegno variamente ellittico con cui sicompone il quadro documentario di riferimento). Non a caso, l’autore deiMémoires ritiene di dover chiarire al lettore che l’impegno autobiografico sigiustifica a partire dall’esigenza di tracciare la fisionomia di «qui a mis surla scene et sous la presse cent cinquante Comédies, soit en vers, soit en pro-se, tant de caractere que d’intrigue, et qui a vu, de son vivant, dix-huit édi-tions de son Théâtre»6. La lusingata quantificazione del proprio operatodrammaturgico non va, significativamente, disgiunta da quella della sua ri-sonanza editoriale7: ma, attraverso quell’implicita equazione tra commediecomposte e commedie pubblicate che il prologo dei Mémoires postula,Goldoni pare intento a rimuovere dalla sua e dell’altrui “memoria”
di stampa). È naturalmente la prima di queste due iniziative editoriali (da cui – salvo diversaavvertenza – si intenderanno desunte, con sola indicazione di volume e di pagina, tutte le ci-tazioni goldoniane) ad aver condizionato la lettura novecentesca del teatro goldoniano, essen-do l’Edizione Nazionale (d’ora in poi: EN) ancora in una fase inziale di realizzazione (sono26 le commedie a tutt’oggi [aprile 2000] pubblicate). Ciò nondimeno, come vedremo, deter-minante è riuscita nell’ultimo decennio l’incidenza di quest’ultima, anche per il fervore distudi che ne avevano (direttamente o meno) accompagnato la genesi e che ne stanno seguen-do gli sviluppi.
6 Mémoires, Préface (I 5).7 Che si esprime peraltro in un’indicazione numerica («dix-huit éditions») difficilmente
valutabile: all’altezza del 1787 (come si ricorderà, i Mémoires – redatti tra il 1783 e il 1786 –erano stati pubblicati nel gennaio 1787 a Parigi, presso Duchesne), si erano effettivamenterealizzate 18 edizioni del teatro goldoniano (cfr. infra la relativa sinossi, pp. 224-242), ma taliquantificabili a prescindere dal numero di ristampe che entro ciascuna di esse è possibile an-noverare – laddove Goldoni sembra spesso propenso a ritenere intercambiabili le definizionidi «ristampa» e di «edizione» (sicché le varie ristampe, ad esempio, che si ebbero della primaedizione, la Bettinelli, sono dall’autore di volta in volta qualificate tanto come «ristampe»quanto come «edizioni»: cfr. rispettivamente I 1020, XIV 462 e I 1019-1020, XIV 456). Nona caso, i conti non tornano rispetto al computo delle edizioni delle proprie opere che Goldoniebbe a fare all’atto della richiesta del privilegio per la Pasquali: nella supplica, datata 29 di-cembre 1760, si asseriva che «fra le edizioni di Venezia, e quelle Straniere se ne contano finoa quest’ora dodici varie Impressioni» (XIV 418-419), laddove, secondo i parametri impiegatiin precedenza, se ne potrebbero contare solo dieci (e difatti questo è il numero proposto nellaprefazione al t. I Pasquali: I 625; come se non bastasse, nei Mémoires, si dirà che l’edizionePasquali era stata preceduta da «quinze éditions sans mon aveu», I 5). Inoltre, nella lettera aZatta del 6 luglio 1788 (utilizzata dall’editore a mo’ di prefazione della propria pubblicazionegoldoniana, e riprodotta in XIV 398), l’autore indicava la nuova come la «ventesima edizionedelle sue Opere».
28 ANNA SCANNAPIECO
l’esistenza – non più tale, perché non supportata dalla codificazione edito-riale – di tutto ciò che, per quanto concretamente vissuto sur la scene, nonavesse ricevuto inveramento “ontologico” sous la presse. Per quanto arti-colata e composita infatti, la straordinaria diffusione editoriale che l’autoreseppe promuovere (o anche subire, ma non senza ragionevole compiaci-mento) della propria produzione teatrale è in realtà all’origine della fuor-viante identificazione del preservato con l’esistito. E non solo: alla stessaprodigiosa fortuna editoriale (come già argomentato in altre sedi, «Lecommedie del dottore Carlo Goldoni avvocato veneto» furono uno dei best-sellers del secolo)8 va senz’altro ricondotta anche quella problematicitàestrema che rende molto spesso inaccessibile ad un pertinente sguardo fi-lologico ed ermeneutico il profilo stesso di ciò che, pure, si è preservato.
In base alle risultanti di recenti indagini bibliografiche9 e a tutte le solle-citazioni critico-metodologiche emerse dagli ultimi sviluppi degli studi, si èvoluto in questa sede tracciare un censimento analitico del corpus comme-diografico goldoniano, mirato a enucleare, nella loro progressione cronolo-
8 Cfr. A. SCANNAPIECO, Giuseppe Bettinelli editore di Goldoni, in «PCG», I, 1994, pp.63-188 e Un editore goldoniano nella Napoli del secondo Settecento, ivi, IV, 1997, pp. 7-152.
9 Presso il Centro Interuniversitario di Studi Veneti di Venezia già a partire dai primis-simi anni novanta si è avviata, sotto la direzione di Giorgio Padoan e con il coordinamento dichi scrive, un’indagine sistematica mirata sia al censimento di quanto superstite delle pubbli-cazioni settecentesche del teatro goldoniano, sia alla realizzazione di una microfilmoteca chericostituisse un quadro ragionato e puntuale della tradizione testuale. L’obiettivo è statoquello (previa ricognizione di quanto ancora conservato presso il patrimonio bibliotecarioitaliano e dei principali centri esteri) di aggiornare la Bibliografia goldoniana di A. G.SPINELLI (Milano, Dumolard, 1884), che ancora oggi costituisce l’unico (e troppo spesso la-cunoso, o fuorviante) strumento disponibile al riguardo; nonché di realizzare una microfil-moteca che, restituendo in un vero e proprio unicum documentario la complessa e compositacostellazione della tradizione testuale, potesse fra l’altro garantire l’allestimento diun’edizione critica. L’iniziativa, pur essendo stata progettata e avviata indipendentementedalla pressoché contemporanea ideazione dell’Edizione Nazionale, ha non a caso finito perincidere in modi determinanti sulla realizzazione della stessa: si veda, a tacer d’altro, come leedizioni critiche di alcune commedie (Todero brontolon, a cura di G. Padoan o Il matrimonioper concorso, a cura di A. Fabiano; altrettanto clamorose saranno le risultanti ecdotiche neicasi della Scozzese o della trilogia di Zelinda e Lindoro) abbiano potuto mettere in luce lacomplessa (e, sinora, del tutto insospettata) stratigrafia compositiva delle opere in questione(e conseguentemente prodotto, a livello più generale, significativi guadagni interpretativi)proprio grazie al reperimento, e alla valutazione bibliografica, di testimoni della tradizionesinora affatto ignoti o inadeguatamente considerati. Anche alla luce di queste considerazioni,a partire dal gennaio 1999 il Comitato Scientifico ha ritenuto di dover attribuire a chi scriveuna mansione di consulenza filologica che consenta ai collaboratori dell’Edizione Nazionaledi essere costantemente informati e orientati rispetto all’evoluzione complessiva dell’indaginestorico-critica.
Per una mappa della produzione goldoniana 29
gica, le varie unità testuali che sembrano – allo stato attuale della ricostru-zione documentaria – aver composto l’insieme: a tal fine ricostruendo diognuna le coordinate relative a tempi di composizione e realizzazione sce-nica e per ognuna delineando in dettaglio lo specifico del rispettivo percor-so editoriale (ivi comprese la segnalazione dell’evoluzione testuale per leopere di cui si è appurata la multiredazionalità e l’esplicitazione – in un no-vero consistente di campionature – dei rapporti stemmatici). La mole delmateriale analitico e, in non pochi casi, l’estrema significatività di alcunedinamiche variantistiche e stemmatiche hanno consentito inoltre di delinea-re alcune prospettive interpretative che, se da un lato dovrebbero impegnaread un surplus di prudenza e pazienza ecdotica, dall’altro dovrebbero per-mettere anche un più agevole – quando non immediato – orientamento cri-tico. La ricognizione analitica non ha voluto però essere assorbitadall’individuazione e classificazione delle sole opere di cui è stata garantitala trasmissione testuale, lasciandosi “distrarre” dalla fuorviante identifica-zione dell’esistito col preservato, e si è pertanto impegnata anche nel tenta-tivo di recensire l’insieme “effettivo” delle opere composte dal «riformatorebenemerito del Comico Italiano Teatro», indipendentemente dalla loro fis-sazione e conservazione testuale (oltre che, talora, dalla loro stessa realizza-zione spettacolare): nella persuasione che «il quadro delle diverse tante sueazioni teatrali» potesse ricomporsi in approssimazione maggiore anche conil tratteggio di ciò che visibile più non è.
2. I difficili contorni dell’esistito
Nel sintetico – quanto certamente ponderato – autoritratto che l’autoredisegna nella prefazione dei Mémoires, la definizione del proprio operatodrammaturgico viene quantificata, come si ricorderà, in un insieme di «centcinquante Comédies». Allorché i termini dell’ammirazione stupefatta concui contemporanei e posteri avevano osservato i lineamenti del corpus gol-doniano hanno potuto essere ancorati all’osservazione di dati concreti – perla prima volta ricomposti in un quadro unitario grazie alla ricognizione sto-rico-critica e alla sistematica restituzione dell’omnia Ortolani – non si ètuttavia avuto modo di verificare una corrispondenza tra il censimento (arigore, indubitabile) operato dallo stesso autore e l’esistenza “effettiva”delle opere individuate dall’indagine filologica. Non a caso, l’unico studioche ha avuto l’ambizione di «fare una ricognizione sistematica dei titoli edel numero delle commedie» consegnati alla tradizione dalle cinque edizio-ni d’autore (Bettinelli, Paperini, Pitteri, Pasquali e Zatta), vagliandoli alla
30 ANNA SCANNAPIECO
luce appunto della loro classificazione novecentesca, ha potuto individuarein 117 il numero di opere che comporrebbero la produzione comica goldo-niana10. Nulla in teoria impedirebbe di risolvere la divaricazione attribuendoall’indicazione numerica fornita dall’autore il valore di cifra simbolica-mente riassuntiva (anche se l’ampiezza dei margini attraverso cui si esprimel’arrotondamento per eccesso dovrebbe insospettire): ma forse riesce criti-camente più produttivo interrogarsi sul significato che, propriamente,l’autore attribuiva al termine «comédie», nonché – conseguentemente – ve-rificarne la supposta rispondenza all’attuale impiego storico-critico.
Un primo proficuo (dis)orientamento potrebbe venire dall’analisi delledefinizioni con cui l’autore stesso venne siglando ciascuna delle operecomposte, messe in scena e riproposte al pubblico per via editoriale. Quelle
10 P. SPEZZANI, La stratificazione delle “centodiciassette” commedie del Goldoni neiprincipali “corpus” editoriali settecenteschi e in una appendice editoriale novecentesca, in«Lettere italiane», XLVII, 1995, pp. 263-270. Assumendo come indubitabile punto di parten-za l’assieme documentario e classificatorio garantito dall’edizione Ortolani (cfr. ivi, p. 263:«il Goldoni compose centodiciasette commedie come risulta dall’elenco allestito da GiuseppeOrtolani per l’edizione intitolata Tutte le opere di Carlo Goldoni»), il critico intende recensireil corpus strettamente commediografico (il computo è infatti effettuato sulla base degli indicidei primi otto volumi mondadoriani, contenenti appunto le «commedie») e verificarel’apporto delle singole edizioni d’autore alla costituzione dell’insieme. Recependo la classifi-cazione di «tragicommedie» che Ortolani riserva alle 18 opere raccolte nel vol. IX ed esclu-dendo dunque l’utilizzo delle stesse dal computo complessivo, non facendo riferimento ai«componimenti teatrali vari» raccolti nel vol. XII (non agli scenari – coerentemente con ilprincipio dell’indagine, che si esercita sui soli testi editi – ma nemmeno a «rappresentazioni»come La metempsicosi o Il disinganno in corte, che pure erano state incluse nell’ultima ini-ziativa editoriale, la Zatta), Spezzani giudica «parzialmente ibrido» ognuno dei corpus edito-riali d’autore perché accoglie anche «opere composte dal Goldoni che non appartengono allasua produzione comica» (p. 263): e adduce a riprova esemplificativa l’inclusione – rispetti-vamente nelle edizioni Paperini e Pitteri – di “tragicommedie” come Don Giovanni e Sposapersiana (ma si tratta di due opere che nessuna delle edizioni d’autore qualificava come“tragicommedie”, essendo invece sempre denominate «commedie in versi») o addirittura diun «melodramma giocoso» (p. 268) quale sarebbe a detta del critico La peruviana (edita nellaPitteri, sin dalla princeps e ancora nella Zatta definita «commedia di cinque atti in versi»).Nel calcolo complessivo degli apporti Paperini (21 commedie) rispetto a quelli (28) già do-vuti all’edizione Bettinelli, risulta appunto escluso il Don Giovanni; così in quello (34) dellaPitteri le sei “tragicommedie”-”melodrammi giocosi” Sposa persiana, Ircana in Julfa, Ircanain Ispaan, Peruviana, Bella selvaggia, Dalmatina (ma è solo quest’ultima nelle edizionid’autore ad essere costantemente definita «tragicommedia»). Con queste esclusioni, e conl’aggiunta delle due commedie francesi, assommando tutti i nuovi apporti “commediografici”delle cinque edizioni d’autore (oltre a quelli già segnalati, i 19 della Pasquali e i 13 della Zat-ta), il critico verifica la corrispondenza delle 117 “commedie” proposte nei primi otto volumidell’edizione Ortolani con quelle di cui ha identificato i rispettivi nuclei geneticinell’originaria definizione editoriale.
Per una mappa della produzione goldoniana 31
che avrebbero dovuto essere le sedi maggiormente deputate ad una classifi-cazione – appunto le cinque edizioni d’autore – offrono un quadro varia-mente difforme da quanto ci si potrebbe attendere: innanzitutto, potrà forsesorprendere che solo a partire dalla terza edizione, la Pitteri, è dato osserva-re l’emergere di un qualche interesse nella catalogazione delle opere pub-blicate11, interesse approfondito non senza discontinuità nella Pasquali e poidispiegato sistematicamente (ma in forme di dubbia autorialità) nella Zat-ta12; in secondo luogo, gioverà osservare che le denominazioni comunquetrasmesseci sono spesso sintomaticamente altre da quelle a cui ci ha abi-tuato la tradizione critica. Ad esempio, delle 18 opere che siamo soliti ac-comunare nella categoria delle “tragicommedie” (a ciò indotti dalla lorocollocazione in un medesimo volume, con questo titolo, praticata da Orto-lani), ben sei sono invece definite «commedie»13, e solo quattro quelle clas-
11 Nella Bettinelli e nella Paperini, infatti, ai titoli fa solo seguito la generica denomina-zione di «commedia» (con indicazione del relativo numero di progressione rispettoall’insieme complessivo della raccolta), salvo pochissime eccezioni (nella prima edizione, perLa putta onorata e La buona moglie, in cui alla canonica qualificazione di «commedia» siaggiunge la specificazione di «veneziana»; nella seconda, anche per il Moliere e La pupilla:cfr. infra, § 4, ni 60 e 106).
12 Per gli apporti “classificatori” di queste tre edizioni, si veda quanto documentato infra,§ 4. Per quanto riguarda la Zatta, è forse poco noto che l’editore, nel relativo manifesto pro-grammatico, così veniva giustificando il ritardo con cui – rispetto alle intenzioni – l’iniziativaveniva avviata: «La corrispondenza e stretta amicizia che abbiamo l’onore di goderecoll’illustre Autore, benché lontano, ci ha posti in istato d’esser forniti dal medesimo di tuttele produzioni della di lui celebre penna, che fino a questo giorno non sono state pubblicate néin Italia, né Oltremonti. Avressimo già data mano a questa impresa se ci fosse pervenuta daParigi la distribuzione per classi delle Comedie desiderata dall’Autore, non che parte delleComedie stesse corrette ed emendate da molti errori corsi nelle passate Edizioni. […]. Tutto ègià pronto dal canto nostro […], giacché di giorno in giorno si attendono dall’autore le pro-messe distribuzioni» (Agli Amatori del Teatro Italiano Antonio Zatta e figli, in «Notizie delMondo», n° 18, sabato 1. Marzo 1788, p. 146, corsivo nostro). A dar credito a queste affer-mazioni parrebbe indubitabile che la «distribuzione per classi» praticata dalla Zatta fosse statadi sicura paternità goldoniana (ma sulla difficile attendibilità delle argomentazionidell’editore, nonché sulla controversa genesi della pubblicazione goldoniana, cfr. infra, pp.79-84); ma forse non a caso, in un Avvertimento inserito nel t. XXXIV l’editore avrebbe di-versamente modulato le proprie espressioni al riguardo: «L’Ordine da noi stabilito di dividerein quattro classi l’Opera presente esser doveva immutabile, perché approvato [ma non defi-nito, voluto ecc.] ancora dall’immortale Riformatore dell’Italiano Teatro Dott. Carlo Goldo-ni» (Opere teatrali del sig. avvocato Carlo Goldoni veneziano, t. XXXIV, Venezia, Zatta, p.7, corsivo nostro). Merita infine ricordare – pur non avendo modo in questa sede di argo-mentarne diffusamente – che la disposizione classificatoria è, negli ultimi decenni del secolo,connotato ricorrente della produzione della tipografia Zatta.
13 Cfr. infra, § 4, ni 3, 4, 5, 77, 86, 96.
32 ANNA SCANNAPIECO
sificate come «tragicommedie»14; può inoltre capitare che l’atteso rigore de-finitorio si dissolva in formulazioni imbarazzanti del tipo «commedia, opiuttosto tragicommedia»15. Ma slittamenti ancora più “inquietanti” è datoosservare qualora l’analisi delle classificazioni formulate in ambito edito-riale si eserciti anche su quelle fornite dall’autore in altre sedi: al riguardoestremamente istruttivo è il caso degli Amori di Alessandro Magno, che sein una corrispondenza privata del 1759 era stata di volta in volta definita«commedia […] appoggiata all’Istoria […] in […] stile drammatico», «tra-gicommedia», «commedia, o sia tragicommedia»16, diventa poi una «tra-gédie en cinq actes en vers» nel catalogo apposto in calce ai Mémoires17,per vedere infine i propri contorni sfumare ancora una volta nella tardivaprinceps del 179318.
Per non rimanere sommersi tra tante fluttuazioni (sulla cui sintomaticitàla storiografia teatrale potrà peraltro proficuamente interrogarsi)19, gioveràprenderne atto per poi ancorare il nostro sguardo alla considerazione dellavalenza che, nella prospettiva dell’autore, poteva effettivamente assumere iltermine «commedia». Sarà a tal fine utile ricordare che, nella già citata let-tera al Vendramin dell’agosto 1759, Goldoni poteva illustrare l’articolatoprogetto delle Nove Muse (che avrebbe dovuto programmaticamente costi-tuire una summa dei generi teatrali, ambiziosamente fatti confluirenell’alveo di un’unica proposta spettacolare) attribuendo frequentemente unpo’ a tutte le forme drammaturgiche implicate la qualifica di «commedia»,nonché ricorrere ad espressioni del tipo «ogni Musa farà il prologo alla sua
14 Cfr. infra, § 4, ni 116, 124, 128, 143. Per alcune di queste opere (cfr. ad es. n. 124) al-tre fonti documentarie, sempre d’autore, attestano peraltro diverse denominazioni.
15 È il caso della Bella selvaggia (n° 113), e analoga oscillazione – misurabile perònell’ambito di contesti editoriali diversi – si riscontra per l’Ircana in Ispaan (n° 104). Circa ledenominazioni trasmesse per le altre opere sinora non espressamente menzionate (spesso ca-ratterizzate da una medesima instabilità classificatoria), cfr. infra, § 4, ni 1, 2, 6, 7, 126, 127.
16 Lettera a Francesco Vendramin del 21 agosto 1759, in XIV 221-226 (le citate defini-zioni ricorrono rispettivamente alle pp. 221-222, 222 e 224, 225). Si consideri che il destina-tario, proprietario del teatro di S. Luca alle cui dipendenze il poeta di compagnia Carlo Gol-doni esercitava la sua professione (e a cui, nello specifico, stava illustrando il progetto reper-toriale relativo alle recite dell’anno comico 1759-60) avrebbe ben presupposto l’impiego diun lessico specifico.
17 I 618 (si tratta per l’esattezza della sezione del Catalogue intitolata Autre pieces deThéâtre de M. Goldoni dont il n’est pas question dans ses Mémoires).
18 Edita nel t. XXXI della Zatta, veniva qui definita «tragicommedia di cinque atti in ver-si».
19 Anche in considerazione di questo spessore documentario, si è ritenuto opportuno, nelcensimento della produzione goldoniana, registrare per ciascuna delle opere l’insieme più si-gnificativo delle denominazioni che ne accompagnarono l’esistenza (cfr. infra, pp. 129-130).
Per una mappa della produzione goldoniana 33
commedia […] Per la consumazione di questa idea vogliono esser novecommedie»20. Sempre nella stessa direzione ci conduce l’osservazionedell’habitus classificatorio in un’altra testimonianza, di ancora più distintasignificatività, trattandosi di scrittura pubblica e costitutivamente impegnatanell’utilizzo di un lessico “specialistico”: in una lettera indirizzata al redat-tore della «Gazzetta Veneta», Gasparo Gozzi, che da competente criticoteatrale aveva in precedenza recensito la rappresentazione dello Zoroastro,Goldoni poteva riconoscere che «la fine della commedia non fosse stata de-bitamente sviluppata», pur continuando a ricondurre l’opera nella categoriadella «tragicommedia»21. Alla luce di questi – e altri possibili – riscontriparrebbe insomma evidente che, nella riflessione teorica goldoniana (am-piamente influenzata dalla pratica compositiva dell’uomo di teatro), il ter-mine «commedia» acquisti la valenza di una categoria onnicomprensiva,pur rivestendo al contempo un’accezione di più distinta individuazionedrammaturgica (e pronta anche ad ulteriori specializzazioni): svolgendo lastessa funzione inclusiva che il concetto-termine di «azione teatrale» di-spiegò nel corso del secolo, dalla riflessione storico-teorica del gesuitaFrancesco Saverio Quadrio22 all’impiego comune con cui poteva essere as-sunta nelle prefazioni di un modesto editore di fine secolo come Gian-Francesco Garbo23.
Il dato è di per sé interessante, e potrebbe indurci alla non trascurabileconsiderazione che il “riformatore” per eccellenza del teatro comico italia-no si sottrae, sotto il profilo della esplicitazione teorica, a quell’impellenzaprescrittiva che è pur sempre tra gli elementi fondamentali dell’intenso di-battito riformistico che si accende attorno alle sorti del teatro tragico e co-mico: un’intensità che, come è stato di recente felicemente sintetizzato, siconfigura in modi direttamente proporzionali alla sua estraneità alla realtà eall’esperienza della scena24. E forse potrebbe spingerci a ipotizzare che lo
20 XIV 223 (il corsivo è mio).21 XV 235. La recensione del Gozzi a «Il Zoroastro Re de’ Battriani tragicommedia in
versi martelliani del sig. dottor Carlo Goldoni» apparve sulla «Gazzetta Veneta» del 26 no-vembre 1760, n° LXXXV; nel numero successivo (29 novembre) fu pubblicata la risposta diGoldoni (cfr. G. GOZZI, La “Gazzetta Veneta”, a cura di A. Zardo, Firenze, Sansoni, 1915,pp. 360-361 e 367-368).
22 F. S. QUADRIO, Della storia, e della ragione di ogni poesia, vol. III, Dove le cose allaDrammatica pertinenti sono comprese, Milano, Francesco Agnelli, 1743 (si veda in particola-re il par. IV dell’Introduzione, Dividonsi le Teatrali Rappresentazioni nelle loro spezie).
23 Cfr. supra, p. 25 e n. 2.24 Cfr. S. FERRONE-T. MEGALE, Il teatro, in Storia della letteratura italiana, cit., vol.
VI, Il Settecento, p. 821.
34 ANNA SCANNAPIECO
«Scrittor di Commedie»25 Carlo Goldoni ha potuto essere un riformatoreproprio perché situato al di fuori di quel «rapporto oppositivo statico», in-capace di mediare tra elaborazione teorica e prassi spettacolare, che i lette-rati riformatori settecenteschi ebbero a intrattenere con il teatro, esprimendouna generale incapacità di proporre modelli scenici consoni sia alle capacitàtecniche che alle esigenze economiche dei comici26: in tale prospettiva, an-che l’impiego così peculiare e indistinto del termine «commedia» (riflessolinguistico di una pratica di scena, e non certamente di una speculazioneprecettistica) documenta la particolarissima fisionomia di uno scrittore cheproprio da una condizione di “emarginazione” rispetto all’establishmentdella cultura riformistica ha potuto trarre un ruolo di assoluta centralità in-novativa per l’istituzione teatrale.
Ma, tornando allo specifico di nostro interesse, potremmo concludereche, ragionando di produzione goldoniana, si è tenuti ad ascrivere ad unamedesima categoria “commediografica” una pluralità di generi (commediein prosa e in versi, tragedia, tragicommedia, tragedia di lieto fine, operascenica ecc.) che solo interpretazioni critiche a posteriori possono percepirecome tali, ma che erano avvertite dall’autore – un “Riformatore” ben im-merso nella realtà spettacolare del tempo – come accomunate da una mede-sima cifra repertoriale. Per Carlo Goldoni (come, verosimilmente, per tuttol’universus spettacolare contemporaneo), «commedia» è termine estensivo– sorta di equivalente nostrano del francese pièce – che ingloba, distintiva-mente rispetto al teatro per musica, tutte le produzioni atte a costituire unrepertorio attorico. Ed è precisamente guidati dal riconoscimento di questaspecifica accezione che si può procedere ad una più congrua individuazionedel novero complessivo delle opere che compongono il corpus goldoniano,nonché situare in più pertinente prospettiva di analisi quell’indicazione di«cent cinquante Comédies» con cui i Mémoires consegnavano alla storio-grafia avvenire la quantificazione dell’operato drammaturgico di chi «qui avisé à la réforme du Théâtre de son pays».
Includendo dunque nella produzione “commediografica” anche testi nonpropriamente congrui ad un codice comico stricto sensu (merita comunque
25 Della «sua professione di Scrittor di Commedie» Goldoni parla nella celebre prefazio-ne Bettinelli (I 763): su tutte le implicazioni storico-critiche della pregnante espressione, cfr.I. MATTOZZI, Carlo Goldoni e la professione di scrittore, in «Studi e problemi di critica te-stuale», 4, 1972, pp. 95-153 e C. DE MICHELIS, Carlo Goldoni e la «professione di Scrittor diCommedie», in Letterati e lettori nel Settecento veneziano, Firenze, Olschki, 1979, pp. 155-201.
26 G. GUCCINI, Introduzione, in Il teatro italiano del Settecento, a cura di G. Guccini,Bologna, Il Mulino, 1988, p. 11.
Per una mappa della produzione goldoniana 35
sin d’ora precisare che l’incidenza di questo tipo di opere nell’insiemecomplessivo del corpus è decisamente marginale)27 nonché il consistente(quanto sfuggente)28 assieme delle cosiddette “commedie a soggetto”, recu-perando ai “difficili contorni dell’esistito” opere di cui si è in tempi recentio nell’ambito stesso di quest’indagine rinvenuta traccia documentaria29, di-stinguendo (con tutte le cautele del caso) in quel complesso metamorfismodel plot drammaturgico che – assieme alla tensione rielaborativa – pare co-stituire il carattere più saliente della produzione goldoniana le unità testualia cui si potesse riconoscere specifica autonomia30, si è pervenuti all’indivi-duazione di 200 opere. Ancora una volta, dunque, rispetto alle indicazionidell’autore i conti non tornerebbero: la divaricazione non è certo da adde-bitare a difetto di controllo memoriale (caratterizzazione congrua solo aquel cliché – della cui inconsistenza ci hanno ormai definitivamente persua-si gli sviluppi critici più recenti – di un buon papà Goldoni umile e cordia-le, sorridente e noncurante sinanche nel computo delle proprie opere); ed èin realtà divaricazione apparente, o per meglio dire coerentissima conquell’equazione tra commedie composte e commedie pubblicate di cui siera già in precedenza osservata la tendenziosità. I dati infatti tornano a col-limare proprio allorché si consideri come delle 200 opere che formano laricostruita mappa del teatro goldoniano, ben 50 non conobbero espressioneeditoriale: e dunque, agli occhi dell’autore rimasero di fatto confinate nellimbo di un’esistenza meramente virtuale – di una non-esistenza nella realtàstorica della trasmissione testuale.
Questa letterale morte (su cui scarsa incidenza davvero, alla resa deiconti, può aver avuto il particolare – certo imbarazzante, e deprecabilissimo
27 Rappresentano infatti solo il 9% dell’insieme, con l’avvertenza che si tratta della ri-sultante di un calcolo per eccesso, essendo le classificazioni di ben 5 delle 18 opere che pos-sono essere fatte rientrare in questa difficile zona di confluenza – perimetrata per via distinti-va rispetto alla produzione commediografica “propriamente” detta – soggette a sintomaticheoscillazioni (cfr. infra, § 4, ni 1, 2, *3, *5, 6, 7, 14, 35, *104, *113, 116, *124, 126, 127, 128,143, 199, 200: i numeri segnalati con asterisco rappresentano appunto opere per cui è attestatavarietà definitoria del tipo “commedia/tragicommedia”, o anche “opera scenica/tragedia/com-media”).
28 Sulla varia problematicità comportata dall’individuazione degli scenari effettivamentecomposti – in particolar modo, ma non solo, nel periodo francese – cfr. infra, pp. 119-125.
29 Cfr. ad esempio infra, § 4, i ni 14 e 110 (per il n° 14, cfr. A. SCANNAPIECO, Alla ricer-ca di un Goldoni perduto: Osmano re di Tunisi, in «Quaderni veneti», 20, 1994, pp. 9-56).
30 Per i criteri adottati nella definizione delle singole unità testuali, cfr. infra, § 4, pp.125-126.
36 ANNA SCANNAPIECO
– della mancata sopravvivenza degli autografi)31 fu, non di rado, addirittura“annunciata” dalla mancata realizzazione scenica dei testi32; in moltissimialtri casi, lo svanire – repentino e irrevocabile – dagli orizzonti della memo-ria storica non risulta contrastato nemmeno dall’apporto (variamente legit-timo e/o frammentario) di una tradizione indiretta, di cui pure oggi è datoindividuare nuove tessere33. L’emarginazione colpisce indifferentemente
31 La circostanza infatti ha indubbiamente condizionato in maniera insormontabile lapossibilità di un recupero dell’identità delle opere in questione, ma con ogni evidenza nonpuò essere additata a causa primaria della loro sparizione.
32 Sono per l’esattezza 11 le opere (il 5,5% dell’insieme) di cui risulta documentata lamancata rappresentazione: quasi tutte appartenenti al periodo parigino, si tratta di commedietanto “a soggetto” (cfr. infra, § 4, i ni 175, 176, 177, 178) quanto “distese” (ni 41, 156, 157;impossibile, allo stadio attuale della ricostruzione documentaria, definire la natura delle opereindicate ai ni 162, 187, 188, 189).Va peraltro segnalato che la realizzazione scenica di un testo non sembra, almeno in lineateorica, aver costituito presupposto per quella editoriale: si veda il caso della Pupilla, «com-media in cinque atti in versi sdruccioli», composta «ad imitazione de’ nostri antichi Poeti co-mici» (VI 518), ideata per il completamento dell’edizione Paperini e nella consapevolezzadella sua costitutiva inadattabilità alla scena contemporanea (ma forse non a caso, a pochimesi dalla pubblicazione, l’autore volle utilizzare la nuova opera in un adattamento a soggettoper le recite private di Bagnoli: cfr. XIII 345). D’altro canto, il mancato riscontro spettacolaredi un’opera poteva comportare la sua esclusione anche dalla trasmissione editoriale (oltre chedi quella scenica), quasi a ratificare la morte – effettiva e simbolica al tempo stesso – di tuttociò che non “convenisse” all’interesse della memoria autobiografica e storiografica. «Cettepièce […] n’ayant pas eu de succès n’a point été imprimée», si legge in una nota apposta al-l’intitolazione dell’Avare fausteux: l’opera venne effettivamente esclusa dalla trasmissioneeditoriale, ed è stata suscettibile di riproposizione a stampa (ma solo nella prima omnia nove-centesca) grazie alla preservazione del testo in un manoscritto, non autografo, conservatopresso la biblioteca della Comédie Française (segnatura: ms. 290. Sulle problematiche filolo-giche di questa commedia, cfr. P. LUCIANI, «Le Bourru bienfaisant» e «L’Avare fastueux»dal «manuscrit» alla stampa, in Il filo della ragione. Studi e testimonianze per Sergio Roma-gnoli, a cura di E. Ghidetti e R. Turchi, Venezia, Marsilio 1999, pp. 209-224). Sulla comples-sa questione dei rapporti scena-stampa cfr. infra, pp. 44-64.
33 Tra le opere non pubblicate solo in due casi è stata garantita la trasmissione testuale(rimasta tuttavia silente per quasi due secoli, essendo i relativi testimoni – non autografi –unici, e recuperati solo in ambito novecentesco): la versione in prosa del Cavaliere di spirito(n° 191: il manoscritto fu rinvenuto nell’archivio queriniano da Manlio DAZZI e pubblicato in«Paragone», VIII, 96, 1957, pp. 3-70) e l’Avare fastueux (n° 197: conservata manoscrittapresso l’archivio della Comédie française, l’opera venne pubblicata per la prima volta nel1923, nell’ambito dell’omnia edita per cura del Municipio di Venezia). Sempre legata a te-stimoni unici, in trascrizione non autografa, la preservazione di tre scenari del periodo france-se (cfr. ni 170, 173, 193): rinvenuti alla fine dell’Ottocento da Pietro TOLDO (che ne diedeampia descrizione in un contributo dal titolo Tre commedie francesi inedite di Carlo Goldoni,in «Giornale storico della letteratura italiana», XXIX, 1897, pp. 377-391) e pubblicati per laprima volta nell’edizione maggiore dell’omnia Ortolani (vol. XXXIII, 1934) possono esseretuttavia, in due casi, ritenuti di dubbia paternità goldoniana (cfr. infra, pp. 122-124 e n. 212).
Per una mappa della produzione goldoniana 37
tutte le possibili tipologie testuali (e relativamente ad opere realizzate in va-rie fasi dell’itinerario artistico goldoniano)34; tra di esse tuttavia quella piùfrequentemente rappresentata è costituita dalle commedie cosiddette a sog-getto35. La circostanza potrebbe, di primo acchito, apparire prevedibile sinoall’ovvietà, dato il carattere costituivamente estemporaneo e transeuntedell’improvvisazione attorica36, in alcun modo suscettibile – pena la perditad’identità “testuale” – di trascrizione. Ma tale in effetti non è, qualora sipensi, in primo luogo, che da una pratica di registrazione editoriale anchedelle commedie a soggetto non rifuggirono i principali comprimari dellascena settecentesca (Chiari e Gozzi)37; in secondo luogo, laddove si consi-deri che – contrariamente a quanto possano suggerirci consolidate abitudinistorico-critiche – la pubblicazione degli scenari avrebbe potuto costituiremotivo di agevole (e, a suo modo, decisamente lusinghiera) affermazione
In altri 14 casi, invece, tutti per lo più scenari, disponiamo solo di “estratti”, o “argomenti”, osuccinte sinossi: cfr. ni 14, *21, 23, *24, *25, *27, *83, 158, 160, 161, 164, 166, 167, *192 (leopere segnalate con asterisco sono quelle il cui relativo materiale documentario viene in que-sta sede reso noto per la prima volta).Di tutt’altro genere – e, come vedremo, di estremo interesse filologico ed ermeneutico – siconfigura il caso di una tradizione indiretta che ha salvaguardato redazioni testuali originariee difformi da quelle poi elaborate dall’autore in sede di definizione editoriale.
34 Tra le opere non pubblicate figurano infatti anche tragicommedie (n° 14), “tragedie”(n° 35) e commedie (ni 33, 41, 110, 156, 157, 191, 197; per i ni 162, 187, 188, 189, cfr. su-pra, n. 32). Sulle ragioni che inibirono ad alcune di queste opere la possibilità di una diffu-sione editoriale, cfr. A. SCANNAPIECO, Alla ricerca di un Goldoni perduto..., cit., e «Io nonsoglio scrivere per le stampe…»: genesi e prima configurazione della prassi editoriale gol-doniana, in «Quaderni veneti», 20, 1994, pp. 119-186.
35 Sono 37 le opere che possono essere sicuramente ricondotte a questa – peraltro pro-blematica – tipologia, e costituiscono il 74% delle opere non pubblicate: cfr. ni 12, 13, 18, 23,24, 25, 26, 27, 42, 43, 44, 83, 91, 92, 93, 150, 151, 152, 153, 155, 163, 166, 168, 169, 170,171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 185, 186, 192, 193, 194. Per un’opportuna problematizza-zione della definizione di «commedie a soggetto», cfr. L. RICCÒ, Goldoni, Chiari e Gozzi frascritto e non scritto, in «PCG», VI, 1999, pp. 7-67 (il suddetto studio è stato di recente rac-colto, insieme ad altri di seguito citati, in L. RICCÒ, «Parrebbe un romanzo». Polemiche edi-toriali e linguaggi teatrali ai tempi di Goldoni, Chiari, Gozzi, Roma, Bulzoni, 2000).
36 Fatte beninteso salve le ineccepibili puntualizzazioni che sul controverso concetto diimprovviso (da non appiattirsi su un’aprioristica quanto infondata antitesi a quelli di preme-ditato e letterario) si devono a F. TAVIANI – M. SCHINO, Il segreto della Commediadell’Arte. La memoria delle compagnie italiane del XVI, XVII e XVIII secolo, Firenze, La Ca-sa Usher, 19923, pp. 309-329.
37 Cfr. L. RICCÒ, Goldoni, Chiari e Gozzi…, cit., in particolare pp. 38-64. Anche Goldo-ni non mancò, con Il buon compatriotto e Il genio buono e genio cattivo, di restituire edito-rialmente opere dalla composita natura di testi parte a soggetto e parte distesi, ma in modioccasionali, estremamente tardivi (le due commedie furono stampate solo con l’edizioneZatta, rispettivamente nel 1790 e nel 1793) e, forse, di dubbia autorialità.
38 ANNA SCANNAPIECO
per il Goldoni impegnato nell’estenuante “cimento” parigino. Si ricordi in-fatti come il giudizio dell’avanguardia intellettuale francese poteva espri-mersi al riguardo:
C’est dommage que, dans ses [di Goldoni] pièces imprimées, les discours, pourêtre trop vrais, soient presque toujours plats. Ce défaut ne se fait pas sentir dansses canevas, où les discours sont abandonnés à la vivacité et au génie desacteurs qui improvisent; aussi ses pièces font-elles un grand plaisir au théâtre. Ilaurait bien mieux fait pour sa réputation de n’en faire imprimer que les cane-vas; on y aurait mieux remarqué les ressources de génie infinies dont elles sontremplies38.
Nell’osservazione della “resistenza” goldoniana a tale tipo di pratiche edito-riali (e, a monte, di identità artistica) potremmo certo ricavare ulteriore mo-tivo di riflessione per valutare, da un lato, la coerente e difficile battagliasostenuta contro chi avrebbe voluto, tatticamente, ridurlo al rango di «far-ceur»39, dall’altro ricavare una conferma della tenacia con cui l’autore seppeperseguire un disegno propagandistico già distintamente tracciato all’attodel suo “esordio” editoriale40.
Ma soprattutto avremmo modo di articolare ulteriormente la prospettivadi analisi entro cui situare la valutazione di quel consistente novero di“soggetti” che venne dall’autore “disteso” in testo compiutamente scritto. Sitratta di un insieme non trascurabile (circa 1/4 delle 49 opere in cui sembraessersi concretata la produzione goldoniana del settore); l’operazione riela-
38 Correspondance littéraire, philosophique et critique par Grimm, Diderot, Raynal,Meister, etc., par M. Tourneux, vol. VI, Paris, Garnier Frères, 1878, p. 9. (il corsivo è mio. Lacitazione è tratta da una recensione, del giugno 1764, a La dupe vengée). Per quanto costituti-vamente inabile a condizionare l’opinione pubblica (periodico manoscritto e segreto – e non acaso rimasto inedito fino al secolo successivo –, la Correspondance era redatta per aggiornarele principali corti d’Europa sulle novità culturali francesi), l’opera comunque riflette una pro-spettiva critica – particolarmente prestigiosa – che avrà di certo conosciuto altre forme dipubblica diffusione. Il giudizio del citato articolo aveva peraltro avuto una complementareanticipazione in quello, negativo, che la Correspondance aveva formulato recensendo (giu-gno 1763) la pubblicazione di uno scenario “disteso” in commedia (il celebre Servitore, nellatraduzione francese edita da Dessain junior nel 1763, per cui cfr. anche infra, p. 50): «on atraduit de l’italien une comédie du célèbre Goldoni, intitulée le Valet à deux maîtres. Cettepièce est un chef-d’oeuvre d’intrique, et fort amusant au théâtre; mais elle doit bien perdre àla lecture, et sourtout dans une traduction» (ivi, vol. V, p. 319)
39 Sugli effetti drammaturgici ed editoriali della polemica Goldoni-Diderot, mi permettodi rinviare a quanto argomentato nell’Introduzione e nella Nota sulla fortuna de Il padre difamiglia (EN, 1996, pp. 9-52, 681-704).
40 Cfr. A. SCANNAPIECO, «Io non soglio scrivere per le stampe…»..., cit.
Per una mappa della produzione goldoniana 39
borativa si svolse per lo più in spazi temporali cospicuamente distanti daquelli in cui se ne erano prodotte composizione e prima rappresentazione eriguardò tanto testi appartenenti alla fase d’esordio – “preriformata” –quanto a quella conclusiva della parabola artistica goldoniana, allorché lamaturità drammaturgica dell’autore dovette confrontarsi nuovamente con lapratica del canevas. In entrambi i casi, tuttavia, e sia pure per ragioni e inmodi diversi, la preservazione dei testi originari – lungi dall’esserne garan-tita – è irrimediabilmente vanificata proprio da quella trasposizione edito-riale che pure avrebbe voluto/dovuto fissarne l’identità e la memoria. Nelcaso delle cinque opere41 che, composte tra il 1738 e il 1745, Goldoni venneripescando, tra il 1753 e il 1757, pungolato dall’esigenza – squisitamenteeteronoma – di adempiere precisi obblighi editoriali42, l’autore stesso volle
41 Cfr. infra, §4, ni 8 e 9, 10 e 11, 15 e 16, 19 e 20, 21 e 22.42 Non mi pare che sia mai stata sufficientemente meditata la circostanza che vede ben
quattro di queste commedie – la cosiddetta «trilogia di Momolo» (> Uomo di mondo, Prodi-go, Bancarotta) e il Tonin Bellagrazia (> Frappatore) – recuperate con faticoso fastidio («an-ziché impiegar tanto tempo nel riformare queste tali Commedie, e nello scriverle intieramentedi nuovo, le avrei gettate nel fuoco», L’autore a chi legge de L’uomo di mondo, in I 782),solo per concludere un’iniziativa editoriale – la fiorentina Paperini – che aveva sofferto diconsiderevolissimi rallentamenti, e per il cui compimento l’autore non aveva inteso “spreca-re” opere ben più significative (e recenti), in quanto già destinate alla nuova impresa edito-riale che, in quello stesso 1757, stava avviando a Venezia per i tipi di Francesco Pitteri (anchein questo caso, d’altronde, è Goldoni stesso a renderne edotto il lettore, con maliziosa since-rità e disinvolta capacità promozionale: «Dirà taluno: Perché non darci di quelle che haiscritte nel corso di ben tre anni, e che sappiamo non essere delle tue peggiori? Perché nondarci la Sposa persiana, il Filosofo inglese […] e tante altre, che sappiamo ascendere al nu-mero di ventiquattro almeno? Signori miei, queste sono riserbate pel mio nuovo Teatro Co-mico, che uscirà a momenti dai torchi del Sig. Francesco Pitteri in Venezia: saranno due To-mi l’anno, e chi vorrà provvedersene, le averà dappertutto da’ buoni corrispondenti del Li-braio suddetto», ibidem). Peraltro, nulla esclude che, almeno nel caso del repêchage dellatrilogia di Momolo, le sollecitazioni contingenti trovassero ulteriore alimento in più intimeragioni di natura artistica: al riguardo si vedano le acute osservazioni di Piermario Vescovo inP. VESCOVO – M. G. MIGGIANI, Sulle recite teatrali a Bagnoli, in «PCG», I, 1994, pp. 10-23.Diverso, ma al tempo stesso analogo, il caso del recupero del Servitore di due padroni: ilfortunatissimo «Scenario disteso» (secondo la definizione che l’autore ne offre nella prefa-zione alla princeps, II 8), è ripescato già nella fase d’avvio dell’edizione fiorentina (vennedifatti proposto ai lettori nel t. III della Paperini, pubblicato nell’autunno del 1753), comeavrebbe dovuto esserlo, nel t. V (edito nei primissimi mesi del 1754), un altro celebre scena-rio – composto, sempre per il Sacchi, nel 1746 –, Il figlio di Truffaldino perduto e ritrovato (epoi soppiantato, per stringenti ragioni apologetiche, da una redazione opportunamente riela-borata dell’Uomo prudente: cfr. EN, a cura P. Vescovo, 1995, p. 52 e n). Che tuttavia, anchein questo caso, non si tratti di una rivisitazione libera da istanze meramente pragmatiche, èdato appurarlo riflettendo sulla sua contiguità – in una prospettiva di pianificazione editoriale– con la riproposizione a stampa, nel t. VII (estate 1754), di opere come il Don Giovanni Te-
40 ANNA SCANNAPIECO
esplicitamente e articolatamente smentire qualsivoglia principio testimo-niale dei testi restituiti a stampa rispetto alle opere originarie. La profonditàdella rielaborazione è non solo ripetutamente esibita, ma viene anche addi-tata a riprova di una precisa volontà di “espiazione” rispetto a pratiche discrittura che si è inteso deliberatamente rimuovere dalla memoria collettiva:
Questa Commedia, […] fatta nei giorni del mal costume, avea bisogno piùd’ogni altra di correzione. […] Quanto son contento d’averla ridotta com’è, al-trettanto mi pento di averla fatta com’era, e già che ho la consolazione in pre-sente di veder le opere mie dalle oneste e religiose persone approvate, così desi-dero che tutto il mondo si scordi delle primiere mie leggierezze, e ne domandosinceramente il perdono43.
norio (composto e rappresentato nella lontana stagione del carnevale 1735-36) e dell’Impo-store (composto invece a Modena nella vicinissima primavera del 1754, per le rappresenta-zioni di un collegio dei Gesuiti): ciò che accomuna infatti tutte queste opere è il loro non averfatto parte del repertorio della compagnia Medebach, attiva al Sant’Angelo, presso cuil’autore aveva lavorato sino alla vigilia della nuova iniziativa editoriale. All’atto dell’allesti-mento della nuova edizione fiorentina – ideata, com’è noto, a seguito della rottura con Me-debach e in agguerrita concorrenza con la precedente edizione veneziana (quella Bettinelliche ora diventava pericoloso appannaggio dell’antico capocomico) –, Goldoni si trova strettoda una duplice difficoltà: da un lato non può attingere materiale per la stampa dal noverodelle composizioni che viene realizzando per la nuova compagnia del San Luca presso cui èingaggiato (un articolo del contratto sottoscritto con il Vendramin prevedeva infatti espres-samente che l’autore potesse stampare le produzioni realizzate per la compagnia solo tre annidopo la loro prima rappresentazione veneziana: cfr. D. MANTOVANI, Carlo Goldoni e il tea-tro di San Luca a Venezia. Carteggio inedito (1755-1765), Milano, Treves, 1885 [rist. ana-statica con introduzione di N. Mangini, Venezia, Marsilio, 1979], p. 25), dall’altro – per at-trezzare la propria edizione con sufficienti requisiti di concorrenzialità rispetto all’ormai an-tagonista Bettinelli (in cui Medebach si accinge a riversare proprio la produzione goldonianadel Sant’Angelo) – è costretto a esibire opere che, in quanto realizzate per altri referenti spet-tacolari, non potevano essere in possesso di Medebach e dunque confluire nell’edizione vene-ziana (si riconsideri d’altronde quello che lo stesso autore ricordava nella prefazione Paperinial Servitore: «Servati finalmente, Lettor mio, esser questa Commedia una di quelle sei che hopromesso oltre le quarantaquattro esibite dal Bettinelli», II 9). Sulla controversia che opposel’autore a Bettinelli e Medebach, cfr. I. MATTOZZI, Carlo Goldoni e la professione di scritto-re, cit.; A. SCANNAPIECO, Giuseppe Bettinelli editore di Goldoni, cit. e Ancora a proposito diGiuseppe Bettinelli editore di Goldoni, in «PCG», II, 1995, pp. 281-292.
43 L’autore a chi legge de Il prodigo, in I 861-862. Come si accennava, diffuse e ripetutesono le dichiarazioni dell’autore rispetto alla qualità e all’intenzione della riscrittura operata pertutte queste commedie (si vedano gli spazi paratestuali – prefazioni e spesso anche dediche – deL’uomo di mondo in I 778 e 782-783; de Il prodigo, ivi, 858-859 e 861-862; de La bancarotta,ivi, 944; de Il frappatore, II 96). Diverso solo il caso del Servitore di due padroni, nella cui pre-fazione la presa di distanza rispetto all’originale scenico è umilmente modulata in termini di“semplice” integrazione scritta, ai fini di una più idonea conduzione registica all’atto di even-tuali riprese spettacolari del testo (cfr. II 8-9; sul valore dell’operazione di riscrittura dello scena-
Per una mappa della produzione goldoniana 41
Ancora più fuorviante e impraticabile il tentativo di distinguere, e siapure in filigrana, l’originaria fisionomia dei testi nel caso dell’altro gruppodi scenari trasformati in commedie distese: le sette «comédies à canevas»44
che il Goldoni parigino utilizzò come materiale drammaturgico nella realiz-zazione di altrettanti testi “compiuti” per il veneziano teatro di San Luca,come previsto da una ridefinizione degli accordi contrattuali subentrata nelmaggio del 1763 (a integrazione e rettifica della precedente scrittura delmarzo 1762) con il proprietario di quel teatro, Francesco Vendramin45. Adifferenza di quanto accaduto nel caso del repêchage delle commedie asoggetto degli esordi, la scrittura distesa dei testi ha ora una genesi spetta-colare, fra l’altro cronologicamente contigua a quella che aveva prodotto lacomposizione e la realizzazione scenica dei canovacci parigini; la “registra-zione” editoriale, invece, subentrerà solo un quarto di secolo dopo46. Nono-stante la prossimità temporale dell’operazione di riscrittura, e l’identità delcontesto fruitivo (scena, e non libro) per cui essa viene concepita, l’opacitàdei testi originari resta impenetrabile: e non tanto perché degli scenari pari-
rio, si vedano le belle osservazioni di L. RICCÒ, Goldoni, Chiari, Gozzi…, cit., pp. 34-35; suirifacimenti della “trilogia di Momolo” cfr. G. FOLENA, Itinerario dialettale goldoniano [1969],in L’italiano in Europa. Esperienze linguistiche del Settecento, Torino, Einaudi, 1983, pp. 163-166; G. PADOAN, L’esordio di Goldoni: la conquista della moralità, in «Lettere italiane»,XXXV, l983, pp. 29-60, part. 32-48; P. VESCOVO, Appunti di filologia goldoniana, in «Year-book of Italian Studies», 11, 1995, pp. 163-182, in part. pp. 169-172).
44 Per lo più «en trois Actes»: è la definizione fornita dal catalogo cronologico delle pro-prie opere che l’autore appose in calce ai Mémoires, peraltro non sempre collimante conquella fornita da altre fonti documentarie (come desumibile dalla documentazione allegatainfra, § 4).
45 La ridefinizione, proposta dall’autore al proprietario del teatro veneziano per cui con-tinuava a lavorare e da questi accettata sia pure obtorto collo, prevedeva fra l’altro che Gol-doni si avvalesse di qualcuna delle commedie realizzate a Parigi «servendosi però soltantodell’argomento e della condotta, scrivendola a posta» su misura della compagnia veneziana«e dell’uso del nostro paese» (lettera a Francesco Vendramin del 2 maggio 1763, in XIV 283;si veda anche la reazione del Vendramin, consegnata in una lettera a Giovanni Fontana, se-gretario dell’ambasciata veneziana a Parigi, del 19 maggio 1763 in D. MANTOVANI, CarloGoldoni e il teatro di San Luca a Venezia, cit., pp. 173-179).
46 Le opere in questione sono registrate infra, ai ni 154 e 183, 158 e 179, 160 e 180, 161e 181, 164 e 165, 167 e 182, 175 e 190. Come si avrà modo di osservare raffrontando le datedelle rappresentazioni (parigina e veneziana) e quelle delle rispettive principes, mentre tra ledefinizioni testuali destinate alla scena parigina e a quella veneziana intercorse mediamenteun anno, la realizzazione editoriale si effettuò invece ben 25 anni dopo (unica eccezione Gliamanti timidi, pubblicati a distanza di “soli” 15 anni). Merita peraltro segnalare sin d’ora che,delle commedie registrate ai ni 179-181 (la celebre trilogia di Zelinda e Lindoro < trilogia diArlecchino e Camilla) un’edizione “pirata” del 1787 ha preservato redazioni presumibilmentepiù vicine all’originaria configurazione scenica e comunque difformi da quelle poi fatte per-venire da Goldoni all’editore Zatta.
42 ANNA SCANNAPIECO
gini è rimasta solo (quando pure è rimasta) traccia documentaria sintetica e,naturalmente, allografa47, quanto perché la ridefinizione redazionale elabo-rata per il teatro veneziano si espresse, consapevolmente e sin dall’origi-naria fase ideativa, in termini di consistenti trasmutazioni testuali48. Inoltre,anche di queste – cioè delle “distese” e rinnovate vesti con cui gli scenariparigini approdarono sulle scene veneziane –, è presumibilmente dato sape-re ben poco (forse nulla più che il resoconto del proprio travaglio rielabora-tivo consegnato da Goldoni alla corrispondenza con Stefano Sciugliaga, cu-ratore dei suoi interessi presso il teatro Vendramin)49, visto che la forma anoi pervenuta è quella affidata ad un’ulteriore trasposizione, quella appuntoeditoriale, definita – come si accennava – a considerevolissima distanza ditempo. Che questo ulteriore passaggio abbia inciso nuovamente, e in pro-fondità, sulla fisionomia delle opere, è dato non tanto congetturarlo in basead un’astratta – quanto abbastanza ovvia e condivisibilissima – ipotesi dicarattere teorico-metodologico, quanto in forza della diretta e inequivoca-bile testimonianza che, almeno nel caso di una di queste commedie, lo stes-
47 Completamente inaccessibili sono a tutt’oggi rimasti L’eventail e Le bon et le mauvaisgénie (quest’ultima fra l’altro «non représentée», come ci ricordano i Mémoires III, 11 in I488); delle altre è conservato soltanto o un particolareggiato resoconto (ma non certo una tra-scrizione degli scenari: ni 158, 160 e 161) o un semplice riassunto (ni 164 e 167), tutti ripro-dotti in VIII 1311-1315, 1318-1322, 1325-1331, 1334-1335 e 1345-1346. Potrà tuttavia esse-re di un qualche interesse ricordare che, nel caso della trilogia di Arlecchino e Camilla,l’autore dell’opera a cui dobbiamo la sintetica ma dettagliata preservazione documentaria (J.-A. JULIEN DESBOULMIERS, Histoire anecdotique et raisonnée du théâtre italien depuis sonrétablissement en France, jusqu’à l’année 1769, Paris, Lacombe, 1769, t. VII, pp. 5-44 [Ge-nève, Slatkine reprints, 1968, t. II, pp. 283-293]), pur ammettendo e rammaricandosi di esser-si – per ragioni di opportunità editoriale – «vu contraint à réduire les grandes beautés de cestrois Comédies» (ivi, p. 44), aveva molto probabilmente elaborato la propria compilazionesulla base di materiale autografo ricevuto da Camilla Veronese su autorizzazione dello stessoGoldoni (è quanto desumibile da una lettera di Charle-Simon Favart a Camilla Veronese con-servata presso gli Archivi dell’Opéra di Parigi e pubblicata in A. FABIANO, Alcune riflessionisui rapporti tra la famiglia Favart e Carlo Goldoni, in Tra libro e scena. Carlo Goldoni, acura di C. Alberti e G. Herry, Venezia, Il Cardo, 1996, p. 55).
48 Cfr. supra, n. 45.49 Nella lettera del 17 gennaio 1764 (XIV 309-311) l’autore viene ad esempio illustrando
tutte le difficoltà traspositive dovute al riflesso che l’attribuzione dei ruoli al San Luca avreb-be avuto – stanti le consuete etichette di compagnia – sulla ridefinizione dello statuto sociale(ma evidentemente non solo) dei personaggi protagonisti. Sulle conseguenze drammaturgichedel trapasso degli scenari parigini nelle commedie realizzate per la scena veneziana, cfr. J.JOLY, Le desir et l’utopie. Études sur le théâtre d’Alfieri et de Goldoni, Faculté des Lettres etSciences humaines de l’Université de Clermont-Ferrand II, n. s., fasc. 4, 1978, pp. 217-228;F. FIDO, Da Venezia all’Europa. Prospettive sull’ultimo Goldoni, Roma, Bulzoni, 1984, pp.100-112.
Per una mappa della produzione goldoniana 43
so autore ci ha lasciato:
Venendomi domandate a Venezia delle Commedie, e convenuto che ne avreimandate di quelle fatte a Parigi, scritte però intieramente, ed accomodate all’usodi que’ Teatri, questa [Le portrait d’Arlequin> Gli amanti timidi] è una delle seiche ho mandate quell’anno [anno comico 1764-65]. L’ho scritta, e l’ho allun-gata. Può essere ch’io abbia mal fatto. Non so se, per colpa mia, o colpa d’altri,la Commedia in Venezia non ha riuscito. Temendo che l’allungamento l’abbiapregiudicata, l’ho ridotta ora a maggior brevità, più breve ancora di quel ch’iol’aveva fatta la prima volta a Parigi; ma quanto basta per renderla finita, con-dotta, e nel suo genere completa50.
«Alcuni continuano ancor oggi a ripetere che nel teatro in fondo ciò chepiù conta sono i testi. Non è vero: questi sono ciò che più rimane»51:l’autorevole asserzione – storicamente e metodologicamente salutare – pur-troppo spesso non soccorre nel caso del teatro goldoniano, in cui la capacitàdi resistenza e di durata propria del testo – rispetto alla sua realizzazionescenica – è stata contrastata proprio dall’autore, non di rado dedito ad uncalcolato gioco di occultamento e di rimozione dei diversi percorsi attraver-so cui si espresse il proprio tragitto artistico.
3. Le tracce labirintiche dell’esistente
La dispersione – o l’impenetrabile fisionomia – dell’esistito, se acquisitaalla consapevolezza storiografica ed ermeneutica, giova comunque adun’illuminazione più pertinente di ciò che resta. I vuoti, o gli ingannevolitratteggi di tessere per sempre scomparse dal quadro, se recuperati ai con-torni di ciò che è superstite, concorrono alla costituzione di una profonditàprospettica in cui più distintamente può collocarsi e definirsi la “verità” diciò che, essendo rimasto nella storia, tutta la varia accidentalità della storiavorrebbe sopraffare. Le amputazioni e gli sfiguramenti con cui il corpusgoldoniano ha voluto/dovuto disegnarsi al nostro sguardo, se non rimossi esublimati in un artificioso gioco di armonie prestabilite, contornano – pro-
50 L’autore a chi legge de Gli amanti timidi o sia L’imbroglio de’ due ritratti (1780), inVIII 677. Delle sette commedie derivate da scenari parigini, questa è l’unica (essendo statapubblicata già nell’edizione Pasquali) la cui proposizione a stampa risulta arricchita della pre-fazione d’autore (mentre la princeps delle altre fu consegnata alla tarda e conclusiva Zatta, incui – com’è noto – scompaiono tutti gli spazi paratestuali).
51 F. TAVIANI, Uomini di scena, uomini di libro. Introduzione alla letteratura teatraleitaliana del Novecento, Bologna, Il Mulino, 1995, p. 24.
44 ANNA SCANNAPIECO
prio con tutta l’indistinguibilità e l’opacità che è loro propria – le disiectamembra galleggiate alla superficie dell’immagine.
In un rinnovato gioco di chiaroscuri, la mole di ciò che è rimasto (le«cent cinquante Comédies»…) dispiega ai nostri occhi la sua difficile im-ponenza. Ciò che ha costretto la filologia goldoniana in condizioni di seriostallo (inibendone, sino a non molto tempo fa, la stessa esistenza) non ètanto la mancata preservazione di manoscritti autografi52: quanto la compo-sita mappa editoriale settecentesca cui è rimasta affidata la problematicaidentità testuale del teatro goldoniano. Perscrutare la genesi e la molteplicefenomenologia con cui l’attraversamento editoriale delle opere ne ha fon-dato, per sedimentazioni successive, la tradizione, può forse consentire direnderne trasparente (o almeno, meno impermeabile) l’opacità.
3.1 Il filo iniziale della matassa Un dato su cui vale la pena di riflettereè che lo «Scrittor di Commedie», il poeta stipendiato di compagnia CarloGoldoni – sin dall’inizio e poi per tutto il prosieguo della sua attività pro-fessionale – volle essere anche, e al tempo stesso, un “editor di commedie”.La trasmissione a stampa della propria opera, insomma, non intese avere unvalore consuntivo o rammemorativo per una produzione che si era resa al-trimenti comunicativa e pubblica; ma – come vedremo – volle piuttostomodularsi secondo un percorso parallelo a quello della scena, accompa-gnandone in progress le espressioni e gli sviluppi, amplificandone o rettifi-candone gli esiti, in una sorta di complementare e dialettico sostegno. Al dilà di tutte le resistenze che la nostra “scaltrezza” teorica potrebbe opporre,osservando la ricchissima vicenda editoriale del nostro autore e i modi pro-pri attraverso cui si condusse la sua esperienza artistica, dovremmo ar-renderci alla constatazione che il pubblico del teatro goldoniano fu, al tem-po stesso, un pubblico di spettatori e di lettori. Lo ricordava l’autore stesso,all’atto di chiedere «al Serenissimo Principe di Venezia» il privilegio per laquarta edizione delle proprie opere («ebbi la fortuna di vedere le mie produ-zioni compatite e aggradite sul Teatro non solo, ma colle stampe ancora»)53,ma l’aveva già intuito – a processo non ancora avviato – la perspicacia im-prenditoriale dei suoi primi editori:
52 Tanto più inquietante proprio in considerazione della prodigiosa imponenza del corpuscon cui è tenuta a confrontarsi: come se non bastasse, l’ironia della sorte ha voluto chel’unico autografo superstite (conservato presso la Biblioteca di Casa Goldoni, Venezia) fossequello di un’opera (il Giustino, «tragicommedia» degli esordi al San Samuele) assolutamenteirrilevante sia dal punto di vista artistico che storico-culturale.
53 La supplica, datata 29 dicembre 1760, si legge in XIV 418-419.
Per una mappa della produzione goldoniana 45
la mia principalissima mira si è di avvantaggiare il mio negozio con l’unicomezzo, che mi somministra la Provvidenza, delle mie stampe. Quindi veggendoapplaudirsi universalmente da ogni genere di persone alle Commedie del Sig.Dottor Carlo Goldoni [...] mi sono indotto a credere certamente che quell’istessocolpo che hanno fatto in me, e conobbi ancora aver fatto negli altri le rappre-sentazioni delle medesime [commedie], produr potrebbe anche la semplice let-tura di esse54;
L’Universale aggradimento, ed applauso con cui, anche replicatamente, da no-stri Teatri [bolognesi] sono state ascoltate le Commedie del celebre Sig. Avvo-cato Carlo Goldoni ha eccitato il comune desiderio di leggerle. […]. Finchéavete avuto il vantaggio di vederle rappresentar dal Teatro, si è differita la pub-blicazione delle medesime; in oggi che siete in breve per restarne privi, abbiamorisoluto di continuarvi, per quanto è in nostro potere, il piacere goduto col nonpiù oltre differirla55.
Coltivando con strategica e agguerrita simultaneità un pubblico di lettoridentro il pubblico degli spettatori, e viceversa, lo “scrittore-editore” dicommedie avvia un processo che, se da un lato porta la sua opera diventatalibro a costituire uno dei casi editoriali più clamorosi del secolo, dall’altro –e al tempo stesso – consente alle proposte spettacolari dei suoi testi di ac-creditarne l’autore come il «Molière italiano»56. Lungi dall’esperire i termi-ni di un rapporto oppositivo (la conturbante diade Scena-Libro, Teatro-Letteratura, che avrebbe connotato – nel senso di un progressivo affranca-mento dal primo termine – il progredire editoriale della sua opera)57, Gol-
54 Lo stampatore a’ lettori, in Le commedie del dottore Carlo Goldoni avvocato venetofra gli arcadi Polisseno Fegejo, t. I, Venezia, Giuseppe Bettinelli, 1750, p. V.
55 Li stampatori a cortesi lettori, in Le commedie del signor avvocato Carlo Goldoni ve-neziano fra gli arcadi Polisseno Fegejo, t. I, Bologna, Per Girolamo Corciolani, ed ErediColli, a S. Tommaso d’Aquino, 1752, pp. VI-VII.
56 La fortunata espressione fu non a caso lanciata dal primo editore goldoniano, Giusep-pe Bettinelli, allorché – inaugurando una ristampa pirata della pubblicazione che l’autoreaveva nel frattempo intrapreso a Firenze – veniva parlando appunto di Goldoni come «di unsoggetto che si è reso cotanto rinomato in questo genere di composizioni Comiche, e che sipuò chiamare il Moliere italiano» (Giuseppe Bettinelli Librajo a chi legge, in Le Commediedel Dottore Carlo Goldoni Avvocato Veneziano fra gli Arcadi Polisseno Fegejo. Quinta Edi-zione Veneta sull’esemplare della fiorentina, t. I, Venezia, Bettinelli, 1753. Su questa“quinta” edizione Bettinelli, cfr. A. SCANNAPIECO, Giuseppe Bettinelli editore di Goldoni,cit., pp. 84-101; sul mito – consapevolmente perseguito dallo stesso autore – di un Goldoni«erede di Molière», cfr. G. PADOAN, L’erede di Molière, in «Quaderni veneti», 20, 1994, pp.57-96).
57 I principali interventi che hanno concorso alla costituzione di questa prospettiva criticasi devono a Bartolo ANGLANI (Ideologia della riforma, messa in scena, spazio teatrale, in
46 ANNA SCANNAPIECO
doni costruisce con tenacia e coerenza i modi – davvero inediti – di una re-lazione cooperativa e dinamica. Dallo scrittoio alla scena al torchio l’operaprecisa i suoi connotati alimentandosi di tutti i suggerimenti contestuali cheil suo articolato iter raccoglie, e disponendosi a movimenti di proficua cir-colarità: giacché l’ultima fase comporta una riattivazione della prima, edentrambe si saldano in un vario potenziamento della seconda (all’atto dellasua (ri)definizione editoriale, l’opera ritorna sullo scrittoio, memore delproprio attraversamento scenico).
Nel vario esperire editoriale di Carlo Goldoni, la stampa sembra aver as-sunto il compito precipuo di accompagnare e sostenere – dispiegandone ointegrandone gli esiti – la vita spettacolare delle opere. Certo, si potrebberoa ragion veduta annoverare altre, concomitanti, funzioni che l’autore divolta in volta sembrò assegnare all’“inveramento” tipografico di una produ-zione scenica: come quella di un appello al pubblico di lettori-spettatori,convocati a misurare il reale valore di un’opera, a prescindere dall’inet-titudine esecutiva dei comici che ne pregiudicarono l’esito spettacolare58; o
L’interpretazione goldoniana. Critica e messa in scena, a cura di N. Borsellino, Roma, Offi-cina, 1982, pp. 79-98; Goldoni: il mercato, la scena, l’utopia, Napoli, Liguori, 1983, pp. 39-78) e a Marzia PIERI (Introduzione e Nota al testo in Il teatro italiano, vol. IV, C. GOLDONI,Teatro, t. I, Torino, Einaudi, 1991, pp. VII-L, part. XLVII-L; Il tormento del testo: le comme-die in tripla redazione, in Goldoni in Toscana, Atti del Convegno (Montecatini Terme, 9-10ottobre1992), in «Studi italiani», V, 1-2, 1993, pp. 107-129).
58 È un motivo che ricorre non di rado nella riflessione goldoniana, dall’Erede fortunata(n° 30) all’Avaro fastoso (n° 198). Per quanto riguarda la prima, si veda la prefazione Betti-nelli alla commedia (1752, in XIV 453-454), da leggere complementarmente al relativo reso-conto dei Mémoires (I 265); per quanto riguarda la seconda, sarà utile ricordare che nella ver-sione italiana dello sfortunatissimo originale francese era introdotta ex novo una sequenzaestremamente significativa: «CONTE […] Avete presentato ai comici la vostra commedia?GIACINTO Sì, signore. CONTE L’avranno ricevuta con applauso, con acclamazione, ne sonsicuro. GIACINTO Al contrario, signore. L’hanno rifiutata solennemente. CONTE L’hanno ri-fiutata? GIACINTO Voi conoscete la mia commedia: meritava ella un simile trattamento?CONTE Ma… se la commedia è buona, perché rifiutarla? Il loro interesse dovrebbe anzi obbli-garli a riceverla, a ringraziarvi. GIACINTO Non la conoscono: non la comprendono. Ma mivendicherò della loro ingiustizia. La farò stampare, ed il pubblico la giudicherà. CONTE Bra-vo, così va fatto. Fatela stampare: per la rappresentazione non ne ho molta pratica, ma mi pa-re ottima alla lettura. Voi ne avrete un esito prodigioso» (VIII 1204; il corsivo è mio. Sullospecifico autobiografico che è all’origine del risentito inserto, cfr. P. LUCIANI, «Le Bourrubienfaisant» e «L’Avare fastueux...», cit., p. 213). Il motivo peraltro non va drammatizzato eassolutizzato, ma piuttosto ricondotto a fasi di particolare esacerbazione nei rapporti con icomici (esemplare il caso dell’Avaro fastoso, ma anche quello dell’Erede). Sull’incompetenzadegli attori a giudicare dell’effetiva potenzialità scenica di un testo, si veda il caso – antiteticoe complementare all’Avare – della Dupe de soi même, come raccontato nei Mémoires III, 37(l’autore – si racconta – fidandosi del giudizio degli attori , che dovrebbero conoscere megliodi lui le aspettative del pubblico parigino, e pur nutrendo forti perplessità sulla pertinenza
Per una mappa della produzione goldoniana 47
quella, decisamente contigua, di una salvaguardia dell’intenzione autoriale(di cui peraltro si giudica necessaria la restituzione proprio in vista dellasussistenza scenica del testo)59. Ma si tratta – a ben vedere – di declinazioniinterne a quello stesso interesse “strategico” che assegna alla stampa ilruolo di dialettico e complementare sostegno al cimento scenico. Credo diaver già illustrato altrove le ragioni della significativa coincidenza che videl’autore impegnarsi (1750) nella prima realizzazione editoriale delle sueopere comiche proprio all’indomani della sottoscrizione del contratto (10marzo 1749) che avrebbe definitivamente legato il proprio destino profes-sionale all’attività di «Scrittor di Commedie»60; quello che giova in questasede sottolineare è che l’“interesse strategico” di cui si diceva – pur doven-do necessariamente fare i conti con le molteplici spinte eteronome che ope-ravano nella realizzazione concreta dei vari progetti editoriali61 – si dispiega
dell’adattamento, acconsente alla loro volontà di mettere in scena l’opera: l’esito – come da“copione” – è catastrofico).
59 Al riguardo, si veda l’importantissima prefazione Paperini alla Moglie saggia (IV1142-1143), dove l’autore ingaggia una serrata polemica con il correttore dell’ormai antago-nista edizione Bettinelli, reo di aver “disteso” «tre […] Scene abbozzate, perché lasciate dame le Maschere in libertà di farle a loro piacere». Anche le realizzazioni attoriali – argomentaGoldoni – devono essere vagliate dal filtro giudicante e compositivo dell’autore per poteressere messe a frutto in sede di definizione editoriale (e, prima ancora, di compiuta – distesa –realizzazione drammaturgica); le tre scene in questione – inutili e quindi nocive nel loro statogrezzo («le Scene, o non s’hanno da fare, se sono inutili, o hanno da contribuire all’intreccio,quando si fanno, o all’intenzion dell’Autore») o suscettibili, quando non dirette dall’integra-zione registica del poeta di compagnia, di realizzazioni maldestre – possono essere «rese di-lettevoli» e anche «fatte credere necessarie» solo allorché l’autore si impegna a distenderle:chi non sa «più che tanto» (e cioè ignora intenzioni autoriali, abilità e caratteristiche interpre-tative degli esecutori, contenuti e modalità attraverso cui si esprimeva la funzione registicadell’autore) non può avventurarsi a scrivere e a stampare delle scene abbozzate. Sullo stessomotivo della salguardia dell’intenzione autoriale, cfr. anche la prefazione alla Castalda, cit.infra, n. 85.
60 Cfr. «Io non soglio scrivere per le stampe…»..., cit.61 La selezione dei testi da pubblicare e l’architettura che governa il loro assemblaggio
nei singoli volumi delle varie edizioni poté infatti in più occasioni sottostare a condiziona-menti esterni: per quanto riguarda esemplificazioni relative alla Bettinelli, cfr. A. SCAN-NAPIECO, Giuseppe Bettinelli, cit., p. 174 e n, ed EAD., Commento a C. GOLDONI, Il padre difamiglia, cit., pp. 284-285 (più in generale, sulla significatività delle opzioni combinatorieosservabili nei primi tre volumi di questa edizione, cfr. L. RICCÒ, Goldoni fra memoria e fi-lologia, in «Paragone», XLI, 5, 1990, pp. 74-77); per quanto riguarda la Paperini, e la casua-lità e l’occasionalità dei repêchages di testi antichi e/o compromessi con le pratiche dellascrittura “à canevas”, cfr. quanto segnalato supra, n. 42 (a riprova dell’aleatorietà della “pre-servazione” testuale e della necessità di non sovradeterminare l’interpretazione delle inten-zioni autoriali). Per quanto riguarda la Pitteri e la Pasquali, non credo sia mai stato osservatoche grandissima incidenza nella definizione dei rispettivi piani editoriali ebbero non solo e
48 ANNA SCANNAPIECO
per tutto l’arco dell’itinerario artistico del nostro autore.La testimonianza che può, in questo senso, ritenersi più esemplare è for-
se garantita dall’anomala pubblicazione – alla spicciolata, e in vista dellarappresentazione – della commedia con cui Goldoni inaugurava il suo tourromano del 1758-59 (La vedova spiritosa, trasposta in prosa, assieme adaltre commedie originariamente in versi, proprio in funzione del nuovocontesto spettacolare)62. Nel dedicare la commedia a Giacinta Orsini –esponente di una tra le famiglie non solo più potenti della città, ma anchepiù distinte nell’ambito del mecenatismo romano del secolo63 – l’autorepoteva significativamente affermare:
Sono parecchi anni, che in questa illustre eccelsa Metropoli dell’Universo ven-gono le mie Commedie rappresentate, e sono state sempre, per mia fortuna, be-nignamente sofferte. Ora vi sono io in persona a dirigerle nel gran Teatro diTordinona; e so, che la mia venuta ha impresso nell’animo di qualcheduno, chel’esito delle Comiche mie rappresentazioni in quest’anno abbia a sorpassar digran lunga il fortunato incontro delle passate. Questa buona oppinione che mo-strasi aver di me, mi pone nella maggiore angustia del mondo. So quanto sianopericolose queste magnifiche prevenzioni […]. Nel dedicare adunque all’E. V.
non tanto le restrizioni previste dal contratto con il Vendramin (cfr. supra, n. 42), ma anche esoprattutto la necessità di rendere ogni nuova edizione compatibile con i diritti che a ciascunadelle precedenti venivano dalla loro natura “privilegiata”. Il privilegio infatti tutelava gli edi-tori garantendo l’esclusività – ventennale per Bettinelli, decennale per Pitteri – della pubbli-cazione: sicché nella Pitteri, come poi nella Pasquali, Goldoni fu tenuto ad evitarel’inclusione dei testi già editi in precedenza (non tenendo conto di questo vincolo contestuale,della struttura delle due edizioni si sono potute fornire o interpretazioni discutibili in quantosovraccaricano di senso le supposte intenzioni autoriali o, viceversa, descrizioni che si limita-no a prendere atto – senza interrogarsi sui possibili motivi genetici – della varia composizionedei volumi: cfr. rispettivamente, per la Pitteri, M. PIERI, Introduzione, cit., pp. XXXII-XXXIII e Nota ai testi, in C. GOLDONI, La sposa persiana. Ircana in Julfa. Ircana in Ispaan,EN, 1996, pp. 108-111; per la Pasquali, L. ROSSETTO, Tra Venezia e l’Europa. Per un profilodell’edizione goldoniana del Pasquali, in «PCG», II, 1995, pp. 101-131, in part. pp. 114-118). Sull’impegnata “architettura” della Zatta, e sulla sua dubbia autorialità, cfr. quanto os-servato supra, n. 12.
62 Cfr. infra, § 4, ni 108 e 123. Non sfuggirà la curiosa circostanza che vede edita perprima (1759) la nuova versione (mentre l’originaria redazione in versi, andata in scenanell’autunno del 1757, sarà pubblicata solo nel 1761): il dato può costituire utile motivo diriflessione, perché documenta come l’autore – se libero da specifici vincoli contrattuali (comelo era nei confronti degli impresari romani) – era pronto ad avvalersi della stampa in terminidi stretto e immediato supporto agli allestimenti spettacolari. Sugli adattamenti romani dicommedie originariamente in versi, cfr. A. SCANNAPIECO, Un editore goldoniano..., cit., pp.63-64 e n. 166).
63 Cfr. M. PAOLI, L’autore e l’editoria italiana del Settecento. Parte terza (I): i mecena-ti, in «Rara volumina», II, 1997, pp. 29-134, in part. pp. 39-59.
Per una mappa della produzione goldoniana 49
questa Commedia mia, che prima delle altre in quest’anno, sotto la mia dire-zione in questa gran Città si produce, intendo non solamente all’altissima pro-tezione di Lei raccomandarla […], ma l’amore Paterno in verso di questa poveramia Figliuola mi sprona ad interessare il credito di una Principessa sì grande, sìdotta, ed in sì alto modo dal Pubblico rispettata64.
E nel rivolgersi al lettore, poteva ulteriormente argomentare:
Io ho sempre temuto il Publico, ma non mai tanto, quanto nella congiontura pre-sente. I motivi del mio timore gli ho espressi nell’antecedente Epistola Dedica-toria, e dopo di essermi raccomandato ad una sì gran Protettrice, mi raccomandoaltresì a questo Pubblico istesso, che mi ha in distanza con tanta generositàcompatito, e da vicino sin’ora con tanto amor consolato. […] L’averla io ridotta[«quest’Opera»] dal verso alla prosa potrebbe per avventura recarle qualche di-scapito, ma penso poi, che ho fatto lo stesso del mio Festino, e in Roma pure fucompatito. […] Insomma, quanto ho scritto fin’ora spiega bastantemente ch’iotemo, e questo è un segno del mio rispetto verso una Città ripiena di uomini in-signi, di uomini letterati, che sono capaci di decidere, e di giudicare, ma cheavranno altresì, come io spero, disposto l’animo a compatire65.
Il caso della stampa romana della Vedova spiritosa è, pur nella sua ecce-zionalità, distesamente eloquente; ma gli esempi, al riguardo, si potrebberomoltiplicare, passando dalla significatività estrema dell’Amore paterno, ilcui allestimento editoriale si esprime – molto al di fuori dell’ordinaria pras-si – in termini di stretta contemporaneità alle prime parigina e veneziana66,
64 La vedova spiritosa. Commedia del signor avvocato Carlo Goldoni veneziano fra gliArcadi Polisseno Fegejo dedicata a Sua Eccellenza la Signora D. Giacinta Orsini Boncom-pagni Ludovisi Duchessa d’Arce, Roma, Fausto Amidei, 1759, pp. 3-5 (il corsivo è mio).
65 L’autore a chi legge, ivi, pp. 9-10 (il corsivo è mio).66 Cfr. n° 149. La commedia andò in scena il 4 febbraio 1763 a Parigi e, nella stessa sta-
gione del carnevale, al S. Luca di Venezia (cfr. A. SCANNAPIECO, «…gli erarii vastissimi delGoldoniano repertorio»..., cit., p. 167); il t. V Pasquali, che propose la princeps dell’opera, fupubblicato tra il giugno e il luglio del 1763 (cfr. XIV 287 e 291), ma il materiale era statoconsegnato all’editore ben prima, giacché la dedica al Tiepolo è datata 14 febbraio 1763 (erastata cioè redatta appena dieci giorni dopo la prima parigina). L’edizione Pasquali ripropone-va anche, in traduzione, quel carteggio Goldoni-Meslé che aveva accompagnato, con sapienteintento apologetico, la pubblicazione a Parigi dell’Extrait de l’Amour paternel (di recente,peraltro, non è mancato chi ha ipotizzato, a proposito di Meslé, la natura di «interlocutore-traduttore “virtuale”», a ulteriore riprova della natura di «operazione promozionale» che a-vrebbe contraddistinto tanto la pubblicazione dell’Extrait quanto quella della commedia nel-l’edizione Pasquali: cfr. A. FABIANO, L’amore paterno ovvero la poetica messa in commedia.Per una nuova lettura del primo lavoro parigino del Goldoni, in «PCG», V, 1998, pp. 131-174, in part. pp. 170-174).
50 ANNA SCANNAPIECO
non mancando di rimettersi genialmente alla protezione di Gian DomenicoErmolao Tiepolo, singolare anello di congiunzione delle due capitali nellasua qualità di ambasciatore della Serenissima in Francia; a quello, ancorapiù sorprendente (e, credo, non noto) di un Arlequin valet de deux maîtresproposto al pubblico degli spettatori-lettori francesi a immediato ridossodella prima con cui a Parigi era stato presentato il riadattamento dell’anticoe celebre scenario67. Nel respiro deliberatamente internazionale con cui sindall’inizio si definisce68, lo stesso progetto Pasquali – che per l’autore com-portò massicci investimenti, economici («grandiosi esborsi») e culturali,nonché il funambolico aggiramento di cospicue barriere legislative69 – sigenerò in sintomatica concomitanza con quello che, sul versante della sce-na, avrebbe dovuto definitivamente consacrare l’autore come «l’erede diMolière»70: e non è forse un caso che la “misteriosa” interruzione della
67 Cfr. infra, § 4, n° 151. Che la traduzione francese del Servitore di due padroni (Am-sterdam et Paris, Dessain junior, 1763) fosse stata – non casualmente – pubblicata in conco-mitanza della prima parigina (4 marzo 1763), è attestato dall’altezza cronologica (giugno1763) in cui Grimm poté stilare la sua (al solito, astiosa) recensione della suddetta edizione(cfr. supra, n. 38).
68 Nella richiesta del privilegio, l’autore si impegnava a «rendere una tale edizione tantocolta e magnfica, quanto esser possano le migliori edizioni forastiere» (XIV 419) e nel mani-festo programmatico esplicitamente prefigurava i connotati, europei, del destinatario («si de-sidera un’Edizione che sia comoda ancora per gli stranieri», XIV 472; ulteriori riferimenti apotenziali lettori «Oltramontani» anche nella prefazione al t. I: cfr. I 626).
69 L’edizione infatti veniva a ledere i diritti privilegiati della Pitteri (che fra l’altro, nel1760, era ancora a metà della sua realizzazione: cfr. infra, § 5) e fu resa possibile dalle vere eproprie torsioni argomentative dell’autore (cfr. ad esempio XIV 472-473), nonché – soprat-tutto – dalle cospicue aderenze politiche di cui Goldoni, ancora una volta, dovette avvalersi:non a caso, l’eccezionalità del suo prodursi a fronte di una normativa altrimenti ineludibile,finì per costituire un precedente legislativo cui poterono appellarsi stampatori dei decennisuccessivi (cfr. quanto segnalato in A. SCANNAPIECO, Giuseppe Bettinelli..., cit., pp. 186-188).
70 Cfr. supra, n. 56. Sul respiro “europeo” della Pasquali si intrattiene, programmatica-mente sin dal titolo, il citato contributo della Rossetto (cfr. supra, n. 61), che tuttavia trascuraquella relazione genetica tra l’esperienza parigina e la nuova iniziativa editoriale che qui si ètentato di evidenziare. Il significato culturale dell’iniziativa Pasquali, il suo volersi situare inconcorrenza con le prestigiose edizioni parigine di Metastasio e – guarda caso – Molière, èstato invece ben individuato da R. TURCHI, Nota al testo, in C. GOLDONI, La bottega delcaffè, EN, 1994, p. 37 e n. 21 (cui si può aggiungere la preziosa testimonianza della «Nuovaveneta gazzetta », che nel marzo 1762, recensendo la pubblicazione del t. II Pasquali, potevaricordare ai lettori che «di questa Edizione si può con giustizia dire, che se la Italia non hameno a gloriarsi di avere un Goldoni, di quello che si vanti la Francia del suo Molliere; Essanon ha che invidiare alle Edizioni Oltramontane di Opere Teatrali»: cfr. «Nuova veneta gaz-zetta che contiene quello, ch’è da vendere, da comperare, da darsi a fitto, le cose ricercate, leperdute, le trovate, in Venezia, o fuori di Venezia, il prezzo delle merci, il valore de’ cambj, edaltre notizie, parte dilettevoli, e parte utili al Pubblico», n° 2, mercoledì addì 17 marzo 1762).
Per una mappa della produzione goldoniana 51
tanto desiderata iniziativa editoriale seguisse di poco l’esaurirsi dell’ambi-ziosa “avventura” parigina71.
D’altronde, è proprio il valore militante di tutte le edizioni (fatta ecce-zione, et pour cause, della Zatta)72 che ne determina i ritmi frenetici di alle-stimento, nonché le modalità estremamente sussultorie di realizzazione73: è
Circa la concomitanza della genesi dei due progetti, si consideri che, per quanto riguarda l’in-gaggio presso la Comédie Italienne, «l’inizio delle trattative [va] collocato nel corso dellastagione 1759-60» (A. FABIANO, Goldoni a Parigi: una diversa prospettiva di indagine, inCarlo Goldoni 1793-1993, Atti del Convegno del Bicentenario (Venezia, 11-13 aprile 1994),a cura di C. Alberti e G. Pizzamiglio, Venezia, Regione del Veneto, 1995, p. 178); l’ideazionedella Pasquali, d’altro canto, va senz’altro ricondotta al 1760, essendo la richiesta di privile-gio – che strutturalmente si dispone al termine di una fase progettuale – del dicembre dellostesso anno (e sull’avvio di una nuova edizione dovette molto probabilmente incidere anchela morte – avvenuta il 27 febbraio 1760 – di Francesco Pitteri, che oltre ad essere carissimoamico di Goldoni era il suo attuale termine di riferimento editoriale: sulle complesse vicendeche nella gestione della “ditta Pitteri” fecero seguito alla scomparsa del direttore, cfr. M.INFELISE, L’editoria veneziana nel ’700, Milano, Angeli, 19912, pp. 153-155). Sulla strettainterdipendenza delle due esperienze veniva non a caso esprimendosi lo stesso autore in unacelebre lettera all’Albergati del 5 settembre 1761 (XIV 243-244). Si consideri infine che la«Nuova gazzetta veneta», il periodico diretto da Domenico Caminer («amico carissimo» –cfr. XIV 244, 287 – dell’autore, e da questi sicuramente ben informato, se non espressamentediretto: cfr. infra, pp. 86-87), poteva, nell’aprile 1762, allineare in un lungo articolo tanto lanotizia relativa all’imminente partenza di Goldoni per Parigi, quanto considerazioni sugli in-numerevoli pregi della nuova edizione (cfr. «Nuova veneta gazzetta», cit., n° 10, mercoledìaddì 14 aprile 1762).
71 Se quest’ultima si conclude nel febbraio 1765 (cfr. XIV 332), l’edizione Pasquali“propriamente detta” non andrà oltre il 1767: sull’esistenza di una “doppia” Pasquali (con tut-te le conseguenze filologiche ed ermeneutiche del caso) e sulla cronologia dei vari volumi,cfr. infra, pp. 103-114, 214-217, 231-232.
72 L’edizione – come si avrà modo di documentare in altra sede – era stata ideata e volutadal tipografo veneziano, e solo assecondata dal patrocinio dell’autore, motivato da interessi dinatura fondamentalmente economica: all’altezza del 1786 (data a cui risale il primo progettoZatta) il centro gravitazionale dei suoi interessi artistici è ormai altrove, essendo il teatro di-venuto solo oggetto di riflessione e celebrazione autobiografica. E forse non è un caso chel’unica edizione a non essere stata promossa dall’autore è l’unica che può definirsi a diversotitolo “compiuta”.
73 Fatta di interruzioni, rallentamenti e sovrapposizioni; sempre insomma estremamentetormentata, quando non incompiuta: cfr. infra, nella sinossi delle edizioni goldoniane, la rela-tiva scansione. Come già osservava Piermario Vescovo, «le edizioni goldoniane sono in mas-sima parte dei progetti interrotti» (P. Vescovo, Appunti di filologia goldoniana, cit., pp. 166-167). Sulle varie contingenze, che – sotto un profilo storico-culturale quanto specificamenteprofessionale – deteminarono il mosso andamento dei diversi allestimenti editoriali si disponeoggi di un contributo acutamente innovativo in L. RICCÒ, «Parrebbe un romanzo»: gareeditoriali fra Goldoni e Chiari, in «PCG», V, 1998, pp. 67-130 (l’assunto di fondo, ricca-mente argomentato e contestualizzato, è che per i due autori «la costituzione delle raccolte
52 ANNA SCANNAPIECO
il loro genetico assecondare le pieghe complesse della carriera di uno«Scrittor di Commedie» a renderle così poco asettiche, così pronte a recepi-re, riflettere e condizionare il mutevole sviluppo di un itinerario artistico. Ènoto quanto l’origine della Bettinelli debba al fatidico anno delle “sedicicommedie nuove”, e quanto d’altro canto il clamoroso successo della primaedizione abbia inciso su quel vero e proprio salto di qualità professionaleche Goldoni guadagnò con il passaggio al San Luca; e se l’origine della Pa-perini è indubbiamente legata all’interruzione coatta della precedente edi-zione e alla volontà – davvero “agonistica”- di fondare, nonostante tutte lelimitazioni del quadro legislativo di riferimento, il proprio status di autore74,è anche vero che il suo sviluppo intende fondamentalmente consolidarel’identità di un poeta di compagnia in una fase davvero nevralgica della suaascesa (i delicati anni dell’approdo al San Luca): ce ne rende persuasi nonsolo la conoscenza del piano originario dell’edizione (che prevedeva ilcompimento dell’iniziativa nello stesso anno – il fatidico 1753 – in cui erastata avviata)75, ma anche la sintomaticità dell’improvviso rallentamento
procede per aggiustamenti successivi legati a mire concorrenziali […]: è una progettualità diriflesso che interviene sulla nozione di ‘raccolta teatrale’ ogni volta che le mosse dell’avver-sario rendono necessaria una correzione di rotta», p. 104).
74 L’“agonismo” dell’edizione Paperini è stato – da un punto di vista filologico – ben ar-gomentato da L. RICCÒ, Prolegomeni ad un’edizione goldoniana: «La Gastalda» e «La Ca-stalda», in Goldoni in Toscana, cit., pp. 251-262 (si veda anche l’Introduzione a La castalda,EN, 1994). Inoltre, per una più adeguata valutazione dell’opzione fiorentina (troppo frequen-temente ricondotta ad astratte – e ben poco goldoniane – ragioni di ambizione letteraria, comese l’autore avesse voluto depurare le scorie della scena nella culla della civiltà linguistico-letteraria nazionale), si consideri, innanzitutto, che l’autore per poter avviare un’edizione inconcorrenza a quella di cui la legislazione veneziana garantiva il monopolio a Bettinelli, do-veva necessariamente rivolgersi a tipografi extra muros. In secondo luogo, lo specifico dellascelta fiorentina (non bolognese, milanese o altro) può essere sicuramente ricondotto alla«concorrenzialità dei torchi locali», ai rapporti dell’editore Paperini con quel «mondo […]dell’alta cultura» la cui frequentazione Goldoni aveva già vantaggiosamente messo a segno(ed era suscettibile di ulteriore incremento), alla «precisa volontà di varcare i limiti precipua-mente padani del proprio impegno di riforma teatrale» (R. PASTA, La stamperia Paperini el’edizione fiorentina delle commedie di Goldoni, in Goldoni in Toscana, cit., pp. 67-106; lecitazioni effettuate ricorrono rispettivamente alle pp. 68, 84, 67); ma anche – a mio avviso –alla volontà di ancorare con forza al proprio nome un contesto spettacolare che già si era mo-strato molto sensibile al prodotto goldoniano, e a cui non a caso risulteranno debitori alcuniorientamenti rielaborativi espressi dalla nuova edizione (cfr. A. SCANNAPIECO, Introduzionea Il padre di famiglia, cit., pp. 20-30). Come dimenticare, infine, che il primo impegnoespletato dal nuovo poeta del San Luca fu proprio quello di seguire la compagnia nella tour-née estiva di Livorno, in un torno di tempo cioè in cui era già stata bruciata la vendita (e,principalmente, in Toscana) di 1.750 copie della nuova edizione fiorentina?
75 Cfr. Risposta Data alla Lettera dell’Avvocato Carlo Goldoni Dall’Amico suo di Vene-zia, s.l. [ma Venezia], s.d. [ma tardo autunno 1753], p. 22.
Per una mappa della produzione goldoniana 53
che ebbe a colpirne la realizzazione a 2/3 del suo svolgimento, adun’altezza cronologica in cui l’affollato ricorrere delle opere del «dottoreCarlo Goldoni avvocato veneto» sotto i torchi dei maggiori centri editorialiitaliani (pronti a replicare la fortunata operazione Paperini)76 aveva creato ipresupposti per un’ulteriore qualificazione della sua carriera. Nel 1756, in-fatti, a seguito di uno sviluppo progressivamente decrescente77, l’edizionefiorentina subì un significativo arresto (e la sua abborracciata conclusione siprodurrà solo nell’estate dell’anno successivo, paradossalmente a seguitodell’avvio della nuova edizione veneziana del Pitteri)78; in quello stesso an-no il fruttuoso soggiorno parmense aveva guadagnato a Goldoni l’ambitapatente di «Poeta di S.A.R. Il Serenissimo Infante di Spagna Don Filippo,duca di Parma, Piacenza, Guastalla ecc.»79, e – con una contiguità certo noncasuale – la ridefinizione (variamente migliorativa) del contratto con Ven-dramin80. Le nuove coordinate professionali non consentono più all’autoredi identificarsi con un progetto editoriale che, nel vorticoso sviluppo dellasua carriera, appariva ormai datato, ed ecco concretarsi sul frontespizio e tra
76 Sulla scorta del clamore pubblicitario che l’autore aveva saputo creare attorno alla suaopera attraverso la rottura con Bettinelli e Medebach, l’edizione Paperini intensificò straordi-nariamente la già cospicua risonanza delle pubblicazioni goldoniane, a cui – oltre ai già attivicentri bolognese e napoletano – si interessò anche la produzione libraria torinese e pesarese(cfr. A. SCANNAPIECO, Un editore goldoniano..., cit., pp. 10, 51-52).
77 Dei 10 tomi di cui si compose l’edizione Paperini, 4 furono pubblicati nel 1753, 3 nel1754, 2 nel 1755, 1 nel 1757 (cfr. infra, pp. 226-227).
78 Lo stesso autore era costretto a riconoscere la scabrosità della circostanza: «evvi unpoco di scandalo che questo tomo [il primo dell’edizione Pitteri] sia escito prima del decimodella edizione fiorentina» (lettera a Giuseppe Antonio Arconati Visconti del 26 marzo 1757,in XIV 196-197). Sulla peculiarità dell’allestimento del decimo tomo Paperini, cfr. supra, n.42.
79 Se ne veda il compiaciuto resoconto che l’autore ne avrebbe – guarda caso – fattonella lettera di congedo all’edizione fiorentina, per motivare i cospicui ritardi con cuil’iniziativa editoriale arrivava a compimento, e in un contesto argomentativo non immemoredi pubblicizzare la nuova edizione veneziana (cfr. XIV 462-465 e 468-469). La denominazio-ne citata a testo («Poeta di S.A.R. ecc.») è quella che ricorre sul frontespizio della Pitteri (eche poi verrà replicata dalle varie edizioni che, a livello nazionale, ne procureranno la ristam-pa: cfr. infra, pp. 227-231, 233-234).
80 Cfr. D. MANTOVANI, Carlo Goldoni e il teatro di San Luca a Venezia, cit., pp. 31-33.Il nuovo contratto, che prevedeva un cospicuo miglioramento del trattamento economico(unitamente ad un alleggerimento degli obblighi previsti), fu stipulato in data 14 ottobre1756. La varia contiguità di questa riqualificazione contrattuale alla prestigiosa nomina dipoeta di corte era sottolineata da Goldoni stesso in una lettera ad Arconati Visconti del 9 ot-tobre 1756 (cfr. XIV 194). Pochi mesi dopo, allo stesso Arconati, l’autore poteva orgoglio-samente offrire il primo tomo del Nuovo teatro comico del «Poeta di S.A.R. Il SerenissimoInfante di Spagna Don Filippo, duca di Parma, Piacenza, Guastalla ecc.» (cfr. XIV 196-197).
54 ANNA SCANNAPIECO
le pagine di una nuova edizione (già da tempo meditata81, ma solo ora chia-ra nella sua necessità progettuale) la nuova identità dell’autore. Un’identità,ancora una volta, rigorosamente in progress82, pronta a misurarsi e a ridi-scutersi nella duplice e reciproca auscultazione della scena e del torchio.L’impossibile approdo ad un’immagine unitaria – la mobilità estrema concui i connotati del corpus goldoniano ancora si offrono ai nostri occhi – èl’istruttiva risultante di una dialettica ininterrotta e inesauribile – quella do-vuta al perseguimento, sostenuto dall’autore lungo tutta la sua carriera di“scrittore-editore” di teatro, «di un testo che sapesse racchiudere nel mas-simo della permanenza il massimo della flessibilità: costituzionalmenteaperto, finché l’esperienza scenica scompaginava la fissità della scrittura equesta a sua volta ridefiniva modi e contenuti del poiein teatrale, alla tenta-zione di tessere un libro infinito»83. Non a caso, allorché si sarebbe spenta laverifica della scena, sarebbero rimasti silenti anche i torchi – e l’identitàdell’autore avrebbe potuto essere ricercata solo nella “verità” della fictionmemoriale.
3.2 Tessere all’infinito il “libro” della scena Che la stampa – nel-l’esperire editoriale di Carlo Goldoni – si generi e si sviluppi in un rapportodi complessa simbiosi con la scena, naturalmente non significa che l’unaoperi per un meccanico rispecchiamento dell’altra: la contiguità dei due polida cui trae alimento il teatro goldoniano è piuttosto ideale e – soprattutto –dialettica.
Ben consapevole della complessità (affatto inedita) del percorso intra-preso, sin dall’inizio Goldoni mostra di saper argomentare con lucidità circail differente statuto semiotico previsto rispettivamente dalla scena e dal tor-chio per un testo teatrale84; anche se non manca poi di riconoscere alla fis-
81 L’ideazione della Pitteri può essere fatta risalire al 1755 (non a caso l’anno in cui piùdistintamente si pronuncia l’esaurirsi dell’interesse per la realizzazione della Paperini), comeha ricordato L. RICCÒ, «Parrebbe un romanzo»..., cit., pp. 94n e 97-98.
82 Da altra prospettiva di indagine, giunge alle stesse conclusioni L. RICCÒ, «Parrebbeun romanzo»..., cit. (se ne veda l’efficace formulazione di p. 106: «È noto che ogni distacco,ogni cambiamento logistico determina in Goldoni traumi drammaturgici legati direttamentealla stretta aderenza della sua produzione alle esigenze di concreti e diversi palcoscenici […],ma è da sottolineare che ogniqualvolta Goldoni ‘parte’ vacillano anche le impalcature edito-riali, che rapidamente finiscono per riassestarsi secondo equilibri diversi»). Per l’ennesimointersecarsi di due piani editoriali (questa volta la Pitteri e la Pasquali), cfr. ivi, pp. 118-123.
83 A. SCANNAPIECO, Giuseppe Bettinelli..., cit., p. 186.84 In forza del quale postulare una fondamentale funzione integrativa del “testo scenico”
rispetto al “testo drammaturgico”: si vedano le espressioni al riguardo ricorrenti nelle prefa-zioni che l’autore redasse per la prima edizione (t. II Bettinelli, 1751) della Putta onorata e
Per una mappa della produzione goldoniana 55
sazione editoriale delle proprie opere una precisa funzione registica – vin-colante e ineludibile – nei confronti di eventuali riprese spettacolari85. «LeCommedie stampate e lette – così l’autore veniva ribadendo «il suo assun-to» a Pietro Priuli, dedicatario del Prodigo, 1757 – sono sempre le stesse,ma rappresentate cambiano aspetto, a tenore de’ Recitanti»86. Paradossal-mente però, proprio il valore di questa identità – consegnato eminentemente(se non esclusivamente) alla lettura, e garantito dalla trasmissione a stampa– si ritrovò ad essere variamente destabilizzato proprio dall’alacrità e dal“successo” con cui l’autore ne volle e ne seppe perseguire la definizione.Non a caso, all’atto di varare la sua più ambiziosa (ma non ultima) iniziati-va editoriale, lo stesso Goldoni poteva già additare al lettore i termini delcurioso paradosso:
Ecco dunque alla luce del mondo il primo Tomo della nuova edizione delle mieCommedie, ed eccolo a fronte di altre dieci Edizioni che lo hanno finor preve-nuto, ed hanno, posso dir senza ostentazione, empito il Mondo delle Opere mie,onde la maggior guerra ch’io soffro, è quella che mi vien fatta da me medesi-mo87.
Oltre che dal fenomeno – imponente e importantissimo, ma pur semprecollaterale – delle cosiddette “stampe-pirata”, la «guerra» era dichiarata ealimentata per via endogena, da quella tensione rielaborativa che governòtutto l’itinerario artistico del nostro autore e che ne ha condizionato – spes-so ai limiti dell’indecifrabilità – la tradizione testuale88. La possibilità – che
della Buona moglie (XIV 443-444).85 Esemplare al riguardo quanto dichiarato nella prefazione alla prima edizione (t. VIII
Paperini, 1755) de La castalda: «Giacché tutti i Comici che girano per lo Mondo non trovanodisutile la rappresentazione delle Opere mie, e molti dilettanti ancora si compiacciono di re-citarle, voglio istantemente pregarli a badar bene alla distribuzion delle parti, da che dipendel’esito fortunato della rappresentazione e il maggior onore di lor medesimi. Tanto più devonfarlo, perché essendo la Commedia stampata, da ciascheduno può esser letta, e peggio perloro se scomparisce in Teatro per difetto di mala distribuzione. Fin tanto che venivano le mieCommedie rubate, e si recitavano da chi le poteva avere, pria che stampate fossero, la colpapoteva essere dell’autore soltanto, se mal riuscivano. Perciò determinato mi sono a stampar-le, più per l’utile ch’io ne ricavo» (EN, cit., pp. 118-119; il corsivo è mio).
86 I 859. Per valutare tra l’altro la varia “identità” della commedia la cui dedica propone-va il citato assioma, cfr. infra, § 4, ni 10, 11 e 92.
87 Dalla prefazione al t. I Pasquali (1761), in I 625 (il corsivo è mio). La stessa espres-sione («mi faccio io stesso la guerra colle varie edizioni già sparse») ricorre significativa-mente anche in una lettera del 24 luglio 1761 a Giambattista Vicini (edita in F. Fido, Da Ve-nezia all’Europa..., cit., pp. 161-162).
88 E a cui, non appena se ne sono creati i presupposti documentari, la critica novecente-
56 ANNA SCANNAPIECO
si è tentato di garantire in questa sede – di verificare anche l’eventuale tassovariantistico di ciascuna delle opere censite, conferma in maniera sorpren-dente un dato di cui sinora si poteva avere conoscenza solo per debolissimae frammentaria approssimazione: giacché, alla luce della ricostruita mappadella produzione goldoniana, in tutte le opere per cui è stato accertato uniter editoriale effettivamente multiplo, si sono individuate dinamiche va-riamente consistenti di evoluzione redazionale89. La mercuriale duttilità del
sca ha prestato immediato interesse (sia pur non confortato, sino a non molto tempo fa, dapertinenti prospettive filologiche ed ermeneutiche: al riguardo, mi sia permesso rinviare aquanto sinteticamente ricordato in Giuseppe Bettinelli..., cit., pp. 157-158 e passim, nonché aLo statuto filologico dell’opera goldoniana nella singolare prospettiva del Padre di famiglia,in «PCG», III, 1996, pp. 39-157, in part. pp. 40-42). Sulla filologia dei testi teatrali, il contri-buto che, per spessore metodologico e respiro sistematico, si è maggiormente distinto (dichia-randosi peraltro «preliminare ad un volume in fase di allestimento») si deve a L. RICCÒ, Testoper la scena – testo per la stampa: problemi di edizione, in «Giornale storico della letteraturaitaliana», CLXXIII, 1996, pp. 210-266.
89 Sono a rigore 69 le opere per cui – allo stato attuale della ricostruzione bibliografica –sono state accertate trasmutazioni testuali (di diverso peso e consistenza, ma spesso anchedistribuite in molteplici fasi editoriali): cfr. infra, § 4, ni 1, *4, 6, 7, 8-9, 10-11, 15-16, 17, 19-20, 21-22, *28, 29, 30, 31, *32, 34, 36, *37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55,*56, 57, *58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, *73, *76, 77, *80, *88,*98, 109, 120, *121, 130-131, *132, 134, 142, 145, 149, 159, 179, 180, 181, *182, *190. Inumeri contraddistinti dall’asterisco segnalano opere per cui è documentata – per lo più attra-verso relativa dichiarazione d’autore – riscrittura solo all’atto della loro prima definizioneeditoriale: pertanto la concreta espressione dell’orientamento variantistico, in mancanza dimanoscritti autografi che consentano di misurarne lo spessore e la fisionomia, rimane al difuori dell’osservazione filologica. Ciò tuttavia nulla toglie al rilievo che questi casi comunquehanno nel monitoraggio e nella valutazione storico-critica della prassi rielaborativa goldonia-na, e per questa ragione si è ritenuto opportuno di iscriverli nel precedente insieme.Che in un quadro complessivo di 200 opere siano solo 69 quelle per cui risulti lecito parlaredi «iter editoriale effettivamente multiplo» (e tale dunque da consentire concretamentel’osservazione di eventuali dinamiche variantistiche), non deve sorprendere: per ovvie ragionisono escluse dal novero tutte quelle (nel numero, come s’è visto, di 50) che non conobberoalcuna realizzazione editoriale, ma anche quelle per cui si dispone di una tradizione a stampaunitestimoniale. In questa categoria rientrano le 14 che furono per la prima volta pubblicatenell’ultima edizione “d’autore”, la Zatta (cfr. ni 2, 124, 125, 126, 127, 128, 143, 144, 165,183, 184, 198, 199, 200), o le 3 che furono pubblicate alla spicciolata (per lo più in vista dellarappresentazione) e che poi non rientrarono in nessuna delle raccolte editoriali settecentesched’autore (cfr. ni 123, 195, 196), o le 2 che furono anticipate da edizioni “spurie” e poi da que-ste supinamente derivate nella Zatta (e dunque a pieno titolo rientranti nella tipologia unite-stimoniale: cfr. ni 3 e 5): ma non solo.Giova infatti anticipare sin d’ora che la Zatta, a parte il caso di 23 opere per cui si avvalse dimateriale manoscritto acquistato dall’autore (relativo, oltre alle 14 segnalate in precedenza, aquelle di cui ai ni 1, 6, 7, 120, 159, 179, 180, 181, 190: eccezion fatta per quest’ultimo, sitratta di testi trasmessici – per lo più attraverso precedenti edizioni cosiddette “pirata” – anche
Per una mappa della produzione goldoniana 57
poiein di Carlo Goldoni, l’immediata intelligenza delle spinte contestuali, lacapacità di ricodificazione “teatrale” di una “realtà” acutamente colta nelsuo molteplice metamorfismo trovano un riflesso puntuale nella sistemati-cità con cui si esprime una prassi rielaborativa che – sia pur con tutte le li-mitazioni documentarie e le complicazioni bibliografiche del caso – risultaampiamente testimoniata proprio dall’attraversamento editoriale dei testi.La misura, e la dettagliata fenomenologia, di tale prassi sarà sondata nellospecifico dei singoli casi (approfondendo una modalità di approccio criticoche le nuove coordinate filologiche di riferimento hanno già proficuamenteattivato)90; in questa sede converrà limitarsi a suggerire alcune possibilichiavi di accesso al fenomeno in questione, perscrutato e valutato nella pa-noramica mappa che si è tentato di ridisegnare.
La sistematicità con cui la scrittura goldoniana si interroga e si ridefini-sce rende scarsamente verosimili ipotesi critiche inclini a leggerne l’espres-sione variantistica in termini di tattico pragmatismo, occasionale sottostarea spinte eteronome91. Non che queste, beninteso, non abbiano potuto pro-
in altre redazioni, e pertanto si sottraggono alla categoria della tradizione unitestimoniale),utilizzò come antigrafo edizioni non autorizzate. L’ultima edizione “d’autore” è dunque daritenersi, per la stragrande maggioranza delle opere pubblicate (112 sulle complessive 135),edizione descripta: ai fini della valutazione di un processo rielaborativo autografo non rivestepertanto alcun valore. Alla luce di queste considerazioni, vanno in teoria – e fatta salval’individuazione avvenire di redazioni difformi, trasmesse da testimoni sinora non noti o nonreperiti – interpretate come stampe unitestimoniali quelle di tutte le opere che ebbero la loroprinceps nella Pasquali o anche nella Pitteri per i testi non ripubblicati poi dalla Pasquali: cfr.infra, rispettivamente i ni 101, 129, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 146, 147 e 82, 89,90, 94, 95, 97, 99, 100, 102, 103, 105, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,122, 148).Infine, per ragioni analoghe (e che saranno argomentate infra, pp. 103-114), si può ipotizzare,con altissimo grado di verosimiglianza, che anche la Pasquali, negli ultimi sette tomi, per leopere già pubblicate in precedenti edizioni non si avvalse di antigrafi elaborati o – almenosupervisionati – dall’autore: eventuali dinamiche variantistiche osservabili nei 19 testi in que-stione andrebbero pertanto interpretate come accidentali e comunque spurie (per quanto si èavuto peraltro modo di verificare attraverso campionature mirate, si tratta – e non a caso –dell’unica parte dell’edizione Pasquali in cui non si producono modifiche testuali di ordinesostanziale); inoltre, quelle tra le suddette 19 opere che sono riproposte dalla Pasquali a se-guito di un’unica precedente pubblicazione (dovuta alla Pitteri o, più raramente, alla Paperini)sono conseguentemente da valutarsi come ascrivibili ad una tradizione di tipo unitestimoniale(cfr. rispettivamente per il tipo PS< PT i ni 75, 78, 79, 81, 85, 86, 87, 96, 104; per il tipo PS<PA i ni 52, 74, 84, 106).
90 Cfr. supra, n. 9.91 La “discontinuità” e la “frettolosità” della prassi correttoria goldoniana sono categorie
interpretative messe in circolo da un celebre e magistrale saggio di Gianfranco FOLENA (Illinguaggio del Goldoni dall’improvviso al concertato [1957], in L’italiano in Europa, cit., p.136). Sulla genesi e il perdurare del motivo critico, nonché sulle ragioni che hanno indotto a
58 ANNA SCANNAPIECO
dursi, e talora anche significativamente incidere sul riassetto redazionale deitesti – ma isolare singoli casi dal contesto complessivo e assolutizzarne ilsignificato preclude l’esercizio di un’equilibrata espressione interpretativa:se lasciata irrelata, l’individualità della tessera inevitabilmente confonde lacorretta focalizzazione della propria immagine e altera, per vizio prospetti-co, i connotati del quadro complessivo. Indagare il dettaglio è senz’altrooperazione indispensabile per un credibile restauro dell’insieme: ma la ri-creazione del quadro attraverso quella delle sue componenti è possibile soloa patto di non trascurare le proporzioni complessive, le dinamiche struttu-rali e per così dire “cromatiche” di fondo.
A saper leggere Goldoni con Goldoni, e sia pur dovendo ricostruire ilfilo di un tessuto logico che spesso si è rivestito di modi argomentativi tatti-ci o che si è dipanato con alterna visibilità, scopriremmo che è l’autore stes-so a consegnarci una solida, e persuasiva, prospettiva d’analisi. Prima tratutte, andrà rimeditata un’affermazione in tal senso capitale, ricorrente inuno degli spazi più incandescescenti dell’apologetica goldoniana, il manife-sto programmatico dell’edizione Paperini:
Facile è persuader ciascheduno che formando io una Commedia col solo og-getto di donarla al Teatro, non averò intorno di essa quel tempo e quella dili-genza impiegata, come se colle stampe pubblicarla avessi dovuto. Né cotal dili-genza poteva usarvi, né tempo aveva di farlo, affollato dalle otto, e dalle dieci, esino dalle sedici Commedie in un anno, e dalle continove prove di esse […].Cerco quanto posso correggerle e migliorarle, le ripulisco col tempo; vedol’effetto che sulla scena mi fanno, odo le critiche e le censure; e quando trattasidi stamparle, alcune di esse le riformo, le rifaccio, e quasi in tutto le cambio92.
Anche se in un contesto argomentativo suscettibile di vari equivoci inter-pretativi (si veda la tattica assunzione di un’identità autoriale culta, che sidichiara nostalgica del labor limae e al tempo stesso non esita a costringerela professionalità del rapporto intrattentuto con l’istituzione spettacolarenella declinazione topica – quanto misitificante e, nel caso specifico, deltutto inappropriata – del dono)93, emerge qui distintamente quel motivo
rivederne i presupposti, cfr. anche quanto già argomentato in A. SCANNAPIECO, GiuseppeBettinelli..., cit., pp. 159-160, 181-188.
92 Lettera dell’avvocato Carlo Goldoni ad un amico suo di Venezia, in XIV 455-456 (ilcorsivo è mio).
93 Sulla strumentalità delle strategie argomentative messe in opera da Goldoni in questadrammatica e capitale fase della sua carriera, cfr. A. SCANNAPIECO, Giuseppe Bettinelli..., cit.e «Io non soglio scrivere per le stampe…»..., cit., passim; sulla tattica assunzione de «l’imma-gine canonica dell’autore di teatro ‘aristotelico’» sostenuta dall’autore per l’allestimento della
Per una mappa della produzione goldoniana 59
dello «sguardo ‘dalla Platea’» che – come è già stato acutamente osservato– «costituisce la mediazione imprescindibile tra scena e libro»94. Se la stra-tegia propagandistica del manifesto Paperini dispiega in questo passo lacontaminazione di due diversi orizzonti teorici, che a ben vedere malamenteconvivono, la riconsiderazione di altre dichiarazioni dell’autore non tarderàa persuaderci che dei due motivi in campo l’unico ad essere autenticamente“goldoniano” è quello che individua nella verifica scenica la dinamica ge-netica della rielaborazione.
Fatta ch’io l’ebbi [la Pamela maritata], partii di Roma; fu rappresentata poil’anno dopo; mi hanno detto che riuscì fortunata, quanto la prima, ma io nonl’ho veduta rappresentare. Non ho avuto campo adunque di far sopra di essaquelle osservazioni, ch’io soglio fare dalla Platea sopra le cose mie, per cor-reggerle pria di stamparle. Ho fatto al Tavolino, tre anni dopo, quel che ho po-tuto, e qualche cosa ho cambiato, e mi pare che sia passabile fra tante altre peg-giori95.
Così, in un passo meritatamente celebre, Goldoni illustra al lettore la dina-mica del processo drammaturgico e del suo costitutivo disporsi secondo itermini di un comporre-scomporre-ricomporre (le diverse – ma intimamentecongiunte – fasi di un fare-vedere-fare che si scandiscono attorno alloscrittoio, alla scena e al torchio). La dichiarazione – che ha valore retro-spettivo ed estensivo – non solo afferma il prodursi duraturo e costantedella riscrittura, ma anche, in certo qual modo, il suo essere immanente allascrittura stessa. La nettezza dell’affermazione tuttavia non manca di sfu-marsi in contorni ambigui, o ellittici: non tanto perché, paradossalmente, siesprime proprio in relazione ad una specifica esperienza rielaborativa in cuile modalità di quel processo non hanno avuto luogo (essendo venuta menola fase intermedia) e che quindi smentisce la generalità dell’asserto nelmomento stesso in cui la postula; quanto perché lascia indistinte le ragioni ela funzione dell’ultima fase, quella della “correzione in vista della stampa”.
Paperini, cfr. L. RICCÒ, Testo per la scena..., cit., pp. 227-232. Sul motivo del tempo comeelemento indispensabile per una compiuta realizzazione drammaturgica, in grado di sussiteresin dalla fase compositiva senza bisogno poi, in fase di definizione editoriale, di ulteriori veri-fiche e revisioni, Goldoni sarebbe distesamente ritornato (1763) nella prefazione all’Amorepaterno (cfr. VIII 331-332); ma sull’evoluzione del concetto si autorialità in Goldoni, e sullevarie concause che poterono animarla, si veda il penetrante saggio di L. RICCÒ, Goldoni,Chiari, Gozzi e lo scrittoio teatrale, in «Paragone», XLVIII, 9-10, 1997, pp. 89-126.
94 Ivi, p. 97.95 C. GOLDONI, Pamela fanciulla – Pamela maritata, a cura di I. Crotti, EN, 1995, pp.
190-191 (il corsivo è mio).
60 ANNA SCANNAPIECO
Facile sarebbe a questo punto indulgere alla tentazione di sovrapporre allospecifico goldoniano collaudati schemi critico-interpretativi, ipotizzandoche l’approdo del tragitto rielaborativo intenda essere quello «ad un testoletterario sempre più perfetto, un Testo ne varietur, che chiede di entrare abuon diritto nelle istituzioni della Letteratura»96, di un testo che, obliterandola sua genesi e valenza spettacolare97, consenta al poeta di compagnia difarsi Autore. Ma riempire i silenzi goldoniani di parole non sue non giova ainterpretarne le intenzioni, né tanto meno alla possibilità di esercitare unapproccio analitico storicamente e metodologicamente congruo alla specifi-cità filologica del caso.
Tanto più se, continuando a ripercorrere il filo delle dichiarazioni del-l’autore, si ha modo di appurare che in realtà «lo sguardo dalla Platea» èintento a valutare la funzionalità spettacolare del testo e che l’eventuale tra-vaglio rielaborativo si genera a partire dall’esigenza di potenziarne l’effica-cia scenica avvenire. Molti sono al riguardo i documenti che potrebbero al-legarsi, e merita citarne qualcuno:
La prima volta ch’io diedi al pubblico la presente Commedia [L’avventuriereonorato], il Protagonista di essa […] parlava col veneziano idioma. Ciò potevarendere la Commedia medesima più gradita in Venezia, ma nelle altre parti do-vea succedere ragionevolmente il contrario […]. Ma dirò anche, per manifesta-re, siccome io soglio, la verità, non aver io preferito nel mio Avventuriere la ve-neziana alla toscana favella, perché ciò credessi essere meglio fatto; ma perchéun valente Giovine [il Collalto], solito a far la parte del Pantalone, brillantissimoin tali caratteri veneziani, senza la maschera sostenuti, mi assicurava di un esitofortunato; lo che difficilmente allora avrei conseguito, se ad altro Comico avessianche in altro linguaggio una cotal parte addossata. Ora poi che tale commediarendesi colla stampa comune, e in vari paesi può accadere che venga rappre-sentata, difficilissima cosa essendo che si trovi per l’appunto un Veneziano chela sostenga, e peggio se taluno volesse una lingua a lui forestiera balbettar ma-lamente, convenevole cosa ho creduto il convertirla in toscano. Anzi necessaris-simo ho trovato di farlo, poiché allora soltanto è permesso usare un linguaggioparticolare nelle Commedie Italiane, quando il carattere del personaggio lo esi-ga, non potendosi, per esempio, fare che il Pantalone, l’Arlecchino, il Brighellausino la favella toscana; siccome né tampoco poteva usarla l’Avvocato mio Ve-neziano nella Commedia così intitolata.
96 B. ANGLANI, Ideologia della riforma..., cit., p. 80.97 «Il suo [di Goldoni] travaglio filologico ruota continuamente attorno alla contraddi-
zione di voler “ripulire”, di tutti gli elementi a posteriori ritenuti spuri, una drammaturgia che,al contrario, traeva forza e originalità proprio dalla sua intrinseca natura attoriale, fedele airuoli recitativi, in grado di raccogliere in modo abile e tempestivo gli umori del pubblico e dimodellarsi secondo le esigenze della messa in scena» (M. PIERI, Introduzione, cit., p. XLVIII).
Per una mappa della produzione goldoniana 61
Quando la scrissi, e quando la feci la prima volta rappresentare, la intitolai IDue Pantaloni […]. Trovandosi nel valoroso Pantalone per cui la scrissi, l’abi-lità di far da vecchio e da giovine eccellentemente, guidai la Commedia in modoch’egli medesimo potesse rappresentare il Padre ed il Figlio […]. Piacque laCommedia in tal guisa rappresentata, ma dovendosi ora dare alle stampe, nonposso lusingarmi che sì facilmente trovisi un altro simile personaggio, che i duecaratteri sostener possa, onde separando il Padre ed il Figlio, ho fatto in modoche abbiano ad essere due personaggi distinti. In tal guisa l’ho fatta rappresenta-re a Livorno, ed è riuscita egualmente bene […]. Anche questa difficoltà [quellarelativa alla «Veneta lingua», in cui continuava ad essere redatta la commediaanche nel nuovo allestimento spettacolare] mi si oppose, stampandola, di ritro-var due persone di abilità che in tal linguaggio favellino, e perché è inconve-niente cosa che il Padre ed il Figlio, in questa tale Commedia, non parlino collinguaggio medesimo, perciò li ho trasportati in Toscano, onde più facilmentepossa essere da qualunque Compagnia recitata.
Quando si rappresentò questa mia Commedia [La guerra], ho creduto di servirbene al piacere del pubblico facendo agire gli assedianti non meno che i difen-sori coll’uso delle artiglierie, delle sortite, degli assalti e de’ movimenti dellemilizie, ma vidi in pratica esser operazioni difficili da eseguirsi sopra la scena,e che male eseguite, guastano anziché adornare la rappresentazione. Ho ridotteora le cose a facilità. Alcune ne ho del tutto levate, supplendovi con brevissimenarrative; altre ne ho moderate, che possono soddisfare collo spettacolo, senzaimpegnare gli attori alla difficile esecuzione98.
«Lo sguardo dalla Platea» consente al drammaturgo di rilevare gli eventualilimiti spettacolari dei testi; la stampa, d’altro canto, non solo permette laconcreta espressione di una sensibilità variantistica che quei limiti vorrebbefar arretrare, ma anche incentiva il processo di auscultazione delle poten-zialità rappresentative di una configurazione drammatrurgica rispetto ad
98 Le citazioni sono desunte dalle prefazioni, rispettivamente, a L’avventuriere onorato(t. III Paperini, 1753, in III 870), I mercatanti (t. V Paperini, 1754, in IV 701), La guerra (t.VI Pasquali, 1764, in VII 559-560); i corsivi sono miei. Affermazioni dello stesso tenore sonoricorrenti nelle prefazioni a La locandiera (t. II Paperini, 1753, in IV 780), Il vero amico (t.IV Paperini, 1753, in III 1199), Gli amanti timidi (t. XVII Pasquali, 1780, in III 870: già cit.supra, p. 43). Merita sottolineare che laddove l’attraversamento scenico di un testo si sia pro-dotto felicemente, l’autore non esita a far arretrare il proprio impulso rielaborativo, proprioperché «lo sguardo dalla Platea» non ne giustifica la necessità: «Quando io la composi [Ipettegolezzi delle donne], pensai a volerla corta, perché dovesse servire l’ultima sera del Car-novale. Piacque a tal segno, che negli anni seguenti la volsero moltissime volte replicata.Provai allungarla, ma viddi che l’avrei facilmente guastata, onde anche perciò m’accorsi cheera opera nel suo genere finita» (I pettegolezzi delle donne [t. IX Paperini, 1755], a cura di P.Luciani, EN, 1994, p. 78).
62 ANNA SCANNAPIECO
un’altra, proprio perché costringe l’autore a situare in una dimensione diflessibilità e agibilità massima (in quanto non commisurata allo specifico dideterminate attitudini interpretative) la comunicatività scenica di un testo99.
Depongono in tal senso anche i casi – tanto più clamorosi quanto più“repugnanti” alla (presunta) compattezza del progetto riformistico – diquelle commedie il cui processo rielaborativo si espresse attraverso l’intro-
99 Circa la complessa problematica delle conversioni in lingua di testi originariamentedialettali – sulla cui valenza “teatrale” e non certo letteraria già ampiamente ci informanoproprio i passi citati – mi sia consentito rinviare all’Introduzione a C. GOLDONI, Il padre difamiglia, cit., pp. 21-29 e a In viaggio con Todero..., cit., pp. 211-220. È vero peraltro chenon mancano occasioni prefative in cui Goldoni sembrerebbe contraddire in pieno il valoredelle ragioni – altrove esposte e, come s’è visto, diffusamente argomentate – che avevanomotivato, tra gli altri interventi rielaborativi, anche quello della conversione in “toscano”. Siconsideri ad esempio il caso de Il poeta fanatico, in cui l’autore sembrerebbe addiritturagiungere a utilizzare uno degli stessi motivi altrove addotti a giustificare la riscrittura in lin-gua (e cioè quello di un’originaria opzione dialettale legata alle caratteristiche interpretativedell’attore) proprio per escluderne ora la legittimità: «Il personaggio di Tonino fu da me inlingua Veneziana scritto, per comodo di un eccellente Attore in tale idioma, che accoppiavaegregiamente al pregio di ben recitare quello ancora del dolce canto, onde non ho creduto oranecessario tradurre un tal personaggio in Toscano, tanto più, che so essere il linguaggio no-stro universalmente gradito» (Il poeta fanatico, a cura di M. Amato, EN, 1996, p. 125). Ma,come è stato puntualmente dimostrato, «l’argomentare di Goldoni è qui ellittico», pur la-sciando intendere «tra le righe […] che se riscrivere i versi della commedia sarebbe stato unlavoro improbo […], addirittura assurdo sarebbe stato snaturare i versi dei poeti improvvisa-tori veneziani traducendoli in toscano. Tanto più che la caratteristica principale della comme-dia consiste proprio nel contrasto tra il fanatismo poetico “in lingua” di Ottavio (pedantesca-mente statico e stereotipato) e l’immediatezza espressiva, la spontanea musicalità dei versirecitati dagli improvvisatori, la cui efficacia è indissolubilmente legata alla dimensione dia-lettale» (M. AMATO, Nota al testo, ivi, pp. 55-56). Che in alcuni casi di mancata conversionein lingua possano tuttavia essere intervenuti anche condizionamenti eteronomi è attestatodalla prefazione Paperini alle Donne gelose, la prima delle cinque commedie che – secondouna scelta non casuale di assemblaggio e, soprattutto, di preservazione dell’originaria reda-zione – compongono il venezianissimo tomo nono dell’edizione Paperini, sorta di obbligatoomaggio all’“identità culturale” del «dottor Carlo Goldoni avvocato veneto»: «io ho volsutoper ora stamparla come fu da me fatta, per non dispiacere a quei tali che così la bramano[…]; a questo proposito ho avuto qualche lettera orba, senza sottoscrizione, che mi rimprove-rava d’aver io in varie Commedie tradotto il Pantalone in toscano, desiderandosi da chi midava l’avviso, leggerlo nel naturale suo idioma» (IV 357, il corsivo è mio: non sfugga la li-mitazione temporale dell’opzione editoriale, che risulta strettamente legata all’intenzione –dichiarata nella stessa sede – «di ridurre a frase e costume toscano questa ed altre Commedie,che dir si possono veneziane, stampandole in altro Tomo, che destinava far dopo il decimo»).Forse non a caso uno dei dedicatari delle commedie che compongono il volume (I pettegolez-zi delle donne, “offerti” a Marcantonio Zorzi) è apprezzato cultore del dialetto veneto, chenon solo impiegò in una vivace produzione poetica, ma anche per la traduzione di alcune ora-zioni ciceroniane (cfr. P. LUCIANI, Commento a I pettegolezzi delle donne, cit., pp. 159-160).
Per una mappa della produzione goldoniana 63
duzione ex novo delle canoniche maschere in sostituzione degli originaripersonaggi, la cui problematicità interpretativa risultava poco congrua aquel principio di una più collaudata eseguibilità scenica perseguito durantela fase della definizione editoriale dell’opera:
Nel rivedere la presente Commedia [Il vecchio bizzarro] coll’oggetto di darla altorchio, la memoria mi suggerisce l’evento sfortunato ch’ella ebbe sopra le Sce-ne, allora quando fu per la prima volta prodotta; e mi sovviene, che allora subitodesiderai di poterla stampare, perché il Pubblico avendola sotto l’occhio, sapes-se dirmi con verità, se tanto parea cattiva in leggendola, quanto apparve nellasua rappresentazione. […] esaminandola senza passione, non parmi essere inde-gna di quel generoso compatimento, che tante altre Commedie mie, di questaancora più difettose, hanno dal Pubblico riportato. Molte combinazioni si uni-scono spesse volte per fare che scomparisca un’opera sfortunata […]. Eravi inallora [nella compagnia del S. Luca] un celebre Pantalone [Francesco Rubini][…]; e mi lusingai, che quanto era egli valente colla sua maschera, potesse ri-uscire egualmente col volto scoperto; […] la Commedia riuscì malissimo; ilpersonaggio suddetto, ch’era l’attor principale, avvezzo sempre a recitar collamaschera, e all’improvviso, si trovò talmente imbarazzato e confuso, che pareaun principiante […]. Stampandosi ora questa male avventurata Commedia, spe-ro non averà l’incontro di prima. […] Temendo non mi succeda lo stesso, s’ellavenisse qualche altra volta rappresentata, per la difficoltà di ritrovare un Vec-chio grazioso senza la maschera, l’ho posta io medesimo presentemente al Vec-chio Bizzarro, facendolo rappresentare dal nostro benemerito Pantalone100.
A fronte di altri esempi che si potrebbero citare101, la testimonianza è in
100 L’autore a chi legge de Il vecchio bizzarro (t. II Pitteri, 1757), in V 353-356 (il corsi-vo è mio).
101 Si veda il caso delle Femmine puntigliose (t. III Paperini, 1753), per cui la stampa ri-pristina un’intenzione compositiva originaria, rimossa in sede di primo allestimento spetta-colare per obbligato ma non persuaso compiacimento verso le “esigenze” di un attore; anchein questo caso la “correzione” va nel senso della salvaguardia di una maggiore efficacia (non-ché coerenza) spettacolare: «Anche la parte dell’Arlecchino vedesi [nell’edizione Bettinelli,che riproduce, con gli obbligati interventi allografi del caso, il “copione”] dimezzata e inquella di un Lacchè convertita. Ciò mi sovviene aver io medesimo fatto per compiacere unArlecchino particolare, che dalla parte di un Moro [il particolare aspetto assunto dalla ma-schera per la modulazione che la sua parte riceveva nella commedia] credevasi pregiudicato,con animo di rimetterlo, come prima, all’occasione di pubblicar con le stampe la mia Com-media; che se in altre ho fatto senza di cotal Maschera, parmi che non s’abbia a togliere oves’adoprano il Pantalone e il Brighella» (II 1121).Un medesimo tipo di variante – che, sia pur non apertamente motivata, deve molto verosi-milmente essere ascritto a questa stessa dinamica rielaborativa – è quello introdotto nel Rag-giratore all’atto del suo passaggio al torchio (t. III Pitteri, 1758): «una mutazione ho fattadalla recita alla edizione. In quella il ridicolo era senza la maschera, in questa ho creduto bene
64 ANNA SCANNAPIECO
questo caso tanto più significativa perché l’impostazione argomentativa a-vrebbe fatto presumere come inevitabile lo sviluppo del motivo della stam-pa quale risarcimento verso l’inadeguatezza dell’esecuzione attorica (non-ché verso l’ondivaga competenza del pubblico teatrale), banco di prova delreale valore drammaturgico delle proprie opere102: e ci si sarebbe conse-guentemente attesi una preservazione della configurazione originaria deltesto. Ciò non avviene perché nella prospettiva dell’autore, più che l’espres-sione di motivi immediatamente apologetici, maggior rilievo ha la salva-guardia di quel principio di massima flessibilità di cui si diceva: pertanto seil piano drammaturgico iniziale del Cortesan vecchio – anche se non perintrinseca insussistenza, ma per inadeguatezza esecutiva del primo inter-prete – ha comunque mostrato di non saper essere all’altezza delle propriepotenzialità spettacolari, si valuta necessario, nell’editorialmente “ri-formato” Vecchio bizzarro, il reintegro della canonica maschera, di piùagevole declinazione attorica di quanto non potesse esserlo il pur “innova-tivo” personaggio che animava l’originaria ideazione drammaturgica.
Siamo dunque in presenza di motivi che si accampano con significativacoerenza lungo tutto l’arco dell’itinerario editoriale di Carlo Goldoni e cheilluminano – con una nettezza a mio avviso difficilmente controvertibile –alcune costanti cruciali del suo poiein teatrale. Ma l’opportunità di enuclea-re le dinamiche fondamentali della dialettica scrittoio-scena-torchio nonpuò evidentemente esaurire la varia (e spesso insidiosa) fenomenologia concui si espresse la tensione rielaborativa: può tutt’al più – come si diceva –aiutare a ricostruire le proporzioni complessive, i prevedibili contorni di unquadro le cui tessere ci sono spesso state restituite – quando pure ci sonostate restituite – con tratti alterati ed eterogenee incrostazioni, sopravviven-do alla duplice «guerra» dell’autore e della storia.
3.3 Trovare il bandolo? Se è vero che «a questo stadio dello scavo do-cumentario e dell’esegesi testuale […], non possiamo che prendere atto chela scena goldoniana rimane filologicamente ‘imprendibile’»103, che le origi-narie configurazioni spettacolari del teatro “riformato” sono forse state persempre cancellate dalla memoria storica anche per il sovraffollarsi dei “te-stimoni” che avrebbero dovuto garantirne la fissazione e la permanenza,tanto più metodologicamente necessario risulterà il concentrarsi – liberi daogni pregiudizio ermeneutico – in un’analisi paziente quanto criticamente
adattarlo al personaggio dell’Arlecchino» (VI 11).102 Secondo modi che abbiamo già visto essere propri delle strategie prefative goldonia-
ne: cfr. supra, pp. 46-47 e n. 58.103 L. RICCÒ, Testo per la scena..., cit., p. 248.
Per una mappa della produzione goldoniana 65
avvertita di quella ramificata costellazione editoriale settecentesca che an-cora per tutto questo secolo ha imprigionato i testi goldoniani in forme cao-tiche o contraffatte. E sempre più ineludibile appare la necessità di costruireuna prospettiva filologica pertinente attraverso l’«approfondimento storicomorfologico analitico delle varie tappe editoriali»104 in cui si sedimentò latradizione dei testi.
La cospicua ridefinizione delle coordinate critiche che ha inauguratoquest’ultimo decennio dell’esegesi goldoniana ha già prodotto qualche si-gnificativo aggiustamento di focus; ma molte sono ancora le zone d’ombrada rischiarare, molti gli stessi problemi di cui ancora prendere consapevo-lezza. Il contributo che si è inteso in questa sede offrire vuole sostanzial-mente essere propedeutico ad una fase ulteriore dell’indagine, allineando –e ricomponendo in un primo inquadramento – il materiale documentarioche la ricerca bibliografica ha sinora individuato; in limine, non pare tutta-via fuori luogo corredare i dati di alcune chiavi d’accesso, che dovrebberoagevolare la possibilità di un loro primo “dipanamento” critico.
Preliminarmente, sarà utile ricordare che alle cinque edizioni volute e invario modo assistite dall’autore, se ne affiancarono innumerevoli altre,prontamente sollecitate dall’appeal commerciale dell’opera e dunque di-sposte a riprodurre – amplificandone la risonanza – qualunque “novità” astampa del «dottore Carlo Goldoni avvocato veneto»: sicché presto tutti iprincipali centri editoriali della penisola si ritrovarono a celebrare le «Opereinsigni»105 del «Molière italiano». Fra le prime a distinguersi, l’area bolo-gnese e quella napoletana, dove, sin dall’inizio degli anni cinquanta, la SanTommaso d’Aquino e la Venaccia non solo avviano, tempestivamente, laristampa della Bettinelli, ma si dispongono anche a riprodurre sistematica-mente tutto ciò che le nuove edizioni «rivedute e corrette» dall’autore an-dranno immettendo sul mercato, e a seguire dunque in fieri (e con ininter-rotta fedeltà: per almeno, rispettivamente, 45 e 25 anni) il comporsi – e ilricomporsi – del teatro goldoniano a stampa (non mancando talvolta di an-ticipare – come vedremo – la pubblicazione di inediti). Nel corso degli anni’50, dopo la già eclatante riuscita della prima edizione veneziana, quellafiorentina degli Eredi Paperini – sulla scorta del clamore pubblicitario cheGoldoni aveva saputo creare attorno alla sua opera attraverso la rottura conBettinelli e Medebach – solleciterà specifiche ristampe (la torinese Fantino-
104 A. SCANNAPIECO, Giuseppe Bettinelli..., cit., p. 160.105 «Questa è la sorte dell’Opere insigni essere pubblicate più volte anche in breve tempo;
si crederebbe far torto al publico se non si pensasse a provederlo delle medesime» (Li stam-patori a cortesi lettori, cit., p. VII).
66 ANNA SCANNAPIECO
Olzati, la pesarese Gavelli); e analoga attenzione continuerà a suscitare lanuova edizione veneziana del Pitteri (seguita, oltre che dalle già menzionate“omnia” in progress San Tommaso e Venaccia, dalla Fantino). Lungidall’affievolirsi l’interesse per un autore ormai lontano – e non solo dallescene, ma anche dai torchi “nazionali” – , negli anni ’70 si svilupperà la di-sposizione a riproposizioni editoriali sistematiche della sua opera (nell’areapiemontese, con Guibert e Orgeas, in rapporti di coproduzione col genoveseYves Gravier; a Venezia, con Agostino Savioli); e la tendenza sarà poi am-piamente diffusa negli anni ’80, allorché il prodotto goldoniano sempre piùdistintamente sembrerà avviarsi ad una sistematizzazione di tipo museale: sipensi alla romana Puccinelli (1783-1787), che replica – ma, come vedremo,in forme talora proficuamente “innovative” – l’operazione Savioli; o allaBonsignori di Lucca e alla Masi di Livorno (1788-1793), vicine e concor-renziali al modello dell’ultima edizione patrocinata dall’autore, la Zatta,alla cui impostazione, negli anni ’90, si ispirerà in forme più dirette – e, perla pubblicazione di alcuni testi, in modi filologicamente non irrilevanti – laveneziana Garbo. Per qualcuna di queste edizioni si è dispone già di speci-fiche indagini, sistematiche o parziali106 (e per ciascuna di esse si forniranno– nel relativo prospetto sintetico – alcune fondamentali informazioni stori-co-critiche e/o bibliografiche): ma la specificità e il vario rilievo storico-culturale (oltre che, beninteso, filologico) di ognuna esigerà ricognizionisistematiche e proprie. In questa sede gioverà sottolineare che a complicarela fondazione di una prospettiva filologica adeguata alla specificità del casogoldoniano è anche l’esuberante presenza di questa tradizione editoriale“apocrifa”107: tutt’altro che esorcizzabile in una comoda categoria di“ristampe-pirata” (che ne consentirebbe l’immediato azzeramento testimo-niale), e viceversa tale da consentire, ad uno sguardo più ravvicinato e at-tento, l’individuazione o di rapporti variamente collaborativi con lo stesso
106 Su Giacomo-Antonio Venaccia, cfr. A. SCANNAPIECO, Un editore goldoniano..., cit.Per la bolognese San Tommaso (in presumibili rapporti societari con gli editori Pisarri-Primo-dì), cfr. ivi, pp. 8-10; EAD., Lo statuto filologico…, cit., pp. 145-149 (cui si rinvia anche perulteriori indicazioni bibliografiche); infra, passim. Sulla Savioli e sulla Guibert e Orgeas si èintrattenuto A. ZANIOL, Per una rilettura storico-filologica delle ultime edizioni goldonianedel Settecento, in «PCG», I, 189-232, su cui cfr. infra, passim.
107 E merita, almeno in margine, ricordare anche il numero non trascurabile di editori oc-casionali (i romani Mainardi e Amidei, il fiorentino Stecchi, il livornese Santini ecc.), cheprocurano stampe di singole commedie, per lo più in appoggio a specifici allestimenti spetta-colari. Proprio per la non sistematicità con cui questi stampatori frequentano l’opera goldo-niana, la descrizione della loro produzione non è rientrata nella sinossi delle edizioni, ma sene è data comunque estesa menzione infra, § 4, in relazione a ciascuno dei testi effettiva-mente pubblicati.
Per una mappa della produzione goldoniana 67
Goldoni108, o di una capacità di influire – “contaminandola” – sulla tradi-zione a stampa d’autore109, o addirittura di risorse concorrenziali nei con-fronti delle pubblicazioni autorizzate, in grado – rispetto a queste – di esibi-re anticipatamente alcuni inediti110. Sono dunque molteplici gli elementi diinteresse che – tanto da un punto di vista storico-culturale quanto stretta-mente filologico – inducono a valutare con attenzione queste edizioni, e nonsarà pertanto fuori luogo allineare qualche osservazione sulle loro più sa-lienti caratteristiche morfologiche.
All’ampia circolazione che conobbero nel mercato editoriale settecente-sco, nazionale ed europeo, (una circolazione tale da qualificarle, molto piùdi quanto non riuscirono ad esserlo le pubblicazioni promosse e assistitedall’autore stesso, come le vere artefici della diffusione e della recezionedel teatro goldoniano a stampa)111, fa oggi spesso riscontro una rilevantedifficoltà di recensione e, conseguentemente, di esatta valutazione della lo-ro originaria consistenza. Le principali tra queste edizioni, infatti (SanTommaso d’Aquino, Venaccia e Savioli: che più delle altre si distinsero per
108 O quanto meno ispirati a forme di benevolo patrocinio: rapporti, che se non identifi-cabili – allo stato attuale della ricostruzione documentaria – in più precisi contorni, postulanoevidentemente un’automatica rivalutazione dell’attendibilità filologica delle edizioni in causa.Gli stampatori di cui è sinora possibile documentare questo positivo legame con l’autore sonoil pesarese Gavelli, i torinesi Guibert e Orgeas e il livornese Masi.
109 Laddove non riconosciuta per tale, quest’influenza è destinata a creare consistentiequivoci interpretativi: per le debite esemplificazioni, cfr. infra, pp. 91-118.
110 E per di più dotati di una fisionoma redazionale diversificata – ma non per questo, ne-cessariamente, allografa o comunque spuria – rispetto a quella che sarà poi proposta dall’edi-zione d’autore. Alcuni volumi dell’EN hanno già proficuamente analizzato il ricco apporto diqueste edizioni non autorizzate, che hanno consentito di focalizzare la stratigrafia compositi-va dei testi (cfr. le edizioni citate supra, n. 9, cui si aggiunga La sposa persiana, cit., a cura diM. Pieri. Ricordo che nel caso de Il matrimonio per concorso, il curatore, Andrea Fabiano, haritenuto addirittura di dover riproporre a testo proprio la redazione “pirata”).
111 La personalità artistica a vario titolo più vicina al Goldoni del periodo francese,Charles-Simon Favart, colleziona, nella sua biblioteca di oltre 1.600 volumi, parte dell’“om-nia” bolognese del teatro goldoniano (accanto alla Bettinelli e alla Pitteri, e ad alcuni volumidella Pasquali: cfr. Catalogue abregé des livres de la bibliothèque de feu le citoyen Charles-Simon Favart, redigé par le citoyen Rozet, Paris, Rozet et Pyre, 1793, cit. in A. FABIANO,Alcune riflessioni..., cit., p. 57); Voltaire, il vero promotore del lancio europeo del «Molièreitaliano», pur essendo direttamente rifornito dall’autore stesso dei volumi Pasquali (cfr. lette-ra a Voltaire del 28 febbraio 1763, edita in F. FIDO, Le inquietudini di Goldoni, Genova, Co-sta & Nolan, 1995, pp. 138-139), disponeva della torinese Guibert e Orgeas. I cataloghi deipiù importanti editori settecenteschi, tanto di area veneta (Zatta e Remondini) quanto napole-tana (Terres e Porcelli), offrono, negli ultimi due decenni del secolo, innanzitutto le varie se-rie della Savioli (per la diffusione, anche sovranazionale, dell’edizione napoletana, cfr. A.SCANNAPIECO, Un editore goldoniano..., cit., pp. 70-71, 148-149 e passim).
68 ANNA SCANNAPIECO
tempestività, assiduità di frequentazione e/o respiro sistematico, e che non acaso molto più delle altre affollano le offerte dei cataloghi settecenteschi ele biblioteche dei lettori) avevano la caratteristica di assemblare i volumicon commedie (nel canonico numero di quattro al tomo) impostate tipogra-ficamente anche per una diffusione al minuto (a tal fine infatti ciascuna ve-niva dotata di un suo autonomo frontespizio, nonché, naturalmente diun’autonoma numerazione di pagine all’interno del volume): lo smerciodelle pubblicazioni poteva pertanto realizzarsi – a seconda delle convenien-ze e delle opportunità del mercato – in maniera flessibile, prevedendosi si-multaneamente sia la vendita alla spicciolata della singola opera quanto lasua proposizione organica nell’ambito di una raccolta. Inoltre, questa stessaflessibilità faceva sì che si potesse procedere a ristampe dei singoli “pezzi”maggiormente richiesti, o anche dell’intera raccolta, nell’ambito dei cuivolumi, tuttavia, poteva risultare inserita – per altra convenienza ancora di“smercio” – la stampa di una commedia appartenente a precedente impres-sione e rimasta invenduta (essendo inimmaginabile una nuova composizio-ne tipografica a fronte dell’esigenza di liberarsi da eventuali giacenze dimagazzino). Questa duttilità commerciale – direttamente proporzionale, tral’altro, alla varia tipologia del potenziale lettore goldoniano – unitamente alsuo aver costituito formula di successo (di cui non a caso si avvalse anchela pur ambiziosa edizione “d’autore” Zatta)112 ha naturalmente avuto pun-tuale riflesso nella conservazione del patrimonio librario e creato problemispesso intricatissimi di valutazione bibliografica: in primo luogo, la possi-bile presenza di frontespizi generali dei volumi recanti indicazioni tipogra-fiche difformi da quelle poi documentate nei frontespizi interni delle sin-gole commedie può – nell’ignoranza delle dinamiche compositive illustratesopra – avere di volta in volta indotto a forme di disorientamento bibliogra-fico e scetticismo filologico o di più sbrigativo sprezzo interpretativo; insecondo luogo, risultando occasionale la preservazione delle raccolte afronte di una vivace (ma naturalmente asistematica) persistenza di quei sin-goli pezzi che pure originariamente le componevano, si è spesso persa divista l’organicità se non l’esistenza stessa del piano editoriale di riferimen-
112 Cfr. A. SCANNAPIECO, Lo statuto filologico…, cit, pp. 137-138 e n. A quanto già ar-gomentato in quella sede si aggiunga la considerazione che, ancora nel 1806, del teatro gol-doniano il catalogo Zatta poteva offrire sia la monumentale raccolta in 44 volumi, che la ven-dita appunto dei singoli testi: «Per chi ne occorressero di separate delle suddette Commedie sipotrà darne della maggior parte di esse. Suo prezzo per cadauna L. 1:10» (Catalogo de’ librilatini, italiani, e francesi che si trovano vendibili presso la ditta Antonio Zatta qu: Giacomodi Venezia da esso stampati, e di quelli che nel suo negozio si ritrova averne in maggior nu-mero, Venezia, 1806, p. 44).
Per una mappa della produzione goldoniana 69
to; in terzo luogo, la possibilità che un singolo collezionista si creasse la suapersonale raccolta goldoniana attraverso l’assemblaggio (del tutto fortuito,in base al materiale accidentalmente posseduto; o amatoriale, in base a per-sonali preferenze estetiche) di singoli “pezzi”, e che la “nuova” identitàeditoriale così fortunosamente definitasi ricevesse relativa certificazione nelcatalogo di una biblioteca, ha prodotto ulteriori complicazioni e indefinitepossibilità di equivoco interpretativo.
La communis opinio che queste edizioni-pirata realizzassero, disordina-tamente e a posteriori, gli assemblaggi dei volumi con del materiale per cuioriginariamente era prevista la sola vendita al dettaglio (in una prospettivadi consumo povero, e dunque – a monte – di allestimento tipografico sciattoe filologicamente poco credibile)113 non ha in realtà alcuna sussistenza sto-rica e bibliografica114. Che la composizione dei volumi non fosse stata se-
113 «La ristampa del Corciolani [= San Tommaso d’Aquino] […] offriva, a costi proba-bilmente ridotti, singole commedie tratte dalla Paperini secondo le richieste del pubblico lo-cale: senza un preciso disegno editoriale che non sia la conclamata fedeltà agli originali. […]Tra il ’54 e il ’55 escono, così, 17 commedie giusta l’edizione fiorentina. Poi la lunga interru-zione dovuta ai ritardi dell’autore indurrà il Corciolani a mutare obiettivo, gettandosi sullariproduzione del Nuovo Teatro Comico»: così, pur nell’ambito di una puntualissima indaginesulla stamperia Paperini, poteva non molti anni fa esprimersi l’autorevole opinione di RenatoPASTA (La stamperia Paperini…, cit., p. 100n; il corsivo è mio), destinata inevitabilmente ainfluenzare anche l’ambito dell’applicazione filologica, già al riguardo particolarmente con-dizionata dalle fuorvianti indicazioni della Bibliografia goldoniana dello Spinelli(nell’ambito dell’Edizione Nazionale, ad esempio non è mancato chi sia arrivato addirittura amettere in discussione «l’effettiva esistenza di una raccolta di commedie goldoniane regolar-mente edita da Corciolani a partire dal 1753»: cfr. M. AMATO, Nota al testo, cit., p. 81). Inrealtà, non solo la San Tommaso non si limitò alla ristampa di 17 commedie “paperiniane”(per di più offerte singolarmente e selezionate in base ai gusti degli acquirenti locali), ripro-ducendo invece integralmente l’edizione fiorentina (e anche a costo di ristampare le comme-die già edite nella precedente redazione Bettinelli), ma si distinse sempre – nella sua lunga earticolata frequentazione dell’opera goldoniana – per tempestiva sistematicità di riproduzionee finanche esplicitazione preventiva dei progetti editoriali perseguiti (cfr. infra, passim).
114 Oltre a quanto argomentato a testo, si consideri la fisionomia delle suddette edizionicome ricostruita infra, § 5. Gioverà sin d’ora precisare che solo nel caso di alcuni volumidella San Tommaso e della Savioli (rispettivamente i t. II-IV della terza serie e il t. XIV dellaseconda) gli editori dovettero effettivamente far precedere la vendita del volume da quelladelle singole commedie: ma la circostanza è da ascrivere a ragioni indipendenti dalla lorovolontà, e cioè a quella mancanza di materiale sufficiente alla composizione del volume do-vuta alla lunghissima sospensione e poi alla definitiva interruzione della Pasquali (sulle cuicommedie inedite era appunto giocata la composizione dei nuovi tomi). Una riprova inequi-vocabile è data da quanto programmaticamente previsto nella prefazione alla terza seriedell’edizione bolognese: «La sontuosa novella Edizione di tutte l’Opere del celebre Sig. Av-vocato Goldoni, la quale si stà attualmente lavorando in Venezia dal Sig. Pasquali, viene (persentimento ancora dell’Autor medesimo) consegrata alle persone magnifiche, e di buon gusto
70 ANNA SCANNAPIECO
riore rispetto ad una commercializzazione individuale dei testi (e che sem-mai le due modalità di vendita dovettero – come si accennava – svilupparsiparallelamente) è attestato finanche nel caso dell’edizione che, fra tuttequelle considerate, più facilmente potrebbe autorizzare l’ipotesi contraria.Nella napoletana Venaccia, infatti, i frontespizi generali dei vari volumi ri-sultano (ad eccezione di quello del primo) privi di note tipografiche (recanosolo il titolo complessivo dell’opera, la numerazione progressiva del tomo el’indicazione delle commedie contenute), mentre la completezza informati-va è propria solo di quelli interni delle singole commedie: sicché sarebbedel tutto legittimo interpretare il dato alla luce appunto dell’ipotesi di unraccoglimento a posteriori (governato dalla casualità e da un mero interessedi svendita) di pezzi editi originariamente sciolti e poi magari rimasti in-
[…]. Ma come render soddisfatti coloro, che stimano egualmente, anche senza fregio esterio-re, le Opere di sì valente Soggetto; ed essendosi già proveduti d’altre edizioni, ne desidereb-bero perciò la continuazione, senza aggravio di nuova notabile spesa? […] Per proveder dun-que a tutto, si è giudicato di ristampare soltanto le produzioni, che sono state finora inedite,insieme colle sue prefazioni, coll’andarne poscia racapezzando alcuni Tomi di mano in mano,che ne compariranno alla luce. Finora quattro sono i Tomi comparsi della Edizion Veneta; masiccome una sola Commedia non più stampata si contiene in ciascheduno di essi, così noi pre-sentiamo al Pubblico queste quattro in un primo Tomo […]. In questa guisa non si viene apregiudicar punto né all’Autore, né a’ Compratori, né a noi medesimi. […] Non finalmente anoi medesimi, che saremmo anzi per lo contrario danneggiati non poco per l’incagliamentodella passata nostra edizione [la seconda serie, ristampa della Pitteri, poi portata a termine – aseguito della tardiva ripresa dell’edizione veneziana – nel 1764], che si troverebbe allora im-perfetta, e mancante di queste nuove Commedie, le quali vengono dag’Intendenti riputateforse delle migliori» (Gli stampatori a chi legge, in Delle commedie del signor Carlo Goldoniavvocato veneto tomo I. Per servire di continuazione al Nuovo Teatro Comico del medesimoautore, Bologna, S. Tommaso d’Aquino, 1762, pp. iniziali non numerate). Se la formazionedel primo volume era stata resa possibile dal fatto che entro il 1762 erano state pubblicate –nei primi quattro tomi Pasquali (1761-1762) – le commedie necessarie all’assemblaggio, inseguito il tormentato sviluppo della nuova edizione veneziana (per una cui ridefinizione cro-nologica, cfr. infra, pp. 214-217) avrebbe impedito a quella bolognese di realizzare, nei modioriginariamente definiti, il proprio progetto. Al punto che si potrebbe ragionevolmente ipotiz-zare che fu proprio la volontà di far comunque fronte ai propri impegni (e, beninteso, alleproprie convenienze) editoriali a spingere la San Tommaso a rifornirsi indirettamente delmateriale utile alla composizione dei volumi: di qui gli inediti (fortunosamente e fortunata-mente pervenuti sino a noi) del Todero (1772), della Scozzese (1772), del Matrimonio perconcorso (1775, ma è data di ristampa: nell’esemplare preservato c’è infatti indicazione direimprimatur, rilasciato in data 5/9/1775) e forse anche dell’Impresario delle Smirne (il fattoche l’esemplare a noi pervenuto dell’edizione bolognese di questa commedia presenti la reda-zione autorizzata dall’autore, ed edita nel t. XII Pasquali, non esclude che in precedenza laSan Tommaso non avesse già pubblicato quella redazione originaria in versi che ci è stataconservata solo attraverso la mediazione della Savioli: essendo una pratica già sostenuta nelcaso della Scozzese, come ricordato infra, n. 128).
Per una mappa della produzione goldoniana 71
venduti e quindi riciclati nella nuova formula della raccolta. Che le cose in-vece non fossero andate così, nemmeno per l’edizione napoletana, ci è ga-rantito dagli annunci pubblicitari della Gazzetta di Napoli, che periodica-mente informava i propri lettori della pubblicazione dei vari volumi goldo-niani editi dal Venaccia, non mancando di illustrare le commedie contenutein ciascuno di essi115, e che ci consente quindi di verificare in modi inequi-vocabili l’originaria configurazione dell’edizione come raccolta (confer-mata d’altro canto anche dalle coincidenze combinatorie osservabili nei po-chi esemplari superstiti di commedie raccolte in volume: laddove invecenon fosse esistito un assemblaggio originario, ci si sarebbe dovuti attendereprincipi combinatori variamente difformi e del tutto casuali).
Altrettanto indiscutibili i riscontri documentari allegabili nel caso dellaSan Tommaso e della Savioli. Per quanto riguarda quest’ultima, non fatanto fede il documentato rilascio di una licenza di stampa relativa appuntoa un’edizione complessiva di commedie (e non a singole commedie)116, an-che se poi la preservazione della corrispettiva pubblicazione dovrebbe di
115 Cfr. ad esempio il «Foglio ordinario» del 12 gennaio 1762, n° 3: «Si fa noto a’ SignoriLetterati, e curiosi, come è uscito alla Luce il Tomo 18. delle Comedie del Dottor Carlo Gol-doni; il detto Tomo contiene le seguenti Comedie, intitolate Il medico olandese, La donnastravagante, L’amante di sé medesimo, Ircana in Ispaan. Si vende ligato in Carta pergamenaal solito prezzo di grana 25. da Giacomo Antonio Venaccia nel Corridojo del Conseglio».
116 Il mandato di stampa per la prima serie dell’edizione Savioli (cfr. infra, pp. 232-233),rilasciato in data 16 luglio 1770, fa infatti riferimento a «Libro intitolato: Le Commedie delDott. Carlo Goldoni, divise in Tomi X ec. stampate» (Archivio di Stato di Venezia, Riforma-tori dello Studio di Padova, f. 342, c. 40, no 317. La licenza è riprodotta nel t. I della primaserie). Il dato documentario, pur molto significativo, non può essere tuttavia ritenuto incon-trovertibile perché il permesso di stampa non costituisce, di per sé, garanzia inequivocabile diconcreta realizzazione editoriale (si poteva cioè ottenere il mandato e poi non procedere allastampa: cfr. M. INFELISE, L’editoria veneziana nel ’700, cit., p. 63n). Nel caso specifico, in-vece, l’editore Agostino Savioli che aveva chiesto ai revisori licenza per la ristampadell’edizione Paperini (come desumibile dall’indicazione di «tomi X» e di «stampate»), diedepoi effettivamente luogo alla riproduzione in quella che oggi può essere classificata come laprima serie Savioli (1770-1772), in tredici volumi: il maggior numero di tomi rispettoall’originale riprodotto è dovuto alla diversa opzione combinatoria praticata dall’editore ve-neziano, che – in linea con la prassi ormai divenuta dominante – preferì allineare quattrocommedie per tomo, laddove la Paperini ne aveva raccolte cinque; proprio per equilibrare lacomposizione degli ultimi due volumi – che altrimenti sarebbero risultati costituiti di sole trecommedie – l’editore ricorse all’inserimento di due opere (la cui collocazione nella raccoltarisulterebbe altrimenti inspiegabile, essendo proprie di tutt’altra fase dell’itinerario artistico-editoriale goldoniano) alla cui realizzazione aveva nel frattempo proceduto in diverso conte-sto editoriale (L’amor paterno, t. XII, la cui collocazione “propria” ricorre nel medesimo vo-lume della seconda serie: cfr. infra, p. 234; la traduzione di Piero Candoni del Bourru bienfai-sant, t. XIII, che era all’origine pubblicazione autonoma, ideata e tempestivamente realizzataa immediato ridosso dell’ultimo grande successo spettacolare del «Molière italiano»).
72 ANNA SCANNAPIECO
per sé persuaderci che la proposizione dei testi in volume era effetto diun’ideazione originaria, e non di un assemblaggio seriore; quanto il fattoche anche a proposito di quest’edizione (come già per la Venaccia), la pub-blicistica contemporanea dava notizia della pubblicazione dei vari volumi(e non, eventualmente, delle singole commedie) e giungeva addirittura alpunto di allinearla alle precedenti edizioni d’autore117. Pertanto, anche aproposito della Savioli, sarà bene abbandonare fuorvianti categorie inter-pretative118 e prendere atto di avere a che fare con un progetto editoriale or-
117 Un accreditato goldonista come Domenico Caminer, ad esempio, nell’ambito di unarecensione del t. XI Pasquali, poteva ricordare ai lettori che stava anche procedendo la «ri-stampa delle Commedie, e delle Opere Comiche del S. Goldoni dal S. Agostino Savioli, ilquale ha già pubblicato il Tomo V della seconda raccolta del Teatro Comico […]. Qual mag-gior elogio per il nostro concittadino Comico poeta, oltre a quello di tante ediz.!» («GiornaleEciclopedico», t. I, Gennajo 1774, Venezia, Nella Stamperia Fenziana, p. 22; non sfugga ilriferimento ad una «seconda raccolta», che richiama evidentemente la nota – e riconosciutaper tale – esistenza della prima serie). In precedenza, dando notizia dell’avvenuta pubblica-zione (cfr. supra, n. 116) del Burbero benefico, così aveva potuto magnificare il “best-sellerCarlo Goldoni”: «Nessun Autore certamente potrà vantarsi, che tante Edizioni delle numeroseproprie Opere siano state fatte lui vivente, quante ne vede il Sig. Dottor Carlo Goldoni, il ve-ro, e solo Riformatore del nostro Teatro Italiano, mio Compatriota, e mio buon amico. Quat-tro sinora se ne fecero a Venezia, fra le quali la bellissima con rami coll’assistenza dell’A.fatta dal Pasquali, condotta fino al X. Tomo, e che ora si proseguisce» («L’Europa letteraria»,t. III, p. I, Gennaro 1772, Venezia, Nella Stamperia Fenziana, p. 74). A quest’altezza crono-logica, le «quattro edizioni» realizzate a Venezia sono, oltre la menzionata Pasquali, la Betti-nelli, la Pitteri e, appunto, la Savioli (prima serie).
118 A tutt’oggi purtroppo variamente diffuse anche nella valutazione della Savioli, e ac-creditate anche da alcuni curatori dell’EN: per citare solo i più recenti, cfr. R. RICORDA, Notaal testo de Un curioso accidente, EN, 1998, p. 49 ed E. MATTIODA, Nota al testo de Il cava-liere di spirito, in C. GOLDONI, Teatro di società, a cura di E. M., EN, 1998, p. 134.L’autorità chiamata in causa, in entrambi i casi, è quella di L. RICCÒ, Nota ai testi, in C. Gol-doni, La castalda, cit., pp. 86-87, che peraltro sapeva argomentare – e ad un’altezza cronolo-gica in cui la “renovatio bibliografica” goldoniana era ancora in una fase iniziale di espres-sione – in termini problematici delle difficoltà di recensione poste dall’edizione Savioli, sot-tolineando la necessità di un preliminare censimento degli esemplari superstiti e di una loroadeguata valutazione bibliografica prima di poter «sperare di dipanare l’intricata matassa». Ilgroviglio della matassa ha invece talora scoraggiato atteggiamenti di cautela interpretativa e,purtroppo, anche indotto ad una certa superficialità analitica e descrittiva: si veda ad esempiocome nella Nota al testo de Il cavaliere di spirito, cit., il Mattioda possa attribuire alla secon-da serie Savioli il fantasioso titolo di Opere drammatiche, pur avendo in precedenza offerto, ap. 129, una trascrizione – per quanto semidiplomatica e incompleta – del relativo frontespi-zio; o come possa perentoriamente asserire (ivi, p. 134) che l’editore veneziano non avrebbestampato né L’apatista né La donna bizzarra, che invece Savioli fedelmente riprodusse, in-sieme alle altre due commedie che componevano il decimo tomo Pitteri, in quel decimo tomodella sua seconda serie la cui esistenza al Mattioda dovrebbe esser pur ben nota, giacché necita a più riprese il frontespizio (cfr. ivi, pp. 129 e 498). Ma per i numerosi limiti del volume
Per una mappa della produzione goldoniana 73
ganico nell’ideazione e coerente nelle modalità di realizzazione (il che noncomporta affatto, si badi bene, il coinvolgimento di altri interessi che nonfossero quelli squisitamente commerciali dello stampatore, assolutamenteestraneo a qualsiasi logica di cura redazionale o – come si è addiritturagiunti a sostenere – di vaglio filologico degli antigrafi da riprodurre)119.
EN curato dallo studioso, cfr. anche infra, nn. 119-120, 188 e nel § 4 le osservazioni di cui ainni 101, 107, 114, 115, 148, 191.
119 Al termine di un’analisi che avrebbe ambito far per la prima volta chiarezza sulla Sa-violi, Alessandro ZANIOL poteva dichiarare: «è evidente quindi che chi allestì l’edizione Sa-violi non agì con leggerezza e non intese solo ristampare alla bell’e meglio, anche se in formacompiuta come mai prima, le opere di un autore di moda; chiunque fosse, ha controllato chela redazione dei testi da pubblicare rispondesse al criterio di pubblicare le versioni ritenutemigliori» (Per una rilettura..., cit., p. 214; il corsivo è mio). Come sarà dimostrato partita-mente in seguito, l’editore veneziano invece si distinse proprio per totale disinteresse versoqualsivoglia forma di cura filologica dei testi e non ebbe mai a porsi eventualmente il pro-blema di quale redazione scegliere, perché semplicemente si limitava a riprodurre quella chegli trasmetteva l’antigrafo di cui soprattutto ebbe ad avvalersi (come vedremo, la San Tom-maso). Non a caso uno dei punti di forza dell’analisi di Zaniol vorrebbe essere il casodell’Uomo prudente, che Savioli, nonostante le significative varianti apportate dall’autorenell’ambito dell’edizione Paperini, riproduce nell’originaria redazione Bettinelli; per motiva-re la circostanza, lo studioso, dopo aver ricondotto la rielaborazione paperiniana a motivi diordine coatto (Goldoni avrebbe modificato il testo «più per accontentare» i cosiddetti «mora-listi […] che per ragioni intimamente sentite»), si spinge ad asserire: «ora, negli anni settanta,Goldoni, definitivamente stabilitosi in Francia, lontano da Venezia, vive un altro clima cultu-rale e fa riferimento ad una tradizione teatrale che conosce molti altri esempi di commediedegli inganni sul genere del suo primo Uomo prudente. Non sarebbe quindi troppo sorpren-dente se la scelta di eliminare ogni paludamento apologetico per tornare al testo originario[…] fosse attuata col suo benestare» (ivi, pp. 205-206). Che sovradeterminare il significato diun’opzione editoriale, materiata in realtà di tutte le accidentali scorie della storia, possa com-portare il rischio di incorrere in gravissimi equivoci interpretativi (tali da incidere addiritturasulla valutazione complessiva dell’itinerario artistico-ideologico dell’autore) è eloquente-mente comprovato proprio dal caso specifico di questa commedia, che Savioli in realtà ripro-duce nell’originaria versione Bettinelli perché questa gli giunge, per moto inerziale e non perdeliberate scelte redazionali, dal ramo della tradizione a cui attinge: avendo a suo tempo do-vuto l’edizione bolognese (1752-1753) della commedia, di cui Savioli si avvale come antigra-fo, optare obbligatoriamente per la Bettinelli (la rielaborata redazione Paperini sarebbe statoedita solo nel 1754, all’interno del t. V). In queste stesse forme “primitive” la commedia poigiungerà alla Zatta, e non certo perché l’ultimo editore autorizzato dall’autore si sarebbe ispi-rato ad «una scelta di origine artistica ben precisa, il ritorno cioè al testo migliore» (ivi, p.218), ma perché semplicemente si limitava a riprodurre l’antigrafo di riferimento (come ve-dremo, la Guibert e Orgeas), che a sua volta aveva dovuto attingere alla Savioli.Sulla sistematicità delle dinamiche in questione, si forniranno in seguito i dovuti riscontri;gioverà per il momento insistere sul fatto che, proprio in riferimento alla Savioli (ma non so-lo), il contributo dello Zaniol ha messo in circolazione una serie di dati infondati e fuorviantiche possono purtroppo godere ancora di qualche credito: dal definire l’edizione Savioli delBugiardo «uno dei rarissimi casi di contaminazione tra più stesure nell’ambito delle edizioni
74 ANNA SCANNAPIECO
Come organici e coerenti erano naturalmente stati anche la progettazio-ne e lo sviluppo di quello che, in moltissimi casi, fu l’antigrafodell’edizione veneziana, e cioè la bolognese San Tommaso d’Aquino (che,sia detto per inciso, è del tutto fuori luogo menzionare come “Corciolani-Colli”)120. Nel caso di questa edizione – vera spina dorsale, per tutto il se-
settecentesche goldoniane», perché a suo dire presenterebbe un testo che sia pur «esemplatoevidentemente dalla versione Pasquali» recuperebbe poi il finale paperiniano con il bargello(ivi, pp. 211-212, il corsivo è mio), laddove la Savioli presenta invece una redazione chiara-mente esemplata dalla Paperini, attraverso la solita mediazione bolognese; al qualificare laprima serie Savioli in tomi quindici e in undici la seconda (ivi, p. 191), laddove risultano co-stituite rispettivamente da tredici e quindici tomi (come d’altronde aveva visto bene persino ilbuon Spinelli: cfr. Bibliografia goldoniana, cit., pp. 123-133); al postulare addirittural’esistenza di una «seconda Pitteri», presunta continuazione della precedente edizioned’autore, che è in realtà una Savioli contraffatta (come del resto aveva già mostrato di capire– e sia pur intuitivamente, e con tutta l’approssimazione bibliografica del caso – GiuseppeOrtolani, allorché aveva occasione di segnalare le varianti di una «Savioli-Pitteri»). Su que-st’ultimo motivo ritengo di aver già fornito altrove i chiarimenti necessari a sfatare l’imbaraz-zante equivoco interpretativo (cfr. Ancora a proposito…, cit., p. 283n); sorprende pertantoche esso trovi ancora credito, e anche tra i curatori dell’Edizione Nazionale (cfr. E. MAT-TIODA, Nota al testo, cit., pp. 133 e 253).
120 Assieme agli Eredi Colli, Girolamo Corciolani fu infatti solo il direttore della stampe-ria (che dal 1721, a seguito della donazione di Luigi Ferdinando Marsili, era divenuta pro-prietà dell’Ordine domenicano, al cui fondatore – per espressa volontà del Marsili stesso –rimase appunto intitolatata) e solo dal 1749 al 1759: difatti solo in questo lasso di tempo an-che il loro nome – non a caso seguito dalla specificazione, che poi nei decenni successivi ri-marrà come unica denominazione, «a S. Tommaso d’Aquino» – certifica sui frontespizil’identità editoriale delle pubblicazioni. In seguito, alla direzione della stamperia si avvicen-darono Giuseppe e Giacomo Taruffi (fino al 1774), Petronio della Volpe (fino al 1787), Giu-seppe Lucchesini (già collaboratore nella precedente conduzione Della Volpe, amministreràla San Tommaso fino ai primi anni del secolo successivo. Sulla sua figura, cfr. E. COLOMBO,Giuseppe Lucchesini stampatore-libraio bolognese tra ’700 e ’800: inventario del carteggioe documenti, in «Archiginnasio», LXXIX, 1984, pp. 287-311; C. DI CARLO, Giuseppe Luc-chesini libraio e tipografo a Bologna, in «Nuovi annali della Scuola Speciale per Archivisti eBibliotecari», VII, 1993, pp. 341-377). La varia gestione della stamperia è ricostruita inquello che a tutt’oggi rimane il più documentato studio sull’argomento (V. ALCE, La stampe-ria bolognese di San Tommaso d’Aquino, in «Culta Bononia», VI, 1974, pp. 29-60; per lospecifico di quanto ricordato sinteticamente in questa sede, cfr. pp. 30-40); sorprende pertantoil constatare che talora proprio dagli esperti di problematiche filologiche goldoniane il sud-detto studio, sia pur citato, risulti sostanzialmente ignorato (e capita di vedere ripetutamenteattribuita all’«editore bolognese Corciolani» – a cui i domenicani avevano rescisso il con-tratto già dal dicembre del 1757 – la produzione di un volume goldoniano edito nel 1763, eche in quanto tale – naturalmente – sin dal frontespizio risulta intitolato esclusivamente «a S.Tommaso d’Aquino»: cfr. E. MATTIODA, Nota al testo, cit., pp. 128, 133, 246, 254).Proprio perché la vera identità editoriale delle pubblicazioni realizzate dalla stamperia èquella di «S. Tommaso d’Aquino» ed è appunto questa la denominazione costantemente ri-corrente sui frontespizi delle relative realizzazioni tipografiche (e addirittura continuerà ad
Per una mappa della produzione goldoniana 75
colo, della diffusione a stampa del teatro goldoniano e autentico snodo, co-me vedremo, della tradizione testuale – i riscontri sono molteplici quantoinoppugnabili: dall’aver espresso la sua ineguagliata sistematicità ripropo-nendo in tre (e forse anche quattro)121 distinte serie tutto ciò che le edizionipatrocinate dall’autore erano venute immettendo sul mercato (rispettandonesostanzialmente l’ordinamento originario e riproducendone i contenuti constraordinaria celerità)122, all’aver – soprattutto – preventivamente esplicita-to, nelle relative sedi prefative, finalità e contenuti delle raccolte stesse123.
Si tratta dunque di edizioni che, lungi dal situarsi ai margini della tra-smissione testuale esprimendosi in forme approssimative e caotiche di alle-stimento tipografico, sollecitano varie ragioni di interesse bibliograficoproprio per la meditata ideazione e il respiro sistematico che le contraddi-stingue. Sono soprattutto edizioni che si impongono con forza all’attenzionefilologica e per il loro proporre anche ristampe interne alle proprie pubbli-cazioni (sintomo di uno smercio rapido e – a monte – di una perdurantefortuna del libro goldoniano, ma anche espressione di una cura tipografica
esserlo, per qualche anno, anche dopo la soppressione dell’ordine dei domenicani: cfr. C. DICARLO, Giuseppe Lucchesini..., cit., p. 358), è con questa stessa denominazione che andrannodefinite anche le pubblicazioni goldoniane: se improprio è dunque citare come “edizioni Cor-ciolani” i volumi delle raccolte goldoniane che uscirono fino al 1759, del tutto erroneo èl’impiego della stessa indicazione per citare tutti quelli degli anni successivi. Non si tratta diuna questione meramente nominale (e quand’anche fosse, avrebbe un valore di per sé sostan-ziale nell’ambito di una recensione bibliografica): il fatto che la stamperia di un ordine dome-nicano (in stretto contatto fra l’altro con i responsabili del S. Officio, la cui sede a Bolognaera appunto presso il convento di San Domenico Maggiore), a prescindere dalle politicheeditoriali che poterono contraddistinguere l’operato dei vari direttori ingaggiati per la condu-zione, alimentasse per circa mezzo secolo i propri torchi con la produzione del teatro goldo-niano, è evidentemente un dato di grande rilievo culturale.
121 Cfr. infra, pp. 225-226, 230-232, 236.122 Risulta evidente la fedeltà all’impianto della Pitteri (riprodotta nella seconda serie);
per quanto riguarda la sostanziale aderenza anche a quello della Paperini (replicata, dopo lariproposizione dei primi tre tomi Bettinelli, nella prima serie) e l’avveduto utilizzo della Pa-squali (i cui inediti andarono a costituire la terza serie), cfr. infra, pp. 220-221). L’estremavelocità con cui i volumi delle varie edizioni d’autore venivano ristampati è attestato dai tem-pi di realizzazione dei corrispettivi bolognesi, individuabili non solo e non tanto attraverso irelativi frontespizi, quanto anche e soprattutto attraverso le date in cui venivano rilasciati gliimprimatur (quasi sempre verificabili all’interno degli esemplari superstiti).
123 Tutte e tre le serie di cui si è ricostruita la struttura e si sono individuati i relativiesemplari recano infatti una prefazione editoriale (pratica invece non sostenuta né dalla Ve-naccia né dalla Savioli) che illustra al lettore lo spirito della nuova iniziativa, sottolineandoneil carattere organico e anche – per la seconda e per la terza raccolta – i rapporti di studiatacontinuità con le precedenti realizzazioni. Si tratta di documenti estremamente interessanti,anche per lo specifico delle strategie argomentative messe in opera, su cui meriterà soffer-marsi diffusamente in altra sede.
76 ANNA SCANNAPIECO
pronta a sanare in fase di ricomposizione dei piombi eventuali refusi inter-corsi nella precedente impressione)124 e, più in generale, per il loro saper
124 Chi ha avuto modo di collazionare anche le ristampe interne di queste edizioni cosid-dette collaterali ha potuto infatti verificare non – come sarebbe stato lecito attendersi in unadiversa prospettiva d’indagine, non confortata dalla conoscenza degli elementi che si sta ten-tado di mettere a fuoco – l’espressione di un rozzo sciacallaggio editoriale, ma la capacità disorvegliare la tenuta redazionale della precedente composizione tipografica e di esprimereladdove necessario interventi correttori (cfr. A. SCANNAPIECO, Lo statuto filologico…, cit, pp.146-147; M. AMATO, Nota al testo, cit., p. 83).Diverso il caso (attestato ripetutamente nella pratica editoriale della San Tommaso) di unacommedia ristampata nella rielaborata redazione che una nuova pubblicazione d’autore avevanel frattempo garantito: segno espesso di come l’avvedutezza commerciale sapesse declinarsisecondo i termini di una pronta sensibilità “filologica”.Diverso ancora, e variamente problematico, il caso di un’edizione che addirittura sindall’inizio si definisce con una duplice composizione tipografica: è quanto ad esempio haavuto modo di verificare l’attenta recensione della trasmissione testuale effettuata da Ricciar-da RICORDA per Un curioso accidente, in cui è appunto emersa la diversa configurazione re-dazionale di due esemplari Savioli, realizzati nello stesso 1774, della commedia (cfr. Nota altesto, cit., pp. 49-50). La Ricorda notava come le stampe in questione, pur essendo inserite indue esemplari dello stesso tomo (il dodicesimo della cosiddetta Savioli-Pitteri, per cui cfr.infra, pp. 222-223) presentassero «sensibili difformità», e ne dava estesa descrizione; nontrascurando di informare che il secondo dei suddetti esemplari è «privo di frontespizio e pro-pone un assemblaggio di commedie un po’ diverso», ma riconducendo «la diversa composi-zione dei tomi» alla presunta pratica dell’editore di «organizzare in raccolta con successivafascicolazione» i «volumetti singoli» originariamente stampati. Il dato che non bisogna perde-re di vista è che la situazione testuale documentata per il Curioso accidente attesta la possibi-lità che, in un medesimo anno, l’editore realizzasse la stampa di una stessa commedia attra-verso due composizioni tipografiche diverse: la circostanza – di cui ho avuto modo di riscon-trare il ricorrere nel caso di altre opere – ha un indubbio interesse storico, nella prospettiva dimonitorare l’impegno produttivo di queste edizioni “minori” e di sondare, a monte, la variadiffusione delle stampe goldoniane; e ancora una volta induce ad assumere un habitus filolo-gico particolarmente vigile. Ma giova in limine guardare un po’ più da vicino l’intricata que-stione relativa proprio al Curioso accidente, giacché l’interpretazione proposta dalla Ricorda(assemblaggio casuale, perché seriore, di stampe originariamente sciolte) sembrerebbe con-traddire in pieno a quanto ai è tentato sinora di dimostrare in questa sede. Il primo dei dueesemplari analizzati (Venezia, Biblioteca di Casa Goldoni, 28.D.3/4) riprone, come si diceva,la commedia nell’ambito del t. XII della cosiddetta “finta Pitteri” (commedie contenute:L’amore paterno, La guerra, Un curioso accidente, La donna di maneggio): è un volume cherisulta strutturato – come quasi sempre nelle produzioni goldoniane del Savioli – con grandefedeltà all’antigrafo bolognese (in questo caso il t. II della terza serie), e dovrebbe dunqueriflettere la fisionomia originaria della realizzazione (e, ancor prima, dell’ideazione) editoria-le. Perché allora il secondo dei due esemplari in questione (ivi, 44.D.8/11) presenta un diversoordinamento interno (al posto dell’Amore paterno risulta inclusa la Casa nova) e, soprattutto,una diversa composizione tipografica? Il fatto è che – come notava la stessa Ricorda – il sud-detto esemplare risulta privo di frontespizio: per essere più precisi, i titoli delle commediecontenute sono annotati a mano nel risvolto della legatura. L’analisi del volume ci porta a
Per una mappa della produzione goldoniana 77
spesso indicare, rispetto ad eventuali lacune (non sempre peraltro evidenti)degli antigrafi a stampa d’autore, varianti emendative che – per la qualità ela pertinenza loro proprie – possono essere proficuamente messe a fruttoanche dal moderno editore.
Ricostruirne le coordinate produttive serve dunque a qualificare un im-portantissimo ramo della tradizione testuale, che non può non rivestiregrande rilievo nell’espressione di una pertinente prospettiva filologica: nonsolo perché contribuisce in maniera determinante a misurare la qualità delladiffusione e della recezione dei testi goldoniani, ma anche perché di queitesti si fece spesso promotore attivo. Come già accennato, è a questa tradi-zione “apocrifa” che non di rado si deve la possibilità di sondare l’altrimen-ti imperscrutabile stratigrafia compositiva della drammaturgia goldoniana,avendoci essa talora garantito la preservazione di redazioni originarie o co-munque difformi da quelle poi trasmesse nelle edizioni autorizzate: difatti,l’alacrità con cui questi editori assecondarono la domanda del prodotto gol-doniano, li spinse ad incrementarne l’offerta, soprattutto laddove la stenta-tissima realizzazione della Pasquali aveva cominciato a determinare penuriadi “materia prima”. Già la meritoria edizione di Ortolani aveva saputo get-
concludere che si tratta di un assemblaggio seriore sì, ma perché dovuto non all’editore ma adun collezionista (presumibilmente tardottocentesco), che tenta con “pezzi superstiti” di simu-lare la composizione del dodicesimo tomo della cosiddetta Savioli-Pitteri: l’aver potuto di-sporre (si ricordi la modalità, precedentemente descritta, della duplice circolazione – tanto inraccolta quanto in volumetti individuali – di queste pubblicazioni goldoniane) di una copiadella Casa nova (che nel piano originario dell’edizione figurava invece nel t. XIII) e non diuna dell’Amor paterno, ebbe a determinare la diversa combinazione dei testi nel volume.Quanto alla diversa composizione tipografica – che ha dato luogo a una diversa configurazio-ne redazionale – è dovuta alla pratica che come s’è visto, l’editore ebbe a sostenere di darluogo – per presumibili ragioni di intenso smercio del prodotto – a più realizzazioni tipografi-che di una stessa commedia nel medesimo anno. Da quello che si è potuto sinora verificare,sembrerebbe che le due diverse composizioni fossero subordinate alle due diverse destinazio-ni di vendita: sicché ad esempio nel caso del Curioso accidente si dispone di un assetto reda-zionale definito per la stampa destinata allo smercio individuale (e poi, come s’è visto, con-fluita per assemblaggio “apocrifo” nel volume conservato nella Biblioteca di Casa Goldoni,44.D.8/11) e di un altro realizzato per la composizione in volume (preservato, insieme allaconfigurazione originaria del tomo, nell’esemplare di 28.D.3/4); la riprova è data dai testimo-ni Savioli superstiti nel caso de La guerra, per la quale, oltre a disporre degli stessi esemplariconservati per il Curioso accidente (figurando le commedie nello stesso t. XII della secondaserie Savioli), possiamo avvalerci anche della copia di una stampa sciolta (Biblioteca di CasaGoldoni, 4.A.44): quest’ultima presenta una composizione tipografica assolutamente identicaa quella dell’esemplare accidentalmente conservato nell’assemblaggio posticcio (e come giàdetto, originariamente circolante invece come volumetto individuale), ed è dunque da ritener-si che siano derivati da una stessa impressione, diversa da quella che diede luogo alle stampedestinate alla raccolta in volume.
78 ANNA SCANNAPIECO
tare luce su qualcuna di queste redazioni “spurie”125, ma la mancanza dispecifiche competenze filologiche126 e lo stato ancora embrionale – quandonon rudimentale – della ricostruzione bibliografica non potevano consentirealla prima omnia novecentesca di focalizzare in modi meno occasionali laqualità degli apporti di questo nevralgico settore della tradizione testuale.Come già accennato in precedenza127, le prospettive filologiche odiernehanno già mostrato di saper mettere a frutto la più matura ricomposizionedel quadro documentario di riferimento; quello che gioverà ora sottolineareè che sono proprio, e non a caso, le tre edizioni su cui ci siamo sinora in-trattenuti ad essersi distinte, nel pur articolatissimo quadro della trasmissio-ne testuale settecentesca, per la capacità di garantire al proprio pubblicoopere che l’autore non aveva ancora (e non avrebbe forse mai, in quelleforme) destinato alla lettura128. Anche se in futuro si dovrà guardare con pa-ziente attenzione a tutte le edizioni non d’autore (lo dimostral’“inquietante” caso della romana Puccinelli – sino a poco tempo fa peraltroneanche conosciuta129 – che, pur apparendo del tutto periferica e ininfluentenella sua natura di copia descripta delle due serie Savioli, è stata invece ca-pace di conservarci la redazione originaria della trilogia di Zelinda e Lindo-
125 Per esempio la redazione in versi dell’Impresario delle Smirne, conservata nel t. XIVdella seconda serie Savioli (ma forse originariamente immessa sul mercato dalla San Tomma-so D’Aquino: cfr. supra, n. 114). Alla Savioli si deve la princeps del Rinaldo (t. XIII dellaseconda serie): ma non si danno per quest’opera documentazioni variantistiche perché la stes-sa redazione venne proposta anche dalla Zatta (che molto probabilmente la derivò propriodalla Savioli attraverso la mediazione della Guibert e Orgeas). Lo stesso dicasi per la Grisel-da, pubblicata per la prima volta nel 1771 da un editore, Angelo Geremia, che risulta talvoltain rapporti di coproduzione con Agostino Savioli; riprodotta poi nel t. XIV della seconda se-rie Savioli, fu assunta – attraverso la consueta mediazione della Guibert – dall’ultima edizio-ne “d’autore”.
126 Non solo e non tanto per quella che è stata brillantemente definita la «filologia delcuore» di Giuseppe Ortolani (cfr. N. MANGINI, Le edizioni goldoniane dell’ultimo ventennio,in L’interpretazione goldoniana, cit., pp. 41-42, 51-52), quanto per la sostanziale estraneitàdella nostra tradizione filologica alle problematiche dei testi a stampa (solo negli ultimi duedecenni la textual bibliography ha conosciuto cospicua diffusione nel panorama critico italia-no, cominciando ad innovarne le prospettive ecdotiche).
127 Cfr. supra, nn. 9 e 110.128 Per gli inediti la cui trasmissione dobbiamo a queste tre edizioni, cfr. infra, § 4, nni
77, 120 (Venaccia); 142, 145, 159 (San Tommaso d’Aquino); 3, 5, 130 (Savioli). Sarà utilesottolineare sin d’ora che della Scozzese (n° 142) l’edizione bolognese propose non solo(1772) quella che doveva essere una redazione originaria, ma anche (1777), a seguito dellapubblicazione (1775) del t. XIII Pasquali (che appunto quella commedia offriva come inedi-to), la redazione rielaborata dall’autore in vista della stampa.
129 L’esistenza dell’ edizione è stata per la prima volta segnalata da L. RICCÒ, Nota ai te-sti, cit., pp. 102-103 e 106.
Per una mappa della produzione goldoniana 79
ro), è in particolare alla triade Venaccia-San Tommaso-Savioli che bisogne-rà prestare cospicuo e guardingo interesse. È stata infatti la loro vivacitàproduttiva – qualitativamente e quantitativamente parlando – a condizionarein modi ancora oggi determinanti la tradizione dei testi goldoniani: e nonsolo per quel significativo – e forse ancora non del tutto sondato – apportovariantistico che giova a situare in profondità prospettica alcune opere fon-damentali della produzione goldoniana, ma anche e soprattutto perché lapervasività con cui si dovettero imporre nel mercato editoriale coevo nedeterminò una capacità di influenza sotterranea – e, per l’odierno editore,insidiosissima – sulla stessa tradizione a stampa d’autore.
In particolare, è l’“asse di ferro” San Tommaso-Savioli (come già dettol’edizione veneziana utilizza la bolognese come proprio antigrafo conestrema frequenza) quello a cui si deve una massiccia inoculazione di va-rianti: queste sì, spurie nel senso più pieno del termine, dovute tanto a ra-gioni di ordine censorio (imposte dai revisori del S. Officio bolognese allestampe goldoniane della San Tommaso), quanto a corruzioni involontarie eaccidentali, quanto anche alla necessità di sanare congetturalmente i guastiprodotti nelle fasi intermedie della trasmissione. In quanto accolte da quellache dovrebbe essere l’ultima edizione d’autore, la Zatta, e non riconosciutenello loro (spesso tortuosa, e distante nel tempo) genesi allografa, hanno poiconnotato la fisionomia dei testi “goldoniani” non solo nella loro circola-zione ottocentesca, ma anche – in ampia misura – in quella tuttora domi-nante. Già alcuni tra i primi e più accurati contributi dell’Edizione Nazio-nale erano riusciti a mettere in evidenza come «l’edizione Zatta […] avva-lora un testo goldoniano di origine, se non spuria, certo assai stratificata»130:in base alle risultanti di alcune significative campionature – attraverso cui siè cercato di ricostruire i rapporti stemmatici intercorrenti tra i testimoni piùsignificativi della tradizione settecentesca – oggi si è in grado di esseremolto più radicali nel valutare le contaminazioni multiple che contraddi-stinguono la fisionomia di un’edizione per più versi ancora molto influentesulla conoscenza e sull’interpretazione dei testi goldoniani.
Tanto più che in tempi recenti la sua autorialità – o comunque autore-vole affidabilità filologica – è stata vigorosamente rivendicata proprio dachi avrebbe voluto specialisticamente intrattenersi su di essa:
Zatta sembra ragionare per blocchi di titoli: quasi tutte le commedie provenientidall’edizione Pasquali si ritrovano tali e quali (con l’eccezione significativa ap-
130 P. LUCIANI, Nota al testo, in C. GOLDONI, I pettegolezzi delle donne, cit., p. 54.
80 ANNA SCANNAPIECO
punto dell’Uomo prudente)131 […] alcune delle commedie provenienti dal nu-cleo formalmente piuttosto guasto della Pitteri sono emendate invece in basealla torinese Guibert e Orgeas. Il resto deriva dalla Savioli. L’edizione Zattanella sua evidente eterogeneità costitutiva rappresenta quindi una sorta di bacinocollettore in cui confluiscono scelte testuali accolte non meccanicamente; […]chi ha curato la messa in opera di tale edizione ha lavorato ragionando sui sin-goli testi di volta in volta vagliando la validità degli esemplari a cui fare riferi-mento132.
Gioverà chiarire subito che, in realtà, l’ultimo editore autorizzato delleopere di Carlo Goldoni non si avvalse mai, nel ristampare commedie già inprecedenza pubblicate con l’assistenza dell’autore, non che di materialeautografo133, nemmeno di precedenti edizioni autorizzate. E tanto meno
131 Al riguardo, cfr. quanto argomentato supra, n. 119 (e, per la relativa documentazionedei rapporti stemmatici, infra, § 4, n° 29). Merita inoltre anticipare che anche nel caso di que-sta commedia la Zatta riceveva la redazione Bettinelli> San Tommaso> Savioli attraverso lamediazione della Guibert e Orgeas.
132 A. ZANIOL, Per una rilettura..., cit., p. 218 (il corsivo è mio). Nel corso dello stessosaggio, anche ad alcune varianti interpuntive della Zatta veniva attribuita una valenza indi-scutibilmente intenzionale, non escludendo addirittura un principio di paternità autografa:sull’insostenibilità della tesi, cfr. quanto già argomentato in A. SCANNAPIECO, Lo statuto fi-lologico…, cit, pp. 139-143.
133 Come lo stesso editore era parso promettere in un iniziale avviso rivolto ai potenzialiacquirenti della progettata (e variamente procrastinata) pubblicazione, allorché illustrava leragioni del differimento con l’attesa da Parigi di «parte delle Comedie stesse corrette edemendate da molti errori corsi nelle passate Edizioni» («Notizie del Mondo», n° 18, sabato 1.Marzo 1788, p. 146). Forse non a caso, tuttavia, allorché si trattò di stilare il manifesto pro-grammatico propriamente detto (con tanto di allegato “saggio” dell’edizione che si invitava asottoscrivere per associazione), la motivazione della “compiutezza” della pubblicazione sirestringeva alla sola promessa degli inediti (già naturalmente formulata nel precedente avvi-so): «Trovandoci noi impegnati col Pubblico sino dallo scorso mese di Marzo a fare unacompiuta ed elegante Edizione delle Commedie tutte del celebre pittor de’ costumi Sig. Av-vocato Carlo Goldoni, non manchiamo in ora di presentargli il promesso Saggio della mede-sima […] Ristringendoci dunque a parlare soltanto del pregio dell’Edizione che intrapren-diamo, ci facciam l’onore di assicurare il Pubblico, ch’ella sarà completissima eimparagonabile a qualunque altra sin’ora eseguitasi, mentre per effetto della corrispondenzaed amicizia che abbiamo col chiarissimo Autore nostro Concittadino, ci troviamo forniti ditutte quelle Commedie, che da esso lui composte dopo il suo soggiorno in Parigi, furono conindicibile applauso accolte da una nazione non avvezza ad abbandonarsi inconsideratamenteall’ammirazione degli stranieri» (Agli amatori del teatro comico italiano Antonio Zatta e fi-gli, s.l., s.d. [ma Venezia, 1788] pp. III-IV: copia di questo rarissimo manifesto è conservatopresso la Biblioteca Palatina di Parma, Misc. A.1682). E non a caso, questa stessa formula-zione restrittiva sarà quella utilizzata nella prefazione all’edizione stessa (cfr. Gli editori a chilegge, in Opere teatrali del sig. avvocato Carlo Goldoni veneziano, t. I, Venezia, Zatta, 1788,pp. V-VI). La genesi e la fisionomia di quella che forse avrebbe dovuto essere l’originaria
Per una mappa della produzione goldoniana 81
procedette a un vaglio di quello che potevano offrire le stampe non autoriz-zate: le nostre aspettative filologiche non governavano la logica produttivadi un editore settecentesco. Zatta fece semplicemente la scelta più economi-ca, (e del tutto congrua alle esigenze di rapida realizzazione tipograficaproprie di una grande azienda, in quel torno di tempo oltretutto impegnatain svariate produzioni faraoniche che non tolleravano indugi produttivi)134:quella di avvalersi di un unico antigrafo. L’unica edizione che – aquell’altezza cronologica – poteva garantirgli il corpus più completo delteatro goldoniano era la torinese Guibert e Orgeas: ed è precisamente dallaGuibert e Orgeas che Zatta – ad eccezione naturalmente che per i 23“inediti”135 – desume gli antigrafi di pressoché tutti i testi della produzione
ideazione del progetto editoriale Zatta, nonché quella che fu poi la sua concreta configurazio-ne, sono argomenti di grande rilievo critico, che meriteranno una specifica trattazione.
134 Come ci consente di appurare il più autorevole studio sull’editoria veneziana sette-centesca, nel penultimo decennio del secolo, mentre le aziende tipografiche cittadine subisco-no una netta involuzione, «Antonio Zatta aveva addirittura potenziato i propri impianti. Nel1788 nessun’altra stamperia di Venezia dimostrava altrettanta vitalità» (M. INFELISE,L’editoria veneziana nel ’700, cit., p. 331). A scorrere i cataloghi dell’editore o a vagliare gliannunci pubblicitari della stampa periodica coeva, si ha una misura significativa della straor-dinaria produttività dell’ultimo editore goldoniano, che risulta particolarmente impegnatoproprio sul fronte di pubblicazioni imponenti e in quanto tali per lo più legate alla praticadell’associazione (che obbligava lo stampatore a osservare regolarità di produzione e di pub-blicazione): ma anche quest’argomento, per il vario interesse e l’impegno analitico presuppo-sti, meriterà di essere affrontato in separata sede. Ai fini del nostro discorso, non sarà fuoriluogo ricordare che nel manifesto programmatico dell’edizione – tenuto a informare i poten-ziali sottoscrittori anche dei tempi di realizzazione dell’impresa – si preventivava la pubblica-zione di un tomo ogni due mesi «sino al compimento della nostra Raccolta de’ Poeti ClassiciItaliani [il celebratissimo Parnaso Italiano, in 55 volumi, che ebbe termine nel 1791], dopo laquale delle Opere del Goldoni se ne pubblicherà un Volume ogni mese» (Agli amatori delteatro comico italiano Antonio Zatta e figli, cit., pp. IV-V). Anche se non rispettando i termi-ni previsti, la pubblicazione dei 34 volumi contenenti la produzione “commediografica” (itomi XXXV-XLIV, destinati alla produzione librettistica, uscirono nel 1794-95) seguì ritmimolto sostenuti: 1788 (incipit della pubblicazione: settembre), 2 tomi; 1789, 8; 1790, 5; 1791,6; 1792, 7; 1793, 6.
135 L’uso delle virgolette è d’obbligo, essendo in realtà – come s’è visto – solo 14 le ope-re propriamente parlando inedite che Zatta stampa nella sua raccolta goldoniana (cfr. supra,n. 89); anche per le rimanenti 9, tuttavia, l’editore dovette avvalersi di materiale manoscrittodell’autore, per quanto a rigore nulla esclude la possibilità che fossero esistiti, per alcune diqueste opere, dei testimoni a stampa oggi non noti. In effetti, anche l’esatta qualificazione equantificazione delle reali novità goldoniane immesse sul mercato dall’ultima edizioned’autore è variamente problematico. La testimonianza che al riguardo dovrebbe rivestiremaggiore persuasività documentaria è quella che dobbiamo allo stesso editore, allorché in unesposto presentato ai Riformatori dello Studio di Padova per denunciare l’atto di appropria-zione indebita delle commedie inedite di cui ai suoi danni il concorrente Garbo si era resoresponsabile, ne stilò un circostanziato elenco, non trascurando di sottolineare come gli fosse-
82 ANNA SCANNAPIECO
“commediografica” goldoniana136. Lo stampatore non ebbe mai a considera-re alcuna delle precedenti edizioni d’autore: non le prime tre (Bettinelli, Pa-perini, Pitteri), del resto troppo lontane nel tempo e probabilmente anche didifficile reperibilità – ma nemmeno la prestigiosissima Pasquali, in qualchemodo ancora “fresca di stampa” (l’ultimo volume, come vedremo, era statopubblicato nel 1780) e soprattutto fortemente accreditata non solo presso ilpubblico dei lettori colti ma anche presso editori non autorizzati come il li-vornese Masi e il lucchese Bonsignori: i quali appunto, a differenza dellosponsorizzatissimo Zatta, elessero anche la Pasquali a proprio antigrafo137.
ro costate l’esborso di «circa ducati mille e cinquecento»: «Gli amori di Zelinda e Lindoro;Le inquietudini di Zelinda; Il ventaglio; Chi la fa l’aspetta; Le donne di buon core [= Le don-ne di buon umore]; Il matrimonio per concorso; La burla retrocessa nel contracambio;L’avaro fastoso tradotta dal francese; Il buon compatrioto; Il genio buono ed il genio cattivo;La scuola di ballo; Il disinganno in corte; Gli amori di Alessandro Magno; La Metempsicosi;Bellisario, tragedia; Zoroastro; Giustino, tragedia; Enea nel Lazio; Raimonda [= Rosmunda];Artimisia; Enrico, non stampato in alcuna raccolta; La ninfa saggia; Gli amanti felici; Lequattro stagioni» (Archivio di Stato di Venezia, Riformatori dello Studio di Padova, f. 61, c.134; sulla controversia Zatta-Garbo, cfr. A. TESSIER, Intorno ad un’edizione goldoniana, in«Archivio Veneto», XXVI, 1883, pp. 367-372 e ID., Ancora intorno ad un’edizione goldo-niana, ivi, XXVIII, 1884, pp. 162-166). Escludendo dal novero gli ultimi tre titoli (relativi atre delle cinque cantate con cui l’editore “rimpolpò” la composizione del t. XXXIII), si ha ache fare con un elenco di 21 opere (ma si noti la significatività dell’inciso che accompagna lamenzione dell’Enrico, che sembrerebbe escluderlo dall’insieme degli inediti), nel quale nonfigurano due testi la cui princeps – per quanto ci è dato sapere – dovrebbe essere ascritta pro-prio alla Zatta (La gelosia di Lindoro e La bella georgiana). Non maggiore chiarezza ci puòvenire da quella che dovrebbe essere la fonte ufficiale, e cioè l’edizione stessa, i frontespizidei cui volumi dichiarano solo occasionalmente la qualifica di «commedia inedita» per i testiinteressati (sono per l’esattezza solo 6 le opere che vengono dichiarate tali: tra queste figuraLa gelosia di Lindoro, ma non La bella georgiana). Giacché l’omissione della suddetta indi-cazione si produce sistematicamente dopo il t. IX, potrebbe essere lecito ipotizzare che essafosse dovuta a ragioni di tutela dell’edizione stessa: la non immediata individuabilità del testoinedito poteva scoraggiare facili operazioni di pirateria editoriale. Ma è solo un’ipotesi, e inrealtà il problema degli inediti zattiani, della qualità e dell’identità dei testi che Goldoni – ochi per esso – ebbe a consegnare all’editore (nonché dei tempi effettivi in cui avvenne la tran-sazione, e delle ragioni che la determinarono), meriterà un’analisi più distesa, da riservare adaltra occasione.
136 Si è invece sostenuto che «per una ristretta cerchia di titoli diversi, la fonte probabileè un’altra edizione poco considerata delle opere a stampa di Goldoni, quella approntata a To-rino tra il 1772 e il 1774 [sic] dagli stampatori Guibert & Orgeas» (A. ZANIOL, Per una ri-lettura..., cit., p. 215; il corsivo è mio): ciò che deve aver indotto in equivoco è il non averavuto modo di consultare la raccolta completa della Guibert, e in particolare il non aver ana-lizzato la prima serie (da cui sono discesi tutti gli errori interpretativi relativi tanto alla collo-cazione stemmatica della Zatta quanto al significato di alcune presunte varianti zattiane, percui – oltre al già segnalato caso dell’Uomo prudente – cfr. infra, pp. 91-103 e 114-118).
137 Come desumibile dai volumi di EN i cui curatori abbiano vagliato anche i testimoni
Per una mappa della produzione goldoniana 83
L’ultimo editore cui Carlo Goldoni aveva dato il benestare e l’assistenzaper la pubblicazione delle proprie opere si rivela così estraneo ad ogni scru-polo “filologico” che nemmeno nel caso delle due uniche commedie (Unadelle ultime sere di carnevale e Gli amanti timidi) i cui testi non poteva at-tingere dalla Guibert – perché, essendo state edite troppo tardivamente negliultimi due tomi Pasquali, non erano potute confluire nell’edizione torinese– nemmeno allora ricorse a quello che avrebbe dovuto essere il fisiologicotermine di riferimento redazionale (appunto, la Pasquali): e “preferì” utiliz-zare ciò che il mercato gli metteva più facilmente a disposizione, due stam-pe San Tommaso del 1790138. Naturalmente Zatta sapeva contrabbandarebene la sua merce di editore autorizzato che saccheggiava edizioni non au-torizzate, e nel caso specifico delle due commedie citate (pubblicate tardi-vamente all’indomani della morte dell’autore, nel t. XXXIV, mentre secon-do quanto previsto dal piano editoriale avrebbero dovuto figurare nelle pre-cedenti classi) poteva così blandire il proprio pubblico:
L’Ordine da noi stabilito di dividere in quattro classi l’Opera presente esser do-veva immutabile, perché approvato ancora dall’immortale Riformatoredell’Italiano Teatro Dott. Carlo Goldoni. Egli però, onde la nostra edizione ri-uscisse la più perfetta, non aveva sdegnato, superando gl’incomodi della età ele giornaliere occupazioni, di scorrere ciascuna delle sue produzioni, e di cor-reggere in esse a suo talento tutto ciò ch’egli stimava degno di riprovazione.Forse per tale oggetto aveva trattenute le quattro componenti il presente Tomo,la prima delle quali appartiene alla prima classe, e le altre tre alla seconda. Allo-ra che compianto da tutta l’Europa fu per sempre rapito alla Letteraria Repub-blica, procurammo di ricuperarle, e presentemente le diamo al pubblico certiche non ci verrà attribuita a colpa un’alterazione dell’ordine propostoci, non ge-nerata da errore o da mancanza, ma da rispetto verso l’autore che da noi richie-deva ogni dipendenza e per i meriti suoi e per la gentilezza con la quale com-piacevasi di assistere alla nostra edizione139.
delle due edizioni, Masi e Bonsignori ripropongono in linea di massima le redazioni Pasquali(naturalmente nel caso di commedie in essa raccolte); la stessa struttura delle due pubblica-zioni (cfr. infra, pp. 239-241) lascia d’altro canto intendere che il modello della prestigiosaedizione veneziana fu ben presente all’atto della definizione dei nuovi allestimenti tipografici.Nate in immediata concorrenza alla Zatta (di cui anzi cercarono di anticipare le mosse), en-trambe le edizioni, per quanto non autorizzate (ma, almeno la Masi, considerata con attento ecompiaciuto interesse dall’autore: cfr. XIV 404 e 410) e non nobilitate dall’appeal delle illu-strazioni, si distinguono per correttezza (la Bonsignori anche per una certa sensibilità aglispazi paratestuali) proprio rispetto alla coeva e autorizzata Zatta.
138 Cfr. infra, § 4, nni 147 e 182 (anche per la relativa documentazione dei rapportistemmatici).
139 Avvertimento, in Opere teatrali, cit., t. XXXIV, pp. 7-8 (il corsivo è mio). Le altre
84 ANNA SCANNAPIECO
Se la strategia argomentativa genialmente zittisce quella mezza verità,che pur tra le righe affiora, di un frettoloso arraffazzonamento («procuram-mo di ricuperarle»), essa d’altra parte, nel suo ribadire retrospettivamente lapresunta autorialità delle cure editoriali, non fa che rimodulare quella chesin dall’inizio era stata la consapevole bugia di voler fornire un’edizione«completissima e imparagonabile a qualunque altra sin’ora eseguitasi»140.Che l’“imparagonabilità” rispetto ad altre inziative editoriali possa essereprerogativa ascrivibile a una produzione che nella sua quasi totalità141 veni-va in realtà sviluppandosi a parassita ridosso di precedenti pubblicazioni, è– come ognuno ben vede – movenza argomentativa ben degna di un navi-gatissimo mercante di libri: e, al tempo stesso, cogente monito ad avvicina-re con sospettosa cautela le vetrine delle dichiarazioni ufficiali (degli edito-ri, come degli autori), e a non perdere mai di vista la materialità, per quantodifficile e poliedrica, dei testi, il formarsi accidentato della loro misitifi-cante “oggettività”.
Dunque la Zatta tutto fa fuorché proporre «scelte testuali accolte nonmeccanicamente» e ancor meno «ragionare sui singoli testi di volta in voltavagliando la validità degli esemplari a cui fare riferimento»: e può tuttaviadare la meditata impressione di costituire «una sorta di bacino collettore».Le ragioni di questa «evidente eterogeneità costitutiva» sono però, ancorauna volta, del tutto indipendenti dalla volontà (e dalla consapevolezza stes-sa) dell’editore: e hanno invece a che fare con la qualità redazionale, com-posita e stratificata, dell’antigrafo utilizzato. A sua volta risultante di unadinamica genetica variamente materiata di accidentalità, l’allestimento dellatorinese Guibert e Orgeas infatti, pur essendosi avviato con il probabile be-nestare dell’autore e con tutti i requisiti di una realizzazione editoriale accu-rata, si trovò poi costretto a commisurare la bontà delle intenzioni alla con-suete – stringenti, e ben poco sollecite alla cura filologica dei testi – logichedi produzione. Sin dalla configurazione esterna (che rispetto al modello
commedie del volume (che incongruamente veniva a collocarsi al termine della terza classe,quella delle commedie e tragedie in versi di vario metro) erano Il genio buono e il genio cat-tivo e La finta ammalata: solo la prima in realtà era desunta da materiale inedito (cfr. supra,n. 135), mentre La finta ammalata risulta come sempre derivata dalla Guibert (cfr. infra, § 4,n° 54).
140 Agli amatori del teatro comico italiano Antonio Zatta e figli, cit., p. III (la stessaespressione peraltro ricorre immutata anche nella prefazione all’edizione stessa: cfr. Gli edi-tori a chi legge, cit., p. V).
141 Sono complessivalmente 135 le opere pubblicate nei 34 volumi della produzione“commediografica”; di queste ben 110 dovrebbero derivare supinamente dalla Guibert e Or-geas e 2 dalla San Tommaso d’Aquino (23 essendo, come s’è visto, gli originali zattiani):quasi l’85% dell’ultima edizione d’autore sarebbe dunque copia descripta.
Per una mappa della produzione goldoniana 85
ormai invalso ripristinava la numerazione continuata di pagine e situavadunque la pubblicazione in un unico orizzonte di circolazione, quello clas-sico e sistematico della raccolta), la nuova edizione, inaugurata nel 1772, siproponeva con i connotati propri di una proposta qualificata e affidabile,pronta a prendere le distanze dal vivacissimo panorama dell’offerta edito-riale goldoniana coeva, oscillante tra la sontuosa quanto avara produzionedella Pasquali (da cinque anni ormai ridotta al silenzio) e quella generosama variamente compromessa con le logiche di una vorace commercialitàdella triade Venaccia-San Tommaso-Savioli. Gli stessi editori non manca-vano di sottolineare la specificità della propria proposta, e di informare illettore del “gradimento” dell’autore stesso, significativo tanto da lasciarpresagire l’espressione, a breve, di un patrocinio attivo:
Avendo noi pertanto fatto riflessione, che le sopraddette edizioni [«molte, e peresemplari numerosissime […] che a concorrenza sono seguite nelle Città piùragguardevoli dell’Italia»] si sono già fatte rare, e che quella pur di Torino[Fantino-Olzati] ha avuto uno spaccio grandissimo, quindi ci siamo determinatidi produrne una assai più copiosa, e compita, e dal proprio Autore recentementecorretta, e ripulita, sì in riguardo delle materie, che dello stile, e della lingua [ilriferimento è all’edizione Pasquali] […] L’Autore, a cui ne è pervenuto l’avviso[«di questa novella edizione»] sommamente la gradisce, e con sua graziosissi-ma lettera ci fa sperare, che ci favorirà di quei mezzi, che possono renderla,quanto alcun’altra, interamente compita. […] oltre le accennate Commedie[quelle già pubblicate nell’ultima edizione, la «corretta e ripulita» Pasquali] sidistribuiranno di mano in mano tutte quelle opere, che dalla saggia, e semprefeconda penna del medesimo sono già state, o saranno prodotte142.
Il piano editoriale è dunque chiaro: ristampare l’opera goldoniananell’accreditata versione che ne ha sinora prodotto Pasquali, e recuperarnetutte quelle parti che, già edite nella Paperini e nella Pitteri, non avevanoancora ricevuto le cure redazionali dell’ultima edizione veneziana (di cui sidà per scontata la fine effettiva), nonché garantire (in virtù della positivadisponibilità dell’autore) i frutti avvenire della «saggia, e sempre fecondapenna del medesimo». Che non si tratti della consueta millanteria di un
142 Al leggitore, in Delle commedie di Carlo Goldoni avvocato veneto, t. I, Torino, Gui-bert e Orgeas, 1772, pp. III-IV. Su Guibert e Orgeas, tra i librai-editori di maggiore spicco nelpanorama torinese del secondo Settecento (e gli unici, assieme ad altri tre librai, che nel 1774potevano essere indicati alla Société typographique di Neuchâtel come interlocutori commer-ciali degni di fiducia), manca una specifica indagine; cfr. comunque L. BRAIDA, Il commerciodelle idee. Editoria e circolazione del libro nella Torino del Settecento, Firenze, Olschki,1995 (in part. pp. 222, 245, 296).
86 ANNA SCANNAPIECO
editore goldoniano, è comprovato da una tempestiva e informatissima re-censione che all’iniziativa torinese riservò un goldonista di provata fedecome Domenico Caminer:
Nessun Autore certamente potrà vantarsi, che tante Edizioni delle numeroseproprie Opere siano state fatte lui vivente, quante ne vede il Sig. Dottor CarloGoldoni […]. Quattro sinora se ne fecero a Venezia […]. Firenze, Napoli, Bo-logna, Pesaro ecc. ne replicarono le Edizioni, ed una bellissima ne hanno at-tualmente sotto al Torchio i Librai Guibert, ed Orgeas di Torino in 16 volumi,più compiuta di tutte le altre, recentemente corretta, e ripulita sì riguardo allematerie, come allo stile, e alla lingua dall’Autore143.
Già da un decennio attivamente inserito nel panorama pubblicistico cit-tadino144, e pronto a sfruttare ogni occasione per esprimere nella propria at-tività giornalistica la «lunga amicizia» che lo lega a Goldoni145 (con il quale,anche nella distanza parigina, perdura un rapporto di stretta confidenza),Caminer si mostra bene informato del piano editoriale di un’iniziativa chedeve ancora essere avviata e i cui pregi – la cui fisionomia stessa – non pos-sono dunque essere ancora verificati, e soprattutto non esita a descriverecome già attiva quella collaborazione dell’autore che nelle dichiarazioniprogrammatiche degli editori sarà solo auspicata146. Forse non a caso la no-
143 «L’Europa letteraria», t. III, p. I, Gennaro 1772, Venezia, Nella Stamperia Fenziana,pp. 74-75.
144 Sull’attività pubblicistica di Domenico Caminer, cfr. R. SACCARDO, La stampa perio-dica veneziana fino alla caduta della Repubblica, Padova, Tip. del Seminario, 1942, pp. 81-84; M. BERENGO, Introduzione a Giornali veneziani del Settecento, Milano, Feltrinelli, 1962,pp. LI-LVIII; C. DE MICHELIS, ad vocem, in Dizionario biografico degli italiani, vol. XVII,Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1974, pp. 234-236.
145 «Nuova veneta gazzetta», n° 29, sabbato addì 19 giugno 1762. Nei sei mesi di vita delgiornale (marzo-settembre 1762), continuazione delle gazzetta che era stata del Gozzi e poidel Chiari, non c’è praticamente numero che non dedichi spazio all’attività goldoniana; il re-dattore mostra inoltre di conoscere dal di dentro, e in dettaglio, i progetti dell’autore: al cuiriguardo l’informazione giornalistica si trasforma molto spesso in cassa di risonanza pubbli-citaria.
146 L’articolo del Caminer, da cui è tratta la precedente citazione, appare nel gennaio1772: è nel corso di quest’anno che vengono pubblicati i primi cinque tomi dell’edizione tori-nese, che quindi il giornalista non aveva potuto vedere prima della stesura dell’articolo. Laripresa testuale di un’espressione che sarà propria della prefazione editoriale («recentementecorretta, e ripulita sì riguardo alle materie, come allo stile, e alla lingua») può far presumereche Caminer avesse potuto prendere visione del manifesto programmatico con cui gli editoriavranno promosso l’iniziativa (e da cui potrebbe aver anche desunto l’indicazione relativaalla prevista consistenza, in 16 volumi, della raccolta); ma è comunque significativo lo slitta-mento sintattico e semantico della citata espressione, che mentre nella prefazione di Guibert e
Per una mappa della produzione goldoniana 87
tizia ricorre nell’ambito della recensione ad una di quelle traduzioni delBourru bienfaisant che l’editoria veneziana andò tempestivamente appron-tando all’indomani della clamorosa affermazione del lontano autore sullascena prestigiosa della Comédie Française147: come difatti è già stato op-portunamente osservato, la genesi dell’edizione torinese si definisce in si-gnificativa contiguità alla nuova risonanza che attorno al nome del «Moliè-re italiano» aveva appunto creato l’impensabile esito del Bourru148. Ma,nella nostra prospettiva, quella a cui gioverà prestare attenzione è un’altra –ben più sintomatica – coincidenza: in quello stesso 1772, alla luce di unanuova ridefinizione del proprio itinerario artistico, Goldoni prende atto cheil progetto Pasquali ha esaurito il proprio significato e definitivamente sicongeda da esso. “Cede” – dietro un compenso presumibilmente moltocongruo – «la sua edizione», con relativo privilegio, allo stampatore (che hail suo preciso tornaconto nel rianimare, dopo cinque anni di oblio,un’edizione che senz’altro potrà ricavare nuovo lustro dall’improvviso, edinternazionale, rialzarsi delle quotazioni dell’autore), non mancando be-ninteso di garantirgli la somministrazione del materiale utile al compimentodell’impresa e di protestare la qualità esclusiva del suo patrocinio149: ma so-stanzialmente abbandonandola a se stessa, e ricercando in altri orizzontil’espressione di un’identità ancora una volta in via di ridefinizione.L’affermazione alla Comédie française rilancia d’improvviso la posta dellescommesse goldoniane, e in questa mutevole ricomposizione del quadro,può tornare utile la realizzazione di un’edizione decorosa, più vicina al ba-ricentro dei propri interessi, che contribuisca a sostenere in un’area franco-
Orgeas era riferita all’edizione Pasquali, da essi riprodotta, nell’articolo dell’«Europa lettera-ria» risulta senz’altro rapportata alla stessa edizione torinese.
147 Per le varie traduzioni del Bourru, cfr. infra, § 4, n° 196; la recensione del Caminerera relativa alla traduzione di Piero Candoni, edita parallelamente da Angelo Geremia e Ago-stino Savioli.
148 Cfr. A. ZANIOL, Per una rilettura..., cit., p. 196.149 Si veda la Lettera del Sig. Dottor Carlo Goldoni a Giambatista Pasquali, datata 15
luglio 1772 e pubblicata in calce a Delle commedie di Carlo Goldoni avvocato veneto, t. XII,Venezia, Pasquali, 1761 [ma 1774]: «Vi ho ceduto la mia Edizione, vi ho ceduto il Privilegio[…] Voi siete divenuto il solo Padrone delle Opere mie; sono contento delle condizione pro-poste da terza Persona, alle quali vi siete arreso assai docilmente, e sarebbe un’abusare dellavostra amicizia […] se io vi lasciassi sproveduto de’ materiali […] metterò tutta la diligenzapossibile […] per terminare, quanto più presto si può, questa nostra Edizione, ch’è la sola,ch’io approvo, e l’unica, per cui prendo impegno, promettendo, che non presto, e non presteròad alcun’altro, né assistenza, né materiali, né correzioni» (la lettera è riprodotta in XIV 367-368). Le solenni affermazioni della clausola (assolutamente essenziali per la tutela diun’edizione ormai “orfana” del proprio autore) dovevano con ogni probabilità essere stateimposte dall’editore come conditio sine qua non della transazione.
88 ANNA SCANNAPIECO
italiana (e con un’importante diffusione nel bacino occidentale del Mediter-raneo)150 il credito di un autore repentinamente tornato alla ribalta. L’appro-fondimento del successo scenico non avrà invece – com’è noto – luogo: e,già dall’anno successivo, il mortificante travaglio dell’Avare fastueux151 dis-suaderà l’autore dal credere che il trionfale riscontro del Bourru aveva po-tuto realmente scandire l’ultima e più prestigiosa fase della sua vicenda ar-tistica. Anche l’eventuale interesse per l’edizione torinese cadrà allora ine-vitabilmente nel vuoto, e l’unica menzione pubblica che l’autore potrà ri-servare, retrospettivamente, a quell’iniziativa sarà ispirata a forme di tangi-bile risentimento: «dans l’Edition de mes œuvres faite à Turin en 1777, parGuibert et Orgeas, cette Griselda se trouve imprimée comme une Piece àmoi appartenante: je déteste les plagiats, et je déclare que je n’en suis pasl’inventeur»152.
Eppure, all’atto di varare la seconda serie, gli editori torinesi non aveva-no trascurato di rassicurare il pubblico sulla “compitezza” della propria of-ferta, che veniva appunto ad integrare il quadro complessivo della produ-zione goldoniana, facendo questa volta esplicito affidamento sulle curedell’autore stesso:
Avendo con universale approvazione adempito a quel tanto, che con nostropubblico manifesto avevamo promesso in riguardo ad una novella ristampadelle Opere del rinomato Poeta il Signor Carlo Goldoni; quindi è, che stimiamoora cosa opportuna di avvertire li Dilettanti delle medesime esserci riuscito diradunarne molte altre […]. Nulla ridiremo del pregio di questa compita edizione[…], ma soltanto accenneremo quivi per motivo d’aggiunta: […] essere state fi-nalmente dette Opere dal suo giudizioso Autore oggidì novellamente corrette,ed appurate sì in riguardo del costume, che della lingua; essere insomma stata
150 Ancora tutta da indagare la relazione degli editori torinesi con il genovese Yves Gra-vier (il cui nome ricorre, assieme a quelli di Guibert e Orgeas, in alcuni volumi di entrambe leserie), nipote di quel Jean Gravier (attivo a Napoli) che era stato uno dei principali libraidell’Europa di metà Settecento, e ben introdotto, come da tradizione di famiglia, su tutte lepiazze del Mediterraneo occidentale (sulla sua figura si vedano E. PARODI, Yves Gravier li-braio-editore in Genova nel sec. XVIII, in «La Berio», 1983, n. 3, pp. 38-47; A. PETRUCCIA-NI, Il libro a Genova nel Settecento, II/1, La «libreria» genovese: composizione, andamento,caratteristiche, in «La Bibliofilia», XLVI, 1994, II, pp. 153-193, in part. pp. 191-192; ID., Illibro a Genova nel Settecento, II/2, I librai genovesi (1685-1797), ivi, III, pp. 243-294, inpart. pp. 263-267).
151 Si veda la lettera agli attori della Comédie Française del 26 aprile 1773 in XIV 368-369; ma su tutta la questione il riferimento d’obbligo è ancora a P. LUCIANI, «Le Bourrubienfaisant» e «L’Avare fastueux»..., cit.
152 Mémoires I, 37, in I 168.
Per una mappa della produzione goldoniana 89
loro data l’ultima perfezione153.
Proprio ad uno dei volumi della «seconda raccolta» (l’undicesimo) si sareb-be dovuta invece quella pubblicazione della Griselda tanto astiosamentericordata poi dall’autore dei Mémoires. E a ragion veduta l’autore avrebbepotuto prendere così recisa distanza dall’operazione e tacciare addirittura diapocrifia un’edizione che – come abbiamo visto – sembrava essersi inaugu-rata sotto tutti altri auspici: anche se, a rigore, la paternità editoriale dellaGriselda non era certo da addebitarsi ai poveri stampatori torinesi, che sierano limitati a riprodurre un testo immesso sul mercato qualche anno pri-ma da Angelo Geremia e poi nuovamente riproposto da Agostino Saviolinella sua organica raccolta del teatro goldoniano. Il fatto è che Guibert eOrgeas si erano dovuti misurare con le regole del mercato da un lato, e conla non prevista indisponibilità dell’autore dall’altro: esaurita la “scorta” deiprimi dieci tomi Pasquali (fedelmente e accuratamente riprodotti nei corri-spettivi volumi della prima serie), impossibilitati ad avvalersi della sperataassistenza dell’autore, si erano limitati a curare i propri interessi e a garanti-re la “compiutezza” della propria edizione continuando a stampare noncertamente le «Opere dal suo giudizioso Autore oggidì novellamente cor-rette», ma quelle che erano già state pubblicate, e oltre tutto nella redazionedi più facile accesso. Nell’arco di cinque anni, così, gli editori torinesi era-no riusciti a realizzare l’allestimento di due raccolte, per complessivi 28volumi e 110 commedie: avevano potuto farlo solo prescindendo dalle in-tenzioni dell’autore, dalla stentatissima prosecuzione della Pasquali (gli ul-timi volumi della quale sarebbero d’altronde stati pubblicati a conclusionegià avvenuta dell’edizione torinese), e da eventuali scrupoli filologici. Die-tro infatti la nettezza delle affermazioni che ricorrono nella prefazione allaseconda raccolta154, dentro la garanzia – così spavaldamente esibita al pro-prio pubblico – di proporre opere cui era stata dall’autore «data l’ultimaperfezione», c’era il disinvolto utilizzo di un antigrafo che certamente nonaveva a sua volta ricevuto alcuna cura autoriale e che era già la risultante diuna tradizione testuale variamente stratificata di scorie, ma che aveva ancheil fondamentale requisito di raccogliere in un assieme unico di recente rea-
153 Ai leggitori, in Delle commedie di Carlo Goldoni avvocato veneto. Seconda raccolta,t. I, Torino, Guibert e Orgeas, 1774, prime pagine non numerate (il corsivo è mio).
154 La cui strumentalità è immediatamente riconoscibile, per chi abbia un po’ di dimesti-chezza con le strategie promozionali di un editore settecentesco, e goldoniano in particolare; eche d’altronde, nel caso specifico, appare subito chiara, laddove si consideri il venir meno diqualsiasi riferimento a rapporti diretti con l’autore, non a caso ricorrente invece nella prefa-zione della prima raccolta.
90 ANNA SCANNAPIECO
lizzazione pressoché tutto il corpus, allora reperibile, del teatro goldoniano:l’edizione Savioli.
In questo modo dunque si definisce la composita fisionomia redazionaledella Guibert (che sarà poi quella della Zatta): essendo i primi dieci volumidella prima serie, come si diceva, esemplati (peraltro con non comune dili-genza tipografica e redazionale) sulla sezione più autenticamente goldonia-na della Pasquali, ed essendo quasi tutto il rimanente (oltre il 60%dell’insieme)155 composto sulla scorta delle redazioni che erano confluitenella Savioli. Anche questa – come s’è visto – aveva a sua volta assunto, aproprio privilegiato modello di riferimento156 l’edizione più sistematica ecompleta che del teatro goldoniano era a suo tempo reperibile, la San Tom-maso d’Aquino, quella sorta di “omnia in progress” che dai primi anni cin-quanta aveva echeggiato le varie pubblicazioni d’autore, mettendo per cosìdire ordine nel loro tumultuoso avvicendarsi e garantendo, anche attraverso
155 Delle 110 commedie edite nei complessivi 28 volumi delle due raccolte, le 40 dei voll.I-X della prima serie sono – come si diceva – esemplate dai corrispettivi tomi Pasquali (di cuiè rispettato anche l’ordinamento interno); ancora ad un antigrafo Pasquali sembrano aver fattoriferimento i torinesi per la stampa delle sette commedie inedite contenute nei tt. XI-XV dellaprestigiosa edizione veneziana. In base a quello che si è potuto appurare attraverso una cam-pionatura indiziaria, la composizione tipografica delle rimanenti commedie ebbe ad avvalersidi un antigrafo Savioli. Per quanto indiziaria, la campionatura è stata tuttavia sufficientementeestesa e mirata per poter ragionevolmente escludere che ricognizioni più sistematiche possanoriservare significative sorprese; ciò nonostante, gioverà anticipare sin d’ora che almeno in uncaso la Guibert non utilizzò la Savioli: la circostanza, proprio per l’eccezionalità (a vari livel-li, come vedremo) del suo prodursi, se non smentisce l’orientamento complessivo dei rapportistemmatici qui illustrati, induce comunque ancora una volta a forme di particolare cautelaecdotica.
156 La Savioli è in realtà edizione molto più “sporca” e compromessa con le dinamicheaccidentali della trasmissione testuale di quanto non risulti esserlo, complessivamente, laGuibert (e ciò finisce inevitabilmente per condizionare la natura della Guibert stessa, che, puressendo più “ordinata” e tendenzialmente sistematica nell’utilizzo delle fonti, acquista di ri-flesso connotati alquanto “scomposti” proprio nella misura in cui una tra quelle di cui piùsistematicamente si avvale le trasmette per via genetica le proprie “contaminate” cellule).Ciò nondimeno, e pur trattandosi di un ambito in cui sarà più che mai necessario procedere averifiche pazienti e puntuali, si può senz’altro sin d’ora affermare che è proprio all’“omnia”bolognese che il modesto editore veneziano fa riferimento, non solo nel replicarne l’ideazionee la struttura, ma anche nell’assumerne, con estrema frequenza, le definizioni testuali: su 111commedie stampate nei complessivi 28 volumi realizzati tra il 1770 e il 1780 (ma con unanetta concentrazione negli anni 1770-1774: cfr. infra, § 5, pp. 232-234; l’unica commedia anon figurare nell’assieme poi proposto dalla Guibert è Il matrimonio per concorso), ho potutoappurare che in almeno 56 casi l’edizione presenta un testo ricevuto attraverso la mediazionedella San Tommaso, mentre solo per 32 commedie si può forse escludere la derivazione bo-lognese e rimanendo in un’altra ventina di casi del tutto da verificare la natura dei rapportistemmatici.
Per una mappa della produzione goldoniana 91
le ripetute ristampe, una compatta continuità d’offerta editoriale al varie-gato pubblico dei lettori goldoniani.
“Affrancate” dalla tutela autoriale, costrette – dalla loro stessa vitalità –ad attraversare percorsi tanto tortuosi e accidentati, le opere goldonianegiunsero al fallace traguardo della sistemazione Zatta all’inevitabile costodi varie perdite, collocandosi in quella vera e propria vetrina per la posteritàche sarebbe stata l’ultima edizione “d’autore” con dei lineamenti affaticatie, non di rado, irriconoscibili. Liminarmente, qualche istruttivo esempiopotrà dare la misura del viaggio da esse sostenuto per giungere sino a noi –quello stesso viaggio che dovremo imparare a fare a ritroso, per tentare diapprossimarci realmente a loro.
a) La buona moglie157
B II 1751(PA IX 1755)158
[non in PS]
STA1 II +S1753(17562; 17743)
S1 X 1771 G1 XV 1774 Z XV I 1791
I.8.38-43BRIGHELLA Co-me intendela mo,con maggior spe-ranza?OTTAVIO Perchéora ch’è maritata,sarà più facile, econdescendente.BRIG. Anzi la xefedelissima al soPasqualin.OTT. È una cosarara trovar unaMoglie fedele do-po due anni dimatrimonio.BRIG. E pur que-
BRIGHELLA Co-me intendela mo,con maggior spe-ranza.
= = =
157 Per la legenda delle sigle di seguito in uso, cfr. infra, § 4, p. 135.158 Rispetto a B III.2.35-37 si osserva in PA la seguente evoluzione variantistica (dovuta
quasi sicuramente a caduta accidentale), che in quanto non attestata poi in STA-S-G-Z è ulte-riore riprova del loro discendere da redazione B: NANE Chi? Vostro fio? MENEGO Tasé là. Nol’ho mai volesto recognesser per fio. NANE Vostra muggier l’ha dito ela. MENEGO Mi nogh’ho mai creduto. Pur troppo se ne dà de sti casi, che le Muggier fa mantenir dai poveri Ma-rii i fioi de qualche pare postizzo.] NANE Chi? Vostro fio? MENEGO Tasé là. No l’ho mai vo-lesto recognesser per fio. NANE Mi no gh’ho mai creduto. Pur troppo se ne dà de sti casi, chele Muggier fa mantenir dai poveri Marii i fioi de qualche pare postizzo.
92 ANNA SCANNAPIECO
sta la xe cussìOTT. Catte suasorella mi ha pro-messo d’introdur-mi da lei senzasaputa di Pasqua-lino, e forse dicondurla in miacasa.
OTT. Catte suasorella mi ha pro-messo d’intro-durmi da lei sen-za saputa di Pa-squalino, e forsedi condurla inmia casa.
= = =
I.17.1: I gh’ha laMuggier in Casa,e no ghe basta, ighe ne vol un’al-tra fora de Casa.Ma Pasqualin,che giera tantobon […]
= =
I gh’ha la mugierin casa, e no ghebasta. Ma Pa-squalin, che gieratanto bon […]
=
II.13.1 Con tre Tsi fa tutto. Tem-po, Testa e Testo-ni. Le donne sivincono, o collemonete, o collaservitù. Bettina èstata inflessibileda fanciulla, nonlo sarà forse damaritata.
Con tre T si fatutto. Tempo, Te-sta e Testoni. Ledonne non pro-viste conforme algenio, o bisogno,d’ordinario allafine se non si vin-cono, si pongonoperò ad un grancimento o con lemonete, o collaservitù. Bettina èstata inflessibileda fanciulla, nonlo sarà forse damaritata.
= =[ma “provviste”]
=
II.26: Fina qual-che busia, per farben, la se pol dir.
Fina qualche bu-sia, per far ben,pare la se possadir.
Fina qualche bu-sia, per far ben,me par che la sepossa dir.
= =
Per una mappa della produzione goldoniana 93
b) L’uomo di mondo
PA X 1757[non in PS]
STA1 XII 1757(17652)
S1XI 1771 G1 XVI 1774 Z XII 1790
I.6.1 S’avemiodevertìo pulito?Una bona maren-da, quattro furla-ne de gusto, e sieputte al nostrocomando.
S’avemio dever-tìo pulito? Unabona marenda,quattro furlane degusto, e via al-legramente.
= = =
I.6.5 Sì, sì, collabruna, voggio,che andemo a darl’assalto a quelafortezza, che a-vemo scovertosta mattina, oe,cossa distu dequei Baloardi?Senti. Ho speran-za, che capi-toleremo la resa,perché me par,che la sia scarsade provision dabocca. Lassa pur,che la se defendafin che la pol;gh’ho una Bombad’oro in scarsela,che m’impegnode farme averzerle porte, o peramor, o per forza.
Sì, sì, colla brunavoggio che ande-mo a dar l’assaltoa quella fortezza,che avemo sco-verto sta mattina.
= = =
I.6.10 Bravo, siorMomolo; viverde incerti fin chese pol.
Bravo, sior Mo-molo.
= = =
I.7.17 Andemo.Se sta patrona mepiase, spero cheno butterò via elmio tempo
Andemo. = = =
I.9.19 Silvio Are-tusi è il mio no-me, ed il mio co-gnome
= =Silvio è il mionome, ed Aretusiil mio cognome
=
94 ANNA SCANNAPIECO
I.10.60 (Oh, chebell’incontro, chexe stà questo! Seandasse anca itrenta zecchinisto muso ghe nemerita più decento).
(Oh, che bell’in-contro che xe stàquesto).
= = =
I. 12.7 cacciandola spada
= mette mano allaspada
= =
I.13.42 (L’è quaquel spiantà deLucindo, ma noghel voio).
= =(L’è qua quelspiantà de Lucin-do, ma no ghelvoio dir).
=
II.14.14 gente adisnar con loro
= = gente a pranzarcon loro
=
c) Il prodigo
PA X 1757[non in PS]
STA1 XII 1757(17662)
S1 XI 1771 G1 XVI 1774 Z XIII 1790
I.3.34 Una veduafresca co fa unaRiosa. Vederè,vederè che mo-bile. Un’aria, unbrio, una grazia;a Venezia nogh’è de meggio.No gh’ho maipodesto […]
Una vedua . Vede-rè, vederè. Un’a-ria, un brio, unagrazia. No gh’homai podesto […]
= [ma “vedoa”] = =
III.10.5 Mi no loso.
= Mi no so gnente = =
III.12.9 Chi hadetto che lo portonel mio granio?
= [ma “granajo”]Chi ha detto, chelo portato nel miogranajo?
= [ma “l’ho”] =
III.12.15 gli hodato tanto danarodel mio, che sonoscoperto di più dimille ducati
=
gli ho dato tantodanaro del mio,che sono al sco-perto di più dimille ducati
= [ma “allo”] =
Per una mappa della produzione goldoniana 95
d) Il frappatore
PA X 1757[non in PS]
STA1 XIII 1757(17662)
S1 IV 1770 G1 XII 1773 Z XIII 1790
I.2.73-74COLOMBINA Evolete ammo-gliarvi?ARLECCHINO Eloun mestier difi-cile el maridarse?l’imparerò.
COLOMBINA Evolete ammo-gliarvi?ARLECCHINO Eperché no?
= = =
II.6.52-56TONINO Donna!colle braghesse! ocara! co te godo!BEATRICE Ada-gio, adagio; nonmi state a far l’in-solente.TON. Me xe ve-gnù el ballon sulbrazzal, e la volche perda unabotta?BEAT. Siate pru-dente, altrimen-ti…TON. Mi vegnoalle curte. Cossafala qua in sta lo-canda?
TONINO Donna!colle Braghesse!
BEATRICE E che!vi è da farne lemaraviglie?
TON. Mi vegnoalle curte Cossafala qua in sta lo-canda?
= = =
III.14.14 FA-BRIZIO Ecco ilfine meritato dalFrappatore.
= omittit = =
e) Torquato Tasso
PT III 1757(PS XVI 1777-
1779)
STA2 III 1758(17632)
S2 II 1772 G2 VI 1775 Z XXVI 1792
II.5.6 E fuor dellaricchezza ho an-ch’io quel, chehanno tutte.
Eccetto le ric-chezze ho dotipari a tutte. = = =
96 ANNA SCANNAPIECO
II.10.32-35D. FAZIO Uhmannaggia lamamma porzì chet’ha filiato. /D. GHERARDOBravo; così lostile di Napoli sisente. /TORQUATO Voimeritate peggio(a don Gherardo)D. GHER. Nonme n’offendoniente. /D. FAZIO Vieni,Torquato mio,vieni alla Cittàbella.
=
D. FAZIO Uhmannaggia lamamma porzì chet’ha filiato. /
TORQUATO Voimeritate peggio(a don Gherardo)D. GHER. Nonme n’offendoniente. /D. FAZIO Vieni,Torquato mio,vieni alla cittàbella.
D. FAZIO Uhmanaggio lamamma porzì,che t’ha filiato. /
TORQUATO Voimeritate peggio(a D. Gherardo)D. GHER. Nonme n’offendoniente. /TORQUATO Dimia sofferenzavoi abusate so-vente. /D. FAZIO Vieni,Torquato mio,vieni alla cittàbella.
=
V.2.4 Chi chiac-chiera, chi chia-gne, chi tace, e seconfonne.
=Chi chiacchiera,chi chiagne, e seconfonne.
Chi chiacchiera,chi chiagne, echisso se con-fonne.
=
f) La villeggiatura
PT V 1758[non in PS]
STA2 V 1759(17712)
S2 IV 1773) G2 VI 1775 Z IX 1789
I.1.34 (Sia male-detto, quando hoparlato)
(Fatal destino,quando ho par-lato)
= = =
I.4.26 (Poverina!la compatisco.Vorrebbe oral’addio, che nonle ha dato questamattina).
(Poverina! lacompatisco).
= = =
I.5.22 La mattinanon lascierei lacaccia per la piùbella Donna diquesto Mondo.
La mattina nonlascierei la cacciaper tutto l’oro diquesto Mondo.
= = =
I.5.49 Spropositi! Spropositi! Voi
Per una mappa della produzione goldoniana 97
il vostro, ed ilmio non è il lettomedesimo?
avete voglia dibarzelettare
= = =
I.5.89 Parto pernon vi dire dipeggio
= = Parto per non dir-vi di peggio
=
II.1.16 Si dilettaanch’egli nei dìdi festa d’andarea caccia.
Si diletta an-ch’egli d’andarea caccia.
= = =
II.2.11 L’avrannofatto per guardar-si meglio nel vi-so.
L’avranno fattoper il suo fine.
= = =
II.2.13 Chi sivuol bene, non i-stà mai da vicino.Sono le occhiate,che giocano.
Chi si vuol bene,non istà mai davicino.
=[ma “davicino”]
=[ma “davvicino”]
=
II.2.20-24MENICHINA Per-ché non si dica…LIBERA Dopo ta-vola poi…MEN. Al passeg-gio…LIB. Nel laberin-to…ZERBINO Oh chebuone lingue, chesiete!
MENICHINA Per-ché non si dica…
ZERBINO Oh chebuone lingue chesiete!
= [ma “perché sidica”]
= =
II.2.40-41ZER. E per meniente.MEN. Eh voi a-vete la Camerieraper voi. Non videgnate di noi.
ZER. E per meniente.MEN. E voi, nonvi degnate di noi.
= [ma “Eh”] = =
II.3.1-3LIB. Che ne diteeh? Il buon Ra-gazzino!MEN. Eh non èpoi tanto piccolo.LIB. Certo, cheper voi non sa-rebbe fuor diproposito
LIB. Che ne diteeh? Il buon Ra-gazzino!MEN. Eh non èpoi tanto Ragaz-zino.LIB. Certo, che èmolto garbato.
= = [ma “ch’è”] =
98 ANNA SCANNAPIECO
II.4.22 Il miocuore, Signore,gli vorrebbe darequalche cosa dipiù.
Il mio cuore, Si-gnore, gli vorreb-be dare qualchecosa di più, se dipiù avessi.
= = =
II.5.24 questi Si-gnori Ospiti Vil-leggianti […] vo-gliono anche ildivertimento del-le Villanelle; ecolle mie s’attac-cano; e io fo loroil mezzano.
questi Signori O-spiti Villeggianti[…] vogliono an-che il divertimen-to delle Villanel-le, e io fo loro ilmezzano.
= = =
II.8.38 Assicura-tevi, che in ciòconsiste la più fi-na delicatezzadella passione.
Assicuratevi, chein ciò consiste lapiù fina delica-tezza dell’amici-zia.
= = =
II.11.16 A mepiace la carnegrassa
A me piace ilgrasso
= = =
II.11.22 Se fossia casa, mi spo-glierei tutto, eandrei a gongola-re nel letto
Se fossi a casa mispoglierei tutto, eandrei a buttarminel letto
= [ma “anderei”] = =
II.11.39 Mi vienvoglia ora di pe-larlo come uncappone
Mi vien vogliaora di pelarli laparrucca come uncappone.
= [ma“perrucca”]
= =
III.5.7 Io non so-no Signora; sonchi sono, e nonmi burlate, che visaprò rispondere,come va risposto.
Io non sono Si-gnora; e non miburlate, che vi sa-prò rispondere,come va risposto.
= = =
III.6.10 Ora nonso niente di ca-valleria. Andatevivoi alzando belbello, io bel bellomi anderò abbas-sando, e vo, chesiamo del pari.
Ora non so nientedi cavalleria. Conle Persone delvolgo vado allabuona.
= = =
III.8.11 Gli leve-remo l’incomodo.Signore, sto qui =
Gli leveremol’incomodo, io,Signore, sto qui
Gli leveremol’incomodo:io, Signore,
Per una mappa della produzione goldoniana 99
poco lontana. (adon Paoluccio, eparte
poco lontana adon Paoluccio, eparte
sto qui pocolontana (adon Paoluc-cio, e parte
III.14.27 una solaè la Dama ch’iovenero, una solaavrà il mio cuoredivoto
= =
una sola avrà ilmio cuore divoto.
=
III.17.5 Lasci fa-re, che sarà ser-vita
= Lasci fare a me,che sarà servita
= =
III.17.8 Se mi da-ranno le mie sod-disfazioni
= = =Se mi daran-no la mia sod-disfazione
III.17.17 che gra-vità ammirabile
= che gravità ama-bile
= =
III.18.13 Non vor-rei però, ch’ei cidisturbasse.
=Non vorrei peròch’ei si disturbas-se.
Non vorrei peròch’ei si turbasse
=
III.ultima.11 Ser-va, illustrissima.
= = Serva umilissima =
La campionatura proposta, per quanto modesta (ma sarà a suo luogo in-tegrata da più cospicue esemplificazioni)159, consente di radiografare moltoagevolmente le principali dinamiche variantistiche che si producono nel la-birintico percorso che conduce i testi dalla princeps all’ultima edizione“d’autore”. Nell’indubitabile sviluppo San Tommaso> Savioli> Guibert>Zatta, ciò che in primo luogo balza agli occhi è la natura consapevolmenteinnovativa degli interventi che si producono nella prima tappa della tra-smissione testuale, all’altezza dell’edizione bolognese. Si tratta, a ben vede-re, delle uniche modifiche che possono essere ascritte ad una tipologia va-riantistica pienamente sostanziale in quanto volontaria, e sono naturalmentequelle che maggiormente incidono sulla ridefinizione degli assetti redazio-nali e a cui pertanto si devono le più significative implicazioni interpretati-ve. Non a caso, proprio perché non riconosciute nella loro origine prima,
159 Cfr. infra, § 4, nni 16, 29, 32, 52, 59, 61, 73, 75, 77, 86, 88, 96, 98, 100, 104, nonchéinfra, pp. 104-105, 107-108, 110-113 e n. 178. Segnalo il caso particolarmente interessantedel Geloso avaro (n° 75), in cui gli interventi censori subentrano solo all’atto della secondaristampa bolognese (cfr. ivi, la relativa documentazione stemmatica): se, invece di attingeread un esemplare STA 1763, S fosse derivato da uno della prima impressione (1757, fedelealla redazione d’autore), le modifiche censorie non sarebbero più state attestate nel corsodella tradizione (per un caso analogo, cfr. infra, pp. 107-108 e n. 182).
100 ANNA SCANNAPIECO
alcune di queste varianti – pur giustamente valutate nel loro discendere dauna «revisione di stampo moralistico delle battute più pesantemente allusi-ve alla sfera erotica e giocate su evidenti doppi sensi» – hanno potuto faraddirittura chiamare in causa il «nuovo clima austero che si era venuto acreare a Venezia durante e dopo gli anni sessanta» e ad adombrare, per lestesse un principio di paternità autografa160. Non la presunta involuzione delcontesto venenziano né tanto meno la volontà di un autore trasfigurato dasenile pruderie, ma i revisori del S. Officio di Bologna erano in realtà gliartefici di questi interventi censori, imposti per il rilascio del prescritto im-primatur agli stampatori della San Tommaso (la stamperia d’altronde erastata donata ai confratelli di San Domenico Maggiore proprio perché rite-nuti «religiosi che fossero sodi difensori della fede cattolica»161). Di questetrasmutazioni coatte che venivano inflitte ai suoi testi Goldoni era ben con-sapevole, e non aveva mancato di lamentarsene pubblicamente, pur doven-do contenere e sfumare i toni del risentimento per presumibili ragioni diopportunità “politica”. Proprio da Bologna, infatti, in data 23 maggio 1752,stilando la prefazione all’Erede fortunata, aveva potuto, con secca ironia,denunciare: «qui in Bologna mi fanno l’onore di ristampare le mie Comme-die; so però che alcuna di esse stampasi mutilata, per ragioni che io noncerco di penetrare»162; di rimando, gli editori bolognesi, all’atto di prefarrela propria ristampa della commedia (edita in quello stesso 1752), potevanocosì giustificarsi:
La presente Commedia è stata mandata alle stampe dal dotto suo Autore standoegli in Bologna […] Fa [l’autore, nella prefazione all’opera] menzione del Sig.Marchese Senatore Francesco Albergati […]; né noi abbiamo voluto tralasciarequesto degno Elogio, per non pregiudicare alle nostre stampe. Noi in esse ab-biamo avuto a dipendere da’ Revisori, a cui è paruto di levare in un passo, o duequalche formola, che poteva cagionare equivoco, per meglio uniformarsi allaincomparabile castigatezza dell’Autore, che si merita lode d’insigne modestia. Eciò vaglia perché nessuno ci tenga così animosi di metter mano in cose d’un
160 Cfr. A. ZANIOL, Per una rilettura..., cit., pp. 209, 212, 218-219.161 Così recitava la principale motivazione della donazione del Marsili, documentata ne-
gli Atti legali per la fondazione dell’Istituto delle scienze ed arti liberali – per memoria a tuttigli ordini ecclesiastici e secolari della città di Bologna, Bologna, S. Tommaso d’Aquino,1728 (cit. in V. ALCE, La stamperia bolognese di San Tommaso d’Aquino, cit., p. 32). Suglistretti rapporti tra i titolari della stamperia e i responsabili del S. Officio, cfr. quanto già se-gnalato supra, n. 120; per la controversa questione dei rapporti tra la San Tommaso e gli«Impressori del S. Offizio» (Eredi di Costantino Pisarri e Giacomo Filippo Primodì), cfr. in-fra, § 5, pp. 220-222.
162 XIV 454 (dalla prima prefazione alla commedia, stampata nel t. III Bettinelli, 1752).
Per una mappa della produzione goldoniana 101
tanto Valentuomo, a cui supponiamo che debba esser grata la nostra ristampa,come uno degli argomenti della stima, in cui qui si tengono le opere sue163.
La necessità di «non contravenire a rispettabili comandi di chi ha tuttal’autorità di darci legge»164, costrinse le stampe bolognesi – lungo tuttol’arco della loro produzione – a rivestire i testi goldoniani di panni varia-mente rassettati, pur nella continua – e a suo modo sincera – protesta di fe-deltà agli originali 165, determinata tanto da escludere il pur vantaggioso ri-corso a materiale apocrifo (almeno fino a quando le pubblicazioni d’autoreavrebbero garantito il necessario rifornimento per il prosieguo della propriainiziativa)166.
Indossate comunque nuove vesti bolognesi, moltissime de «le commediedel signor avvocato Carlo Goldoni veneziano» continuarono il loro viaggiotestuale attraversando il variegato orizzonte della produzione editoriale set-tecentesca: gli inevitabili strappi che si produssero durante il tragitto solle-citarono nuovi rammendi, che ricomposero il tessuto secondo altre fattezzeancora – fino a che il passivo accoglimento nell’ultima “edizione d’autore”non impresse alle loro forme variamente adulterate un marchio – definitivo
163 A’ lettori de L’erede fortunata, in Le commedie del signor avvocato Carlo Goldoniveneziano, t. III, Bologna, Girolamo Corciolani ed Eredi Colli a S. Tommaso d’Aquino, 1752,p. 3 (il corsivo è mio). Giova segnalare che il passo citato venne espunto nelle successive ri-stampe della commedia.
164 «Questa [commedia] è l’unica che trovarete variata in qualche piccola parte; per noncontravenire a rispettabili comandi di chi ha tutta l’autorità di darci legge. Nell’Atto secondo,Scena X, trovarete la mutazione, questa però sì piccola che poco è ciò che si è levato, e nonpassano le tre le parole aggiunte» (A’ lettori de I due gemelli veneziani, ivi, t. I, 1752, p. iii).
165 Cfr. ad esempio le affermazioni ricorrenti nella prefazione al Moliere: «Noi che pervantaggio, e profitto delle nostre stampe abbiamo intrapreso di ristampar le Commedie ap-plauditissime di questo gran poeta, non ardiremo mai di mutar in esse consigliatamente purun apice» (A’ lettori de Il Moliere, ivi, t. V, 1753).
166 Estremamente interessanti, al riguardo, le dichiarazioni ricorrenti nella prefazione allaSposa persiana: «Eccovi finalmente la tanto bramata, tanto applaudita Sposa persiana […].Non si estinse l’ardente sete di vederla col chiudersi de’ Teatri […]; cominciò però a giraremanoscritta di mano in mano, né manco chi con premurose instanze ci sollecitasse a pubbli-carla con le nostre stampe, esibendoci il manoscritto talmente disposto, che tosto potevasimetter mano all’opera. Nell’eseguire il progetto ci vedevamo manifesto il nostro vantaggio,ma abbiamo creduto di non dover farlo; eravamo di questo rispetto debitori al rinomato suoAutore di non pubblicarla prima di esso, ed assicurarci, che non riuscisse con suo dispiacere,forse in molte parti difformata. L’attenzione di noi posta nel darvela fedele, compensarà latardanza nel soddisfarvi» (A chi legge La sposa persiana, in Nuovo teatro comico del signoravvocato Carlo Goldoni, t. I, Bologna, Girolamo Corciolani ed Eredi Colli a S. Tommasod’Aquino, 1757, p. 3; il corsivo è mio). Per le ragioni che, nei primissimi anni settanta, pro-vocarono il rovesciamento di questa politica verso gli inediti, cfr. supra, pp. 69-70, n. 114.
102 ANNA SCANNAPIECO
quanto mendace – di autenticità. Accanto infatti all’indiscutibile intenzio-nalità e sostanzialità delle trasmutazioni subentrate nell’officina della SanTommaso, ciò che maggiormente contraddistingue l’evoluzione variantisti-ca è, da un lato, la casualità del suo prodursi, dall’altro il suo essere recepitain modi del tutto inerti dalla Zatta. In particolare, non sarà sfuggito come,all’altezza della Savioli – che naturalmente non si interroga (come potrebbefarlo?) sulla qualità delle redazioni accolte –, lo scarso controllodell’allestimento tipografico innesca un eterogeneo processo corruttivo,dando luogo a soluzioni testuali rispetto a cui il successivo passaggio reda-zionale – quello della Guibert – potrà, per così dire, difendersi come può.Del tutto a loro agio – ma anche davvero marginali – le resistenze di tipoortografico (per il non sprovveduto compositore della tipografia torinese èimmediata la normalizzazione di un lo portato in l’ho portato); del tuttoinermi quelle che devono confrontarsi con varianti adiafore (come distin-guere in un Mi no so gnente il prodotto di una sovrapposizione inconsape-vole con cui il proto veneziano della Savioli ha occultato l’originario Mi nolo so; o in un che gravità amabile l’errore ottico che ha trasformatol’iniziale che gravità ammirabile?); tanto energiche e creative quanto sub-dolamente apocrife quelle che si impegnano a sanare per congettura le la-cune identificabili per tali. In tali casi, lo zelo del correttore può approdare asoluzioni emendatrici o formalmente ineccepibili, ma nettamente difformidall’intenzione espressiva originaria (si consideri l’evoluzione Non vorreiperò, ch’ei ci disturbasse> Non vorrei però ch’ei si disturbasse> Non vor-rei però ch’ei si turbasse); o a vere e proprie innovazioni che vorrebberoemulare, in absentia, i frammenti scomparsi: capita così che tra i versi delgoldoniano Torquato Tasso possa persuasivamente infiltrarsi («un bel ver-so», lo giudicò Ortolani)167 l’autentica patacca di un proto torinese. Peraltro,come si sarà notato, anche la Guibert non manca, autonomamente, di“aggredire” ciò che le è pervenuto del testo originario, allineando sulla pa-gina nuove sovrapposizioni (involontarie e con risultante – apparentemente
167 Cfr. supra la variante occorrente in II.10.32-35 (alla caduta accidentale di un versonella Savioli che viene a lasciare incongruamente sospesa la rima successiva, la Guibert rea-gisce creandone uno ex novo – attribuito peraltro a diverso personaggio – che riassesti losquilibrio metrico). Per il citato giudizio di Ortolani, cfr. V 1382; va tuttavia segnalato che ilcritico, pur nell’“ingenuità” ecdotica che gli era propria, espresse sempre una sana – perquanto del tutto intuitiva – diffidenza e/o perplessità nei confronti degli sviluppi variantisticiseriori (ascritti alla Zatta, o tutt’al più alla Savioli, come lo stato della conoscenza bibliografi-ca gli consentiva di fare). Proprio tale cautela (forse tanto più apprezzabile quanto più incon-sapevole) è stata peraltro stigmatizzata – e sia pure in una fase decisamente più avanzata dellosviluppo critico e bibliografico – a causa di un’indebita sovradeterminazione delle intenzioniautoriali (cfr. A. ZANIOL, Per una rilettura..., cit., pp. 213n e 218n).
Per una mappa della produzione goldoniana 103
– adiafora, del tipo Serva, Illustrissima> Serva umilissima), nuove lacune(si consideri, in Buona moglie I.17.1, la palese occorrenza di un saut dumême au même, che pure potrebbe sembrare variante censoria), correzioniimproprie – in quanto sollecitate dal fraintendimento dell’originale – chedanno luogo a nuove alterazioni (e così, ad esempio, la mancata confidenzacon le strutture morfosintattiche dialettali può indurre lo zelo correttorio atrasformare un L’è qua quel spiantà de Lucindo, ma no ghel voio – nel sen-so di “non ce lo voglio” – in un L’è qua quel spiantà de Lucindo, ma noghel voio dir). Rispetto a questa «cascata variantistica»168 la Zatta si disponecome inerte bacino di raccolta, “limitandosi” ad autenticare sotto un’indebi-ta garanzia di autorialità la varia collana di tradimenti che la tradizione hainflitto ai testi.
In realtà non è nemmeno necessario attendere la forza monumentale eambiguamente testamentaria della Zatta, per vedere apposto un definitivosigillo di autografia su uno sviluppo redazionale variamente apocrifo: per-ché persino la prestigiosissima Pasquali – cui gli studi goldoniani hannosempre riconosciuto un’indiscussa autorità di ne varietur – si mostra espo-sta alle contaminazioni di una tradizione testuale tanto vitale quanto insi-diosa. Come si è già accennato169, sarà bene infatti abituarsi a pensarequest’edizione, che l’autore avrebbe voluto «perfetta»170, come invece con-notata da una natura anfibia di realizzazione tanto autentica quanto spuria.Con il chiamare in causa una valenza di inattendibilità filologica non si in-tende far riferimento a tutte le fisiologiche mende proprie di un qualsivogliaprocesso di composizione tipografica, tanto più se legato a realizzazioneche di fatto escludeva l’autore dalla possibilità di un suo diretto o ravvici-nato controllo: ma proprio ad una dimensione di originaria e costitutivainaffidabilità. La cesura – netta – tra autentico e inautentico cade dopo lapubblicazione del t. X, a seguito della quale il disinteresse dell’autore per
168 La formulazione, felicemente sintetica, si deve a L. RICCÒ, Nota al testo, cit., p. 86 (emerita segnalare che il lavoro preparatorio per quest’edizione della Castalda ha particolar-mente contribuito alla focalizzazione – peraltro precoce – di alcuni nodi assai problematici:cfr. ad esempio ivi, pp. 87-94, la ricostruzione dei rapporti tra Guibert e Zatta).
169 Cfr. supra, n. 89.170 «Alcuni si lagnano degli autori viventi, perché nel ristampare che fanno le Opere loro,
cambiano sempre […] e non sono mai certi che l’Edizione che comprano abbia ad essere laperfetta, temendone in appresso un’altra migliore. […] ciò non ostante […] posso […] pro-mettere, e sull’onor mio lo prometto, che, fin ch’io viva, non sarà da me in verun modo que-sta mia Edizione alterata, né presterò l’assenso né i mezzi ad alcuno perché possa alterarla[…]; e se la sorte mi favorisce a segno di poter ristampare io medesimo quest’Opera volumi-nosa, sarà sempre la stessa» (XIV 473: dal manifesto dell’edizione Pasquali).
104 ANNA SCANNAPIECO
un’edizione che non può più “servirgli”171 si esprime dapprima in un im-provviso e prolungato silenzio, per risolversi poi nell’abbandono definitivoal proprio destino di un progetto che, da quel momento, diventerà affareesclusivo di Giambatista Pasquali. Certo, l’editore potrà continuare a rende-re il suo prodotto competitivo grazie al materiale inedito acquistatoall’autore (esattamente come avrebbe poi fatto Zatta), e potrà anche spin-gersi ad asserire – confortato dal forzoso compiacimento di Goldoni172 – che«questa Edizione ha le Aggiunte, i Cambiamenti, e le Prefazioni sommini-stratemi dall’Autore», cioè anche «le Commedie nuovamente dallo stessocorrette, e riformate, che comparvero altre volte al Pubblico»173 (ancora unavolta, nihil sub sole novi…): ma, di fatto, le cose non andarono propria-mente così. La mancata assistenza dell’autore comportò non solo una ripre-sa della realizzazione editoriale estremamente faticosa (non più di un volu-me l’anno tra il 1773 e il 1777, gli ultimi due stentamente pubblicati tra il’77 e l’80)174, ma anche la necessità, per il Pasquali, di improvvisarsi succe-daneo dell’autore stesso. Glielo imponeva il prestigio di quel costoso pro-dotto cui bisognava pur continuare a garantire uno smercio: ma le risorse dicui poté avvalersi non furono, naturalmente, diverse da quelle che avevano(e avrebbero) potuto impiegare altre – e sia pur meno “impegnate” e “impe-gnative” – edizioni. Fermo restando che quanto suggerito in questa sedeavrà bisogno di più estese e puntuali verifiche, giova cominciare a conside-rare nel concreto le modalità secondo cui, dal t. XI in poi, le commedie giàin precedenza pubblicate venissero riproposte nella Pasquali «nuovamente[…] corrette, e riformate». Si osservino per esempio le più significative in-novazioni introdotte nel caso della Donna vendicativa:
PA VII 1754 STA1 X 1754 (17632; 17753)S1 V 1771 (17752)
G1 XIII 1773PS XVI 1777-1779
(Z XVII 1791)I.8.61io non me ne fido per niente io non me ne fido niente
171 Cfr. quanto argomentato supra, pp. 87-88.172 Cfr. quanto segnalato supra, n. 149.173 Giambatista Pasquali Librajo, e Stampatore Veneto, Alli Signori Associati
all’Edizione delle Commedie del Sig. Dottor Carlo Goldoni, in Delle commedie, cit., t. XII(ultime pagine non numerate).
174 Per la ridefinizione cronologica della Pasquali, resa possibile da un vaglio delle fontidocumentarie superstiti, cfr. infra, § 5, pp. 214-217.
Per una mappa della produzione goldoniana 105
II.3.1altri non desidero, che Florindo altro non desidero, che Florindo
II.7.16Siete… Siete… basta… Non ve la vogliodare
Siete… Siete… Non ve la voglio dare
III.1.8onde, o non mi ha amata mai, o si è pentito onde, non mi ha amata mai, o si è pentito
III.16.30sebbene mi strapazza […] so poi anche, chemi vuol bene
sebbene mi strapazza […] so poi, che mivuol bene [STA=PA]
III.17.5BEATRICE Così non ci foste venuta ROSAURA Così non ci foste venuta
III.17.16Sì, anderò via Sì, sì, anderò via [STA=PA]
III.17.56Rapire? Bastonare? Ammazzare? Rapire? Bastonare?
III.ultima.26Non avete sentito? Tutti. Non avete sentito?
Come si vede, anche l’«amatissimo», «caro amico Pasquali»175, nonesitò ad “aggiornare” la propria offerta goldoniana, ricorrendo precisamentea quelle «altre [edizioni] tutte imperfette, e mancanti» che avevano prece-duto la «sola […] Edizione, che approva e riconosce per sua il degnissimoAutore»176: in particolare, anche la sua scelta – obbligata – dovette far rife-rimento alla stratificata fisionomia del testo goldoniano così come impostasul mercato dal ramo vincente della tradizione, l’“asse di ferro” San Tom-maso-Savioli177. Anche se meno significativi, si potrebbero allegare altri
175 Così Goldoni ebbe ad esprimersi sull’editore rispettivamente nella Lettera del Sig.Dottor Carlo Goldoni… [1772], cit., e in una lettera a Gabriele Cornet del 24 ottobre 1762(XIV 266; cfr. anche ivi 262, 264, 274-276).
176 Così dichiarava l’editore stesso in Giambatista Pasquali Librajo…, cit.177 Anche se il caso della Donna vendicativa potrebbe rendere lecita l’ipotesi di una deri-
vazione della Pasquali dalla Guibert, in realtà l’osservazione degli sviluppi redazionali nelcaso di altre commedie (cfr. infra, pp. 106-108, 110-111 e n. 182) induce a credere che l’an-tigrafo di riferimento dovette essere costituito dalla Savioli (a sua volta discendente da STA).
106 ANNA SCANNAPIECO
esempi178, e si potrebbe anche, più in generale, riconsiderare come non ca-suale – in questa nuova prospettiva d’analisi – lo spartiacque deciso che se-para la fisionomia redazionale (pressoché sempre soggetta a trasmutazioni,anche radicali, del precedente assetto testuale) delle commedie ristampatenei primi dieci tomi Pasquali179, da quella insolitamente “rispettosa” versol’antecedente configurazione editoriale, che risulta documentata invecenella ristampa delle commedie contenute negli altri volumi. Sarà tuttaviaancor più utile tentare una prima focalizzazione delle modalità secondo cui,nell’officina tipografica di un editore “orfano” dell’assistenza dell’autore, sipocedette a garantire l’ormai difficile binomio dell’autografia e della“nuova correzione”.
Sarebbe in effetti possibile indulgere alla tentazione di ritenere anche ilPasquali un “plagiario” del tutto in linea con le logiche produttive del mer-cato editoriale. Ad esempio è quanto spingerebbe a fare il caso curioso – e,sorprendentemente, mai considerato – della Pupilla, per la cui ammoder-nata confezione l’editore pensò bene di travasare, sic et simpliciter, nellapropria accreditatissima ristampa il riassunto dell’originaria prefazione Pa-perini che avevano a loro tempo stilato i correttori della San Tommasod’Aquino180; ma in realtà la verifica testuale riserva altre sorprese ancora:
178 Cfr. ad esempio alcuni degli sviluppi variantistici osservabili nel caso dell’Impostore(n° 84): PA Signor] STA S G PS Sior (I.1.14 e I.2); PA STA ciera de galantomo] S G PS Zciera da galantomo (I.3.34); PA STA Donè da magnar] S G Z Dene da magnar ] PS (per at-trazione ottica dalla riga successiva) Dem da magnar (I.3.64); PA STA padre] S G PS Z pare(II.4.15); PA dove che ghe xe delle putte] STA S G PS Z dove ghe xe delle putte (II.5.13);PA STA vi preme assai.] S G PS Z vi preme assai? (III.17.20).
179 Come desumibile dalla segnalazione delle evoluzioni redazionali che correda la rico-struita mappa della produzione goldoniana (cfr. infra, § 4), solo una commedia, tra quelleristampate nei primi 10 tomi Pasquali, sembra – salvo ulteriori verifiche – non aver sostenutointerventi correttori (La moglie saggia, n° 64).
180 Giova riportarne il testo, anche perché Ortolani riproduce l’originaria prefazione Pa-perini e, contrariamente alla sua prassi ordinaria, non menziona neppure la radicale diversitàdell’assetto testuale nell’edizione Pasquali della commedia (cfr. VI 1252-1253): «QuestaCommedia intitolata LA PUPILLA, protestasi l’insigno nostro Autore d’averla composta per lasola edizione, ad imitazione de’ nostri antichi Poeti Comici. È facile scoprire quali tracce egliabbia seguite; [STA S: seguite,] e di che sarebbe capace di fare su l’esempio degli altri, se[STA S: degl’altri se] si volesse angustiare ne’ limiti della sola imitazione, e non gli piacesseseguire la sua abilità, e soddisfare all’età presente, che qualche cosa più esige. Non v’ha luo-go a temere, che la simplicità dell’argomento, la scarsa fecondità dell’intreccio, la nudità de’caratteri, il verso sdrucciolo la [STA S: le] pregiudichino, mentre egli ha saputo liberarla datali pregiudizj: [STA S: pregiudizj;] lo stile usato da esso non è antico, ma soltanto all’anticafoggia trattato; della catastrofe tanto famigliare agli antichi [STA S: agl’antichi], e dello scio-glimento di essa possono essere contenti ancora i moderni. Nel dare questo saggio della suaabilità nella imitazione, o a dir meglio, nel miglioramento di essi, ha ritenuto l’invariabile suo
Per una mappa della produzione goldoniana 107
PA X 1757 a) STA1 XII 1757181
b) STA1 XII 17652a) S1 V 1771 (17752)
b) G1 XI 1773[Z XXX 1793]
PS XVII 1780
I.5.18questo poi continuo /starsi attaccati
questo poi continuo /starsene insieme
= = PA
II.3.18E ab intestato conse-guire i rediti / del-l’avo suo
a) = PAb): E ab intestatoconseguire i crediti /dell’avo suo
= STA1 17652 = STA1 17652 , S, [G]
II.6.4Basta, ch’ei non sipenta, io non oppon-gomi
Basta ch’ei non sipenta, io non mi op-pongo
= = STA1, S, [G]
III.2.15
costume di non farsi loro [STA S: farseli] seguace nella poco modesta libertà del parlare;[STA S: parlare,] onde anche perciò l’è dovuto il titolo di Riformatore [STA S: Rifformatore]della Commedia Italiana. Vivete felici». Nel corpo del testo, tra parentesi quadre, sono statesegnalate le lezioni originarie (Savioli –, che, come si dirà, è il vero anello di trasmissione nelcaso di questa e di altre commedie – riproduceva fedelmente dall’edizione bolognese anchequesta prefazione): come si vede le varianti sono del tutto circoscritte e marginali, e in quelloche doveva poi risultare l’ultimo tomo della prestigiosa edizione goldoniana risulta così bru-talmente immesso il “lontano” prodotto – apocrifo e scadente – dell’officina tipografica bolo-gnese (l’unico, pallidissimo sforzo di ricreare omogeneità redazionale con il contesto è nellavariazione apportata al titolo, che trasforma l’originario A chi legge nel canonico L’autore achi legge). Il clamoroso falso dell’editore ha tuttavia continuato ad ingannare lettori e studio-si, e in tempi recenti non è mancato chi ha tratto proprio dalla “nuova” veste della prefazione“Pasquali” alla Pupilla motivo di riflessione per definire alcuni tratti dell’evoluzione ideolo-gico-artistica dell’autore (cfr. L. ROSSETTO, Tra Venezia e l’Europa…, cit., pp. 126-127, se-condo cui nella prefazione Pasquali alla Pupilla è dato scorgere i segni di una «revisioneeditoriale [che] mira […] a conferire ai testi una maggiore moralità, adeguata al titolo di“Riformatore della Commedia Italiana” che egli [Goldoni] si attribuisce». Cfr. anche infra, n.184).
181 L’imprimatur venne rilasciato il 17/7/1757, a seguito di revisione di «D. PlacidusRambaldi Clericus Regularis Sancti Pauli, & in Ecclesia Metropolitana Bononiæ Pœnitentia-rius pro Eminentissimo & Reverendissimo Domino D. Vincentio Card. Malvetio Archiepi-scopo Bononiæ, & Principe S.R.I.»; circa due settimane dopo (il 2 agosto), veniva rilasciatol’imprimatur per la stessa commedia a Giacomo Primodì, «Impressore del Sant’Officio» aseguito di revisione di «D. Jo: Maria Vidari Clericus Regularis Sancti Pauli, & in EcclesiaMetropolitana Bononiæ Pœnitentiarius pro Eminentissimo & Reverendissimo Domino D.Vincentio Card. Malvetio ecc.»: l’edizione Pisarri, rispetto alle zone testuali citate a testo, sipresenta estremamente fedele alla redazione Paperini (solo in V.2.22 l’originario bel senoviene modificato in core). Se Savioli avesse derivato il proprio testo da un esemplare dellaPisarri (il che altre volte accadde: cfr. A. SCANNAPIECO, Lo statuto filologico…, cit, pp. 151-152), piuttosto diverso – ancora una volta per ragioni del tutto casuali – sarebbe stato l’assetto“definitivo” del testo.
108 ANNA SCANNAPIECO
Nel dì medesmo disposarla io medito,ch’ei ti porge la ma-no
= Nel dì medesmo disposarla io medito,ch’ei ti porga la ma-no
= S, [G]
III.5.25Domine, / non so chedir
a) = PAb): Diamine, / non soche dir
= STA1 17652 = STA1 17652 , S, [G]
IV.3.3S’ei, Messer Luca,non ha di che oppo-nere / al desiderio,che mi sprona, e ac-celera
a) = PAb): S’ei, Messer Lu-ca, non ha di che op-ponere / al desiderio,che mi sprona, e lace-ra
a) = STA1 17652
b): Se Messer Lucanon ha di che oppo-nere / al desiderio,che mi sprona, e lace-ra
= STA1 17652 , S
IV.3.32a voi, che questa ma-ne a chiedere / mevenite in isposa
= a voi, che questa ma-ne a chiedere / meveniste in isposa
= S, [G]
V.1.9è un’ottima / scusaper noi d’essere en-trati libera- / mente,senza ottener pria lalicenzia
a) = PAb) è un’ottima / scusaper noi d’essere en-trati liberamente, /senza ottener pria lalicenzia
a) è un’ottima / scusaper noi d’essere en-trati liberi, senza ot-tener pria la licenziab) è un’ottima / scusaper noi d’essere en-trati liberi, senza pri-ma ottenerne la li-cenzia
= PA, [STA1 1757]
V.2.22E quel bel seno, chefelice un giovane /render potrebbe
E quel bel viso, chefelice un giovane /render potrebbe
= STA1 STA1, S, [G]
Come si vede, se la stragrande maggioranza delle varianti confermaquello che la riproduzione integrale della prefazione bolognese aveva leci-tamente lasciato presagire (e cioè un allestimento tipografico basato sullaredazione San Tommaso, nella mediazione Savioli)182, alcune significative
182 Ben sette occorrenze sulle complessive nove segnalate appartengono al ramo SanTommaso-Savioli: cfr. II.3.18, II.6.4, III.5.25, IV.3.3, V.2.22; per lo specifico della media-zione Savioli si considerino gli ulteriori slittamenti di III.2.15 e IV.3.32. Non sfugga la circo-stanza che vede la nuova stampa bolognese della commedia introdurre varianti rispetto al suoprecedente allestimento editoriale (e cfr. infra, § 4, quanto segnalato per il Geloso avaro, n°75), e come sia precisamente dall’impressione del ’65 che la Savioli (e poi la Pasquali da unlato, e la Guibert e la Zatta dall’altro) deriva la “propria” redazione: a non conoscerequest’ulteriore anello di trasmissione si sarebbe inevitabilmente attribuita all’edizione vene-
Per una mappa della produzione goldoniana 109
diffrazioni (I.5.18 e V.1.9) lasciano invece inequivocabilmente intendereche il compositore della Pasquali ebbe ad avvalersi anche di una stampa cheriproduceva l’originaria redazione Paperini. Allo stato attuale delle rico-struzione bibliografica, è impossibile documentare l’ipotesi dell’eventualeesistenza di un ulteriore anello della catena, che già presentasse in formaunitaria la risultante di una collazione operata in sede di allestimento tipo-grafico e di cui il Pasquali avesse potuto più sbrigativamente avvalersi nellaconfezione del proprio prodotto: per la verità, i dati sinora in nostro posses-so ci indurrebbero ad escludere una simile eventualità – che tuttavia,quand’anche si fosse prodotta, non potrebbe alterare i termini della valuta-zione filologica e critica. Quello che Pasquali appone sotto il segno del-l’autografia più certa è una redazione mescidata, che mette assieme pezzioriginari (non si sa in base a quale criterio richiamati in vita)183 con lezionispurie (della cui apocrifia l’editore non poteva non essere consapevole), ac-colte o per pragmatismo compositivo184 o per l’espressione di un parametrodi giudizio estetico sulla cui identificazione si potrà pure ragionare, ma dicui tutto può dirsi fuorché documentario di intenzioni autoriali. Anche se aquesto punto dovrebbero essere ben chiare le conseguenze ecdotiche chederivano dall’ibridazione redazionale che sembra essere stata propria dellecommedie ripubblicate negli ultimi sette tomi, gioverà soffermarsi sulle im-plicazioni interpretative che possono venire da una più ragionata conoscen-
ziana buona parte (II.3.18, III.5.25, IV.3.3) degli interventi che erano già stati invece intro-dotti nella bolognese.
183 Si veda l’incongruente rifiuto dell’intervento censorio in I.5.18 a fronte della preser-vazione di quello occorrente in V.2.22, oppure la fedeltà alla configurazione redazionale (emetrica) di V.1.9 contro l’accoglimento della banalizzazione operante in IV.3.3.
184 È il caso, evidente, della riproduzione della prefazione bolognese che, per quantomolto difforme dal registro stilistico e dalle strategie argomentative propri delle autenticheprefazioni goldoniane (si veda l’utilizzo della terza persona o la formula di congedo;l’insistito moralismo o quei toni smaccatamente apologetici così estranei all’intelligenza reto-rica di Goldoni), fu sbrigativamente assunta dal Pasquali perché veniva a toglierlo dal diffi-cile imbarazzo di non poter intervenire con semplici tagli redazionali (come mostra di saper epoter fare in altri casi) sulla prefazione originaria, troppo articolatamente compromessa con ilpiano editoriale di appartenenza (cfr. VI 516-519); anche in forza della “nuova” genericitàredazionale, il sunto bolognese poteva invece simulare – e sia pur ad occhi inesperti – unaqualche pertinenza argomentativa (si consideri la maggiore duttilità della formulazione inci-pitaria, «Questa Commedia […] protestasi l’insigno nostro Autore d’averla composta per lasola edizione», che può utilmente prestarsi ad ambiguità interpretativa – e lasciare all’ingenuolettore intendere che sia prodotto “nuovo” della “nuova” edizione Pasquali –, laddovel’originale paperiniano recitava un inequivocabile «Per supplire al numero delle cinquantapromesse, alcuna ho dovuto crearne di nuova […]. Questa è una delle novissime per la solaEdizione composte»).
110 ANNA SCANNAPIECO
za della morfologia dell’edizione Pasquali, nonché da quella del suo stessosviluppo cronologico.
Si prenda il caso dell’Erede fortunata, edita in quel t. XV che sinora unutilizzo davvero maldestro delle fonti ascriveva al 1774185 e che invece nonpuò essere considerato anteriore al 1776-77. Anche in questo caso, la ri-stampa Pasquali della commedia può – una volta riconosciuta nella sua giu-sta collocazione cronologica – rivelare una configurazione redazionale va-riamente debitrice di apporti apocrifi:
PA VI 1754 STA1 III +S1753(17542; 17663)
a) S1 VI 1771b) G1 XIII 1774c) Z XXI 1791
PS XV 1776-77
I.1.8stabili, e semoventi = stabili, semoventi = PAI.1.9Fin qui va bene = Fin qui la va bene = PAI.6ci mettono i piedi sulcollo, ci comandano,ci disprezzano, e cistrapazzano.
= ci mettono i piedi sulcollo, ci comandano,ci disprezzano, cistrapazzano.
= S, [G]
I.9.1Che temeraria! Che temerità! = STA = STA, S, [G]I.10.8-9OTTAVIO Ma [vostropadre] dispone dellavostra fortuna.ROSAURA La miafortuna non consistenell’amor vostro.
OTTAVIO Ma [vostropadre] dispone dellavostra fortuna.ROSAURA La miafortuna consiste nel-l’amor vostro.
= STAOTTAVIO Ma [vostropadre] dispone dellavostra fortuna.ROSAURA La miafortuna non consistenell’amor vostro?
I.13.8questi rimedi sontroppo violenti, e po-trebbono precipitarenon solo […]
= [ma: “potrebbero”] questi rimedi sontroppo violenti, po-trebbero precipitarenon solo […]
= S, [G] [ma: “vio-lenti:”]
185 Cfr. infra, § 5, n. 339. Che possa essere talora essenziale individuare l’esatta scansio-ne cronologica dei tomi Pasquali – con particolare riferimento agli ultimi sette – è compro-vato proprio dal caso dell’Erede fortunata: laddove si fosse continuato a ritenere il t. XV del1774, cioè dello stesso anno in cui Guibert e Orgeas proponevano nel t. XIII della propriaedizione la ristampa della stessa commedia (in una redazione per forza di cose affine a quelladell’edizione d’autore) si sarebbe stati inevitabilmente indotti a rovesciare i termini del rap-porto genetico tra le due edizioni (anche se poi in realtà, come vedremo, la Guibert derivadirettamente – e non attraverso un’eventuale mediazione Pasquali – dalla Savioli: ma l’impor-tante è escludere a priori che la Pasquali possa aver influenzato la Guibert).
Per una mappa della produzione goldoniana 111
I.13.25O farmi parlar conRosaura, o io faròdelle pazze risoluzio-ni.
= O fammi parlar conRosaura, o io faròdelle pazze risoluzio-ni.
= S, [G]
I.14.1mi prevarrò di lui. = mi prevalerò di lui. = S, [G]I.15.27quand l’ha stabilidocusì, sarà cusì
= quand l’ha stabilì co-sì, sarà cusì [Z: cusì[…] cusì]
= PA
I.15.35Va là, che ti è un uo-mo de garbo.
= Va là, ti ti è un omode garbo.
Va là, che ti è un o-mo de garbo.
I.16Se dichiaro di volerlo = Se mi dichiaro di vo-
lerlo.= S, [G]
II.5.8Via, sì, stasera = Via, sì, questa sera. = PAII.5.15Sì, me ne recordo. = Sì, me recordo [G, Z:
ricordo].= PA
II.5.17-29ARLECCHINO A mez-z’ora di notte? TRA-STULLO Sì; poco cimanca. ARL. Cossahoio da far a mezz’o-ra?
= [ma: “Sì, poco”]
S = STA (ma “de”)G, Z:ARL. A mezz’ora denotte? TRAST. Sì, po-co ci manca. ARL.Cossa hojo da far amezz’ora di notte?
= PA, STA, S
III.2.27-28FIAMMETTA Non siparla.ARLECCHINO Patirò.
FIAMMETTA Non siparla.ARLECCHINO Partirò.
= = PA
III.2.32FIAMMETTA Coman-do.ARLECCHINO Biso-gnerà obbedir.
= FIAMMETTA Coman-do.ARLECCHINO Biso-gna obbedir?
FIAMMETTA Coman-do.ARLECCHINO Biso-gnerà obbedir?
III.3.15Dirò, sior… la sap-pia…
= Dirò… la sappia… = S, [G]
La campionatura proposta consente di riscontrare quella stessa ibrida-zione redazionale che avevamo già visto operante nella Pupilla, anche seespressa in forme ancora più sottili, e – laddove non riconosciute nella loro
112 ANNA SCANNAPIECO
dinamica genetica – fuorvianti; ma per valutare appieno il peso delle conse-guenze interpretative che potrebbero venire da una mancata definizione deirapporti stemmatici, gioverà considerare la natura delle seguenti occorrenzevariantistiche:
I.4 PA / S> [G] PS186
1 ARLECCHINO Sior Padron… [PS: Patron]OTTAVIO Son l’uomo più infelice di questa terra.ARLECCHINO Sior Padron… [PS: Patron]OTTAVIO Non me l’averei mai creduto. [PS: avrei]5 ARLECCHINO Ah, Sior Padron… [PS: Patron]OTTAVIO Va’ al diavolo.ARLECCHINO Che vada? Anderò in atto di partireOTTAVIO Cosa volevi da me?ARLECCHINO Aveva da dirghe un no so che, per part de siora Rosaura, ma vado via.10 OTTAVIO No, fermati. Cosa mi dovevi tu dire?ARLECCHINO Vado al diavolo.OTTAVIO Parla dico, o ti bastono. alza il bastoneARLECCHINO La se ferma, parlerò. Siora Rosaura dis cusì, che ghe premeria de parlarghe.OTTAVIO Rosaura? Dove?15 ARLECCHINO L’è in te la so camera.OTTAVIO Vado subito. Ma no… Dille, che ora non posso.ARLECCHINO Gnor sì. in atto di partireOTTAVIO Aspetta… Sarà meglio, che io vada. s’incamminaARLECCHINO Gnor sì, sarà mei.20 OTTAVIO Ma, che mai potrò dirle! No, Arlecchino, dille, che non mi hai trovato.ARLECCHINO Ghe lo dirò. in atto di partireOTTAVIO Fermati. Se scopre [scuopre] non esser vero, si lagnerà di me. Anderò dunque.ARLECCHINO Da bravo.OTTAVIO Ma! nella confusione in cui sono… Vanne, dille, che andrò poi.25 ARLECCHINO Non occorr’altro. in atto di partireOTTAVIO No, arrestati, il mio dovere è ch’io vada. parte
I.5 PA / S> [G] PS1 ARLECCHINO Oh, che bel matto!FIAMMETTA Arlecchino…ARLECCHINO L’è veramente redicolo. [ridicolo]FIAMMETTA Arlecchino dico.5 ARLECCHINO Cosa gh’è? [cossa]FIAMMETTA La Signora Beatrice ti domanda.ARLECCHINO Vado… ma no. Famme un servizio, vaghe tì in vece mia.FIAMMETTA E che cosa vuoi, ch’io le dica?ARLECCHINO Sarà meglio [PS: mejo], che vada io. [mi]10 FIAMMETTA Oh sì sarà meglio.ARLECCHINO Va’, dille [dighe], che non mi hai trovato.
186 Salvo diversa avvertenza, le varianti in grassetto indicate tra parentesi quadre a se-guito della lezione PA devono intendersi introdotte da S e poi mantenute in [G,] PS.
Per una mappa della produzione goldoniana 113
FIAMMETTA Ma perché ho da dire questa bugia?ARLECCHINO Se scoprisse non esser vero… anderò io. [se scoverse, che no xe vero…anderò mi]FIAMMETTA Via presto.15 ARLECCHINO Vacci tu. [Va tì]FIAMMETTA Ha domandato di te, non di me.ARLECCHINO Se vuol me, non vuol te… vado… non vado… Oh Dio… resta tu… restatu… che vado io. parte
A prima vista sembrerebbe di avere a che fare con modifiche testualimolto marginali e, tutto sommato, scarsamente incidenti anche sotto il pro-filo interpretativo: ma, a ben vedere, l’emergenza dialettale che nella Sa-violi innova le battute di Arlecchino è qualcosa di più dell’inconscia so-vrapposizione linguistica di un proto veneziano (non a caso la San Tomma-so è estranea allo specifico di questa evoluzione redazionale). Già il ricono-scere per tale una tipologia variantistica accidentale che poi troverà confer-ma anche nella Pasquali comporta per la verità un guadagno ecdotico edinterpretativo non trascurabile (giacché è evidente che una corretta valuta-zione filologica disconoscerebbe qualsiasi valenza positiva alle nuove le-zioni); ma, nel caso specifico le conseguenze critiche sono più estese. Nellascena in questione infatti, il mancato riconoscimento della genesi spuriadella variante rischierebbe di trasformare in intenzione autoriale quella cheè una banalizzazione estremamente depauperativa della redazione origina-ria: si consideri come tutta la scena I.5 era ideata e sviluppata per opporrecon il duetto Arlecchino-Fiammetta un controcanto parodico al precedenteconfronto Arlecchino-Ottavio (che, in questa commedia, estremizzava ilcollaudato prototipo dell’innamorato sospiroso e ammalato d’“amletu-dine”), e come questa intenzione si esprimeva precisamente nell’improvvisaaffettazione linguistica con cui il balordo ma sagace Arlecchino infliggevaalla sbigottita Fiammetta il parossistico e melodrammatico “pendolarismo”con cui il padrone l’aveva in precedenza tormentato (sicché il Sarà meglio,che vada io di I.5.9 maliziosamente rimodulava il Sarà meglio, che io vadadi I.4.18, o il Se scoprisse non esser vero… anderò io di I.5.13 faceva ilverso al Se scopre non esser vero, si lagnerà di me. Anderò dunque diI.4.22, e così via dicendo). È chiaro che la riformulazione dialettale dellestesse battute azzera del tutto non solo quell’intenzione espressiva, ma an-che il valore complessivo della scena che per veicolare quell’intenzione erastata ideata: e, ad accogliere come autografe quelle varianti, ci troveremmodi fronte all’osservazione di un imbarazzante (quanto storicamente infon-dato) esaurirsi della vis poetica goldoniana. Eppure, l’edizione Pasquali ac-credita proprio questi interventi banalmente allografi: Ortolani li riproduce
114 ANNA SCANNAPIECO
a testo187, e la circolazione novecentesca della commedia (a quella ottocen-tesca ci aveva già pensato la Zatta, attraverso la consueta evoluzione STA>S > G> Z) ha continuato a contrabbandare come goldoniana una commediaalle cui rinnovate vesti avevano variamente contribuito le disattenzioni deitipografi settecenteschi.
Prendere atto delle dinamiche evolutive che in vario modo segnano latormentata tradizione del corpus goldoniano mette tra le mani un bandoloprezioso, che indubbiamente aiuta ad orientarsi con più consapevolezza – eanche, mi pare, disinvoltura – in un altrimenti inestricabile groviglio filolo-gico ed ermeneutico. Con l’avvertenza, tuttavia, che il filo andrà seguitocon pazienza, badando a non disperderlo mai tra le lusinghe di certezzeaprioristiche e fuorvianti. Perché questo rischierebbero di diventare anche lepiù ragionate e documentate acquisizioni critiche, laddove si dimenticassedi perseguire il loro ulteriore sviluppo attraverso una verifica puntuale, an-cora una volta libera da ogni pre-giudizio ecdotico, dei dati documentari.Aver individuato alcune possibili piste di percorrenza non deve insommafar credere, per inganno prospettico, che siano delle scorciatoie: prima o poisi potrebbe scoprire che erano solo dei vicoli ciechi. E allora, per evitarne ilrischio, potrebbe essere utile tracciare un punto di netta provvisorietà a que-sta prima ricognizione della “mappa” goldoniana, suggerendo alcuni spuntidi riflessione che impongano al percorso analitico sin qui seguito l’explicitdi un disorientante quanto salutare “finale aperto”.
Che lo sviluppo San Tommaso> Savioli> Guibert> Zatta caratterizzi, neimodi che si è delineato in precedenza, buona parte della tradizione testuale,non deve far perdere di vista il pur consistente assieme di opere per cui nonè attestata una dipendenza della Savioli dalla San Tommaso. In tali casi sitratterà di individuare l’antigrafo utilizzato dall’edizione veneziana e quali-ficare la genesi del processo variantistico, senza però trascurare l’os-servazione del ramo della tradizione che ne è rimasto escluso: gli interventicensori che si produssero nell’ambito dell’edizione bolognese infatti con-notarono una fetta comunque rilevante della diffusione e della recezione delteatro goldoniano a stampa e non possono non rivestire particolare interesseper un’avveduta ricostruzione storico-filologica dei testi188. D’altro canto, la
187 Cfr. II 977.188 A titolo di esempio, si possono considerare alcune delle trasmutazioni testuali riscon-
trate nei casi di due commedie (Il festino, n° 82; Il cavaliere di spirito, n° 107) per cui la tra-smissione Savioli> Guibert> Zatta risulta indipendente dalla San Tommaso: PT (S G Z)CONTE: […] Per altro lo assicura la mano che gli scrive, / Che al Conte sarà grata la dama,finché vive. / E a titol si protesta di mera confidenza, / Trattarlo qualche volta con qualcheinavvertenza. / (Se questa cosa è vera, si vede certamente / Ch’io sono di Madama il maggior
Per una mappa della produzione goldoniana 115
sistematicità con cui la Guibert attinge alla Savioli (fatta eccezione per i te-sti, già segnalati, di derivazione Pasquali) può riservare alcune “inquietanti”sorprese. Si considerino le sostanziali innovazioni riscontrabili nel passag-gio delle Donne gelose dalla prima189 all’ultima edizione d’autore:
PA IX 1755 (> STA > S)[°B VI 1753]
G1 XVI 1774> Z XVII 1791
s’ha tiolto l’insulto (a) [(a) impegno](I.2.13)
s’ha tiolto l’assunto (a) [(a) impegno]
ARLECCHINO Sior sì, anzi per questo. Lamia premura l’è che la me voia ben a mi, eno m’importa che la voia ben a un altro.Nualtri facchini che pratichemo in certe ca-se ricche, vedemo tutto, savemo come lava, bisogna contentarse de quel che se pol.Lo fa un lustrissimo, e no lo pol far un fa-chin?BASEGGIO (Un gran galiotto che xe custù!Se volesse, el me batteria l’azzalin)(I.8.27-28)
ARLECCHINO Sior sì, anzi per questo. Lamia premura l’è che la me voia ben a mi, eno m’importa che la voia ben a un altro.
BASEGGIO (Un gran galiotto che xe custù!)
Son qua, patrona bella,Ghe venderò anca a ela.Basta che la comanda,
Gh’ho un non so che da banda.Per chi xe de bon gusto
Ghe venderò un bel busto,
Son qua, patrona bella,Ghe venderò anca a ela.
Per chi xe de bon gustoGhe venderò un bel busto,
confidente). / E se di tal protesta scontento egli non è, / L’attende in propria casa a bevere ilcaffè ] STA CONTE: […] Per altro lo assicura la mano che gli scrive, / Che al Conte saràgrata la dama, finché vive. / E se di tal protesta scontento egli non è, / L’attende in propriacasa a bevere il caffè (Il festino III.3.20-27); PT (S G Z) GANDOLFO […] E gioveria con essela rustica lezione; / Non dico con i pugni, che è cosa troppo vile, / Ma con qualche altra cosa,che avesse del virile. ] STA GANDOLFO […] E gioveria con esse la rustica lezione. / Non dicocon i pugni, che è cosa troppo vile, / Ma con un buon bastone, qual ha più del virile. (Il cava-liere di spirito II.1.40-42); PT (S G Z) CONTE […] Ma affé, vi compatisco, vi manca quellacosa / Che più d’ogni altro spasso fa ridere una sposa] STA CONTE […] Ma affé, vi compati-sco, vi manca qualche cosa / Che più d’ogni altro spasso rende paga una sposa. (ivi II.5.3-4).Nel caso di quest’ultima commedia, sorprende che l’edizione critica recentemente realizzata-ne (cfr. supra, n. 118), pur menzionando l’edizione bolognese e facendo mostra di averla at-tentamente soppesata nell’ambito della ricostruzione dei rapporti stemmatici, manchi di de-scrivere proprio l’apporto variantistico più significativo della San Tommaso, appunto i citatiinterventi censori (sugli inevitabili guasti interpretativi prodotti dalla “dimenticanza”, cfr.anche infra, § 4, n° 107 e relativa nota).
189 In questo caso non può naturalmente essere considerata princeps d’autore la Bettinelli,che stampa la commedia nella sua fase “scomunicata” di edizione spuria.
116 ANNA SCANNAPIECO
Che dove gh’è mancanzaFa parer abbondanza.
[solo in B, nota: intende di mammelle]Ghe darò una carpetta (a)
[(a) gonnella]Coi fianchi de de stoppetta
(II.3.5)
Ghe darò una carpetta (a)[(a) gonnella]
Coi fianchi de de stoppetta190
LUGREZIA […] Che roba xela [riferito a«macchinetta», ‘compagnia femminile inmaschera’]?BASEGGIO Bona, Bona.LUGREZIA Da vender o da nolizar? Comeche avé dito vu, co cantevi da strazzariol.[riferimento giocoso a II.3.1](III.8.26-28)
LUGREZIA […] Che roba xela?
BASEGGIO Bona, Bona.LUGREZIA Come, che avé ditto vu, cocantevi da strazzariol?
e co l’avé sposada, la sarà vostra(III.8.68)
e co l’averé sposada, la sarà vostra
Vedeu, se ho pensà ben a metter el 16 in-vece de l’8, che giera serrà. Co mi gh’hovoltà la schena a mio mario, anca elo mel’ha voltada a mi. Do fia otto, sedese.(III.10.17)
Vedeu, se ho pensà ben a metter el 16 in-vece de l’8, che giera serrà?
Che anche in questo caso la Zatta, lungi dall’esprimere – come pure si èvoluto far credere – un “valore filologico autonomo”191, derivi supinamentedelle innovazioni testuali già attestate nella Guibert, da un lato può essere“rassicurante”, nella misura in cui consente di verificare la validitàdell’ipotesi stemmatica in precedenza delineata (e di escludere pertanto,nella stragrande maggioranza dei casi, l’ultima edizione “d’autore” da un
190 Invece la variante di II.3.19 (De mi la xe parona, / E se gh’ho robba bona, / E se gh’horobba bela, / Tutta la xe per ela> De mi la xe parona, / E se gh’ho robba bela, / Tutta la xe perela), che Ortolani ascriveva a responsabilità Zatta (IV 1168), subentra in realtà già nel pas-saggio da B a PA (e non escludo la caduta accidentale per saut du même au même).
191 Il valore autonomo dell’edizione Zatta è il titolo di uno dei paragrafi del più volte ci-tato contributo di Alessandro Zaniol, che verte proprio sull’analisi delle varianti delle Donnegelose (attribuite erroneamente, nell’ignoranza della mediazione Guibert, alla Zatta) per di-mostrare appunto come anche l’ultima edizione d’autore presenti consistenti varianti autogra-fe (la cui interpretazione poi varia dal motivo di un volontario allineamento di Goldoni al«nuovo clima di rigore moralistico del tempo», alla necessità per «l’autore del Bourru bien-faisant, dell’Avare fastueux e dei Mémoires» di affrancarsi da «battute o movenze particolari[…] proprie di un mondo particolare, regionale», avvertite come «ostacoli verso la compren-sione del suo teatro in terra di Francia»: cfr. A. ZANIOL, Per una rilettura..., cit., pp. 217-221).
Per una mappa della produzione goldoniana 117
ruolo filologicamente attivo nella stratificata definizione dei testi goldonia-ni)192; dall’altro, tuttavia, l’improvviso iato che nella tradizione si producetra la Guibert e la Savioli, e il valore autonomo che repentinamentel’edizione torinese sembra aver assunto con l’immettere nei testi variantiintenzionali e sostanziali (dello stesso ordine censorio che avevamo osser-vato nella San Tommaso), non può non vanificare la fondatezza di quellastessa ipotesi. In realtà la nostra prospettiva interpretativa riceve conl’anomalo caso delle Donne gelose solo una salutare relativizzazione, sal-vaguardando complessivamente la tenuta della sua verosimiglianza critica esemmai ancora una volta invitando all’assunzione di un paziente habitusanalitico ed ermeneutico. Perché in effetti, nemmeno in questo caso la Gui-bert va oltre il ruolo, che abbiamo già imparato a riconoscerle, di edizionescrupolosa nella sostanziale fedeltà all’antigrafo e semmai fin troppo ze-lante nell’espressione delle cure redazionali193: essendosi gli interventi cen-sori, anche questa volta, prodotti in precedenza, e meccanicamente –“fedelmente” – derivati nella nuova edizione dalla stampa che in questo ca-so è stata occasionalmente assunta come antigrafo. Contravvenendo infattiall’orientamento dominante di avvalersi di un unico testimone di riferi-mento (pratica confermata finanche per gli altri testi che compongono ilvolume in cui figurano le stesse Donne gelose)194, nel caso di questa com-media il compositore della Guibert ebbe a fronte una stampa della prece-dente edizione torinese. È infatti nell’edizione Fantino-Olzati che il testodelle Donne gelose già registra gli interventi censori che poi attraverso la(casuale) mediazione Guibert-Zatta sono entrati definitivamente nella tradi-zione. Al loro diretto antecedente editoriale – un altro, piccolo e periferico,
192 Ciò nondimeno, sarà bene precisare che un’analisi ravvicinata delle dinamiche com-positive proprie degli allestimenti tipografici della Zatta anche nel caso delle commedie giàedite (112 sulle complessive 135) risulta essenziale proprio per una più pertinente valutazionedell’assetto redazionale delle commedie che ebbero qui la loro princeps.
193 Anche per il caso delle Donne gelose, si può osservare nell’allestimento tipograficodell’edizione torinese un buon grado di sorveglianza redazionale; si consideri ad esempiocome, in II.19.2, il correttore della Guibert sappia intervenire a sanare, con persuasiva rico-struzione congetturale, una lacuna attiva sin dalla princeps: TONINA (Vela qua sta sfazzado-na) LUGREZIA Patrona, siora Tonina. Che cara matta che xe quella so massera.] TON. (Velaqua sta sfazzadona) LUG. Patrona , siora Tonina. TON. Patrona, siora Lugrezia. LUG. Che caramatta che xe quella so massera. La cura redazionale peraltro non va esente, anche in questocaso, da tutti gli incidenti di percorso propri della composizione tipografica (ad esempio inII.30.16 si assiste alla seguente sovrapposizione inconscia e banalizzante, con inevitabile alte-razione della fisionomia originaria: ho vadagnà un poco de felippi] ho vadagnà un per de fe-lippi).
194 Per cui è stata appunto appurata la loro discendenza dalla Savioli: cfr. infra, § 4, nni 9,11 e 81.
118 ANNA SCANNAPIECO
esempio di “omnia in progress”195 – Guibert e Orgeas avranno certamenteguardato con interesse196, mostrando anche di saper “mettere a frutto”quanto d’innovativo l’aveva caratterizzato nel panorama complessivodell’offerta editoriale goldoniana197: ma di fatto – per quanto si è avutomodo di verificare – non gli riconobbero un ruolo attivo nell’allestimentoconcreto dei testi (e nello sviluppo avvenire della tradizione) e preferironola trasandata edizione Savioli ad una realizzazione che si era pur distinta peraccuratezza e completezza198. Forse li orientarono in tal senso la difficilereperibilità di un’edizione ormai lontana, nonché il suo non essersi più ag-giornata nel tempo: ma allora perché il ricorso ad essa – del tutto illogico inuna prospettiva pur cogente di economia compositiva – proprio nel caso diquesta (forse) unica commedia? Quante “tessere”, davvero, ancora manca-no…
4. Per una mappa della produzione goldoniana
Si offre in questa sezione un censimento analitico degli elementi checomposero il corpus “commediografico”199 di Carlo Goldoni, a prescinderedalla loro preservazione testuale, nonché dalla loro stessa realizzazionespettacolare. Non si dà invece registrazione di opere di cui è rimasta docu-
195 Rocco Fantino e Agostino Olzati non si limitarono a ristampare l’edizione Paperini,ma – persuasi dal successo dell’operazione e sulla scorta dei già attivi esempi bolognese enapoletano – realizzarono anche la ristampa della Pitteri (il solo Fantino: cfr. infra, § 5, p.231), nonché l’edizione, in 4 tomi, delle Opere drammatiche giocose (ad opera del solo Ol-zati, che presumibilmente utilizzò come antigrafo la prima raccolta: Venezia, Tevernin,1753).
196 Non a caso, nella prefazione alla prima serie, gli editori avevano così potuto, tral’altro, argomentare le ragioni della propria iniziativa: «Avendo noi pertanto fatto riflessione,che le sopraddette edizioni si sono già fatte rare, e che quella pur di Torino ha avuto unospaccio grandissimo, quindi ci siamo determinati…» (Al leggitore, cit., p. III).
197 Fantino e Olzati avevano corredato l’ultimo volume della “prima serie”, composto disole due commedie (per le ragioni combinatorie esposte supra, n. 116), con alcuni già celebriinterventi apologetici – La vera commedia e Il museo d’Apollo – nonché con un glossariointeso a fornire la «spiegazion delle frase veneziane e modi figurai»: Guibert e Orgeas nontrascurarono di servirsi dello stesso materiale per arricchire la propria pubblicazione goldo-niana.
198 Oltre a proporre i testi nella dimensione della sola raccolta (e dunque numerazionecontinuata di pagine nel volume, dotato di unico frontespizio generale), la Fantino-Olzati è lasola edizione, insieme alla Gavelli, che riproduce integralmente anche tutti gli spazi parate-stuali; le stesse caratteristiche sembra aver avuto anche la prosecuzione “pitteriana” del soloRocco Fantino.
199 Cfr. supra, § 2, pp. 30-35.
Per una mappa della produzione goldoniana 119
mentata solo la relativa intenzione compositiva200 o di cui non è stato possi-bile rintracciare elementi utili all’identificazione, pur disponendo di notiziacerta – ma troppo generica – di avvenuta composizione201.
Per l’individuazione delle opere di cui non è stato preservato il testo, e ilcui censimento si configurava pertanto più problematicamente, sono statevagliate tutte le attribuzioni goldoniane sostenute da fonti coeve (annota-zioni diaristiche, annunci di giornali, repertori ecc.) ed escluse quelle im-proprie202; si è naturalmente tenuto conto di tutte le dichiarazioni del-l’autore, usando però cautela nell’utilizzo delle fonti canoniche e viceversaconsiderando con attenzione tutte le occasioni autobiografiche “colla-terali”203.
Particolarmente delicata è stata l’operazione relativa all’identificazionedella produzione parigina, per la quale si è reso necessario un vaglio siste-matico e incrociato delle varie – ma spesso discordanti – documentazionisuperstiti. Se è stato ad esempio relativamente agevole escludere dal novero
200 Come Il Carneval di Venezia (opera pensata per interessare «con delle novità, con deispettacoli, e con molto franzese» la parte femminile del pubblico parigino, indispensabile ca-talizzatore dell’affluso generale degli spettatori), della cui ideazione l’autore parlava detta-gliatamente in una lettera all’Albergati del 18 aprile 1763 (XIV 281: «vi saranno molti fran-zesi e molti italiani; non risparmierò la critica né agli uni né agli altri. Farò dei confronti dicostumi, di usi, di divertimenti, di musica e de’ teatri»); nessun ulteriore riscontro documenta-rio ha consentito di verificare l’effettiva composizione della progettata opera.
201 Ad esempio, nel dedicare ad Elisabetta Mocenigo Venier Le donne gelose (n° 66),Goldoni poteva ricordare come i figli della dedicataria, cultori di «sceniche rappresentazio-ni», si fossero fra l’altro «compiaciuti di recitare una piccola Farsa mia, dall’E.V. commes-sami» (IV 354-355): al di là della «bravura de’ recitanti» e del conseguente «fortunatissimo»esito della rappresentazione, la mancanza di qualsiasi altro dettaglio documentario impediscedi identificare, e sia pure in absentia, l’opera in questione (e di collocarla pertanto nella map-pa che si propone a testo).
202 Come ad esempio nel caso di «Eraclito, e Democrito, uno, che piange, e l’altro, cheride» attribuito alla «virtuosa penna del Sigr Dr Carlo Goldoni» dai Notatorj del Gradenigo(Venezia, Biblioteca del Museo Correr, Codice Gradenigo-Dolfin n° 67, III, c. 110v: ne èregistrata rappresentazione al S. Angelo il 16/10/1756), mentre è invece opera del Chiari (Ifilosofi pazzi, derivata da Démocrite prétendu fou di Autreau).
203 Sono stati cioè utilizzati con la dovuta attenzione ma senza soggezione e previa verifi-ca dell’attendibilità delle informazioni in essi contenute i Catalogues des Pieces de Théâtrede M. Goldoni apposti in calce ai Mémoires; si sono viceversa rivelate molto più puntuali esignificative le testimonianze affidate all’epistolario e a quella sorta di riflessione autobiogra-fica dissimulata che Goldoni praticò negli spazi paratestuali delle edizioni: particolarmenteutili sono state ad esempio la prefazione Paperini alla Donna vendicativa (n° 74), in cuil’autore venne puntigliosamente elencando tutte le composizioni realizzate per Medebach, oalcune dediche ad esponenti di quella nobiltà con cui Goldoni intratteneva rapporti di com-mittenza privata (come Pietro Priuli, o Giovanni Bonfadini) e in cui l’autore venne appuntoricordando alcuni dei prodotti realizzati per le recite “in villa”.
120 ANNA SCANNAPIECO
delle composizioni appositamente realizzate o riadattate per la scena fran-cese opere come Les deux Pantalons o L’epouse persienne (le cui modalitàdi registrazione negli Anecdotes dramatiques pure indurrebbero a inserirlein quel novero)204, molto più complesso – e tutto sommato ancora aperto – è
204 De Le deux Pantalons gli Anecdotes dramatiques (t. II, p. 354) a rigore dicono solo(segnalandone la rappresentazione del 1768) che è «Comédie Italienne de M. Goldoni», manon ne effettuano la registrazione nell’elenco completo delle opere che l’autore avrebbe com-posto per la Comédie Italienne (cfr. ivi, t. III, pp. 210-211), dove invece figura L’epouse per-sienne (erroneamente menzionata come Parisienne, ma l’esatta registrazione del titolo ricorrequando se ne segnala la rappresentazione del 1772, dove è fra l’altro qualificata come«Comédie héroïque Italienne […] par M. Goldoni»: cfr. ivi, t. II, p. 368; lo stesso utilizzodella diversa preposizione – «par» anziché, come nel caso dei Deux Pantalons, «de» – sembradeporre nel senso di opera appositamente composta – o riadattata – dall’autore per la scenafrancese). Le uniche altre fonti che dichiarano la paternità goldoniana delle opere nei relativiallestimenti parigini sono, nel caso della prima commedia, «Les Spectacles de Paris» e ilD’Origny; nel caso della seconda, ancora «Les Spectacles de Paris» e la Correspondance lit-téraire. Per quanto riguarda Le deux Pantalons mentre la registrazione del D’Origny non of-fre alcun chiarimento («le deux Pantalons de M. Goldoni offrirent une belle intrigue, desScénes bien filées, des situations touchantes», t. II, p. 53), quella de «Les Spectacles de Paris»induce ad escludere che nell’allestimento e nell’adattamento dell’opera possa esserci stato undiretto intervento dell’autore (viene infatti qualificata come «tirée du théatre du M. Goldo-ni»); circa L’epouse persienne, invece, se «Les Spectacles de Paris» rimane nel vago (l’operaviene indicata come «de M. Goldoni»: ma si è già visto quale possa essere, rispetto al «par»,la funzione semantica di questa preposizione nell’uso sintetico che ne fanno i repertori),l’articolata “recensione” della Correspondance littéraire non sembrerebbe lasciar adito adubbi (cfr. t. X, pp. 70-71): dell’opera – che viene giudicata una delle «meilleures pièces»goldoniane ma che non viene ascritta allo specifico della produzione parigina dell’autore («Jene sais si M. Goldoni a fait cette pièce depuis qu’il est en France») viene data una descrizioneche non lascia in alcun modo presumere un adattamento sostanziale (e/o autoriale)dell’originale al diverso contesto spettacolare (se ne critica ferocemente l’esecuzione attoricaproprio perché non in grado di essere all’altezza dell’originale italiano; che la commedia ve-nisse rappresentata nella lingua originale è confermato anche dai registri del Théâtre Italien).Va peraltro chiarito che una una specie di sotterranea parentela – spinta talora sinoall’intercambiabilità – accomuna tre fonti come «Les Spectacles de Paris», gli Anecdotesdramatiques, e – almeno per parte del suo sviluppo (gli anni cruciali 1760-1768) – il «Mercu-re de France» (e, attraverso questo, anche il D’Origny: cfr. infra, n. 209): essendo sostanzial-mente responsabile della redazione di entrambi i repertori l’abate Joseph de La Porte, che erastato anche uno dei principali collaboratori del «Mercure» durante la direzione di Antoine deLa Place (cfr. Dictionnaire des Journaux 1600-1789, dir. de J. Sgard, J-V, Paris, Universitas,1991, p. 855), nonché un sodale dello stesso Goldoni nella cosiddetta «società dei domenica-li» (cfr. Mémoires III, 5; sulla varia qualità dei rapporti che intercorsero tra i due, cfr. E.MADDALENA, Goldoni e Favart, in «Ateneo Veneto», XXII, 1899, pp. 210-217). Al di làdella difficile decifrabilità del valore documentario di fonti in larga parte dipendenti da unostesso referente (e per di più così “esposto”), ciò che in questa sede è possibile sottolineare ècome fu proprio Goldoni a pronunciare esplicitamente, almeno a proposito degli «Spectaclesde Paris», una sorta di formale legittimazione (cfr. Mémoires III, 4 in I 453: «je donnai dans
Per una mappa della produzione goldoniana 121
stato in molti altri casi il tentativo di distinguere da un lato la semplice ri-presa scenica di opere composte dall’autore per altri contesti spettacolari epoi riadattate dagli attori della Comédie Italienne di propria iniziativa,dall’altro nuove ridefinizioni apportate da Goldoni stesso e tali da consenti-re l’individuazione di un’unità testuale effettivamente nuova ed autogra-fa205. I casi più problematici al riguardo – la cui valutazione, purnell’evidente affinità delle circostanze documentarie, ha dato luogo a solu-zioni antitetiche – sono stati quelli dell’Arlequin charbonnier (rielaborazio-ne – allestita alla Comédie Italienne nel 1769 – di un celebre scenario com-posto per il Sacchi negli anni quaranta: cfr. nni 24 e 192) e della Dupe desoi-même (adattamento del Curioso accidente, andato in scena nel maggiodel 1785). A escludere quest’ultima dalla ricostruzione della “mappa” non ètanto il fermissimo quanto sospetto disconoscimento dell’autore dei Mémoi-res (troppo interessato ad allontanare dalla propria rispettabilità artisticauna proposta spettacolare che aveva di recente suscitato diffusa indignazio-ne)206, né una presunta tendenziosità della fonte che ascrive invece con net-
l’espace de ces duex années vingt-quatre Pieces dont les titres et les succès bons ou mauvaisse trouvent dans l’Almanch des Spectacles [= «Les spectacles de Paris, ou Calendrier Histori-que & Chronologique des Théâtres»]).
205 È evidente che nel primo caso non si può ascrivere a paternità goldoniana un testooriginariamente tale ma poi trasmutato, per ragioni e con modalità indipendenti dalla volontàdell’autore, da una drammaturgia (nel senso pieno del termine) degli attori: come nel casoesemplare de Le fils d’Arlequin perdu et retrouvé 1762 (< Il figlio di Arlecchino perduto eritrovato 1746, n° 23), che fu tra l’altro l’opera “goldoniana” di più duraturo e intenso suc-cesso sulle scene della Comédie Italienne.
206 La «chute solemnelle» dell’opera venne a prodursi nel pieno della composizione deiMémoires, che non trascurarono di prenderne articolatamente le distanze: secondo la testimo-nianza di III, 37, infatti, la traduzione e l’adattamento del Curioso accidente sarebbero statipropri di un non meglio identificato «hommes des Lettres», che ne aveva propostol’allestimento agli attori della Comédie Italienne previo parere e consenso dell’autore (a cuisarebbero fra l’altro stati destinati anche i proventi); fidando nella competenza del traduttore edegli attori (che avrebbero, in quanto francesi, dovuto essere costitutivamente in grado diprevedere la compatibilità dell’opera con gli orizzonti d’attesa del pubblico parigino) l’autoreebbe a dare il suo «consentement», pur prevedendo che un non meglio identificato «endroitde la Piece» avrebbe «révolté […] la délicatesse Françoise». Il tentativo di dissociare la pro-pria responsabilità (pur ammessa tra le righe) dalla “reale” paternità della proposta spettacola-re si diffonde ulteriormente in argomentazioni che proprio nella insistita esibizione del detta-glio denunciano la propria capziosità (cfr. I 591-592). Non a caso, tutte le fonti documentarieconcordano nel sottolineare l’inammissibilità morale della pièce («elle blesse tout à la fois laraison, les bienséances théatrales et l’honnêteté publique: aussi a-t-elle révolté les gens degoût, et indigné ceux qui conservent encore du respect pour les moeurs»: così ad esempio ilD’Origny, t. III, p. 206, ma del tutto analoghi erano stati i toni della recensione del «Mercurede France», samedì 4 juin 1785, pp. 39-41, come quelli della Correspondance littéraire, juin1785 in t. XIV, p. 167). Per misurare il grado di tendenziosità che la reticenza goldoniana
122 ANNA SCANNAPIECO
tezza a paternità goldoniana la realizzazione dell’adattamento207, quanto ilfatto che la maggior parte delle attestazioni si limita a qualificare l’operacome «imitée de Goldoni»208: tuttavia sussiste un non irrilevante margine didubbio, alimentato dall’impossibilità di sondare l’effettiva trasparenza dellefonti tutte209. Antitetica, come si accennava, ma altrettanto dubbia, l’in-terpretazione dei dati analitici nel caso dell’Arlequin charbonnier, a pro-posito del quale ben tre delle quattro testimonianze non autografe al riguar-do disponibili escludono la diretta paternità goldoniana, chiamando piutto-sto in causa la responsabilità dell’attore-autore Bertinazzi210. In questo caso,a orientare per l’inclusione è valsa la registrazione – puntuale sia nella defi-nizione del genere di appartenenza che in quella della sua collocazione cro-nologica – tra le «Pieces de Théâtre de M. Goldoni» operata dal Cataloguein calce ai Mémoires211. La mancata menzione autografa avrebbe dovuto
poteva raggiungere laddove l’autore avesse ritenuto opportuno mettere la propria onorabilitàartistica al riparo da accuse di immoralità, basti ricordare che in una lettera al «Journal deParis» (23 aprile 1779) era addirittura arrivato a sconfessare in maniera netta e accorata lapaternità della Buona figliola maritata (XIV 383-384).
207 È la Correspondance littéraire, cit., che inequivocabilmente recita: «On a donné sur leThéâtre-Italien, le mardi 24 mai, la première et la dernière représentation de la Dupe de soi-même, comédie, en prose et en trois actes, de M. Goldoni. En la traduisant lui-même, il a crul’adapter aux convenances particulières de notre théâtre, mais ce nouvel essai lui a mal réus-si» (il corsivo è mio); per quanto tendenzialmente incline a cogliere ogni occasione per infie-rire su Goldoni (ma sulla varietà di atteggiamenti tenuti nel tempo dalla Correspondance neiconfronti di questo scomodo «Molière italiano», cfr. C. DÉDÉYAN, La fortune littéraire deGoldoni en France d’aprés la «Correspondance littéraire» de Grimm et Diderot, in Goldoniin Francia, Atti del Convegno (Roma, 29-30 maggio 1970), Roma, Accademia dei Lincei,1972, pp. 15-33), bisogna pur riconoscere che i suoi articoli sono solitamente caratterizzati daattendibilità documentaria nella registrazione dei dati meramente informativi.
208 Così infatti i già citati «Mercure de France» e D’Origny (le «Spectacles de Paris» nondanno indicazione d’autore) .
209 Le annotazioni del D’Origny sembrano spesso derivare, anche alla lettera, dalle recen-sioni del «Mercure de France»: per poter esser certi dell’obiettività della fonte primaria sidovrebbe poter escludere che nella realizzazione delle recensioni non subentrassero a montemanipolazioni informative (Goldoni era ben addentro all’entourage pubblicistico parigino peraver potuto esercitare, direttamente o meno, le pressioni del caso); riguardo allo specificodella Dupe de soi même, si riconsideri inoltre la tortuosa strumentalità della stessa testimo-nianza dell’autore (cit. supra, n. 206).
210 Cfr. i relativi riscontri documentari allegati infra, al n° 192. Solo gli Anecdotes dra-matiques ascrivono l’adattamento francese dello scenario allo specifico della produzione rea-lizzata da Goldoni per la Comédie Italienne (cfr. t. III, p. 211) e ne registrano il primo alle-stimento del 1769 come «Comédie Italienne […] par Goldoni aux Italiens» (t. II, p. 307).
211 Cfr. I 615, dove l’Arlequin charbonnier è correttamente collocato tra Arlequin et Ca-mille esclaves en Barbarie e La bague magique (e per la definizione del genere, cfr. infra, n°192). Giova tuttavia segnalare che lo stesso Catalogue non fa menzione dello scenario
Per una mappa della produzione goldoniana 123
avere un’incidenza ancora maggiore nell’esclusione di altri due scenari –Les métamorphoses d’Arlequin, n° 170 e Les vingt deux infortunesd’Arlequin, n° 173 – rispetto a cui nemmeno le registrazioni coeve docu-mentano una – neppur mediata – responsabilità compositiva dell’autore ita-liano212: ne è stata invece necessaria l’inclusione, in forza del loro essere
d’origine, La congiura de’ carbonari, e che trattamento inverso è riservato ad un altro scena-rio composto per il Sacchi e riadattato poi per la scena francese, cioè Il servitore di due pa-droni (di cui appunto si registra la versione originale ma non si menziona la derivazione pari-gina): sicché si potrebbe ipotizzare che l’una forma di registrazione escludesse l’altra e chedella variante francese della Congiura de’ carbonari fosse rivendicata la responsabilità com-positiva proprio perché si era taciuto riguardo quella dell’originale.
212 L’unica menzione de Les métamorphoses d’Arlequin come di opera goldoniana è inuna lettera dell’ambasciatore portoghese che, in data 29 ottobre 1764, ne ricorda la rappre-sentazione a Fontaineblaeu (cit. in P. TOLDO, Tre commedie francesi…, cit., p. 379), ma biso-gnerebbe verificarne l’attendibilità attraverso la consultazione del «Journal des Spectacles dela Cour», attualmente non accessibile (e comunque una recita dello scenario a Fontaineblaeunel 1764 non è documentata dai registri del Théâtre Italien). Circa lo scenario che, per lo piùcon il titolo de Les nouvelles métamorphoses d’Arlequin viene allestito con straordinario suc-cesso a partire dall’ottobre 1763, tutte le fonti concordano nell’attribuirne, inequivocabil-mente, la paternità all’Arlecchino Bertinazzi: cfr. «Mercure de France», Decembre 1763, pp.182-183 («M. Carrelin [Bertinazzi], Sujet, Acteur, & pour ainsi dire Spectacle principal decette Pièce, en est en même temps l’Auteur. Elle avoit attiré beaucoup de monde, & il y futpartout applaudi avec autant de vivacité que s’il n’etoit pas en possession depuis si longtempsde ces flatteuses caresse du Public, & toujours appliquées avec justice à son égard. Ce genrede Comédie est un tissu bien formé d’incidens, fondés sur la magie, par lesquels Arlequin estobligé de prendre douze fois des formes différentes, & si subitement, pour la plûpart, que leprestige est complet & le moyen presqu’incroyable au Spectateur. M. Carrelin y fait usage dequelques-uns des talens qu’il posséde entr’autres de la Mandolin & du Violon dont il joue audessus de la médiocrité»: l’attribuzione compositiva all’attore può essere anche intesa comesottolineatura dell’estrema incidenza di una drammaturgia dell’attore, ma di solito – in questacome in tutte le altre fonti – non viene mai omessa la citazione di Goldoni, anche a frontedell’esaltazione delle doti “creative” degli attori); «Les Spectacles de Paris», 1764 (attribuitoa «M. Carlin»); Desboulmiers, t. VII, p. 376 («Cette Piece est un tissu d’incidens fondés surla Magie, par lesquels Arlequin est obligé de reprendre douze fois des formes différentes, &si subitement, que le prestige est complet, & le moyen presque incroyable aux Spectateurs.M. Carlin est lui seul dans cette Piece, le sujet, l’Auteur, l’Acteur & le Spectacle»);D’Origny, t. II, p. 20 («M. Carlin en étoit lui seul le sujet, l’Auteur, l’Acteur, le Spectacle, &il prenoit douze formes différentes, avec tant de promptitude & d’agilité, que l’illusion étoitcomplette»). Si limitano a registrane la rappresentazione, senza esplicitarne l’autore, gliAnecdotes dramatiques (che naturalmente poi non includono lo scenario nell’elenco dellaproduzione goldoniana per la Comédie Italienne: cfr. t. II, p. 431 e t. III, pp. 210-211).Ancora più problematico il caso de Les vingt deux infortunes d’Arlequin (che dovrebbe esserederivato da Le trentadue disgrazie di Arlecchino, celebre scenario composto per Sacchi nel1740): neanche della presunta rielaborazione di questo canovaccio l’autore fa mai menzione,come non lo ascrivono a produzione goldoniana tutte le altre fonti, concordi invece nel regi-strare un Vingt-six infortunes d’Arlequin (ed è con questo titolo che la rappresentazione dello
124 ANNA SCANNAPIECO
stati preservati in una trascrizione manoscritta che – almeno in un caso – neidentifica l’autore in «Goldony, pensonnier du Roy»213. Anche al riguardo, enonostante la conservazione documentaria dei relativi “testi”, rimangonocospicui dubbi, e l’osservazione di alcune sintomatiche discrepanze testi-moniali da un lato induce a sospettare che i due scenari in questione (tra ipiù fortunati della Comédie Italienne, ma nell’acclarata paternità, rispetti-vamente, degli attori-autori Bertinazzi e Veronese) fossero stati consegnaticome goldoniani alla tradizione per una sorta di paternità “espansa”, unaspecie di obbligato quanto inconsapevole omaggio a chi, ancora negli annisettanta, era giudicato «auteur célèbre et précieux pour eux [gli attori dellaComédie Italienne], dont le génie fertile pouvoit renouveler totalement leurgenre»214; dall’altro – pur non potendo, in mancanza di più cogenti riscontri
scenario è sempre documentata nei registri del Théâtre Italien), qualificato come «comédie encinq actes, canevas italien, retouché par Veronese, 1751».
213 Cfr. Bibliothèque Nationale, Catalogue général des manuscrits français, par H.Omont, Ancien supplément français, I, nos 6171-9560 du fonds français, Paris, Leroux, 1895,n° 9254 (3064): «n. 9254 (3064) Cinquième Portefeuille – Les Vingt-deux Infortunesd’Arlequin, pièce ital. pr., de la composition de Goldony, pensonnier du Roy; Les Métamor-phoses d’Arlequin, sujet ital. orné de machines, de changements et de deux ballets (par Gol-doni), Th. Ital. 1758; La Bague magique, com. ital. 3 pr. (aut., par Goldoni). Th. Ital. 1770».Come l’analisi dei relativi testimoni consente di appurare, solo del primo scenario vieneesplicitamente riconosciuta la paternità goldoniana, essendo le altre attribuzioni sostenute dalcuratore della raccolta (il Soleinne, responsabile anche dell’individuazione delle date di rap-presentazione) in cui sono inseriti anche questi scenari “goldoniani” (cfr. ivi, p. 331n); inrealtà solo i dati relativi a La bague magique sono confermati da altre fonti, nonchédall’esplicita menzione che ne fa l’autore stesso.
214 Così un Mémoire sur la situation de la Comédie Italienne del 1772, che stigmatizzavala perdita di Goldoni («par une fausse spéculation et par une économie mal entendue, ils sesont privés de la ressource qu’ils avoient dans un auteur célèbre et précieux pour eux, dont legénie fertile pouvoit renouveler totalement leur genre») e prospettava come unica soluzione(una volta messo a fuoco l’obiettivo di rinnovare il repertorio delle «petites pièces» che «sontde la plus grande conséquence pour ce théâtre» e quindi di «réformer au moins la moitié et lesremplacer au doble at au triple par des pièces nouvelles dont les intrigues seroient plus vrai-semblables et les dénouemens mieux amenés») proprio quella «d’engager M. Goldoni à tra-vailler encore pour eux», giacché – come gli attori sanno bene – «est le seul auteur capable derenouveler leur genre» (il documento è stato edito in É. CAMPARDON, Les Comédiens du Roide la troupe italienne pendant les deux derniers siècles, t. II, Paris, Berger-Levrault et Cie,1880, pp. 301-327). Sono vari gli elementi che potrebbero suffragare l’ipotesi diun’attribuzione indotta dal prestigio di colui che tornava ad essere l’autore per eccellenza diquesto genere di produzione. In primo luogo il fatto che Les Métamorphoses d’Arlequin ven-gono ascritte (anche se dal Soleinne, non si sa sulla base di quali riscontri documentari) al1758, e dunque ad un torno di tempo in cui opere eventualmente goldoniane approdavano allaComédie Italienne nelle rielaborazioni degli attori della troupe; in secondo luogo il fatto cheGoldoni venga definito «pensonnier du Roy» induce a collocare la redazione del primo ma-
Per una mappa della produzione goldoniana 125
documentari, disconoscere l’attribuzione dei testi conservati nel manoscrittoparigino – impedisce che possano essere identificati con quelli delle cuifortunate rappresentazioni si ha notizia certa215.
Nella definizione della mappa non minori difficoltà ha, più in generale,comportato l’identificazione delle stesse unità testuali in cui far consistere ilcorpus goldoniano, essendo stati nella prassi compositiva dell’autore forte-mente caratterizzanti da un lato la tensione rielaborativa, dall’altro quelmetamorfismo del plot drammaturgico con cui Goldoni faceva spesso
noscritto in un periodo successivo al 1769 (anno a partire dal quale appunto l’autore divennebeneficiario della pensione reale) e dunque in una fase strettamente contemporanea a quellanetta ripresa di quotazioni dell’autore che faceva presumere imminente un suo ritorno allaComédie Italienne; in terzo luogo, e soprattutto, la circostanza per cui proprio due tra gli sce-nari di maggior successo del Théâtre Italien (ma, come vedremo, quelli delle cui rappresenta-zioni si ha notizia non possono essere identificati con i “testi” conservati nel manoscritto pa-rigino) non vengano ricordati come goldoniani né dalle varie fonti documentarie di cui si di-spone, né dall’autore stesso.
215 In base a quanto documentato per Les métamorphoses di Bertinazzi (cfr. supra, n.212), abbiamo modo di appurare che il relativo intreccio era consistentemente diverso daquello del testo “goldoniano” conservato nel manoscritto parigino (dove la dinamicadell’azione portante non è determinata, come nello scenario del Bertinazzi, dalle continuetrasformazioni che Arlecchino subisce, ma da quelle che il personaggio produce con la spa-tola magica). Anche nel caso delle Vingt-six infortunes d’Arlequin – al di là della poco signi-ficativa difformità del titolo, o della scansione in cinque atti invece che in tre – abbiamomodo di osservare la sua diversità rispetto allo scenario “goldoniano”, essendone stato un«programme imprimé» riprodotto in [F. ET C. PARFAICT], Dictionnaire des Théâtres de Pa-ris, t. VI, Paris, Rozet, 1767, pp. 234-246 (Slatkine reprints, Genève, 1967, vol. II, pp. 356-359). Le diffrazioni sono molteplici: dal diverso sistema dei personaggi, che ha consistentiriflessi nello sviluppo della vicenda (nello scenario di Veronese, il Dottore, oltre al figlio, haanche una figlia, accompagnata dal relativo amante; significative le difformità anche nellefigure di contorno e nei relativi episodi cui danno vita: al «meunier» delle Vingt-six si opponead esempio il «jouer» delle Vingt-deux), alla diversa configurazione del finale (tragicomico inVeronese, lieto a sorpresa doppia in “Goldoni”). Va peraltro sottolineato che dovevano esiste-re varie versioni del celebre scenario, se lo stesso Parfaict si sente in dovere di aggiungere incalce al riprodotto «programme imprimé» la registrazione di un’importante variante, «unescéne fort heureuse», che coincide con il corrispettivo III.6 dello scenario “goldoniano”(l’esilarante duetto di Arlequin e del jouer, che Parfaict riproduce, sulla base di una «Notecommuniquée», in forme molto più articolate di quanto non sia nel manoscritto parigino delloscenario “goldoniano”). Va infine segnalato che né con la versione Veronese, né con quella“Goldoni” coincide l’argomento delle Trenta tre disgrazie ridicole d’Arlechino, pubblicato inM. KLIMOWICZ – W. ROSZKOWSKA, La commedia dell’arte alla corte di Augusto III di Sas-sonia (1748-1756), in «Memorie dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», vol. XLI,fasc. I, Venezia, 1988, tavv. CII-CIII (qui il sistema dei personaggi è senz’altro vicino, se noncoincidente, con quello di Veronese, ma diverso l’antefatto: di più non è possibile dire, per-ché l’argomento restituisce solo il filo della vicenda seria, e nulla racconta delle disgrazie diArlecchino).
126 ANNA SCANNAPIECO
fronte alle esigenze di una professione tenuta a confrontarsi con ritmi pro-duttivi particolarmente sostenuti. Pur nella consapevolezza che i criteriadottati sono ampiamente discrezionali, si è ritenuto di dover valutare comevarianti della medesima unità testuale solo le commedie multiredazionali(che sono state pertanto registrate assieme nella stessa indicazione numeri-ca), in considerazione della difficoltà di definire un parametro sempre per-suasivo di multiredazionalità: e sia pur nella piena consapevolezza che ilcriterio è variamente discutibile, venendo ad essere nella realtà della classi-ficazione ricondotte ad una natura di opere “singole” testi che invece – sipensi al Padre di famiglia, ma anche al Todero, o alla trilogia di Zelinda eLindoro ecc. – presentano trasmutazioni così radicali da situarle tanto lon-tane da commedie sottoposte a rielaborazione ma sostanzialmente fedeliall’originaria fisionomia redazionale, quanto prossime ad opere a propositodelle quali è parso invece opportuno riconoscere una natura molteplice.Come tali (e dunque entità testuali diverse) sono state appunto consideratele realizzazioni distese di commedie originariamente a soggetto (nel pro-spetto è stata dunque segnalata con numerazione doppia la registrazionedello scenario, per forza di cose cronologicamente anteriore rispetto allarelativa commedia distesa, realizzata in concomitanza della pubblicazione);così come le riduzioni in prosa di originarie commedie in versi o le tradu-zioni in italiano delle commedie francesi (in tal caso le opere sono incolon-nate distintamente con numerazione non contigua perché o la nuova versio-ne è legata a nuovo allestimento spettacolare o, anche, a specifica realizza-zione editoriale).
Di ciascuna opera sono stati registrati i seguenti elementi:a) titolo. Laddove possibile, ne sono state annotate eventuali varianti o
la configurazione originaria, per lo più legata allo specifico del contestospettacolare cui era subordinata la composizione e poi talora modificata insede di ridefinizione editoriale del testo («il titolo – ricordava l’autore stes-so – si dà alla Commedia tal’ora per appagare il popolo, il quale poi meritaessere nelle stampe corretto»)216. Quando un’opera è in rapporti di dipen-
216 L’autore a chi legge de Il poeta fanatico, a cura di M. Amato, cit., p. 123. Va peraltrosottolineato che non sempre la diversa configurazione del titolo per la destinazione scenicadell’opera era subordinata a motivi di maggiore appeal commerciale: poteva anche esseredeterminata da ragioni funzionali ad una sua più immediata distinguibilità nell’ambitodell’offerta spettacolare cittadina (cfr. al riguardo la testimonianza della prefazione Paperinialla Moglie saggia: «La Moglie Saggia è il vero titolo che conviene alla presente Commedia,quantunque la prima volta che io la feci al Pubblico rappresentare, altrimenti la intitolassi.Negli anni due precedenti all’uscita di questa mia, erasi vedute in Venezia altre Commedie divari autori collo stesso titolo in fronte, onde per evitare l’equivoco e la confusione di quelli
Per una mappa della produzione goldoniana 127
denza genetica con una precedente composizione, al titolo fa immediata-mente seguito, tra parentesi quadre e preceduto dal simbolo “<”, la menzio-ne di quest’ultima, accompagnata dal relativo numero di collocazione nella“mappa”;
b) data di composizione e/o prima rappresentazione. Molto di rado èpossibile distinguere, in base a specifica documentazione, la fase temporaledella composizione da quella della prima rappresentazione: quando è statopossibile appurarne la diversità se ne è fatta esplicita menzione (anche nellaconvinzione che possa essere non trascurabile motivo di riflessione criti-ca)217, facendo seguire alla data di composizione, tra parentesi quadre,quella della prima rappresentazione documentata; l’indicazione cronologicadi solo anno (priva di specificazione relativa a stagione teatrale) sta invece asegnalare l’unico elemento temporale di cui si ha notizia certa, vale a dire ladata di composizione, non essendo stato possibile individuarne di relative alprimo allestimento (nel caso in cui invece fosse risultata attestata la man-cata rappresentazione di un’opera se ne è data espressa segnalazione). Laregistrazione della prima rappresentazione è comprensiva del luogo in cuiebbe a prodursi: con l’avvertenza che, dove non specificato, si è sottinteso ilcontesto cittadino di riferimento professionale dell’autore (i veneziani teatridi Sant’Angelo o – a seconda del periodo – di San Luca; negli anni in cui lacollaborazione con quest’ultimo teatro si sovrappone agli impegni con laComédie Italienne, gli allestimenti francesi sono preceduti dall’indicazionedi «Parigi»), e che laddove la prima rappresentazione sia stata effettuatanelle cosiddette “piazze di terraferma” si deve ritenere scontata (salvo di-versa indicazione) la ripresa veneziana nelle stagioni successive (autunno ocarnevale). Se la prima realizzazione spettacolare dell’opera ebbe luogo inun contesto privato, se ne è data specificazione solo nel caso di possibileequivoco rispetto a contesto pubblico e professionale (ad esempo Bologna,ma non Bagnoli). L’impossibilità di seguire in forme non occasionali oframmentarie la vita spettacolare dei testi ha indotto a contenere il corredo
che del titolo fanno capitale grandissimo, uno ne immaginai per la Piazza, ed un altro riser-bato ne ho per la stampa», IV 1142), o anche dalla volontà di esibire con maggior nettezzal’ascendenza culturale dell’opera (si veda il titolo originario della Pamela, n° 49, che nellasua coda esplicativa – «o sia la virtù premiata» – riecheggiava puntualmente il modello ri-chardsoniano di riferimento).
217 Si è solitamente portati a ritenere ovvia la sostanziale coincidenza delle due fasi nellapratica drammaturgica di un poeta di compagnia: ma si tratta, a ben vedere, di un’illazione, oquanto meno di una generalizzazione storiografica (e quindi di una potenziale banalizzazionecritica), come inducono a credere i pur sporadici casi in cui è possibile riscontrare un impe-gno drammaturgico non immediatamente confluito in espressione spettacolare.
128 ANNA SCANNAPIECO
dei dati documentari alla sola data di prima rappresentazione, anche se inmolti casi si sarebbero potute allegare informazioni relative alla fortunascenica che le opere conobbero nel tempo. Ma per quanto riguarda la pro-duzione parigina, la possibilità di fare affidamento su un assieme testimo-niale compatto e coerente – vale a dire i repertori del Théâtre Italien –,nonché quella di integrarne i dati (costitutivamente ellittici) attraversol’utilizzo di altre fonti, ha fatto optare per la registrazione di tutte le rappre-sentazioni parigine di cui è appunto rimasta documentazione218. Ha spinto inquesta direzione anche l’esigenza di sondare almeno in una sia pur parzia-lissima prospettiva la fisionomia di opere la cui mancata preservazionesembra averne provocato la rimozione dagli orizzonti della memoria stori-ca; e sempre per l’esigenza di illuminare, sia pur indirettamente, connotatitestuali comunque non più distinguibili, è parso opportuno riprodurre anchetutte le testimonianze superstiti relative all’esito scenico e alla varia valuta-zione critica delle singole opere. In calce ad ognuna (oltre a quelledell’autore stesso, che precedono sempre) sono state pertanto riportate insuccessione cronologica le testimonianze attinte alle seguenti fonti:
CL = Correspondance littéraire, philosophique et critique par Grimm,Diderot, Raynal, Meister, etc., par M. Tourneux, tt. 16, Paris, Garnier Frè-res, 1877-1888
DB = JEAN-AUGUSTE JULIEN DESBOULMIERS, Histoire anecdotique etraisonnée du théâtre italien depuis son rétablissement en France, jusqu’àl’année 1769, Paris, Lacombe, 1769, tt. VI-VII [Genève, Slatkine reprints,1968, t. II]; Cat. = Catalogue raisonnée contenant, par ordre alphabétique,les Pieces, les Auteurs, & les Acteurs dont il n’a point été parlé dans lecourant de cette histoire, ivi, t. VII, pp. 219 ss.
D’O = ANTOINE D’ORIGNY, Annales du théâtre italien depuis son ori-gine jusqu’a ce jour, Paris, Duchesne, 1788, tt. 3 [Genève, Slatkine reprints,1970]
MF = «Mercure de France, dédié au Roi», 1724-1791 (dal 1768: «Mer-
218 L’elenco delle rappresentazioni che animarono l’offerta spettacolare del Théâtre Ita-lian dal 1716 al 1792-93 è conservato in registri manoscritti presso la Bibliothèque de l’Opéradi Parigi; ne ha offerto per la prima volta riproduzione integrale (cercando anche di colmareeventuali lacune attraverso il ricorso a fonti integrative) C. D. BRENNER, The Théâtre Italien.Its Repertory, 1716-1793, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1961, dacui si è appunto attinto per il censimento delle rappresentazioni goldoniane (limitatamente alperiodo 1763-1780, e cioè dall’anno in cui furono allestite le prime produzioni espressamenterealizzate dall’autore per la Comédie Italienne a quello in cui di fatto cessò il «Théâtre Ita-lien» propriamente detto). La non sempre agevole identificazione delle opere (registrate senzaindicazione d’autore, e spesso attraverso designazione sintetica) è stata garantita dal riscontrodi altre fonti documentarie.
Per una mappa della produzione goldoniana 129
cure de France dédié au Roi, par une Société de gens des lettres» ) [Genève,Slatkine reprints, 1968-1971];
c) genere di appartenenza. Per le ragioni illustrate supra, § 2, pp. 29-35,è parso utile desumere dalle relative codificazioni editoriali la definizionedel genere di appartenenza cui furono dall’autore ascritti i singoli testi. Incaso di trasmissione pluritestimoniale, si è registrata la prima denominazio-ne realmente caratterizzante (tale cioè da andare oltre la semplice qualificadi «commedia», con cui – soprattutto nelle prime edizioni – le opere veni-vano designate)219, e si è specificata – attraverso la relativa sigla –l’edizione che se ne fa latrice. Quando la princeps è dovuta a pubblicazioninon autorizzate, si è annotata anche la denominazione “spuria”, facendolaprecedere dal contrassegno proprio (“°”) di quel tipo di edizioni. Si sonoinvece segnalate più denominazioni, per quanto derivate da edizioni auto-rizzate, solo quando la diversità è apparsa di effettivo rilievo documentario(cfr. ad esempio nni 96 e 147). Nel caso di opere di cui non è stata garantitatrasmissione editoriale o comunque preservazione “testuale”, la definizionedel genere di appartenenza è stata ricavata o da dichiarazioni d’autore220 odalle fonti che ne hanno, in vario modo, assicurato l’indiretta conoscenza.Data l’estrema “inafferrabilità” di questo tipo di testi, laddove la varietàdella documentazione superstite l’ha reso possibile (e cioè in particolare pergli scenari francesi), sono state annotate più designazioni, anche e soprat-tutto in considerazione delle frequenti difformità testimoniali. Oltre a quellegià segnalate in precedenza, queste le fonti da cui sono state ricavati i dati:
AD = Anecdotes dramatiques, Paris, Duchesne, 1775, tt. 3CAIL = JEAN-FRANÇOIS CAILHAVA DE L’ESTENDOUX, De l’Art de la
Comédie, ou Détail raisonné des diverses parties de la comédie et des sesdifférents genres, suivi d’un traité de l’imitation, ou l’on compare à leursoriginaux les imitations de Molière et celles des modernes [...] terminé parl’exposition des causes de la décadence du théâtre et des moyens de la fairerefleurir, Paris, Didot, 1772, tt. 4
CM1 = Catalogue des Pieces de Théâtre de M. Goldoni dont il est parlé
219 Al riguardo, cfr. quanto già segnalato supra, p. 31 e n. 11 (e si consideri il caso limitedel Don Giovanni, n° 4, la cui qualifica di «commedia» – sostenuta dalla Paperini e dalla Pa-squali, nonché dalla Bettinelli – sarà dettagliata in un «di cinque atti in versi» solo con laZatta)
220 In casi di particolare significatività testimoniale, queste sono state registrate anche peropere che ricavarono dalla relativa realizzazione editoriale la propria qualifica “ufficiale” (cfr.ad esempio n° 124). Quando non desunte dai Catalogues in calce ai Mémoires, le testimo-nianze autografe si intendono sempre ricavate dall’omnia Ortolani (di cui si fornisce, comesempre, sola indicazione di volume e di pagina).
130 ANNA SCANNAPIECO
dans ces Mémoires par ordre chronologiqueCM2 = Autre pieces de Théâtre de M. Goldoni dont il n’est pas question
dans ses Mémoires221
G = CARLO GOZZI, Appendice a Il ragionamento ingenuo [18012], in C.Gozzi, Il ragionamento ingenuo, a cura di A. Beniscelli, Genova, Costa &Nolan, 1983, p. 119
K-R = MIECZYSLAW KLIMOWICZ – WANDA ROSZKOWSKA, La comme-dia dell’arte alla corte di Augusto III di Sassonia (1748-1756), in «Memo-rie dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», vol. XLI, fasc. I, Vene-zia, 1988
SP = «Les spectacles de Paris, ou Calendrier Historique & Chronologi-que des Théâtres», Paris, Duchèsne, 1751-78;
d) eventuali rapporti di parentela con altri testi del corpus. Sono stati se-gnalati tra parentesi tonde a seguito della registrazione del genere di appar-tenenza, attraverso la sola indicazione numerica dell’opera interessata;
e) percorso editoriale. A fianco alla registrazione dell’opera (titolo, datadi composizione e/o rappresentazione, genere di appartenenza) ne sonostate segnalate le eventuali pubblicazioni, da un lato nelle cinque edizionid’autore (allineate in ordine cronologico progressivo), dall’altro nelle edi-zioni non autorizzate (ma nella prima colonna, inevitabilmente destinataalla Bettinelli222, è parso indispensabile far confluire anche tutte le variepubblicazioni – fra l’altro non necessariamente “pirata” – che hanno garan-tito o la princeps dell’opera o la preservazione di una sua configurazioneoriginaria). Sono state segnalate tutte le pubblicazioni in cui pare essersiespresso – allo stato attuale della ricostruzione documentaria – l’attra-versamento editoriale settecentesco del teatro goldoniano, ma non è parsoopportuno fare menzione di quelle collettanee (come la Biblioteca teatraleitaliana di Ottaviano Diodati, Lucca, Della Valle, 1765) o di emissioni co-me la Bettinelli 1757223; non si è inoltre data specifica descrizione della co-siddetta Zatta minor – cui oggi si può dare contorni finalmente più precisi
221 Merita sottolineare che le definizioni offerte dai Catalogues non sono sempre attendi-bili: si consideri, a titolo esemplificativo, il caso dei Rusteghi, definiti «comédie vénitienne,en cinq actes en vers» (I 612).
222 Con l’avvertenza che nel caso di pubblicazioni per cui la Bettinelli è risultata copiadescripta della Paperini (cfr. A. SCANNAPIECO, Giuseppe Bettinelli editore di Goldoni, cit.,pp. 100-101 e 178-180), la relativa registrazione è stata effettuata nella colonna intestata alle«altre edizioni».
223 Al riguardo, cfr. ivi, pp. 101-107.
Per una mappa della produzione goldoniana 131
grazie all’individuazione di un esemplare superstite224 – perché la strettacorrispondenza con la maior in tomi contenuti e composizione tipograficaconsente un’implicazione di entrambe le impressioni nella registrazioneunica. Sono state segnalate le edizioni dei cui esemplari è a tutt’oggi garan-tita la reperibilità; quelle la cui documentazione è affidata ad attestazioniarchivistiche, catalografiche ecc. o a repertori bibliografici (soprattutto Al-lacci e Spinelli)225, ma di cui non è stata appurata l’effettiva esistenza e/oattuale conservazione sono ugualmente registrate ma distinte con il simbolodi mancato reperimento (“+”). Sono state naturalmente segnalate per estesotutte le stampe individuali che occasionalmente – e, a quanto è dato inferiredalle attuali conoscenze bibliografiche, piuttosto raramente – sostennero lapubblicazione di un’opera goldoniana; ma, giacché la stragrande maggio-ranza dei testi risulta pubblicata nell’ambito di raccolte, è attraverso la solasigla di ciascuna di queste, seguita dal numero di volume in cui ricorrel’opera interessata, che si sono appunto registrate le varie edizioni dei sin-goli testi (per rendere più agevole la possibilità di considerare i contestieditoriali complessivi in cui sono inserite le pubblicazioni delle varie opere,si è ritenuto opportuno offrire descrizione separata – cfr. infra, § 5 – delle23 raccolte in cui sembra essersi espressa l’offerta editoriale settecentescadel teatro goldoniano). Eventuali ristampe interne alle singole edizioni sonostate segnalate immediatamente di seguito all’indicazione della “princeps”,
224 Cfr. infra, § 5, pp. 219-220.225 Drammaturgia di Lione Allacci accresciuta e continuata fino all’anno MDCCLV, Ve-
nezia, Pasquali, 1755; A. G. SPINELLI, Bibliografia goldoniana, cit. È appena il caso di sotto-lineare che tutte le segnalazioni di Spinelli devono essere accolte con beneficio d’inventario;per completezza documentaria – e soprattutto per la necessità di usare cautela in una fase incui la ricostruzione bibliografica è ancora in via di definizione – è parso comunque opportunoregistrare i dati del suo repertorio anche laddove non si sia avuto modo di appurare la fonda-tezza delle informazioni o di sollevarle da un sospetto di incongruenza: in tal caso, tuttavia, ilsimbolo di mancato reperimento è stato caratterizzato con sigla che denoti la fonte (“+S”),anche per sottolineare la potenziale inattendibilità del dato documentario. Analogamente ci siè orientati nel caso delle attestazioni che si devono alla Drammaturgia di Allacci (e dunqueeventuali esemplari documentati solo in questo repertorio sono stati fatti precedere dal sim-bolo “+A”), limitate peraltro alla presunta edizione bolognese del Pisarri. In realtà, l’atten-dibilità della documentazione Allacci è da ridimensionare sin dalla denominazione dell’edito-re che molto verosimilmente deve essere stata designazione abbreviata per «Eredi di Co-stantino Pisarri e Giacomo Filippo Primodì»; inoltre alcune menzioni bibliografiche sono pa-lesemente aberranti e, in quanto tali, non sono state neanche registrate (quelle ad esempiorelative a commedie revisionate dall’autore in fase di allestimento editoriale – e il cui testo lostampatore “pirata” non avrebbe potuto dunque derivare da altra fonte – e che il “Pisarri” adetta delle annotazioni di Allacci avrebbe pubblicato anticipatamente rispetto all’unico anti-grafo possibile: si vedano i casi de Il poeta fanatico, de I mercatanti ecc.).
132 ANNA SCANNAPIECO
tra parentesi tonde, con la sola indicazione del relativo anno e, in esponente,di numero progressivo di ristampa; tra parentesi quadre sono state inveceannotate le date dei frontespizi generali dei volumi (per lo più appartenentialle serie San Tommaso, Venaccia e Savioli), laddove difformi da quelliinterni delle singole opere in ciascuno di essi raccolte226. Queste, in ordinealfabetico, le sigle utilizzate per le indicare le varie edizioni:B BettinelliBO BonsignoriBPA Bettinelli «quinta edizione veneta sull’esemplare della fiorentina»Do documentazioni – editoriali o manoscritte – di redazioni originarie,
uniche superstiti nella tradizione testuale o comunque difformi daquelle poi eventualmente autorizzate nelle edizioni d’autore. Seprecedute dal segno “°” si intendono non direttamente dipendenti onon avallate da volontà autoriale.
F FantinoFO Fantino e OlzatiG1 Guibert e Orgeas, prima serieG2 Guibert e Orgeas, seconda serieGA GavelliGR GarboMA MasiPA PaperiniPi Pisarri227
PP Eredi Pisarri e Giacomo Filippo Primodì228
Pr PrimodìPS PasqualiPT PitteriPU1 Puccinelli, prima serie
226 Per l’apparente anomalia di un frontespizio interno con datazione difforme da quelladel frontespizio generale, in realtà dovuta ad assemblaggi seriori, cfr. quanto argomentatosupra, pp. 67-75.
227 È designazione desunta dal repertorio di Allacci, per la cui presumibile inattendibilità,cfr. quanto segnalato supra, n. 225.
228 Come si cercherà di dimostrare in seguito, in realtà le pubblicazioni goldoniane Pisar-ri-Primodì dovettero in buona parte comporre una sorta di unità editoriale con quelle SanTommaso d’Aquino. Ciò nondimeno, l’autonomia che in qualche caso esse sembrano averavuto rispetto alla consorella maggiore, nonché la possibilità che siano state preservate auto-nomamente, al di fuori dei volumi costitutivi la San Tommaso, ha indotto a darne menzionespecifica, attraverso appunto la corrispettiva sigla; quando sono state invece conservateall’interno di volumi della San Tommaso, alla sigla specifica degli editori Pisarri-Primodì faseguito, tra parentesi tonde, quella del volume STA in cui ricorrono.
Per una mappa della produzione goldoniana 133
PU2 Puccinelli, seconda serieS1 Savioli, prima serieS2 Savioli, seconda serieSTA1 San Tommaso d’Aquino, prima serieSTA2 San Tommaso d’Aquino, seconda serieSTA3 San Tommaso d’Aquino, terza serieSTA4 San Tommaso d’Aquino, quarta “serie”VE VenacciaZ Zatta
f) eventuali sviluppi rielaborativi. La ricostruzione della mappa edito-riale ha cercato anche di sondare l’eventuale tasso variantistico di ciascunadelle opere censite. L’evoluzione redazionale è stata osservata solo relati-vamente a varianti sostanziali, e – laddove individuata – è stata evidenziatacon il segno “*” (e con eventuali multipli nel caso di sviluppi variantistici adistanza); si avverte tuttavia che, nell’impossibilità di tracciare un discrimi-ne netto tra varianti sostanziali che, per qualità e quantità, danno luogo afisionomie propriamente multiredazionali e varianti che per quanto sostan-ziali non contraddicono alla fisionomia di unica redazione (nonché, comun-que, per l’impossibilità di verificarla nello specifico di tutte le opere) non siè appunto proceduto ad una relativa differenziazione del simbolo: che pure,almeno in alcuni casi già noti, sarebbe stata oltre che possibile doverosa229.Nonostante tutti i limiti propri dell’indebita generalizzazione cui può darluogo la schematicità del simbolo rielaborativo, è parso tuttavia opportunocorredare il prospetto anche con questo tipo di informazione, coerentementecon quello che era uno dei suoi intenti documentari (monitorare l’esistenzadi interventi sul testo in sede di stampa). Quando le varianti sostanziali sonoderivate da edizione spuria, al consueto asterisco è stato affiancato il sim-bolo “°” (tra parentesi tonde solo nel caso in cui siano varianti non partico-larmente radicali, del tipo: vera amica] sincera amica); le varianti discen-denti (introdotte a correzione di precedenti, erronee, modifiche) sono statesegnalate con doppio simbolo, sempre tra parentesi (“(°°)”). Quando è atte-stata, in base a dichiarazione d’autore o altra forma di documentazione indi-
229 Si consideri ad esempio l’incongrua equivalenza che un simile tipo di registrazionesembrerebbe suggerire tra le evoluzioni redazionali di una commedia come Il padre di fami-glia (n° 40) e quelle di una come La bottega del caffè (n° 46), che pure documentano processirielaborativi qualitativamente e quantitativamente molto difformi (come puntualmente illu-strato dalle rispettive edizioni critiche realizzate nell’ambito di EN); oppure come l’incidenzadegli interventi di riscrittura nella fase editoriale della Paperini sia del tutto impropriamenteequiparata a quella dell’ulteriore ridefinizione Pasquali nel caso di opere come La vedovascaltra (n° 31) o Il cavaliere e la dama (n° 36).
134 ANNA SCANNAPIECO
retta, una difformità testuale dell’opera rispetto all’originaria configurazio-ne scenica già all’atto della sua prima realizzazione editoriale, la sigla dellastampa viene preceduta dal consueto simbolo di rielaborazione (“*”); inol-tre, viene immediatamente di seguito fornita tra parentesi indicazione sinte-tica della relativa fonte documentaria (se d’autore, in base alla solita se-gnalazione di volume e pagina, intendendosi riferita all’omnia Ortolani).
g) rapporti stemmatici. Si sono evidenziati i rapporti di parentela tra levarie edizioni solo in presenza di edizioni sostanziali multiple (ma nonesplicitando le relazioni di ovvia derivazione, come ad esempio BPA, GA,FO< PA o GR< Z), nonché per le commedie già edite criticamente. Sonostate inoltre effettuate, con particolare riferimento alla fascia più bassa dellatrasmissione testuale (in virtù dei particolari approfondimenti resisi neces-sari per chiarire i rapporti STA-S-G-Z), campionature analitiche mirate ed èstata quindi fornita indicazione degli individuati rapporti stemmatici anchein presenza di varianti non sostanziali in senso ampio. In tali casi è statoesplicitato in nota un sintetico corredo documentario (laddove assente, lerelazioni tra i testimoni si intendono tacitamente desunte dalle edizioni cri-tiche dei testi)230.
230 Con l’avvertenza tuttavia, che laddove resosi necessario si sono integrate (o addirittu-ra, in qualche caso, corrette) le indicazioni stemmatiche desumibili dagli allestimenti criticisinora realizzati.
Per una mappa della produzione goldoniana 135
TAVOLA DELLE ABBREVIAZIONI E DEI SEGNI CONVENZIONALI
B BettinelliBO BonsignoriBPA Bettinelli «quinta edizione veneta sull’esemplare della fiorentina»Do documentazioni – editoriali o manoscritte – di redazioni originarie, uniche
superstiti nella tradizione testuale o comunque difformi da quelle poieventualmente autorizzate nelle edizioni d’autore. Se precedute dal segno“°” si intendono non direttamente dipendenti o non avallate da volontàautoriale.
F FantinoFO Fantino e OlzatiG1 Guibert e Orgeas, prima serieG2 Guibert e Orgeas, seconda serieGA GavelliGR GarboMA MasiPA PaperiniPi PisarriPP Eredi Pisarri e Giacomo Filippo PrimodìPr PrimodìPS PasqualiPT PitteriPU1 Puccinelli, prima seriePU2 Puccinelli, seconda serieS1 Savioli, prima serieS2 Savioli, seconda serieSTA1 San Tommaso d’Aquino, prima serieSTA2 San Tommaso d’Aquino, seconda serieSTA3 San Tommaso d’Aquino, terza serieSTA4 San Tommaso d’Aquino, quarta “serie”VE VenacciaZ Zatta
AD = Anecdotes dramatiques, Paris, Duchesne, 1775, tt. 3CAIL = JEAN-FRANÇOIS CAILHAVA DE L’ESTENDOUX, De l’Art de la Comédie, ou
Détail raisonné des diverses parties de la comédie et des ses différentsgenres, suivi d’un traité de l’imitation, ou l’on compare à leurs originauxles imitations de Molière et celles des modernes [...] terminé parl’exposition des causes de la décadence du théâtre et des moyens de la fai-re refleurir, Paris, Didot, 1772, tt. 4
CL = Correspondance littéraire, philosophique et critique par Grimm, Diderot,
136 ANNA SCANNAPIECO
Raynal, Meister, etc., par M. Tourneux, tt. 16, Paris, Garnier Frères, 1877-1888
CM1 = Catalogue des Pieces de Théâtre de M. Goldoni dont il est parlé dans cesMémoires par ordre chronologique
CM2 = Autre pieces de Théâtre de M. Goldoni dont il n’est pas question dans sesMémoires
DB = JEAN-AUGUSTE JULIEN DESBOULMIERS, Histoire anecdotique et raisonnéedu théâtre italien depuis son rétablissement en France, jusqu’à l’année1769, Paris, Lacombe, 1769, tt. VI-VII [Genève, Slatkine reprints, 1968, t.II]; Cat. = Catalogue raisonnée contenant, par ordre alphabétique, lesPieces, les Auteurs, & les Acteurs dont il n’a point été parlé dans le cou-rant de cette histoire, ivi, t. VII, pp. 219 ss.
D’O = ANTOINE D’ORIGNY, Annales du théâtre italien depuis son origine jusqu’ace jour, Paris, Duchesne, 1788, tt. 3 [Genève, Slatkine reprints, 1970]
G = CARLO GOZZI, Appendice a Il ragionamento ingenuo [18012], in C. Gozzi,Il ragionamento ingenuo, a cura di A. Beniscelli, Genova, Costa & Nolan,1983, p. 119
K-R = MIECZYSLAW KLIMOWICZ - WANDA ROSZKOWSKA, La commedia dell’artealla corte di Augusto III di Sassonia (1748-1756), in «Memoriedell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», vol. XLI, fasc. I, Vene-zia, 1988
MF = «Mercure de France, dédié au Roi», 1724-1791 (dal 1768: «Mercure deFrance dédié au Roi, par une Société de gens des lettres») [Genève, Sla-tkine reprints, 1968-1971]
SP = «Les spectacles de Paris, ou Calendrier Historique & Chronologique desThéâtres», Paris, Duchesne, 1751-78.
< rapporti di dipendenza genetica tra un’opera e l’altra, o di discendenzastemmatica tra un’edizione e l’altra
* varianti sostanziali rispetto alla precedente configurazione (scenica o edi-toriale)
° princeps veicolata da edizione non autorizzata (o testimoni non autografi,nel caso di manoscritti o di preservazione testuale sintetica)
*° varianti sostanziali introdotte da pubblicazioni non d’autore+ edizioni di cui non è stata appurata l’esistenza e/o l’attuale conservazione
(se seguito dalla sigla “A”, o da quella “S”, il simbolo sta ad indicare che ladocumentazione bibliografica è stata desunta dai repertori rispettivamentedi Allacci e di Spinelli).
Per una mappa della produzione goldoniana 137
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
1 Belisario aut. 1734°tragedia di lietofinetragicommedia (I696; cfr. anche I163)tragedia di cinqueatti in versi
°Pi 1738,17402
*XXXII1793
2 Rosmonda carn.1734-35tragédie (I 161)tragedia di cinqueatti in versi
XXXIII1793
3 Griselda aut. 1735°opera scenicatragédie (I 174)commedia in tre attiin versi (Z)
°Venezia,A. Gere-mia,1771
XXII1792 (<G< S<Geremia)
S2 XIV 1775[1778] (<Geremia); G2
XI 1777 (S<Geremia);Firenze, Se-reni, 1787;PU2 XIII1787; BOXXX 1792;MA XXX1793
4 Don Giovanni Te-norio o sia Il Dis-soluto carn. 1735-36commedia (I 730;cfr. anche I 176)commedia di cinqueatti in versi (Z)
+°Bolo-gna [Pi-sarri?],pre1754231
*VII1754 [I178]
XIV1776-1777
XXVI1792
PP X 1754[1755]; VEX 1754(17602); GAVII 1754; °BVIII 1755;STA1 X
231 Si veda la relativa testimonianza dei Mémoires I, 39: «Malgré son succès, il n’étoitpas destiné à paraoître dans le Recueil de mes Ouvrages, non plus que mon Bélisaire; […]ayant retrouvé cette Piece imprimée à Bologne, et horriblement maltraitée, je consentis à luidonner place dans mon Théâtre» (I 178; le stesse ragioni non erano però valse per il Belisa-rio, che oggetto di una stampa pirata già nel ’38, sarebbe stato ripescato solo dalla Zatta: cfr.XIV 428 e I 719). L’ipotesi che il presunto editore potesse essere Pisarri è confortata dal sa-pere che, a Bologna, è proprio il Pisarri a intuire e a sfruttare immediatamente la remunerati-vità della produzione goldoniana, sin dai tardi anni ’30; a questo stesso periodo sarebbe vero-similmente da ricondurre anche la stampa del Don Giovanni, che l’editore bolognese avrebbepotuto promuovere – come già quella del Belisario – a ridosso delle prime rappresentazionilocali dell’opera goldoniana; ciò nondimeno essendo quella dell’autore l’unica documenta-zione indiretta dell’esistenza di questa stampa bolognese, mi pare corretto attenersi alla solaindicazione cronologica da essa a rigore desumibile: e cioè che l’edizione pirata fosse statarealizzata prima di quella (t. VII Paperini, 1754) “riparatoria” voluta dall’autore.
138 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
+S1755(17632,17753); FOVIII 1756;S1 VI 1771;G1 XIII1774; PU1 VI1784; MAXIII 1790;BO XIX1790
5 Rinaldo di Montal-bano carn. 1736-37°commediatragicommedia (I183)commedia di cinqueatti in versi
°S2 XIII1774
XXIII1792 (G <S)
G2 XII 1777(< S); PU2
XII 1787;BO XXVI1791; MAXXXI 1793;STA4 s.d.
6 Enrico re di Siciliacarn. 1737-38tragediatragedia di cinqueatti in versi
Bettinelli,1740
*XXXIII1793
7 Giustino pre 1738tragicommediatragedia di cinqueatti in versi
Venezia,Bibl. diCasa Gol-doni, Ar-ch.Ven-dramin,ms. (Salacimeli,vetr. VI)
*XXXII1793
8-9 Momolo cortesancarn. 1738-39commedia «per lamaggior parteall’improvviso»(PA)
*L’uomodi mondoX 1757comme-dia di treatti inprosa (Z)
**°XII1790[<G< S<*°STA]232
B IX 1757;PP 1757;*°STA1 XII1757(17652); VEXIII 1757;GA X 1757;FO XII1758; S1 XI1771 (<*°STA); G1
XVI 1774 (<S); PU1 XI
232 Per la documentazione dei rapporti stemmatici, cfr. supra, pp. 93-94.
Per una mappa della produzione goldoniana 139
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
1786; BOXXII 1790;MA XXI1791; GRXII 1796
10-11
Momolo sullaBrenta aut. 1739commedia partescritta e parteall’improvviso (PA)(cfr. anche n° 92)
*Il prodi-goX 1757comme-dia di treatti inprosa (Z)
**°XIII1790[<G< S<*°STA]233
B IX 1757;*°STA1 XII1757(17662); VEXIII 1757;GA X 1757;FO XII1758; S1 XI1771 (<*°STA); G1
XVI 1774 (<S); PU1 XI1786; MA X1789; BOXXIV 1791;GR XIII1797
12 Le trentadue disgra-zie di Arlecchinoaut. 1740comédie en troisactes à canevas(CM1)(cfr. anche n° 173)
13 I Cento e quattroaccidenti in unanotte o La nottecritica aut. 1740comèdie à canevas,en trois actes (CM1)(cfr. anche n° 168)
14 Osmano re di Tunisiaut. 1740tragicommedia
argo-mento astampa,1740(Venezia,Bibl.Marciana,Dramm.1056.8)
233 Cfr. supra, p. 94.
140 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
15-16
Il mercante fallitocarn. 1740-41commedia «partescritta e parte a sog-getto» (PA)
*La ban-carotta osia IlmercantefallitoX 1757comme-dia di treatti inprosa (Z)
XVIII1791(<G <S<STA)234
B IX 1757;Pr 1757;STA1 XIII1757(17662); VEXIII 1757;GA X 1757;FO XII1758; S1 VII1771 (<STA); G1
XIV 1774 (<S); PU1 VII1784; BOXXII 1790;MA XXI1791
17 La donna di garbo1743 [1a rappresen-tazione aut. 1744]commedia di tre attiin prosa (PS)
[+Berga-mo,1747?235]*B I 1750(17512;17523;°17534)
**V 1754 ***IX1766
XVI 1791(< G<PS)236
+APi 1751;STA1 I 1752(17532,17683) (< B);VE I +1753(17562) (<B); +BPA V1754; GA V1757; FO VI1756; S1 VIII1771 (<
234 Esempi di varianti congiuntive: PA STA Fela vegnir] S G Z Fela vegnir avanti(III.2.7); PA si regola peggio che mai nel giorno stesso della sua risorsa] STA S G Z si re-gola peggio che mai nel giorno istesso della sua rissorta [G Z: risorta] (III.11.3). Va inoltresegnalato che la Savioli riproduce la prefazione alla commedia redatta dalla San Tommaso.
235 Dà notizia (senza peraltro suffragarla con nessun riscontro documentario) di questastampa pirata, E. Loehner nel commento alla sua edizione dei Mémoires (Venezia, Visentini,1883, p. 410 n. 1). Per quanto riguarda invece le rielaborazioni intervenute già in fase di pri-mo allestimento editoriale (Bettinelli), cfr. quanto asserito nella Poscritta dell’Autore allaLettera sua in data di Firenze 28. Aprile 1753, in Le Commedie del dottore Carlo Goldoniavvocato veneziano fra gli Arcadi Polisseno Fegejo. Prima edizione fiorentina dall’Autorecorretta, riveduta ed ampliata, t. I, Firenze, Eredi Paperini, 1753, p. 21. In quest’occasioneGoldoni afferma che «essenzialissime mutazioni», rispetto agli originali scenici, erano inter-venute in sede di definizione editoriale per tutte le dodici commedie stampate nei primi tretomi Bettinelli (con inoltre particolare riferimento a L’erede fortunata, Il teatro comico, Ilcavaliere e la dama, Il padre di famiglia).
236 Esempio di variante congiuntiva: PS così qualch’ brutta diavola co st’imbroi adoss lano par più brutta] G Z così qualche brutta diavola co st’imbroi adess la no par più brutta(I.6.1).
Per una mappa della produzione goldoniana 141
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
STA); G1 IX1773 (< PS);PU1 VIII1784; BOXII 1789;MA XVI1790; +GRXVI 1798 [?]
18 Arlecchino impera-tore nella Luna oIl mondo della luna1743comédie en troisactes et en prose(CM1)
19-20
Tonin Bellagrazia1745commedia «parte asoggetto e parte indialogo scritta» (II96)
*Il frap-patoreX 1757comme-dia di treatti inprosa (Z)
*°XIII1790[<G< S<*°STA]237
B IX 1757;Pr 1757;*°STA1 XIII1757 (17662;18003); VEXIII 1757;GA X 1757;FO XIII1758; S1 IV1770(< *°STA);
G1 XII 1773;PU1 IV1784; BOXXIII1789; MAXXII 1791;GR XIII1797
21-22
Il servitore di duepadroni 1745scenario disteso (II8)(cfr. anche n° 151)
°K-RXCVI-XCVIII[argo-mento]
*III 1753comme-dia di treatti inprosa(PS)
**V 1763 XX 1791 VE VII 1753(17592); GAIII 1753 [ma1754]; +BPAIII 1754;+APi 1754;STA1 VI+S1754(17612,17683); °BVIII 1755;
237 Per la documentazione dei rapporti stemmatici, cfr. supra, p. 95.
142 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
FO IV 1756;S1 IX 1771;G1 V 1772;PU1 IX 1785;BO V 1788;MA XII1790
23 Il figlio di Arlecchi-no [Truffaldino]perduto e ritrovato[o La nascita delprimogenito diTruffaldino], 1746comédie en troisactes et en prose,partie écrite, partie àcanevas (CM1)
°Le filsd’Arlequinperdu etretrouvéexposi-tion de lapièce[«comé-die ita-lienne encinq ac-tes, mêléed’ariettesitaliennes[…] ar-rangée augenre dela ScèneItalienneen Francepar leSieur Za-nuzzi»],Paris,Ballard,1762238
238 DB VI, pp. 357-363, dopo aver riportato l’estratto (ricavato dalla stampa del ’62), as-segnandone la prima rappresentazione al 13 giugno 1758 (una rappresentazione in data16/6/1758 è documentata anche dai registri del Théâtre Italien, che ne segnalavano però an-che una precedente del 29/8/1755), così commenta: «Cette excellente Comédie est de Mon-sieur Goldoni, & a été mise au théâtre par le Sieur Zanuzzi avec beaucoup d’intelligence; onpeut la mettre à côté des meilleures pieces d’intrigue, soit anciennes, soit modernes: le célébreAuteur à qui l’on est redevable, est, sans contredit, celui qui a marché le plus près sur les tra-ces de Plaute, & des anciens Auteurs comiques» (pp. 362-363). D’O II pp. 4-5, ugualmenteparla di un «canevas de M. Goldoni adapté à ce Théâtre avec beaucoup de sagacité par M.Zanuzzi» (come data di prima rappresentazione viene indicato l’11/7/1761: anche questa dataè confermata dai registri del Théâtre Italien). SP ascrive a diretta paternità goldoniana unEnfant d’Arlequin perdu et retrouvé; lo stesso fa AD, che indica nel 1764 la data di primarappresentazione. I registri del Théâtre Italien documentano solo due recite di una pièce con
Per una mappa della produzione goldoniana 143
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
24 La congiura de’carbonaricomposto presumi-bilmente entro il1746239
comediasoggetto (G)(cfr. anche n° 192)
°K-RCLXII-CLXIII[argo-mento]
25 Truffaldino ubbria-co e re dormendocomposto presumi-bilmente entro il1746comediasoggetto (G)
°K-RCXLVI-CXLVIII[argo-mento]
26 Truffaldino confusotra il bene e il malecomposto presumi-bilmente entro il1746soggetto (G)(cfr. anche ni 175 e190)
27 I due gemelli truf-faldinicomposto presumi-bilmente entro il1746comediasoggetto (G)
°K-RLXXVII-LXXVIII,CLXIX-CLXX[argo-mento]
28 I due gemelli vene-ziani Pisa, est. 1747commedia di tre atti
*B I 1750[cfr. n°17 e rela-
IX 1755 XV 1790(<G <S)240
+APi 1751;STA1 I 1752(17532) (<
questo titolo: 21/5/1765 e 19/6/1770.239 Documentate recite al S. Luca nelle stagioni autunnali del 1758 e del 1762 (cfr. A.
SCANNAPIECO, «…gli erarii vastissimi del Goldoniano repertorio»..., cit., p. 168). Al S. Gio-vanni Grisostomo il 6 febbraio 1765 la compagnia Medebach allestisce La Congiura de’Carbonari contro il Marchese di Nuvola, con Arlichino Capo de’ congiurati (cfr. «Diarioveneto appartenente al commercio civile e alle curiosità di ogni genere», mercordì 6 febraro1765, n° 37). Di questo soggetto, come dei successivi ai ni 25-27, l’indicazione di presumibilecomposizione entro il ’46 è desunta dalla testimonianza gozziana, che li descrive come pro-duzioni realizzate per il Sacchi (ed è appunto entro questa data che Goldoni compone per ilcelebre Truffaldino).
240 Esempi di sviluppi variantistici congiuntivi: chiamado … signor … fegura] S G Zchiamà … sior … figura (I.5.2); aspettate ancora] S aspettate anche] G Z aspettate almen(I.10.12); (a Florindo)] S G Z (a Beatrice) (I.11.10).
144 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
in prosa (Z) tiva nota](17512;17523;°17534)
B); VE V1753 (17582)(< B); GA IX1755; FO XI1757; S1 XI1771 (< PA);G2 II 1775 (<S); PU1 XI1786; BOXXV 1791;MA XXV1792; GRXV 1798
29 L’uomo prudenteMantova, prim.1748commedia di tre attiin prosa (PS)
*B I 1750[cfr. n°17 e rela-tiva nota](17512;17523;°17534)
**V 1754 XIV1776-1777
XII 1790(<G < S<STA<B)241
+APi 1751;STA1 I 1752(17532;17783) (< B);+BPA V1754; VE II1754 (< PA);GA V 1754;FO VII1756; S1
VIII 1771 (<STA); G1
XV 1774 (<S); PU1 VIII1784; BOXVI 1789;MA XXIII1792; GRXII 1796
30 L’erede fortunata1748 [1a rapp.: carn.1749-50]commedia di tre attiin prosa (PS)
*B III1752 [cfr.n° 17 erelativanota](°17532)
**VI1754
(*°)XV1776-1777(< PA+(*°)S<STA)
(*°)XXI1791(< G<(*°)S<STA)242
PP [STA1
III] 1752 (<B); +APi1753; STA1
III +S1753(17542;
241 Come attesta la stessa riproduzione della relativa prefazione, S è sicuramente esem-plata sulla prima edizione STA, che per ragioni cronologiche non poteva che derivare da B.Attraverso la mediazione G (cfr. I.10.2: torcendo> contorcendo), la redazione B-STA-S ven-ne assunta da Z. L’edizione critica della commedia, a cura di P. Vescovo, segnala sintetica-mente la derivazione di Z da B attraverso mediazione S, non trascurando di sottolineare comesia del tutto «implausibile l’ipotesi di un ritorno a B come “ultima volontà d’autore”» e comesia da ritenere «sostanzialmente “casuale” il recupero Savioli [< B]» in Z (EN, 1995, p. 54).
242 Per la relativa documentazione, cfr. supra, § 3, pp. 110-113.
Per una mappa della produzione goldoniana 145
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
17663) (<PA); +BPAVI 1754;GA VI 1754;VE I 1754 (<PA); FO VIII1756; (*°)S1
VI 1771 (<STA 1754);G1 XIII 1774(< (*°)S);PU1 VI 1784;BO XIX1790; MAXIX 1791
31 La vedova scaltraModena [?], est.1748commedia di tre attiin prosa (PS)
*B I 1750[cfr. n°17 e rela-tiva nota](17512;17523;°17534)
** III1753
***V1763
XIX 1791([<G] <PS)
+APi 1751;STA1 I 1752(17532) (<B); STA1 I1756 (17662;17973) (<PA); GA VI1753 [ma1754]; +BPAIII 1754; VEI 1754(17792) (<PA); FO IV1756; S1 X1771 (< STA1756); G1 V1772 (< PS);PU1 X 1785;BO V 1788;MA II 1788
32 La putta onoratacarn. 1748-49commedia venezia-na (B)commedia di tre atti
*B II1751 [cfr.n° 17 erelativanota]
IX 1755 (*°)XXI1791(<G< S<(*°)STA<PA)243
PP II 1752(17532) (<B); (*°)STA1
II +S1753(17562
243 La derivazione da PA è attestata dalla preservazione delle pochissime varianti, so-prattutto di ordine corruttivo (tipo: III.12.did, Nane […] conducendo maschere al teatro, poiTitta barcaiuolo con il lampione, conducendo altre maschere; poi il servitore] Nane […]conducendo maschere al teatro; poi il servitore; III.29.3, Sì, che ti xe le mie viscere, sì che tixe el mio caro fio] Sì, che ti xe el mio caro fio: entrambe sicuramente dovute a caduta acci-dentale), che la redazione fiorentina introduceva rispetto a B. Esempio di variante congiunti-
146 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
in prosa (Z) (17522;°17533)
[1762];17663
[1762]) (<PA); GA IX1755; VE III1754 (< B);FO XI 1757;S1 X 1771 (<(*°)STA); G1
XV 1774 (<S); PU1 X1785; BOXXII 1790;MA XXVII1792; Vene-zia, Gatti,1792
33 Il sensale da matri-moni 1748commedia (IV1008)
34 Il bugiardo 1748[*1a rapp. Mantova,prim. 1750 (IV1007-1008)]commedia di tre attiin prosa (Z)
°IV 1753 *I 1753 **II 1762 XIII 1790(< G< PS)
PP IV 1753(< PA);STA1 IV+S1753(17622
[1763]) (<PA); +BPA I1753; GA I1753; VE IV+1753 (17572)(< PA); FO I1756; S1
XIII 1772 (<STA); G1 II1772 (< PS);PU1 XIII1787; BO II1788; MA V1788; GRXIII 1797
35 Il Nerone carn.1748-49opera scenica (XIV
letteraprefativa28 di-
va: PA no posso più star, no vedo l’ora de butarmeghe a brazacolo] STA S G Z omittit(II.3.26).
Per una mappa della produzione goldoniana 147
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
426)tragédie en cinqactes en vers (CM2)
cembre1748
36 Il cavaliere e ladama Verona, est.1749commedia di tre attiin prosa (Z)
*B III1752 [cfr.n° 17 erelativanota](°17532)
**II 1753 ***II1762
III 1789([< G] <PS)
PP [STA1
III] 1752 (<B); STA1 III1752(+S17532;17543; 17664)(< PA); BPAII 1753; GAII 1753; VE I1754 (< PA);FO II 1756;S1 IX 1771(< PP); G1 II1772 (< PS);PU1 IX 1785;BO II 1788;MA IV1788; GR III1794
37 La buona moglieaut. 1749commedia venezia-na (B)commedia di tre attiin prosa (Z)
*B II1751 [cfr.n° 17 erelativanota](17522;°17533)
IX 1755 (*°)XVI1791(<G< S<(*°)STA<PA)244
°Firenze,Stecchi,1752; PP II1752 (17532)(< B);(*°)STA1 II+S1753(17562
[1762];17743) (<PA); GA IX1755; VE II+1753 (17582)(< B); FO XI1757; S1 X1771 (17862)(< (*°)STA);G1 XV 1774(< S); PU1 X
244 Come già nel caso della Putta onorata, la derivazione da PA è attestata dalla preser-vazione delle scarne modifiche introdotte rispetto a B dalla redazione fiorentina (es.: III.3.7:B TITA E mi ve digo che a mi me toca. NANE E mi ve digo che a mi me toca.] PA TITA E mive digo che a mi me toca. Anche in questo caso è evidente la natura accidentale delle modifi-che). Per la documentazione dei rapporti stemmatici, cfr. supra, pp. 91-92.
148 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
1785; BOXXII 1790;MA XXVIII1792; +GRXVI 1798 [?]
38 L’avvocato venezia-no carn. 1749-50commedia di tre attiin prosa (PS)
*B III1752 [cfr.n° 17 erelativanota](°17532)
VI 1754 ***VIII1765
XI 1790(< G<PS)245
PP (STA1
III) 1752 (<B); STA1+SIII 1753(17542;17653
[1766];17904)(<PA); +BPAVI 1754;GA VI 1754;VE III 1754(< PA); FOVII 1756; S1
X 1771 (<STA); G1
VIII 1773 (<PS); PU1 X1785; MA III1788; BOVII 1789;GR XI 1796
39 La famigliadell’antiquario o siaLa suocera e lanuora carn. 1749-50commedia di tre attiin prosa (PS)
*B III1752 [cfr.n° 17 erelativanota](°17532)
**IV1753
***VII1764
XVIII1791([< G]<PS)
STA1 III1752 (< B);STA1 III+S1753(17542;17663) (<PA); +APi1753; +BPAIV 1754;GA IV 1754;VE III 1754(< PA); FOV 1756; S1 II1770 (< PA);G1 VII 1773(< PS); PU1
II 1783; MA
245 Esempio di variante congiuntiva: PS BEATRICE Via, Rosaura, mettete ancor voi. ] GZ omittit.
Per una mappa della produzione goldoniana 149
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
III 1788; BOVI 1788
40 Il padre di famigliacarn. 1749-50commedia di tre attiin prosa (Z)
*B II1751 [cfr.n° 17 erelativanota](**17522;°17533)
***VII1754
****VII1764
III 1789(< G< PS)
PP II 1752(17532;17923) (<B1751); STA1
II +S1753(17562 [1762];17663) (<PA); +BPAVII 1754;GA VII1754; VE II+1753 (17572)(< B 1751);FO IX 1757;S1 XIII 1772(< PP); G1
VII 1773 (<PS); PU1 XIII1787; MAIV 1788(<PS); BOVIII 1789(<PS); GR II1794 (<Z);
41 Pantalone impru-dente a. c. 1749-50commedia non rap-presentata (IV 1007)[ma forse documen-tato allestimentodella comp. Mede-bach al S. GiovanniGrisostomo nelcarn. 1764-65]246
42 I flati ipocondriacia. c. 1749-50commedia a sog-
246 Il «Diario veneto appartenente al commercio civile e alle curiosità di ogni genere», n°14, lunedì 14 Gennaro 1765 annunciava la rappresentazione al S. Giovanni Grisostomo di unPantalon Padre Inprudente o sia la Famiglia scoreta; nel numero del giorno successivo, siavvisava che questa «Commedia Nuovissima del Sig. Dottore Carlo Goldi [sic]» (ora regi-strata col titolo di Le debolezze di Pantalone Corrette dalla buona Famiglia, o sia l’uomoimprudente) «si replicava a richiesta universale» (ivi, n° 15, martedì 15 gennaro 1765; lacommedia era replicata anche il 17 gennaio: cfr. ivi, n° 17).
150 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
getto con «Dote,cioè con parte dellescene scritte» (IV1007)
43 Le amorose fattuc-chierie di Brighellaa. c. 1749-50commedia a sog-getto con «Dote,cioè con parte dellescene scritte» (IV1007)
44 I fratelli riconosciu-ti a. c. 1749-50commedia a sog-getto con «Dote,cioè con parte dellescene scritte» (IV1007)
45 Le femmine punti-gliose Mantova,prim. 1750commedia di tre attiin prosa (PS)
°B VI1753
*III 1753 **VI 1764 XVII1791 ([<G] < PS]
VE VI +1753(17592) (<°B); +APi1753; GA III1753 [ma1754]; +BPAIII 1754;STA1 VI1754 (17632;17743); FOIV 1756; S1
XII 1771[1772]; G1
VI 1773;PU1 XII1787; MAVI 1788; BOV 1788
46 La bottega del caffèMantova, prim.1750commedia di tre attiin prosa (PS)
*°B IV1753 [III5]
**I 1753 ***I 1761 IV 1789(< G<PS)247
PP IV 1753(< PA);*°STA1 IV+S1753(17622
[1763];17753) (<
247 Ben 6 delle 7 varianti segnalate da Roberta Turchi (EN, 1994, p. 54 come diffrazioniZ rispetto a PS sono dovute a mediazione G (cfr. I.1.4, I.8.47, I.12.9, II.1.1, II.2.30 [2]).
Per una mappa della produzione goldoniana 151
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
PA); VE IV1753 (17562)[< PA]; BPAI 1753; GA I1753;FO I 1756;S1 I 1770(17742) (<PA); G1 I1772 (< PS);PU1 I 1783;MA I 1788;BO I 1788;GR IV 1794
47 L’adulatore Manto-va, prim. 1750commedia di tre attiin prosa (Z)
°B IV1753
*II 1753 **III 1762 XIII 1790([< G] <PS]
STA1 V1753(17622;17632) (<PA); VE IV+1753 (17582)(< PA); BPAII 1753; GAII 1753; FOII 1756; S1
VIII 1771 (<STA); G1 III1772; PU1
VIII 1784;MA VI1788; BO III1788; GRXIII 1797
48 I poeti Milano, est.1750commedia di tre attiin prosa (Z)
°B VII1753(17552)
Il poetafanatico*VIII1755
XX 1791(< G< S<PA)
PP X 1755;STA1 X+S1755(17632;17753) (<PA); GAVIII 1754[ma 1755];+BPA VIII1755; VE IX1756; FO X1757;S1 III1770; G1 XI1773 (< S);PU1 III
152 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
1783; BOXXI 1790 (<S); MA XVI1790 (< G)
49 La Pamella, o sia lavirtù premiata248
Mantova, prim.1750commedia di tre attiin prosa (PS)
*°PamelaB V 1753
**LaPamela I1753
***Pa-mela fan-ciulla I1761
Pamelanubile I1788 ([<G] < PS]
+APi 1753;STA1 IV1753 (1756[1763]2;17653); VEIV +1753(17562);BPA I 1753;GA I 1753;FO I 1756;S1 I 1770(17742); G1 I1772; PU1 I1783; MA II1788; BO I1788; GR I1793 [1794]
50 Il teatro comicoMilano, sett. 1750commedia di tre attiin prosa (PS)
*B II1751 [cfr.n° 17 erelativanota](17522;°17533)
** I 1753 ***I 1761 I 1788(< G<PS)249
PP II 1752(17532) (<B); STA1 II+S1753(17602
[1762];+17623) (<PA); BPA I1753; GA I1753; VE III1754 (< PA);FO 1 1756;S1 I 1770(17742) (<STA); G1 I1772 (< PS);PU1 I 1783;
248 Così documentato il titolo originale della commedia nella registrazione che, in data 28novembre 1750, danno della prima veneziana i Notatorj del Gradenigo (Venezia, Bibliotecadel Museo Correr, Codice Gradenigo-Dolfin n° 67, I). Per quanto riguarda la data di primarappresentazione, segnalo che le indicazioni al riguardo fornite da °B V (non smentitedall’autore, come invece già accaduto nel caso dell’Adulatore: cfr. III 1162) la assegnanoall’allestimento veneziano della stagione autunnale 1750.
249 Esempio di variante congiuntiva: PS prospetto di camera] G Z prospetto di cortile(Personaggi).
Per una mappa della produzione goldoniana 153
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
MA I 1788;BO I 1788;GR I 1793[1794]
51 Il cavaliere di buongusto aut. 1750commedia di tre attiin prosa (Z)
°B VI1753
*III 1753 **IV 1762 XI 1790 VE VI +1753(17592) (<°B); PP VI1754 (< PA);STA1 VI+S1754(1762[1763]2);17763)(<PA); +BPAIII 1754; GAIII 1753 [ma1754]; FO III1756; S1 V1770 [1771](17712); G1
IV 1772;PU1 V 1784;BO IV 1788;MA XII1790; GR XI1796
52 Il giocatore carn.1750-51commedia di tre attiin prosa (PS)
V 1754 XII 1774[Il giuo-catore]
XIV 1790(< G< S<STA/PP<PA)250
PP VIII1754; STA1
VIII +S1754(1762
250 Rapporto stemmatico non chiaramente delineato nell’edizione critica di A. Zaniol(EN, 1997), che anzi postula una biforcazione – del tutto indimostrabile, e ripugnante aglistessi dati messi in luce dallo studioso – PA-PS-GA-FO-STA / S-G-Z (p. 77): in realtà PS facaso a sé (sarebbe semmai da valutarne il rapporto con MA e BO, peraltro neanche menzio-nate da Zaniol) e non può essere certamente collocato nella serie nei modi su citati (la seriesembra infatti costruita in maniera caotica: quali criteri la sorreggono? certamente non cro-nologici, né stemmatici); inoltre il gruppo di varianti che viene classificato come disgiuntivotra i due presunti rami della tradizione è invece introdotto, per dinamiche corruttive, da S, epoi recepito dalla tradizione successiva (G< Z), ma questo naturalmente non comportal’indipendenza di S e seguenti da STA, di cui vengono anzi (e proprio attraverso la mediazio-ne di S) recepite e trasmesse alcune fondamentali evoluzioni testuali. Al riguardo, e a ulterio-re riprova di quanto sin qui argomentato, sorprende che, tra le varianti addotte dallo Zaniol asostegno della suddetta biforcazione, ne figuri anche una – a cui peraltro lo studioso attribui-sce particolare rilievo (cfr. ivi, pp. 77-78) – che, lungi dall’essere introdotta da S, è variantedovuta a STA (o, per essere più precisi, a PP, antigrafo di STA: II.13.26: PA PS TIBURZIOVia, voglio compiacervi. Tre. LELIO Fante, ho vinto; parolì. FLORINDO Va’ subito.
154 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
[1763]2);+BPA V1754; VEVIII +1754(17602); GAV 1754; FOVI 1756; S1
IX 1771(<STA); G1
XV 1774 (<S); PU1 IX1785; BOXV 1789;MA XXVIII1792; GRXIV 1798
53 Il vero amico carn.1750-51commedia di tre attiin prosa (Z)
*IV 1753[III 1199]
**VII1764
V 1789([< G] <PS]
PP (STA1
VII) 1754;STA1 VII+S1754 (1762[1763]2;17753);+BPA IV1754; GA IV1754; VEVIII +1754(17592); FOV 1756; S1 II1770(17742); G1
VII 1773 (<PS); PU1 II1783; MA III1788; BOVII 1789;GR V 1794[1795]
TIBURZIO Tre, ho vinto.] STA S G Z TIBURZIO Via, voglio compiacervi. Tre. FLORINDOVa’ subito. LELIO Fante, ho vinto; parolì. TIBURZIO Tre, ho vinto).Segnalo inoltre che la su citata edizione critica, oltre a incorrere in varie sviste cronologiche(si indicano come del 1764 PA V [p. 69], del 1756 STA1 VIII [p. 75], del 1772-74 G1 XV [p.76], trascura anche la menzione di VE, PU, BO, MA, GR.
Per una mappa della produzione goldoniana 155
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
54 Lo speziale, o sia Lafinta ammalata251
carn. 1750-51commedia di tre attiin prosa (PS)
La fintaammalataIV 1753
*VI 1764 XXXIV1793 (<G< PS)252
STA1 VII1754 (1759[1763]2;17623);+BPA IV1754; GA IV1754; VEVII 1753(17592); FOV 1756; S1 I1770 (17742;+s17753) (<PA); G1 VI1773 (< PS);PU1 I 1783;MA V 1788;BO VI 1788
55 La dama prudentecarn. 1750-51commedia di tre attiin prosa (PS)
VII 1754 *X 1767 VI 1789([< G] <PS)
PP [STA1
IX] 1754;STA1 IX1754 (1762[1763]2);+BPA VII1754; GAVII 1754;VE X 1754(17602); FOVIII 1756;S1 VII 1771(< STA); G1
X 1773 (<PS); PU1 VII1784; BOXIII 1789;MA XXIII1792; GR VI1795
56 L’incognita perse- *L’inco- XX 1791 GA VIII
251 Il titolo originario è ricordato e giustificato da Goldoni stesso nella prima prefazionealla commedia (III 648).
252 Esempio di variante congiuntiva: Se il matrimonio fosse una medicina cattiva, tantevedove non tornerebbero a medicarsi] G Z Se il matrimonio fosse una medicina cattiva, tantevedove non tornerebbero a maritarsi (I.14.33); come riprova di sviluppo redazionale “a cate-na” si osservi questo caso: Oh, signor dottore, mi ha dato la vita] G Oh signor dottore mi hadato la vita] Z Oh, il signor dottore mi ha dato la vita (II.8.43).
156 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
guitata dal bravoimpertinente253
carn. 1750-51commedia di tre attiin prosa (Z)
gnitaVIII 1755[III 795]
1754 [ma1755]; +BPAVIII 1755;STA1 XI1755 (1763[1764]2); VEXI 1755(17762); FOIX 1757; S1
IV 1770;G1 XII1773; PU1 IV1784; BOXXIII 1790;MA XXV1792
57 L’avventuriere ono-rato carn. 1750-51commedia di tre attiin prosa (Z)
°V 1753 *III 1753 **IV 1762 V 1789([< G] <PS)
VE VI +1753(17602) (<°B); +BPAIII 1754; GAIII 1753 [ma1754]; PP VI1754 (< PA);STA1 VI+S1754(1762[1763]2) (<PA); FO III1756; S1 V1771 (17752)(< STA); G1
IV 1772 (<PS); PU1 V1784; MA I1788; BO IV1788; GR V1794 [1795]
58 La donna volubilecarn. 1750-51commedia di tre attiin prosa (Z)
*VIII1755[XIV458-459]
XIX 1791 GA VIII1754 [ma1755]; +BPAVIII 1755;STA1 X1755 (17632;17773); VE
253 Anche in questo caso è l’autore stesso a documentare e motivare il titolo originario(cfr. III 795).
Per una mappa della produzione goldoniana 157
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
XI 1755; FOX 1757; S1
III 1770(17752); G1
XI 1773;PU1 III 1783;BO XXI1790; MAXIII 1790
59 I pettegolezzi delledonne carn. 1750-51commedia di tre attiin prosa (Z)
°V 1753 *IX 1755 (*°)XIX1791 (<G< S<STA)
VE VII 1753(17602) (<°B); +APi1755;(*°)STA1 XI1755 (1763[1764]2;17913); GAIX 1755; FOXIII 1758;S1 III 1770(17752) (<°STA); G1
XI 1773 (<S); PU1 III1783; BOXXI 1790;MA XVIII1791
60 Il Moliere Torino,est. 1751commedia in cinqueatti in versi (PA)
*°B IV1753
*II 1753 **III 1762 XXV1792([<G] < PS)
STA1 V1753 (17942)(< PA); PP[STA1 V]1753; +APi1754; BPA II1753; GA II1753; VE II1753 (17582)(< PA); FOII 1756; S1
III 1770(17742) (<STA); G1 III1772; PU1 III1783; BO III1788; MAIV 1788
61 La gastalda aut.1751
°B VII1753
*La ca-stalda
XIX 1791(<G< S<
+APi 1754;GA VIII
158 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
commedia di tre attiin prosa (Z)
(17552) VIII1755
STA< PA) 1754 [ma1755]; +BPAVIII 1755;STA1 XI1755 (1763[1764]2) (<PA); VE IX1754 (17612)[< °B]; FO X1757; S1 IV1770(< STA);G1 XII 1773(< S); PU1
IV 1784;BO XXIII1790; MAXXVI 1792
62 L’amante militareaut. 1751commedia di tre attiin prosa (PS)
V 1754 *X 1767 XI 1790(< G <PS)
STA1 VIII1754(17632);+BPA V1754; VEVIII 1754(17592); GAV 1754; FOVI 1756; S1
VI 1771 (<STA); G1 X1773 (< PS);PU1 VI 1784;BO XIV1789; MAXXIV 1792;Venezia,Gatti, 1792;GR XI 1795[1796]
63 Il tutore carn. 1751-52commedia di tre attiin prosa (Z)
°B V1753
*II 1753 **II 1762 XII 1790(< G <PS)
STA1 V1753 (17622;17633)(< PA); BPAII 1753; GAII 1753; VEVI +1753(17592)(< PA); +APi1754; FO III
Per una mappa della produzione goldoniana 159
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
1756; S1 VI1771 (<STA); G1 II1772 (< PS);PU1 VI 1784;BO II 1788;MA VI1788; GRXII 1796
64 Il trionfo della pru-denza in Rosauramoglie amorosa254
carn. 1751-52commedia di tre attiin prosa (PS)
°La mo-glie amo-rosa °BVI 1753
*La mo-glie sag-giaIV1753
V 1763 XVI 1791([< G] <PS)
+APi 1754;STA1 VII1754 (17632;1776[1775]3) (<PA); +BPAIV 1754;GA IV 1754;VE V 1753(< PA); FOIV 1756; S1
II 1770(17742) (<PA); G1 V1772 (< PS);PU1 II 1783;BO IV 1788;MA VIII1789; +GRXVI 1798 [?]
65 Il marchese diMonte Fosco carn.1751-52commedia di tre attiin prosa (PS)
°B VII1753(17552)
*Il feu-datarioVI 1754
**VIII1765
XI 1790(< G <PS)255
+APi 1754;STA1 IX1754 (1759[1763]2;17763) (<PA); +BPAVI 1754;GA VI 1754;VE IX +1754(17602) (<°B); FO VII1756; S1 VII
254 Nella prefazione Paperini alla commedia Goldoni così ricorda, e diffusamente giusti-fica, il titolo originario (IV 1142).
255 Esempio di variante congiuntiva: PA PS Eccoci ad offerire, ed obliare a Vostra Ec-cellenza […] accetterà con ampullosità di riconoscenza] G Z Eccoci ad offerire, ed obbligarea Vostra Eccellenza […] accetterà con ampliosità di riconoscenza (I.9.11).
160 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
1771 (<STA); G1
VIII 1773 (<PS); PU1 VII1784; MAVII 1789;BO X 1789;GR XI 1796
66 Le donne gelosecarn. 1751-52commedia di tre attiin prosa (Z)
°B VI1753
*IX 1755 *°XVII1791(< G<*°FO)256
+APi 1754;PP [STA1
XII] 1755;STA1 XII+S[XIII]1757 (1763[1757,1775]2;17963); GAIX 1755; VEXII 1757;°FO XI1757; S1 XI1771; G1
XVI 1774 (<*°FO); PU1
XI 1786; BOXXIV 1791;MA XXII1791
67 La serva amorosaBologna, prim. 1752commedia di tre attiin prosa (PS)
I 1753 *III 1762 XXI 1791(< G <PS)257
+APi 1753;STA1 IV1753 (1762[1763]2);BPA I 1753;GA I 1753;VE V +1753(17582); FOII 1756; S1
XII 1771[1772]; G1
III 1772 (<PS); PU1 XII1787; BO III
256 Per la relativa documentazione, cfr. supra, pp. 115-117.257 Per la derivazione di Z da G, cfr. le seguenti varianti: PS preverrò] G Z prevenirò
(I.3); PS Ed io penso] G Z Eh! io penso (II.2.6); PS cacciar di casa] G Z cacciar fuor dicasa (III.17.5).
Per una mappa della produzione goldoniana 161
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
1788; MAVIII 1789
68 I puntigli domesticiMilano, est. 1752commedia di tre attiin prosa (PS)
VI 1754 *X 1767 XVIII1791 ([<G] < PS)
+APi 1754;STA1 IX1754 (17632;17893);+BPA VI1754; GA VI1754; VE X1754(17602); FOVIII 1756;S1 VII 1771(< STA); G1
X 1773 (<PS); PU1 VII1784; BOXIII 1789;MA XXV1792
69 La figlia obbedienteaut. 1752commedia di tre attiin prosa (PS)
VI 1754 *VIII1765
XXI 1791([< G] <PS)
STA1 VIII1754 (17632;1777[1775]3);+BPA VI1754; GA VI1754; VE IX+1754(17612); FOVII 1756; S1
XIII 1772 (<STA); G1
VIII 1773 (<PS); PU1
XIII 1787;BO XII1789; MAXIII 1790
70 I due Pantalonicarn. 1752-53commedia di tre attiin prosa (PS)
°B VIII1755
*I mer-catantiV 1754
**IX 1766 X 1789 (<G < PS)
PP VIII 1754(< PA);STA1 VIII+S1754 (1762[1763]2;17753) (<PP); +BPA V1754; VEVIII +1754(17602) (<
162 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
PA); GA V1754; FO VI1756; S1
VIII 1771 (<STA); G1 IX1773; PU1
VIII 1784;BO XIII1789; MAXV 1790;GR X 1796
71 La locandiera carn.1752-53commedia di tre attiin prosa (PS)(cfr. anche n° 163)
*II 1753[IV 780]
**IV 1762 IV 1789([< G] <PS)
B VII 1753(17552)(<PA); PP[STA1 V]1753; STA1
V +S1753(1759[1763]2;17763); BPAII 1753; GAII 1753; VEV 1753(17582); FOIII 1756; S1
IX 1771 (<PA); G1 IV1772 (< PS);PU1 IX 1785;BO IV 1788;MA I 1788;GR IV 1794
72 Le donne curiosecarn. 1752-53commedia di tre attiin prosa (PS)
IV 1753 *VI 1764 XVII1791(< G<PS)258
PP [STA1
VII] 1754;STA1 VII+S1754 (1762[1763]2;17753);+BPA IV1754; GA IV1754; VEVII 1753
258 Derivazione non segnalata dall’edizione critica della commedia a cura di A. Di Ricco(EN, 1995), che difatti non recensisce G: ma il rapporto stemmatico è facilmente documenta-bile (cfr. ad es. I.1.25, dove la diversa attribuzione di battuta, attestata in Z rispetto a PS, è giàin G).
Per una mappa della produzione goldoniana 163
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
(17592); FOV 1756; S1 II1770 (17712;17733;17744) (<PA); G1 VI1773 (< PS);PU1 II 1783;BO VI 1788;MA XVI1790
73 L’uomo impruden-te259 carn. 1752-53commedia di tre attiin prosa (Z)
*Il con-trattem-po, o siaIl chiac-chieroneimpru-denteVIII 1755[IV 927]
XV 1790(< G< S<STA)260
GA VIII1755;PP [STA1
XI] 1755;STA1 XI+S1755(1763[1764]2;17913);+BPA VIII1755; VE XI1755; FO X1757; S1 IV1770 (17862)(< STA); G1
XII 1773;PU1 IV 1784;BO XXIII1790; MAXXVI 1792;GR XV 1798
74 La donna vendicati-va carn. 1752-53 [1a
rapp. aut. 1753]
VII 1754 (*°)XVI1777-1779(< PA +
(*°)XVII1791 (<G< S<
+APi 1754;(*°)STA1 X1754 [1755]
259 Per la configurazione originaria del titolo, cfr. quanto asserito dall’autore nella prefa-zione alla commedia (IV 927).
260 Esempi di lezioni congiuntive e di sviluppi variantistici a catena: PA STA Metti collapadrona delle buone parole] S G Z Metti colla tua padrona delle buone parole (I.7.20); PASTA Finché egli ha avuto di me bisogno] S G Z Finché ha avuto di me bisogno (II.2); PASTA La lo aggiusta in piazza] S La lo aggiuta in piazza] G Z La lo agiusta in piazza(III.1.7); PA Oh donne, donne, desperazion dei padri] STA S G Z Oh donne, desperazion deipadri (III.5.15); PA lo aspettano, ed egli non si è veduto] STA S G Z lo aspettano, ed eglinon è venuto (III.17.9).
164 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
commedia di tre attiin prosa (PS)
[G<] S <(*°)STA)
(*°)STA)261
(17632;17753);+BPA VII1754; GAVII 1754;VE XI +1754(17612); FOIX 1757; S1
V 1771(17752) (<(*°)STA); G1
XIII 1774 (<S); PU1 V1784; BOXVIII 1790;MA XIX1791
75 Il geloso avaro Li-vorno, est. 1753commedia di carat-tere in tre atti inprosa (PT)
I 1757 XII 1774 (*°)XVIII1791(<G< S<(*°)STA1763)262
STA2 I 1757(1763[1757]2)(+SSTA1 XII1757); (*°)Pr1757; VEXII 1757; F I1758; S2 IV1773 (< STA1763); G2 II1775 (< S);PU2 IV 1787;BO XV1789; MAXXII 1791
76 L’uomo sincero263
Livorno, est. 1753commedia di carat-tere in tre atti inprosa (PT)
*Ladonna ditestadebole osia la
XIV1776-1777
XV 1790 Pr 1757;STA2 I 1757(1763[1757]2)(+SSTA1 XII
261 Per la relativa documentazione, cfr. supra, § 3, pp. 104-105.262 Varianti congiuntive: PT STA 1757 PS Caro signor padron, gh’è tante donne in sta
città de Napoli, e la va a incapriciarse in una donna maridada] STA 1763 S G Z Caro signorpadron, l’è za un grande intrigo a incapriciarse in tele donne, ma pezo po, che la va a incapri-ciarse in una donna maridada (I.1.39); PT STA 1757 PS La donna xe per mi un gran intrigo.Xe vero che la ne dà qualche diletto, ma el ne costa assae caro. Una donna costa un tesoro.]STA 1763 S G Z La dona xe per mi un gran intrigo. Una dona costa un tesoro. (I.6).
263 Sulla fisionomia originaria del titolo, si veda quanto asserito dall’autore nella prefa-zione Pitteri alla commedia (V 107).
Per una mappa della produzione goldoniana 165
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
vedovainfatuataI 1757[V 107]
1757); VEXII 1757; F I1758; S2 V1773; G2 II1775; PU2 V1787; BOXVI 1789;MA XIX1791; GRXV 1798
77 La sposa persianaaut. 1753°commediacommedia di carat-tere orientale in cin-que atti in versi ri-mati che diconsimartelliani (PT)
°VE XII1756;°Bologna,Bibl. Uni-versitaria,ms. 3817
*I 1757 XIII 1775 XXII1792 (< G< S)264
STA2 I 1757(1763[1757]2)(+SSTA1 XII1757); Pr1757; F I1758; S2 I1770(+s17722
[1770]) (<STA); G2 I1774; Vene-
264 Nell’edizione critica della commedia (EN, 1996, cit., pp. 123-124), Marzia Pieri, purnon mancando di segnalare che «molti degli interventi operati nella Zatta risalgono in realtàalla Guibert Orgeas […] e talvolta anche alla San Tommaso e alla Savioli» finisce poi inspie-gabilmente per presentare come campionatura variantistica zattiana un assieme di lezioni chetutto sono fuorché tali (ad eccezione di quella occorrente in II.6.15, nemeno> almeno). Neldettaglio: PT STA S PS Nulla intanto io voglio lasciar per un tal bene] G Z Nulla intentatoio voglio lasciar per un tal bene (I.4.1); PT STA S PS Che innamorar farebbe anche le piante,e i sassi] G Z Che innamorar farebbe anche le pietre, e i sassi (I.5.18); PT STA S PS Respirao langue, è in libertà o in periglio?] G Z Respira forse o langue, è in libertà o in periglio?(IV.10.21); PT STA S PS Fuggasi, giacché il fato tronca ha ogni mia speranza] G Z Fuggasi,giacché il fato tronca ha ogni speranza (V.1.11); PT STA PS Ecco un lume, ecco un uscio;mi celerò: ah son tradita!] S G Z Ecco un lume, ecco un uscio; mi celo: ah son tradita!(V.1.35). Nonostante la chiara derivazione – ancora una volta, di natura prettamente inerziale,di Z da G (e la precedente discendenza STA> S> G, che del pari non sembra essere stata ana-lizzata e individuata) – la studiosa non manca poi di collocare in condizioni di pari dignitàgerarchica l’ultima edizione “d’autore” alle precedenti (cfr. p. 125: «la connotazione dellaZatta conferma l’andamento di un processo già verificato nel passaggio PT] PS: il testo vieneulteriormente normalizzato, perdendo gran parte della sua composita espressività»), trattandocioè varianti inequivocabilmente spurie come mutamenti testuali documentari di una volontàd’autore e utili pertanto a definire l’evoluzione della sua parabola artistica. Segnalo infine chenella stessa edizione critica (p. 536), la pubblicazione STA della commedia viene ascritta al t.XII della seconda serie (così come quelle dell’Ircana in Julfa e dell’Ircana in Ispaan, nei to-mi V e VI della «serie successiva»): sulla base cioè della documentazione Spinelli, non veri-ficabile.
166 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
zia, Gatti1784; PU2 I1787; BO IX1789; MA X1789; Garbo1795 [1796]
78 La cameriera bril-lante carn. 1753-54commedia di carat-tere di tre atti inprosa (PT)
II 1757 XVI1777-1779
XX 1791 STA2 II1757 (1763[1757]2;17913); VEXIV 1758(17722); F II1758; S2 V1773(17752); G2
IV 1775;PU2 V 1787;BO XVIII1790; MAXVIII 1791
79 Il filosofo inglesecarn. 1753-54commedia di carat-tere in cinque atti inversi rimati che di-consi martelliani(PT)
I 1757 XII 1774 XXIV1792(<G >S)
STA2 I 1757(1763[1757]2;17763)(+SSTA1 XII1757); VEXII 1757; F I1758; S2 V1773; G2 III1775 (<S);PU2 V 1787;BO XV1789; MAXIV 1790
80 Il Cortesan vec-chio265 carn. 1753-54commedia di tre attiin prosa (PT)
*Il vec-chio biz-zarroII 1757[V 356]
XVII1780
XIV 1790 STA2 II1757 (1765[1757]2;17963); VEXIV 1758(17722); F II1758; S2 VI1773 (<STA); G2 IV1775; PU2 VI
265 Così Goldoni documenta il titolo originario nella prefazione Pitteri alla commedia (V353).
Per una mappa della produzione goldoniana 167
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
1787; BOXX 1790;MA XVII1790; GRXIV 1798
81 La madre amorosa1753-54 [*1a rapp.Genova, prim. 1754(V 605)]commedia di tre attiin prosa (PT)
II 1757 XV 1776-1777
XVI 1791(< G<S)266
STA2 II1757 (1763[1757]2;17942); VEXIV 1758(17732); F II1758; S2 V1773(17752); G1
XVI 1774 (<S); PU2 V1787; BOXII 1789;MA XX1791; +GRXVI 1798 [?]
82 Il festino carn.1753-54commedia di carat-tere in cinque atti inversi che diconsimartelliani (PT)(cfr. anche n° 110)
II 1757 XXXI1793 (<G< S)267
*°STA2 II1757 (1763[1757]2;17873); VEXIV 1758(17722); F II1758; S2 I1770 (17712;17743); G2 V1775 (< S);PU2 I 1787;MA XII1790; BOXXVI 1791
83 La maschera 1753comédie en troisactes, partie écrite,partie à canevas(CM2)
°K-RCXCIX-CCVI
84 L’impostore comp. VII 1754 XVII XIV 1790 PP [STA1
266 Esempi di varianti congiuntive: prometterne] S G Z promettere (I.8.20); sono un in-grato se non procuro di assicurargliela, anche a costo della mia vita medesima] S G Z sonoun ingrato se non procuro di assicurargliela, a costo della mia vita medesima (II.4.1); patrona]S G Z padrona (III.8.4 e passim).
267 Per la documentazione dei rapporti stemmatici, cfr. supra, n. 188.
168 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
prim. 1754 [per re-cite di convittori diun collegio gesuiti-co (Bologna o Mo-dena)]commedia di tre attiin prosa (PS)
1780 (<PA + [G<]S< STA)
(< G< S <STA)268
IX] 1754;STA1 IX1754 (1762[1763]2;17773);+BPA VII1754; GAVII 1754;VE X 1754(17602); °BVIII 1755;FO IX 1757;S1 XII 1772(< STA); G2
I 1774 (< S);PU1 XII1787; BOXX 1790;MA XXI1791; GRXIV 1798
85 Terenzio aut. 1754commedia di carat-tere antico romanodi cinque atti in ver-si (PT)
III 1758 XI 1773 XXV1792
STA2 III1758 (1765[1758]2); VEXV 1758(17732); S2 II1772 (<STA); G1
XIII 1774;PU2 II 1787;MA III 1788;BO VII 1789
86 La peruviana aut.1754commedia di cinqueatti in versi rimati(PT)
III 1758 XV 1776-1777
XXVIII1792(< G< S <STA)269
STA2 III1758 (1764[1758]2;17683); VEXV 1758(17732);*(°)S2 II
268 Per la relativa documentazione, cfr. supra, § 3, n. 178.269 Esempi di sviluppi variantistici a catena: PT Il povero Padrone principia a vacillare. /
Ma suo danno, suo danno; che Diavol di pazzia!] S Il povero Padrone principia a vacillare. /Ma suo danno, che Diavol di pazzia!] G Z Il povero Padrone principia a vacillare. / Ma va-cilli a suo danno, che diavol di pazzia! (III.1.16). La discendenza STA> S è attestata dal fattoche l’edizione veneziana riproduce la prefazione alla commedia redatta dall’edizione bolo-gnese.
Per una mappa della produzione goldoniana 169
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
1772 (17742)(< STA);*(°°)G2 V1775 (< S);PU2 II 1787;MA XVI1790; BOXIX 1790
87 Torquato Tassocarn. 1754-55commedia di cinqueatti in versi martel-liani (PT)
III 1758 XVI1777-1779
*° XXVI1792(<*°°°G<*°°S<*°STA)270
*°STA2 III1758 (1763[1758]2;17923); VEXV 1758(17722);*°°S2 II 1772(<STA);*°°°G2 VI1775 (< S);PU2 II 1787;MA VIII1789; BOVIII 1789
88 I viaggiatori271
carn. 1754-55commedia di cinqueatti in versi (PT)
*Il ca-valierGiocon-doIV1758272
(*°)XXIV1792(<(*°°)G<(*°)S)273
STA2 IV1758 [1759];VE XVI1758(17732);(*°)S2 III
270 Per la relativa documentazione, cfr. supra, pp. 95-96 e 102.271 Nella prefazione alla commedia, l’autore ricorda la configurazione originaria del titolo
e ne motiva la modifica in fase di stampa (V 855).272 La diffrazione testuale in sede di stampa è data dalla diversità del titolo e dal venir
meno del prologo (cfr. XII 1001-1002): ma altamente probabile è anche la seriorità dei versiche figurano in IV.1 ad esaltazione del collegio dei Nobili di Parma e di Filippo di Borbone,il nuovo «clementissimo [...] Padrone» di Goldoni (così nella dedica della commedia a Fru-goni, dedicatario scelto proprio per il ruolo dall’autore recentemente assunto alla corte diParma, che è naturalmente menzionata in abbondanza nella dedica stessa): nominato poeta dicorte, a partire dall’ottobre 1756, Goldoni riceve una pensione annua e non manca di fregiarela nuova edizione Pitteri con il titolo che gli derivava dalla nuova qualifica.
273 Esempi di varianti congiuntive: PT Eccone [denaro] qui. Tacete] S G Z Eccone qui.Tenete (I.1.2); PT CAVALIER GIOCONDO Domandate a Madama se vuol la cioccolata… / No,ditele che meco a prenderla l’aspetto. / Andate… (il servitore parte… FABIO Vi voleva perciòun altro biglietto. / CAVALIER GIOCONDO. Non dite mal, vo’ farlo. ] S CAV. Domandate aMadama se vuol la cioccolata… / No, ditele, che meco a prenderla l’aspetto. / (il servitoreparte… FABIO Vi voleva perciò un altro biglietto. / CAV. Non dite mal, vo’ farlo. ] G Z CAV.Domandate a Madama se vuol la cioccolata… / No ditele, che meco a prenderla l’aspetto. / (il
170 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
1772(17742);(*°°)G2 IX1776 (< S);PU2 III 1787;MA XXIV1792; BOXXIX 1792
89 Le massare carn.1754-55commedia di cinqueatti in versi scrittacol vernacolo vene-ziano (PT)
IV 1758 XXX1793(Le mas-sere) (<G<S)
STA2 IV1759; VEXVI 1758(17742); S2
III 1772; G2
XI 1777;PU2 III 1787;MA XXVII1792; BOXXIX 1792
90 I malcontenti prim.1755 [1a rapp. Ve-rona, est. 1755;proibite le recite aVenezia]274
commedia di tre attiin prosa (PT)
IV 1758 VII 1789 STA2 IV 175[1759]; VEXVI 1758(17732); S2
III 1772(17742); G2
VII 1775;PU2 III 1787;BO XVI1789; MAXX 1791;GR VII1795
91 Le due cameriereBagnoli, est. 1755commediaall’improvviso(V 348)
92 Il prodigo [< Mo-molo sulla Brenta,n° 10] Bagnoli, est.
servitore parte… FABIO Signor, vi voleva perciò un altro biglietto. / CAV. Non dite mal, vo’farlo. (I.2.16-19).
274 Entro il 5 aprile 1755 la commedia era già composta, come si desume da una letteraad Arconati Visconti (XIV 188); sulle censure imposte dal segretario del Magistrato alla Be-stemmia, Agazzi, censure che indussero Goldoni ad un rimaneggiamento del testo (poi co-munque non rappresentato a Venezia: cfr. prefazione PT in V 1021), si veda quanto raccon-tato dall’autore a Francesco Vendramin in una lettera del 27 settembre 1755 (XIV 192-193).
Per una mappa della produzione goldoniana 171
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
1755ossatura/soggetto (I859)
93 La fiera Bagnoli,est. 1755petite piece (I 359)
94 La buona famigliaaut. 1755commedia di tre attiin prosa (PT)
IV 1758 VIII 1789 STA2 IV1758 [1759];VE XVI1758(17742); S2
III 1772; G2
VIII 1776;PU2 III 1787;MA XVII1790; BOXXIV 1791;GR VIII1795
95 Le donne de casasoa aut. 1755commedia venezia-na (PT)commedia di cinqueatti in versi (Z)
V 1758 XXX1793
STA2 V1759(17602); S2
IV 1773; G2
VIII 1776;PU2 IV 1787;BO XXVI1791; MAXXX 1793
96 Ircana in Julfa aut.1755commedia di carat-tere orientale(PT/PS)
V 1758 XIII 1775 (*°)XXII1792 (< G< S <(*°)
STA)275
(*°)STA2 V1759 (1764[1759]2;17913); VEXVII 1759
275 Il rapporto stemmatico non è definito nell’edizione critica della commedia (EN, 1996,cit., pp. 123 e 536), dove viene solo genericamente menzionato (sulla base di documentazionevariantistica Ortolani) un confluire nella Zatta di apporti redazionali di precedenti edizioninon d’autore (cfr. supra, n° 77 e relativa nota). Anche Ortolani, difatti, non descriveva indettaglio la genesi, e il vario percorso, delle trasmutazioni testuali, limitandosi a vaghi riferi-menti a Z, o a Z e G, o anche a STA. Per verificare il rapporto genetico indicato a testo, siconsideri invece la seguente campionatura: PT STA PS Fra noi dee una sol donna bastar aoneste voglie] S G Z Fra noi dee una sol donna bastar a nostre voglie (I.3.107); PT STA S PSSapresti, se li offrissi, sprezzar gli affetti miei?] G Z Sapresti, se il soffrissi, sprezzar gli af-fetti miei? (II.8.6); PT PS KISKIA Far quel che puoi t’impegni per spegnere il mio foco?IRCANA Sì, ma quel che poss’io, pe ’l tuo bisogno è poco] STA S G Z omittit (II.8.7-8); PTSTA S PS Quelli che uniti vivono sotto un medesmo tetto] G Z Quelli che vivono uniti sottouno stesso tetto (III.10.1).
172 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
commedia di cinqueatti in versi (Z)
(17762); S2 I1770(+s17722
[1770]) (<(*°)STA)17743); G2
III 1775 (<S); PU2 I1787; MA X1789; BO IX1789; Vene-zia, Gatti1792; Garbo1795 [1796]
97 La villeggiaturacarn. 1755-56commedia di tre attiin prosa (Z)
V 1758 *°IX 1789(<*°(°°)G<*°(°)S <*°STA)276
*°STA2 V1759(17712); VEXVII 1758(17742);*°(°)S2 IV1773 (17742)(< STA);*°(°°)G2 VI1775(<S); PU2 IV1787; MAXVIII 1791;BO XXV1791; GR IX1796
98 Il raggiratore carn.1755-56commedia di tre attiin prosa (PT)
*III1758 [VI11]
(*°)XIV1790(<G<(*°°)S<(*°)STA)277
(*°)STA2 III1758 (17652;17993); VEXV 1758(17732);(*°°)S2 II1772 (<(*°)STA); G2
III 1775 (<S(*°°)S); PU2
276 Per la relativa documentazione, cfr. supra, pp. 96-99.277 Esempi di varianti congiuntive: PT un negozio] STA S G Z un affar (I.1.12); PT gran
negozio] STA S G Z grande affare (I.1.13); PT STA CONTE (Tanto vi siete fatto aspettare?)(s’accosta ad Arlecchino) ARLECCHINO L’è stà per causa de Giacomina. CON (Secondatemi)(piano ad Arlecchino)] S G Z CONTE (Tanto vi siete fatto aspettare?) (s’accosta ad Arlecchi-no) (Secondatemi) (piano ad Arlecchino) (I.14.2-4).
Per una mappa della produzione goldoniana 173
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
II 1787; MAXV 1790;BO XXV1791; GRXIV 1798
99 La donna strava-gante carn. 1755-56commedia di cinqueatti in versi (Z)(cfr. n° 115)
VI 1760 (*°°°)
XXVII1792(< G<S)278
STA2 VI1760(17752); VEXXVIII 1761(17792); S2
VI 1773; G2
X 1776 (<S); PU2 VI1787; MAXV 1790;BO XXVII1791
100 Il campiello carn.1755-56commedia venezia-na in versi dramma-tici (PT)
V 1758 XXV1792(< G< S<STA)279
STA2 V1759(17682); VEXXII 1774;S2 IV1773 (17742)(< STA); G2
V 1775 (<S); PU2 IV1787; MAXXXI 1791;BO XXVII1791
101 L’avaro Bologna[recita privata], est.1756commedia di un attosolo in prosa (PS)
IV 1762 V 1789 (<G< PS)
STA3 I 1762;VE XX1767; S2 XI1774 (<STA); G1 IV
278 Esempi di sviluppi redazionali: PT S E per vedervi afflitta senza il consorte a lato] GZ Ed anche per vedervi senza il consorte a lato (I.4.19); PT Con più attenzion dell’altre que-sta commedia ha scritto] S G Z Con più attenzion dell’arte questa commedia ha scritto(III.4.51).
279 Esempi di varianti congiuntive e/o di evoluzioni redazionali “a catena”: PT CA-VALIERE Un altro padre? GASPARINA Oh zior no; cozza dizelo? Gh’ho un barba. CAV. Labarba?] STA S CAV. Un altro padre? GAS. Oh zior no; cozza dizelo? Gh’ho un barba. CAV.Un Barba?] G Z CAV. Un altro padre? GAS. Oh zior no; cozza dizelo? Gh’ho un barba. CAV.Una barba? (II.11.33-35); PT No posso far la guardia] STA S G Z No ghe voi far la guardia(III.1.19); PT STA Povere zenza zezto, no le sa] S Povere zente zezto, no le sa] G Z Poverazente zerto, no le sa (III.10.26).
174 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
1772; PU2 X1787; MAVII 1789;BO X 1789;GR V 1794[1795]280
102 L’amante di se me-desimo [L’amante dise medesimo, oL’egoista;L’egoista]281 Mila-no, sett. 1756commedia di cinqueatti in versi (Z)
VI 1760 XXVI1792
STA2 VI1760; VEXVIII 1761(17782); S2
VI 1773; G2
IX 1776;PU2 VI 1787;MA XXII1791; BOXXVI 1791
103 Il medico olandeseMilano, est. 1756commedia di cinqueatti in versi (Z)
VI 1760 XXIII1792
STA2 VI1760; VEXVIII 1761(17772); S2
VI 1773(17752); G2
V 1775; PU2
VI 1787;MA VII1789; BO X1789
104 Osmano ritornatodal campo, o siaIrcana prossegui-mento della SposaPersiana282 aut.1756
Ircana inIspaanVI 1760
XIII 1775 (*°)XXII1792 (<G< S<(*°)STA)283
(*°)STA2 VI1760(17682); VEXVIII 1761(17782); S2 I1770 (+s1772
280 L’edizione critica della commedia, a cura di E. Mattioda (EN, 1998, cit., pp. 43-46)non segnala le edizioni STA (da cui, come indicato a testo, deriva S), PU, GR. Attribuisceinoltre a redazione Z le varianti di 2.24 (intorno a lei> intorno di lei), 5.38 (se hanno ragionedi sperare> se hanno una ragione di sperare) e 49-50 (da sé> omittit), che erano in realtàlezioni già attestate in PS (esemplare della Biblioteca di Casa Goldoni, Venezia) e conservatein tutta la tradizione STA, S, G, Z (dunque non è chiaro a quale edizione appartengano le le-zioni ritenute originarie e in quanto tali accolte a testo).
281 Così attestato il titolo in CM1; cfr. anche I 386-387.282 Questo il titolo originale della commedia secondo quanto documentato dai Notatorj
del Gradenigo, che, in data 24 novembre 1756, registrano come «non tralasciando il Sig. Dor
Carlo Goldoni d’impiegar il di lui talento, fu posta in scena nel Teatro in S. Luca una nuovaComedia intitolata…» (Venezia, Biblioteca del Museo Correr, Codice Gradenigo-Dolfin n°67, III, c. 117).
Per una mappa della produzione goldoniana 175
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
tragicommedia(PT/PS)commedia di cinqueatti in versi (Z)
[1770] 2)(< STA);G2 III 1775(< S); Vene-zia, Gatti1784(17942); PU2
I 1787; MAX 1789; BOIX 1789;Garbo 1795[1796]
105 La donna sola carn.1756-57commedia di cinqueatti in versi martel-liani (PT)
VII 1761 XXIX1793
STA2 VII1761 [1762](17752); S2
VII 1773;VE XXIV1777; G2 VI1775; PU2
VII 1787;MA XXI1791; BOXXVIII 1792
106 La pupillacomposta entro ilgiugno 1757commedia in cinqueatti in versi sdruc-cioli e di scena sta-bile (PA)[in una riduzione asoggetto, rappr. aBagnoli, est. 1757]
X 1757 (*°)XVII1780(PA+ S<(*°)STA)
(*°)XXX1793 (<G< S<(*°)STA)284
B IX 1757;Pr 1757;(*°)STA1 XII1757 (17652
[1757;1775]); GAX 1757; VEXIII 1757;FO XII1758; S1 V1771 (17752)(< STA); G1
XI 1773 (<S); PU1 V1784; BOXX 1790;MA XXX1793
107 Il cavaliere di spi- X XXIV *°STA2 X
283 Cfr. supra, nni 77, 96 e relative note. Per lo specifico dei rapporti stemmatici indicatia testo, cfr. almeno IV.5.9: PT PS Povero giovinetto, goda la sposa in pace] STA S G Z Po-vero giovinetto, parli alla sposa in pace.
284 Per la relativa documentazione, cfr. supra, pp. 106-109.
176 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
rito o sia la donnadi testa debole Zola,est. 1757commedia in cinqueatti in versi martel-liani (PT)(cfr. anche n° 191)
1763-64 1792 (< G< S?)
1764(17882); VEXIX 1766;S2 X 1773(+s17752); G2
IX 1776;PU2 IX 1787;MA II 1788;BO VII1789285
108 La vedova spiritosaaut. 1757commedia di cinqueatti in versi (Z)(cfr. anche n° 123)
VII 1761 XXX1793
STA2 VII1761 [1762](17732); S2
VII 1773(17752); G2
VII 1775;PU2 VII1787; MAXVIII 1791;BO XXIX1792
109 Il padre per amoreaut. 1757commedia di carat-tere in cinque atti inversi martelliani(PT)
IX 1763 *IX 1766 XXIII1792 (<[G<] PS)
STA2 IX1763 [1764];S2 IX 1773;(< STA) G1
IX 1773 (<PS); PU2 IX1787; MA V1788; BOVIII 1789
110 Il festino Roma,entro 1757commedia in pro-sa286
285 L’edizione critica curata da E. Mattioda (cfr. supra, § 3, nn. 118 e 188) non segnala leedizioni VE e PU; ma soprattutto sostiene che G «accoglie pressoché tutte le innovazioni» diSTA (p. 129): il che è palesemente impossibile, visto che l’edizione bolognese introduce dellevarianti sostanziali di ordine censorio che non solo risultano del tutto estranee alla redazioneproposta da G (come d’altronde anche da S, che in questo caso è indipendente da STA), mastranamente risultano ignote allo stesso Mattioda, che pure si spinge ad asserire l’importanzadell’edizione bolognese nel suo introdurre «alcune innovazioni grafico-lessicali che perdure-ranno nelle edizioni seguenti» (p. 128). Quanto alla presunta indipendenza di G da S è tuttada dimostrare, riscontrandosi possibili lezioni congiuntive in II.5.116, III.4.50, V.4.8.
286 L’attestazione della riduzione in prosa anche di questa commedia (cfr. nni 108 e 123,112 e 120) è in quanto dichiarato dall’autore nella prefazione alla prima edizionedell’originaria redazione in versi (cfr. n° 82). Essendo fra l’altro la suddetta prefazione ascri-
Per una mappa della produzione goldoniana 177
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
(cfr. n° 82)111 Lo spirito di contra-
dizione carn. 1757-58commedia di carat-tere in cinque atti inversi martelliani(PT)
IX 1763 XXXVII1792
STA2 IX1763 [1764];S2 IX 1773;G2 X 1776;MA XXV1792; BOXXX 1792
112 Le morbinose carn.1757-58commedia venezia-na di cinque atti inversi martelliani(PT)(cfr. anche n° 120)
VIII1761
XXVII1792
STA2 VIII1762; S2
VIII 1773(17742); G2
X 1776; PU2
VIII 1787;MA XXIX1793
113 La bella selvaggiacarn. 1757-58commedia, o piutto-sto tragicommedia,di cinque atti in ver-si martelliani (PT)tragicommedia dicinque atti in versi(Z)
VII 1761 XXVIII1792
STA2 VII1761 [1762](17782); S2
VII 1773(17752); VEXXII 1774;G2 VII 1775;PU2 VII1787; MAXVII 1790;BO XXVII1791
114 L’apatista o siaL’indifferente Zola,est. 1758commedia in cinqueatti in versi martel-liani (PT)
X 1763-64
XXV1792 (< G< S?)
STA2 X1764(17662); Fer-rara, T. For-nari, 1764;S2 X 1773;G2 VII 1775;MA XI1789; BOXXIX1792287
vibile al 1757, è precisamente entro quest’anno che va collocata la riduzione in prosa dellacommedia, realizzata – come l’autore testimonia altrove (cfr. supra, p. 49) – in funzione dialcune rappresentazioni romane (se ne desume dunque che già prima del soggiorno del 1758-59 Goldoni aveva rapporti diretti di committenza con i teatri romani).
287 L’edizione critica della commedia, a cura di E. Mattioda (EN, 1998, cit., pp. 245-254)cita solo – e senza riferimento ad eventuali ristampe – le edizioni STA, G, MA e BO. In par-ticolare sorprende la mancata menzione di S (cfr. quanto già segnalto supra, n. 118).
178 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
115 La donna bizzarra[<La donna strava-gante, n° 99] Zola,est. 1758288
commedia in cinqueatti in versi martel-liani (PT)
X 1763-64
XXVII1792 (<G< S?)
STA2 X1764; S2 X1773; G2 IV1775; PU2
XV 1787;MA XIX1791; BOXXVIII1792289
116 La dalmatina aut.1758tragicommedia dicinque atti in versimartelliani (PT)(cfr. anche n° 157)
IX 1763 XXVIII1792
STA2 IX1763 [1764];S2 IX 1773(17742); G2
IX 1776;PU2 IX 1787;MA XXIII1792; BOXXX 1792
117 Il ricco insidiatoaut. 1758commedia di cinqueatti in versi martel-liani (PT)(cfr. anche n° 152)
VII 1761 XXIII1792
STA2 VII1761 [1762](17752); S2
VII 1773(17752); G2
X 1776; PU2
VII 1787;MA VI1788; BOVIII 1789
118 La sposa sagaceaut. 1758commedia di cinqueatti in versi martel-liani (PT)
VIII1761
XXIX1793
STA2 VIII1762(17762); S2
VIII 1773;G2 VIII
288 Non sottoscrivibile la postdatazione sostenuta nell’edizione critica della commedia (acura di E. Mattioda EN, 1998, cit., p. 378), perché basata sull’errata convinzione che Goldoninon avesse intrattenuto rapporti con i teatri romani prima del ’57 (cfr. invece supra, n. 286) esu un improprio utilizzo delle fonti (in particolare l’interpretazione del celebre progetto delle“nove muse” – lettera a Vendramin 21/8/1759, XIV 422 – nel passo relativo all’“offerta” diEuterpe: che certo non può riferirsi alla Donna bizzarra, come – non si sa in base a quale cri-terio – ipotizzò il Mantovani, ripreso dal Mattioda; ma semmai all’Impresario delle Smirne,come ben visto già da Ortolani, XIV 792).
289 Anche in questo caso (cfr. supra, n° 114 e relativa nota) sorprende il riscontrarenell’edizione critica di E. Mattioda (EN 1998, cit., pp. 245-254) la mancata menzione di S;tanto più che alcune varianti, dal critico segnalate come introdotte da Z, sono già attestate in S(che, come in moltissimi altri casi, sarà stato antigrafo di G): cfr. in particolare le occorrenzedi III.5.13 e di V.2.29, registrate ivi, pp. 475 e 482.
Per una mappa della produzione goldoniana 179
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
1776; PU2
VIII 1787;BO XXVII1791; MAXXVI 1792
119 La donna di gover-no aut. 1758commedia di cinqueatti in versi martel-liani (PT)
VIII1761
XXIX1793
STA2 VIII1762; S2
VIII 1772[1773](17732); VEXXII 1774;G2 VIII1776; PU2
VIII 1787;MA IX1789; BOXXVIII 1792
120 Le donne di buonumore [< Le morbi-nose, n° 112] Roma,aut. 1758commedia di tre attiin prosa (Z)
°VEXVII1759(17762)[< Roma,1758?]
(*)VI1789
STA4 1791;BO XXIV1791; MAXXX 1793;GR VI 1794[1795]
121 La sposa fedele290
carn. 1758-59commedia di cinqueatti in versi martel-liani (PT)
*La don-na forteVIII1761[VII165]
XXIX1793
STA2 VIII1762(17762); S2
VIII 1773(17752); VEXXII 1774;G2 IV 1775;PU2 VIII1787; MAXX 1791;BO XXVIII1792
122 I morbinosi carn.1758-59commedia venezia-na in cinque atti inversi martelliani(PT)
IX 1763 XXXI1793
STA2 IX1763 [1764];S2 IX 1773;G2 VI 1775;MA XXVIII1792; BOXXXI 1793
123 La vedova spiritosaRoma, carn. 1758-
FaustoAmidei,
VE XVII1759 (17742)
290 Il titolo originario, legato ad una diversa fisionomia testuale, viene ricordato dall’auto-re nella prefazione alla commedia (VII 165).
180 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
59commedia[riduzione in prosadell’omonimacommedia in versi:cfr. n° 108]
Roma,1759
124 Gli amori di Ales-sandro Magno aut.1759commedia […] ap-poggiata all’Istoria[…] in […] stiledrammatico (XIV221-222; cfr. ancheXIV 228)tragicommedia(XIV 222, 224)commedia, o siatragicommedia(XIV 225)tragédie en cinqactes en vers (CM2)tragicommedia dicinque atti in versi
XXXI1793
BO XXXI1793
125 La scuola di balloaut. 1759291
commedia […] interza rima, o sia interzetti (XIV 222)commedia di cinqueatti in versi
*(?)XXIV1792[XIV 229]
BO XXX1792; MAXXIX 1793
126 Artemisia aut.1759292
tragedia in verso
XXXIII1793
291 Il CM2 specifica in nota che la «Piece […] n’a pas été représentée». In realtà venneallestita al San Luca nell’autunno del 1759, ma ebbe solo due rappresentazioni e non venne, aquanto pare, mai più ripresa (cfr. A. SCANNAPIECO, «…gli erarii vastissimi del Goldonianorepertorio»..., cit., pp. 170, 173 e passim). La notazione in calce ai Mémoires potrebbe essereil frutto della rimozione di un cocente insuccesso; nella prefazione al t. I Pasquali l’autoreveniva infatti ricordando che l’opera «riscosse poco meno che le fischiate» (I 627), a causadell’impiego di un toscano cruscante.
292 Anche in questo caso il CM2 specifica in nota che la «n’a pas été ni jouée ni impri-mée»: ma se effettivamente, all’altezza dei Mémoires, l’opera – come d’altronde anche laScuola di ballo – non era stata ancora stampata, era stata invece rappresentata, e anche congrandissimo successo (cfr. A. SCANNAPIECO, «…gli erarii vastissimi del Goldoniano reperto-rio»..., cit., pp. 167 e 171).
Per una mappa della produzione goldoniana 181
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
sciolto (XIV 222)tragedia di cinqueatti in versi
XXXIII1793
127 Enea nel Lazio aut.1759in versi chiamatieroici ad imitazionedei latini esametri(XIV 222)293
tragedia di cinqueatti in versi [endeca-sillabi sciolti]
XXXII1793
128 Zoroastro aut. 1759tragicommedia […]in ottava rima (XIV222)294
tragicommedia dicinque atti in versi[distici martelliani]
XXXII1793
STA4 s.d.
129 Gl’innamorati aut.1759commedia di tre attiin prosa (Z)
II 1762 VI 1789 STA3 I 1762(17742); Li-vorno, A.Santini eCompagni,1763; VEXIX 1766;G1 II 1772;S2 XI 1774(< STA);PU2 X 1787;BO II 1788;MA VIII1789; GR VI1795
130-131
L’impresario delleSmirne carn. 1759-60°commediacomédie en troisactes […] en vers (I375)
°S2 XIV1775[1778]
*XII 1774commediadi cinqueatti inprosa
VII 1789([<G] <PS)
STA3 IV1775 [1776](<PS); G2 I1774 (< PS);PU2 XIII1787 (<S);BO XV 1789
293 Anche nel Monte Parnaso, l’introduzione alle recite per l’autunno 1759 stampata infoglio volante da Pitteri e poi ripubblicata da Zatta con correzioni nel 1793 (t. XXXI) si men-ziona il modello di «Carmi eroici […] al latin metro esametro conformi» (XII 1011).
294 Cfr. ivi 1010: «Sarà l’ottava rima / De’ miei carmi lo stil. Novella foggia / Per lo Tea-tro, è vero, / Ma non ingrata agli uditori io spero»
182 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
(<PS); MAXXIV 1792(<PS); GRVII 1795 (<Z)
132 La guerra carn.1759-60commedia di tre attiin prosa (PS)
*VI 1764[VII 559-560]
X 1789 (<G< PS)
STA3 II1764 [1765];VE XIX1766; G1 VI1773; S2 XII1774 (<STA); PU2
XI 1787; BOVI 1788;MA V 1788;GR X 1796
133 La Compagnia deiSalvadeghi, ossia Irusteghi295 carn.1759-60commedia in linguaveneziana di tre attiin prosa (PS)
I rusteghiIII 1762
VII 1789 STA3 I 1762;G1 III 1772;S2 XI 1774(< STA);PU2 X 1787;BO III 1788;MA XX1791; GRVII 1795
134 Pamela maritataRoma, carn. 1759-60°commedia di ca-ratterecommedia di tre attiin prosa (PS)
°Roma,Mainardi,1760
*I 1761[VII 422]
I 1788([< G] <PS]
STA3 I 1762;Livorno,Santini,1762; VEXX 1767; G1
I 1772; S2 XI1774 (<STA); PU2 X1787; BO I1788; MA II1788; GR I1793 [1794]
135 Un curioso acci-dente aut. 1760commedia di tre attiin prosa (PS)
VII 1764 III 1789(<G<PS)
STA3 II1764 [1765];VE XIX1766; G1 VII1773; S2 XII1774 (<STA); PU2
295 Così documentato il titolo nella recensione che della commedia fece Gasparo Gozzinel n° 5 della «Gazzatta veneta» (20 febbraio 1760; ed. Zardo, cit., p. 24).
Per una mappa della produzione goldoniana 183
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
XI 1787; BOXI 1789;MA XVII1790; GR II1794
136 La donna di maneg-gio aut. 1760commedia di tre attiin prosa (PS)
VIII 1765 VI 1789 STA3 II1765; VEXX 1766; G1
VIII 1773;S2 XII 1774(< STA);PU2 XI 1787;BO XII1789; MAXIII 1790;GR VI 1795
137 La casa nova aut.1760commedia venezia-na di tre atti in prosa(PS)
X 1767 IX 1789 STA3 IV1767 [1776];G1 X 1773;S2 XIII 1774[1775]; PU2
XII 1787;BO XIV1789; MAXXVI 1792;GR IX 1796
138 La buona madrecarn. 1760-61commedia di tre attiin prosa (PS)commedia venezia-na di tre atti in prosa(Z)
IX 1766 VIII 1789(<G >PS)
STA3 III1766 [1775];G1 IX 1773;S2 XIV 1775[1778]; PU2
XIII 1787;BO XIII1789; MAXV 1790;GR VIII1795
139 Le smanie per lavilleggiatura aut.1761commedia di tre attiin prosa (PS)
XI 1773 II 178817892
STA3 III1775; G1
XIV 1774;VE XXIII1777; S2 XV1780; PU2
XIV 1787;BO XVII1789; MAXI 1789; GRIII 1794
184 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
140 Le avventure dellavilleggiatura aut.1761commedia di tre attiin prosa (PS)
XI 1773 II 178817892
STA3 III1775; G1
XIV 1774;VE XXIII1777; S2 XV1780; PU2
XIV 1787;BO XVII1789; MAXI 1789; GRIII 1794
141 Il ritorno dalla vil-leggiatura aut. 1761commedia di tre attiin prosa (PS)
XI 1773 II 178817892
STA3 III1775; G1
XIV 1774;VE XXIII1777; S2 XV1780; PU2
XIV 1787;BO XVII1789; MAXI 1789; GRIII 1794
142 La scozzese aut.1761°commedia tradottadal franzese in ita-lianocommedia di cinqueatti in prosa (PS)
°STA3 IV1772[1776]
*XIII1775
X 1789([<G] <PS
S2 XIII 1774[1775] (<°STA); STA3
IV 1777[1776] (<PS); G2 XI1777 (<PS);PU2 XII1787; BO IX1789; MAXIV 1790;GR X 1796
143 La bella georgianaaut. 1761tragicommedia dicinque atti in versi
XXVIII1792
BO XXXI1793
144 Il buon compatriottocarn. 1761-62comédie en troisactes, partie écrite,partie à canevas(CM2)commedia di tre attiin prosa
XV 1790 BO XXV1791; MAXXVIII1792; GRXV 1798;STA4 s.d.
145 Todero brontolonSior Todero bron-
°STA3 IV1772
Sior Tode-ro bron-
IX 1789(< G< PS)
G2 XI 1777(< PS); PU2
Per una mappa della produzione goldoniana 185
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
tolon, o sia Il vec-chio indiscretocarn. 1761-62°commedia in lin-gua venezianacommedia venezia-na di tre atti in prosa(PS)
[1776];°°S2 XIII1774[1775]
tolon, osia Ilvecchiofastidioso*XIV1776-1777
XII 1787;BO XVII1789 (< PS);MA XXIII1792 (<G/BO); GRIX 1796
146 Le baruffe chioz-zotte carn. 1761-62commedia di tre attiin prosa (PS)
XV 1776-1777
X 1789(< G< PS)
G2 XII 1777;S2 XV 1780;STA4 1786;PU2 XIV1787; BOXXI 1790;MA XXIV1792; GR X1796
147 Una delle ultimesere di carnovalecarn. 1761-62commedia venezia-na di tre atti in prosa(PS)commedia allegori-ca di tre atti in prosa(Z)
XVI1777-1779
(*°)
XXXIV1793 (<(*°)STA)296
STA4 1790;BO XVIII1790; MAXXIX 1793
148 L’osteria della po-sta Zola, est. 1762commedia di un attosolo in prosa (PT)
X 1763-64
IV 1789(< G <S?)297
STA2 X1764; G2 II1775; S2 X1773 (17742;+s17753);
296 Esempi di varianti congiuntive: PS (BO, MA)] Siora Marta? Xe la più bona creatura]STA Z Siora Marta, xe la più bona creatura (I.2.25); PS (BO) MARTA Via, chi manca ametter su? ] STA Z ALBA Via, chi manca a metter su? (II.3.63; MA: ELENETTA Via, chimanca a metter su?); PS (BO, MA) (Oh! povereto mi! […])] STA Z (Oh! povereto mi! […])da sé (III.7.5).
297 L’edizione critica a cura di E. Mattioda (EN 1998, cit., pp. 495-503) evidenzia la de-rivazione di Z da G (anche se poi, come nel caso di tutte le altre commedie del volume, in-spiegabilmente registra in apparato tutte le varianti come proprie di Z, quando – nella mag-gior parte dei casi – sono appunto derivate a Z da G), ma non fa cenno dei rapporti con S.Potrebbero invece far sospettare operante anche in questo caso la frequente evoluzione S> G>Z i seguenti sviluppi variantistici: PT mi lusingo non mi tenete] S mi lusingo non mi tenerete(che è correzione morfosintattica, però regionalmente connotata; STA correggeva con ten-ghiate) ] G Z mi lusingo non mi terrete (5.37); PT Siate voi pur collerico […], non potete es-serlo] S (e già STA) Siate voi pur collerico […], non potrete esserlo] G Z Siate pur collerico[…], non potrete esserlo (ultima.32).
186 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
PU2 IX 1787;BO X 1789;MA XXVII1792 ; GRIV 1794
149 L’amour paternelParigi, 4/2/1763 (8,22 e 25/2/63;1/3/63)comédie italienne entrois actes et en pro-se
ExtraitParis, Du-chesne,1762(17632)
*V 1763L’amorepaterno osia Laserva ri-cono-scentecommediadi tre attiin prosa
XII 1790 STA3 II1763 [1765];VE XX 1767;S1 XII 1771[1772]; S2
XII 1774 (<STA); G1 V1772; PU1
XII 1787;PU2 XI 1787;BO V 1788;MA XII 1790;GR XII 1796
150 Arlequin cru mortParigi, 25/2/1763(1763: 5 e 18/3; 11 e26/4; 26/6; 25/9; 9 e17/11; 11/12. 1764:17/3; 20/5; 6/8.1765: 14/1; 18/4;3/6; 11/9; 19/10.1766: 26/1; 2/10;20/11. 1767: 24/1;27/4; 20/8. 1768:4/1; 15/2; 25/4; 7/9;31/10. 1769:21/1;1/3; 12 e 28/4;15/7; 4/11; 21/12.1770: 7/2; 17/3; 5/5;24/6; 15/7; 8/10;5/12. 1771: 13 e27/1; 10/4; 2/5;29/6. 1772: 6/1;20/2; 9/5; 3/8. 1773:15/2; 19/7; 25/8;14/10; 16/10 [Fon-tainebleau]. 1774:27/2; 12/3; 18/4;15/10; 24/11. 1775:9/1; 29/7; 2/9;14/10. 1776: 3 e11/5; 28/9. 1777:
Per una mappa della produzione goldoniana 187
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
12/6. 1778: 13 e16/3. 1779: 13/2;3/9)298
commedia a sog-getto di un atto solo(XIV 276)comédie italienne enun acte (MF)canevas italien enun acte (DB)comédie italienne enun acte à canevas(AD)
151 Arlequin valet dedeux maîtres [< Ser-vitore di due padro-ni, n° 21] Parigi,4/3/1763 (1763: 8,11 e 15/3. 1767:26/6; 20/10. 1771:8/1; 4 e 25/6. 1772:23/6)299
298 Lettera a G. Cornet 28 febbraio 1763: «ha incontrato quanto l’altra [L’amour pater-nel], e forse di più. […] Vi è dentro tanto interesse e tanto intrigo da poter fare una lungacommedia. Si seguita a dare…» (XIV 276).MF, mars 1763, p. 210: (segnalata il 24/2 come data di prima rappresentazione) «avec beau-coup d’applaudissemens». Avril 1763, premier volume, p. 170: [«Suite des Spectacles de laCour Versailles»] «fit plaisir; & l’on rendit, par des suffrages très-honorables, la même justi-ce aux talens de ce célébre Etranger, que l’on avoit déjà rendue à la représentation de l’AmourPaternel»; ivi, pp. 193-194 [«Spectacles de Paris – Comédie Italienne», rappresentazione del25/2]: si reseconta del successo generale, non mancando di giustificare l’autore perché ancheMolière ha dovuto fare commedie «en la masquant quelquefois des livrées de la farce»; sisottolinea inoltre come nell’Arlequin cru mort Goldoni «s’est prêté encore plus aux Specta-teurs François en mettant les scènes plus étendues entre l’Arlequin & le Scapin, qui sont dansl’usage de parler François dans les Comédies Italiennes».DB, Cat., p. 249: «canevas […] très-plaisant, & joué avec quelque succès».D’O II, p. 16: «reçut les applaudissemens les plus flatteurs».
299 Lettera a G. Cornet del 24 ottobre 1762: «Ne ho fatta un’altra [commedia] a soggetto,cavata dal Servitore di due padroni, ma tutta rinnovata al gusto di questo teatro» (XIV 265);lettera a F. Vendramin del 13 marzo 1763: «L’incontro della mia prima commedia [Amourpaternel] a Parigi, e di alcuni soggetti dati posteriormente [Arlequin cru mort, Arlequin valetde deux maîtres] mi hanno un poco calmato lo spirito» (XIV 277); lettera a A. Paradisi del 28marzo 1763: «la prima commedia […] è riuscita bene. […] Dopo di questa ne ho date tre asoggetto [terza = ?]. L’esito è stato felice, ed io ne sono contento» (XIV 278).
188 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
commedia a sog-getto (XIV 265)comédie en cinqactes (MF)canevas italien entrois actes (DB)comédie italienne encinq actes à cane-vas (AD)
152 Arlequin héritierridicule [< Riccoinsidiato, n° 117]Parigi, 12/4/ 1763(15/4/63) [Venezia,aut. 1764]300
commedia a sog-getto (XIV 280)comédie italienne,en cinq actes (MF)canevas en cinqactes (DB)comédie italienne,en cinq actes, à ca-nevas (AD)comédie en cinqactes à canevas
MF avril 1763, premier volume, pp. 194-195: «Cette Pièce contient un Imbroglio soutenuavec un Génie singulier & qui produit des Scènes fort comiques. Elle a été suivie & a paruréussir généralement».CL juin 1763 (V, p. 319): «on a traduit de l’italien une comédie du célèbre Goldoni, intituléele Valet à deux maîtres. Cette pièce est un chef-d’oeuvre d’intrigue, et fort amusante au théâ-tre; mais elle doit bien perdre à la lecture, et sourtout dans une traduction».DB, Cat., p. 274 (per probabile refuso, segnalata come data di prima rappresentazione il4/3/64): «bien intrigué & avec quelque succès».D’O II, p. 24: «il ne fut pas possible de méconnoître le cachet de M. Goldoni dans ArlequinValet de deux Maîtres».
300 Lettera a F. Albergati Capacelli del 18 aprile 1763: «è andata felicemente, per me, mai comici non l’hanno recitata a dovere, forse perché le scene erano troppo filate [in seguito siargomenta che «questi attori […] non imparano le scene studiate; non eseguiscono le scenelunghe, ben disegnate»]. La commedia è stata conosciuta, applaudita, ma i comici sono statirimproverati» (XIV 280).MF, mai 1763, p. 189: viene segnalata, senza alcun commento, la prima rappresentazione indata 11 aprile.DB, Cat., p. 259: «c’est une des plus faibles de M. Goldoni. Elle n’eut point de succès».D’O II, p. 16: «eut du moins en partage l’art de plaire. C’est une succession qui ne peut é-chapper aux enfans de l’Auteur (M. Goldoni)».
Per una mappa della produzione goldoniana 189
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
(CM1)153 La famille en de-
scorde Parigi,17/5/1763 420/5/63)[Venezia, aut.1763]301
canevas en un acte(DB)comédie italienne enun acte à canevas(AD)comédie en un acteà canevas (CM1)
154 L’eventail Parigi,27/5/1763302
canevas italien entrois actes (DB)comédie nouvelle entrois actes (MF)comédie italienne entrois actes à canevas(AD)comédie en troisactes, à canevas(CM1)
301 DB, Cat., p. 324: «sans succès».D’O II, p. 17: «petite Piece Italienne […] eut autant de Partisans que de Spectateurs»
302 Lettera a F. Albergati Capacelli del 18 aprile 1763: «ho fatto una commedia di moltescene, brevi, frizzanti, animate da una perpetua azione, da un movimento continuo, onde icomici non abbiano a far altro che eseguire più coll’azione che colle parole. Vi vorrà unaquantità grande di prove sul luogo dell’azione, vi vorrà pazienza e fatica, ma vuo’ vedere semi riesce di far colpo con questo metodo nuovo. Un ventaglio da donna principia la comme-dia, la termina, e ne forma tutto l’intrigo. La scena è stabile, e rappresenta una piazza di villacon varie case, e botteghe, e viali d’alberi. Al primo alzar della tenda, tutti i personaggi sivedono in scena, in situazioni, impieghi ed attitudini differenti. Tutti agiscono. Si vuota e siriempie la scena, e termina con tutti i personaggi in situazioni diverse. Vi ho messo dentro,per essere meglio inteso, quattro personaggi francesi. Ho letto la commedia all’assemblea de’comici, e tutti ne sono restati contenti. Credo che si darà in questo mese, e se sarà con calorerappresentata, mi lusingo che farà buon effetto» (XIV 280-281); allo stesso, 13 giugno 1763:«Si è data la mia commedia intitolata il Ventaglio, ma non ha fatto quell’incontro che io cre-deva. È troppo inviluppata per l’abilità di questi comici» (XIV 287).MF juin 1763, p. 196: «comédie nouvelle en trois Actes de M. Goldoni dans laquelle il y abeaucoup de choses amusantes, qui doivent faire espérer qu’elle sera suivie».DB, Cat., p. 323: «sans succès».D’O II, p. 17: «n’est pas son [de M. Goldoni] plus bel ouvrage; cependant il n’a pas laisséd’amuser»
190 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
(cfr. anche n° 183)155 Les deux frères ri-
vaux Parigi,3/6/1763 (1763: 18e 25/6; 11 e 23/7;25/10; 19/12. 1764:22/1; 19/2; 2/5; 8/7;1/9; 24/10. 1765: 3 e31/1; 16/8; 16/10;7/12. 1766: 8/2; 9/7;12/10. 1767: 17/1;15/6; 19/11. 1768:8/2; 15/10; 29/12.1769: 26/1; 17/7; 5e 30/9; 18/11. 1770:10/1; 3/8; 15/12.1771: 13/2; 11/12.1772: 9/1; 12/2; 2/5;12/8; 18/10. 1773:16/1; 30/9; 11/11.1774: 28/1; 5/3;28/4; 28/11. 1775:14/1; 1/7; 26/8;30/9; 5/10. 1776:9/3; 1/7. 1777: 16/6.1779: 1/2; 26/10)303
comédie italienne enun acte à canevas(AD)comédie en un acteà canevas (CM1)
156 Les deux Italiennescomposta tra il giu-gno e il luglio 1763;non rappresentata304
303 Lettera a F. Albergati Capacelli del 13 giugno 1763: «Sono stato risarcito [rispetto alcattivo esito de L’eventail] dai Due fratelli rivali, picciola commedia in un atto che è una cosada niente, ed ha fatto incontro grandissimo. Non ostante il suo incontro, non la credo buonaper Lei. È troppo comica, è troppo bassa, e questo è quel che piace a Parigi al Teatro Italiano.Io sono assai malcontento di questa sorta d’applausi, e tanto più mi determino a non prolun-gare a Parigi la mia dimora. Il gusto delle buone commedie in questo paese è finito. Fa pietà ilTeatro moderno francese: non si bada più alla condotta, ai caratteri, alla verità. Non badanoche alle scene, ai couplets, alle tirades, alle fautes de détail» (XIV 287).D’O II, pp. 17-18: «la plume [de M. Goldoni] est aussi élégante que féconde».
304 In una lettera ad A. Paradisi del 28 marzo 1763 Goldoni scriveva: «Per l’avvenire nedarò qualcun’altra di scritta, e fintanto che i commedianti l’imparano, empirò il voto con altre
Per una mappa della produzione goldoniana 191
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
comédie italienne endeux actes (AD)comédie en troisactes en prose(CM1)(cfr. anche n° 159)
157 L’esclave généreuseou La générosité deCamille [< Ladalmatina, n° 116]composta entrol’agosto 1763; nonrappresentata305
comédie italienne entrois actes (AD)comédie en troisactes en prose(CM1)
158 Les amoursd’Arlequin et deCamille Parigi,27/9/1763 (1763:30/9; 4, 7, 9, 11, 14e 18/10; 11, 15 e29/11; 2/12; 1764:10/1; 14/2; 30/10.
°DB VII1769 (5-16)
a soggetto» (XIV 278); quanto dichiarato in una lettera a F. Albergati Capacelli del 18 feb-braio 1764 può forse alludere a Les deux Italiennes, L’esclave généreuse ou la générosité deCamille, Les marchands (composte entro il 1763 e non rappresentate): «Dopo le tre notecommedie [trilogia di Arlecchino e Camilla], non si è dato altro del mio. Ne ho fatte tre[completamente fuori strada l’identificazione proposta da Ortolani, XIV 819, perché riferita atesti andati in scena senza problemi tra il maggio e l’agosto di quest’anno], ma non le hannorappresentate, perché i commedianti sono commedianti per tutto, cioè gente non santa. Alcu-ne dispute fra di loro, che non mi riguardano, sono de’ motivi che pregiudicano il loro inte-resse, e danno a me il dispiacere di non soddisfare il pubblico» (XIV 314). Che Les deux Ita-liennes fosse commedia scritta, è inequivocabilmente attestato da una lettera a F. AlbergatiCapacelli dell’11 luglio 1763: «Ne ho fatta una [commedia] per qui [Parigi], intitolata Lesdeux Italiennes, ma tutta scritta, avendo protestato a questi sig.ri di non voler più fare com-medie a soggetto, le quali non ponno fare onore all’autore, né profitto al teatro. Mi ho sagrifi-cato a farne sei o sette, per compiacenza, ma ci perderei del mio onorifico a seguitare. Vero èche staranno molto a impararle, ma almeno saranno commedie» (XIV 291); lo stesso dicasiper L’esclave généreuse, come inoppugnabilmente documentato da una successiva letteraall’Albergati del 15 agosto 1763: «Ho dato a questi comici un’altra commedia scritta, che hotratto dalla mia Dalmatina. Ma non hanno ancora imparato Les deux Italiennes. Non impara-no le commedie scritte, quelle a soggetto non le sanno fare» (XIV 295).
305 Cfr. supra, n. 304.
192 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
1766: 22/7; 1/8.1768: 15/4; 3/5.1769: 17/1 [Amoursd’Argentine]; 14/7[Amours d’Arlequinet d’Argentine];10/11 [id.]. 1770:14/8 [id.]. 1772: 5/5[id.]. 1773: 28/2[id.]. 1774: 19/4[id.]; 20/9 [id.]; 7/10[id.]; 13/12 [id.].1775: 12/9 [id.].1776: 5/11 [id.].1777: 11/7 [id.].1778: 11/9 [id.];22/12 [id.]. 1779:16/4 [id.])306
306 Lettera a F. Albergati Capacelli del 3 ottobre 1763: «ha avuto un incontro sì univer-sale e pieno, che ora posso dire che la mia reputazione è stabilita a Parigi. […] Ella sa che iFrancesi amano di piangere alle tragedie, e non sono persuasi del patetico nelle commedie. Aquesta mia hanno riso ed hanno pianto con egual piacere. Il comico li ha divertiti, e l’interesseli ha penetrati, e questo nuovo genere li ha incantati. Dicono che il loro Teatro franzese nonha una commedia moderna di questo valore» (XIV 297).MF octobre 1763, prem. vol., pp. 199-200: «Pièce nouvelle en Italien […] qui a eu le plusgrand succès, & qui ne pouvoit en avoir jamais autant qu’elle en merite. On ne sçauroit croi-re combien, dans un sujet si simple, il y a de beautés du vrai genre de la Comédie. Rien n’estsi riche d’incidens, & chacun sort naturellement, & prèsque nécessairement de celui qui leprécéde. Dans tout le Drame, le Pathétique de la nature & le Comique le plus plaisant, sonttellement assortis & mèlés ensemble, qu’ils ne sont jamais disparate & produisent chacun leureffet sans se destruire» (fa seguito l’elogio degli attori, Collalto [= Pantalone], Camilla, Car-relin [= Arlecchino], Ciavarelli [= Scapino]). Altre segnalazioni del successo delle rappre-sentazioni nei numeri di janvier 1764 pr. vol., p. 150 (14/1, Versailles: da cfr. con la testimo-nianza goldoniana consegnata nella lettera a Sciugliaga del 9/1/64, in cui fra l’altro si lamentala stroppiatura inflitta alla commedia dall’esigenza di allestimento breve) e février 1764, pp.169-170 (su una rappresentazione del 4/1).CL octobre 1763 (V, p. 399): «a beaucoup réussi. La conduit et l’intrigue en sont simples etcependant pleines d’imagination et de ressources. On ne peut lui reprocher que d’être troplongue. Il y a dans cette seule pièce de l’étoffe pour trois ou quatre comédies».DB VII, pp. 43-44 (giudizio complessivo sulla trilogia): «jamais intrigue ne fut mieux con-duite, le plus petit ressort concourt au mouvement général: la vérité, la nature & le sentimentse font sentir à chaque scène. On est toujours surpris agréablement de ce que le moyen le plussimple produit la situation la plus intéressante. Le génie se montre partout; mais sage & con-duit par la raison, nous ne craignons point de reproche en donnant à ces trois Drames uneplace à côté des meilleurs ouvrages de notre Théâtre. C’est le seul éloge que nous osons nouspermettre, car il faudrait être Moliere pour louer dignement M. Goldoni» (a p. 216 l’elogio
Per una mappa della produzione goldoniana 193
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
canevas italien entrois actescomédie italienne entrois actes à canevas(AD)comédie en troisactes à canevas(CM1)(cfr. anche n° 179)
159 Il matrimonio perconcorso [< Lesdeux Italiennes, n°156] aut. 1763commedia di tre attiin prosa
°STA3
1775*VII 1789 VE XXIV
1777 (<STA); S2
XIV 1778 (<STA); PU2
XIII 1787 (<S); BO XVI1789 (< Z);MA XIV1790 (< Z);GR VII 1795
160 La jalousied’Arlequin Parigi,15/11/1763 (1763:18, 22 e 25/11; 6 e9/12. 1764: 13/1;17/2; 2/11. 1766: 19e 22/8. 1768: 19/4.1769: 20/1; 4/8.1770: 17/8. 1772:8/5. 1773: 11/6.1774: 22/4. 1775:15/9. 1776: 8/11.1777: 15/7. 1778:15/9. 1779: 6/3)307
°DB VII1769 (17-26)
estasiato della Veronese si accompagna al ricordo delle sue interpretazioni del Fils… e dellatrilogia).D’O II, p. 20: «On vit encore ce que l’imagination de M. Goldoni peut verser de richesses surun sujet simple; combien les incidens peuvent être multipliés, avec quel art il est possible deles faire naître l’un de l’autre, comment il faut unir le pathétique au plaisant & le sérieux aucomique, sans qu’ils se détruisent & perdent de leur effet».
307 Lettera a G. Cornet del novembre 1763: «La Gelosia d’Arlecchino, continuazionedelle Avventure di Arlecchino e di Cammilla, ha raddoppiato il piacere al pubblico, ed a meha raddoppiato il contento. Questa secondogenita contrasta arditamente il merito che si è ac-quistato la sorella maggiore. Hanno tutte e due i loro parziali, ed io che sono il padre di tutte edue, godo di una disputa che mi fa onore, e non penso che a produrre la terza, ed a renderlameno indegna d’un’eguale fortuna. Martedì passato è andata in scena questa seconda.
194 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
canevas italien entrois actescomédie italienne entrois actes à canevas(AD)comédie en troisactes, à canevas(CM1)(cfr. anche n° 180)
161 Les inquiétudes deCamille Parigi,20/12 1763 (1763:21, 27 e 30/12.1764: 17/1; 21/2;6/11. 1766: 26/8.1769: 24/1 [Inquié-tudes d’Argentine];22/8 [id.]. 1770:21/8 [id.]. 1772:12/5 [id.]. 1775:19/9. 1776:12/11)308
°DB VII1769 (27-43)
L’incontro è stato pienissimo» (XIV 300); lettera a F. Albergati Capacelli del 10 dicembre1763: «Ella ha saputo da me l’esito degli Amori di Arlecchino e di Camilla. Eguale e forsemaggiore è stato quello della Gelosia d’Arlecchino, fatta in seguito della prima. S’Ella leggeil Mercurio di Francia sentirà gli elogi dell’una e dell’altra» (XIV 303).MF decembre 1763, pp. 180-182: «le Public, dont nous ne sommes que l’écho, nous forced’en [scil.: eloge] ajoûter encore pour celle des Jalousies d’Arlequin». Si celebra la «singula-rité» del prosieguo narrativo (sono menzionate anche Les inquiétudes…), che «blesse d’abordnos préjugés d’habitude», e si sottolinea la «fécondité du plus rare génie» (elogiati natural-mente anche gli attori, in particolare Camilla).CL e DB: cfr. le note rispettivamente al n° 161 e n° 158.D’O II, p. 21: «M. Goldoni a supposé avec raison qu’Arlequin amoureux de la vive Camille,pouvoit être jaloux, & il a peint ses inquiétudes d’une maniere intéressante dans la Comédiequi a pour titre: la Jalousie d’Arlequin».
308 Lettera a F. Albergati Capacelli del 10 dicembre 1763: «Martedì prossimo si deve da-re la terza […]. I commedianti la credono superiore alle due sorelle; se il pubblico è dellastessa opinione, il terno sarà per me favorevole» (XIV 303); lettera a F. Cornet del 27 dicem-bre 1763: «Sia ringraziato e benedetto il Cielo, ora sono contento. La terza commedia è an-data in scena oggi otto passato, ed ha fatto uno strepito sì grande e sì universale che non hotermini bastanti per ispiegarlo. Le altre due avevano fatto assai, e questa ha fatto tutto. Lealtre due avevano i suoi parziali, e questa ha tutti per lei. S’io Vi dicessi le cose che dicono diquesta commedia, con tutta l’amicizia che avete per me non potreste perdonarmi l’eccessodelle mie proprie lodi. […] Io ho sentito cose al Foyer del teatro, dopo la commedia, che mihanno fatto stordire» (XIV 305).MF janvier 1764, pp. 162-163: «Nous avons précédemment rendu compte du mérite & du
Per una mappa della produzione goldoniana 195
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
canevas italien entrois actescomédie italienne entrois actes à canevas(AD)
succès des deux premières suites: celle ci, loin de céder en rien aux autres, semble au contrai-re avoir généralement entraîné encore plus de suffrages. La pathétique en est si naturellementlié au comique, qui naît de la naïveté des deux Personnages intéressans, que le cœur est inces-samment partagé entre deux sentimens opposés; mais qui, par un art qu’on ne sçauroit tropadmirer, se réunissent pour le plaisir continuel du Spectateur. Plus on aime, plus on connoîtce grand art de la véritable & bonne Comédie, plus on admire les rapports réguliers des ca-ractères & de l’action, de cette dernière suite, avec les précédentes, plus aussi on regrette ceque font perdre les interruptions qu’occasionne dans chacune, le talent, fort agréable en soi,mais déplacé, de la meilleure Cantarice. Nous comptons donner une idée de ce Drame singu-lier, dans une courte Analyse, qui mettra du moins les Lecteurs en état de juger par eux-mêmes du génie de son célébre Auteur, & de la justesse de nos éloges. L’espace de cet Arti-cle ne nous permet pas d’y placer une partie de ceux que méritent les Acteurs, entre autres M.Carlin & Mlle. Camille. Cette dernière peut être regardée aujourd’hui comme la première &la plus grande Actrice de son genre»; nello stesso numero, a p. 13, figurano gli anonimi Versà Mlle Camille, che se ancora ripropongono l’entusiastico apprezzamento per Goldoni, in uncerto qual senso lo subordinano alla grandezza davvero creatrice dell’interprete («Quel nou-veau prestige m’entraîne? / O fécond Goldoni! que j’aime tes succès: / Ils enrichissent notrescène; / Et, grace à tes travaux, Thalie & Melpomène / Vont encor charmer les François. /Jouiis… mais tombe aux pieds de l’Actrice applaudie / Dont les talens animent tes efforts. /Comme Pigmalion, tu n’as formé qu’un corps: / Camille vient, elle y donne la vie»).CL janvier 1764 (V, p. 432): «ce poëte [Goldoni], aussi ingénieux que fécond, a imaginé dedonner deux suites à cette pièce [Amours d’Arlequin et de Camille], qui ont eu aussi le plusgrand succès. L’auteur a su, avec un art merveilleux, entralacer les affaires domestiques de lafamille de feu M. Pantalon avec les affaires de cœur d’ Arlequin et de Camille: car ce testa-ment du défunt produit dans le cours de la pièce une transaction entre la veuve et le fils dutestateur, à laquelle Arlequin et Camille accèdent. Cette pièce est un chef-d’œuvre de naturel,de vérité, d’imagination et de finesse; mais il faut la voir jouer, et il n’est pas possible d’endonner une idée par un extrait. Il y a quelques scènes si vraies et si pathétiques entre Arlequinet Camille qu’on ne peut s’empêcher de pleurer à chaudes larmes; il est vrai qu’elle a été par-faitement bien jouée. Si vous voulez savoir quels sont les meilleurs acteurs de Paris, je nenommerai ni Le Kain, ni Mlle Clairon, mais je vous enverrai voir Camille et l’acteur qui joueordinairement le rôle de Pantalon, et qui fait dans cette pièce-ci celui d’un avocat honnêtehomme; et vous direz: Voilà des acteurs. Vous admirez aussi la fécondité du poëte, lorsquevous aurez observé qu’il fait une pareille pièce en un mois ou six semaines de temps».DB: cfr. nota al n° 158.D’O II, pp. 21-22: «C’est ainsi [l’Inquiétude de Camille] qu’on nomme la second suite desAmours d’Arlequin & de Camille, qui d’abord n’en avoient semblé susceptibles d’aucune. Cequi n’eût été pour un Ecrivain médiocre que le sujet d’un canevas, est devenu entre les mainsde l’Auteur (M. Goldoni) la matiere de trois Comédies qui intéressent autant qu’elles amu-sent».
196 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
comédie en troisactes, à canevas(CM1)(cfr. anche n° 181)
162 Les marchandscomposta nel 1763;non rappresentata309
comédie italienne entrois actes (AD)
163 Camille aubergiste[< La locandiera, n°71] Parigi, 1/51764(1764: 4 e 8/5) [Ve-nezia, carn. 1764-65]310
309 Cfr. supra, n. 304.310 Lettera a F. Albergati Capacelli del 6 febbraio 1764: «Quanto prima si darà una mia
commedia, intitolata Camille aubergiste. Questa è tirata dalla mia Locandiera, ma in fatti èdivenuta tutt’altra cosa, sendo una commedia in due atti, e di quattro soli personaggi, cioèCamilla locandiera, Celio forestiere, Arlecchino servitore di Celio, e Scappino servitore dellalocanda. Il carattere della locandiera è quasi cambiato, poiché qui non soffrirebbero sulla sce-na una donna sì artifiziosa per il solo fine della vanità. Anche il carattere di Celio, che èquello del nemico delle donne, è moderato, figurandolo nemico del sesso, dopo essere statoingannato, onde si può credere in lui non spenti affatto i semi dell’amore. Camilla è amanted’Arlecchino, e questi la vorrebbe sposare, ma è attaccato al padrone per obbligo e per affet-to, e teme di disgustarlo. L’artificio della locandiera tende a guadagnare la stima di Celio, perindurlo a condescendere al matrimonio del servitore, ma Celio diventa amante, ed Arlecchinogeloso del suo padrone. L’intreccio è assai comico, ridicolo ed interessante, ed il fine onesto,inaspettato e piacevole. Oh che bella commedia! Incontrerà? De futuribus contingentibusetc.» (XIV 311-312).MF juin 1764: se ne segnala, senza commento, la rappresentazione.CL juin 1764 (VI, pp. 7-8): «Cette pièce est imprimée dans ses oeuvres sous le titre de la Lo-candiera; l’idée en est jolie. Une jeune aubergiste, d’un caractère et d’une figure très ai-mables, reçoit chez elle un étranger farouche et sauvage dont le système est surtout de fuirtoutes les femmes comme fausses et dangereuses. L’aubergiste entreprend de le rendre amou-reux, en se prêtant à ses préventions, et finit par lui tourner la tête, après quoi elle se moquede lui, et épouse son premier garçon d’auberge, dans la pièce imprimée ou dans la piècejouée, M. Arlequin, valet de cet étranger. Voilà, au reste, comme la chose se serait passéedans le fait; mais le fait de cette manière n’est pas intéressant pour le théâtre. Il faut, dans lesouvrages de l’art, outre la vérité de l’imitation, aussi le vernis de la poésie et de cette faussetéqui, d’une aventure commune et insipide, fait un événement intéressant et rare. Il fallait doncque la petite aubergiste, tout en voulant séduire par son manége cet ennemi du sexe, prît elle-même une violent passion pour lui: cela aurait jeté dans toute la pièce une vivacité et un inté-rêt qui n’y sont pas. Quoiqu’elle soit regardée comme une des meilleures pièces de Goldoni,elle n’a point eu de succès au théâtre de Paris».
Per una mappa della produzione goldoniana 197
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
commedia [a sog-getto] in due atti(XIV 311)canevas italien entrois actes (DB)comédie italienne endeux actes à canevas(AD)
164 La dupe vengée ouArlequin dupe ven-gée Parigi, 11/51764(1764: 5, 8 e 15/6;10/7; 14 e 25/9.1769: 5 e 12/12.1770: 5 e 8/6. 1771:14/5; 23/7; 14/11.1774: 14/1; 26/7;26/8. 1775: 24/3.1776: 16/2; 30/7;3/12. 1777: 17/10.1778: 17/2; 6/3;10/7; 4/8; 24/11.1779: 2/3; 23/6.1780: 24/2)311
°CAIL, II,173-174(riassun-to)°CL VI 8-9
DB, Cat., p. 290: «sans succès».D’O II, p. 26: «n’eut pas un seul instant l’espérance de faire fortune».
311 MF juin 1764, p. 193: segnalato senza commento l’allestimento della commedia, in-terrotto dopo la seconda rappresentazione per «une maladie grave de M. De Hesse, ancienActeur dont les talens multipliés & variès ont été si long temps & sont encore très-utiles à ceThéâtre en divers genres».CL juin 1764 (VI, pp. 8-9): «cet auteur inépuisable a pris tout de suite sa revanche [sull’esitoinfelice della Camille aubergiste], en donnant un canevas plein de gaieté et de finesse, intituléla Dupe Vengée. M. Arlequin, nouvellement marié et vivant d’un petit commerce, estd’humeur peu libérale. Un jour, il envoie sa femme dîner chez sa mère, disant qu’il est enga-gé lui, à dîner chez son perruquier. Ses amis, qui lui avaient demandé à dîner ce jour-là, etqu’il avait refusés, trouvent le secret de se faire régaler chez lui en son absence et à ses dé-pens. De retour au logis avec sa femme, il voit arriver le traiteur et le limonadier, qui veulentêtre payés. Il ne conçoit rien à leurs prétentions et, pour comble de malheur, sa femmes’imagine qu’il ne l’a envoyée dîner dehors que pour faire chez lui une partie fine avec quel-que rivale inconnue. Tous cela produit un embrouillement très-comique. Arlequin, après avoiréclairci le fait, non sans beaucoup de peine, trouve le secret, non seulement de faire payer àses amis le diner qu’ils ont fait chez lui à son insu, mais aussi de leur donner à souper à leurdépens. Toute l’intrigue roule sur le changement d’une clef qu’on escamote dès le premieracte, et qui sert a la duperie et à la revanche. Cet auteur a une grande fécondité et un art sur-prenant à tirer parti des incidents qu’il imagine, et qui sont d’un naturel qui charme. C’estdommage que, dans ses pièces imprimées, les discours, pour être trop vrais, soient presque
198 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
canevas italien entrois actes (DB)comédie italienne entrois actes à canevas(AD)comédie en troisactes à canevas(CM1)(cfr. anche ni 165 e184)
165 La burla retrocessanel contraccambio[<La dupe vengée,n° 164; cfr. anche n°184] Zola, est. 1764commedia di cinqueatti in prosa
VIII1789312
BO XVIII1790; MAXIV 1790;STA4 1791;GR VIII1795
166 Gli eredi ab inte-stato Zola, est. 1764commedia in un attosolo (XIV 316)313
°Livorno-Bibliote-ca Labro-nica, «F.
toujours plats. Ce défaut ne se fait pas sentir dans ses canevas, où les discours sont abandon-nés à la vivacité et au génie des acteurs qui improvisent; aussi ses pièces font-elles un grandplaisir au théâtre. Il aurait bien mieux fait pour sa réputation de n’en faire imprimer que lescanevas; on y aurait mieux remarqué les ressources de génie infinies dont elles sont rem-plies».DB Cat., p. 312: «avec peu de succès».D’O II, p. 26: «le succès d’ Arlequin, dupe vengée dut consoler l’Auteur (M. Goldoni) decette disgrace [la caduta della Camille aubergiste, cfr. supra, n. 310]».
312 Merita segnalare la spietata recensione che Elisabetta Caminer riservò a questo ineditodel t. VIII Zatta: la commedia viene definita uno «strano garbuglio, simile a quello da noi ac-cennato nel mese scorso approposito delle Donne di buon umore […] potrebbe dirsi una stor-piatura di Chi la fa l’aspetta […] tutta la differenza consiste nel linguaggio Toscano, nellacondotta meno felice, nei caratteri meno piacevoli. Forse Goldoni mascherò a questa guisaalcune delle sue Commedie Veneziane per poterle esporre sul Teatro della Commedia Italianaa Parigi; ma oltreché così trasformate perdono moltissimo, e necessariamente, del loro meritonaturale, si rende inutile in una edizione Italiana una cattiva copia, dopo che nella medesimasi è letto il buono o il mediocre originale. L’editore non ne ha però colpa: egli si è fatto leggedi rispettare tutto ciò che l’Autore gli ha spedito per comporre i suoi volumi; e ’l buon Gol-doni ha senza dubbio creduto di non dover defraudare il Pubblico della più picciola cosauscitagli dalla penna, come non lo ha defraudato della più minuta circostanza della sua vitane’ tre volumi delle sue ingenue e peravventura prolisse Memorie» («Nuovo Giornale Enci-clopedico d’Italia», Luglio MDCCXC, Anno Terzo, Venezia, Giacomo Storti, pp. 18-30).
313 Ancora discussa la paternità goldoniana di questo “scenario”, a suo tempo sostenutada N. VACCALLUZZO, Uno scenario inedito del Goldoni, in Saggi e documenti di letteratura
Per una mappa della produzione goldoniana 199
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
D. Guer-razzi»,Autogra-fotecaBastogi,ins. 1186
167 Le portraitd’Arlequin Parigi,17/8/1764 (1764: 21e 28/8; 5, 11 e 18/9;15/11. 1769: 15/12.1770: 12 e 15/6;31/7. 1771: 26/7.1774: 5 e 16/8.1775: 3/3; 7/11.1776: 13/2; 16 e26/7. 1777: 21/10.1778: 17/3; 16/6;18/8; 15/12. 1779:26/1;11/5; 29/5;10/8)314
°CAIL, II,200-203(riassun-to)
e storia, Crescenzio Galàtola, Catania, 1924, pp. 327-342. Se non questa, ci fu comunque unacommedia, oltre a quelle note e identificate, che Goldoni inviò ad Albergati nel periodo inquestione.
314 Lettera a F. Albergati Capacelli del 24 settembre 1764: «Le cose mie a Parigi conti-nuano a andar bene. Tre commedie ho dato ultimamente: Le Portrait d’Arlequin, Le Rendez-vous nocturne, e L’inimitié d’Arlequin et Scappin. Tutte tre hanno incontrato assaissimo, etutte tre si daranno a Fontainebleau, dove io pure anderò ai primi del mese venturo» (XIV324).MF septembre 1764, p. 203: «L’intrigue de cette Piéce roule sur un Portrait d’Arlequin & unautre de Célio avec lequel Camille, amoureuse d’Arlequin, trompe la jalousie de Scapin. Tousles événemens, tous les imbroglio qu’occasionnent ces deux portraits qui passent alternative-ment dans les mains de tous les personnages, & qui y passent par des incidens si naturelsqu’ils paroissent en quelque sortes nécessaires, attachent, amusent, & même intéressent tantle Spectateur, qu’il n’y a ni vuide, ni langueur dans la conduite de cette Piéce. Toutes lesscènes sont autant de nouveaux sujets d’admirer l’immense fécondité du génie de l’Auteur.Mlle Camille & M. Carlin ont donné de nouvelles preuves, s’il en restoit encore à donner, deplus haut dégré où puisse atteindre dans leur genre, la fidelle & la plus aimable imitation de laNature».CL septembre 1764 (VI, p. 65): «Ce portrait passe de mains en mains, et cause une confusiondont il résulte des quiproquo sans fin. Les Italiens, et M. Goldoni en particulier, entendentsupérieurement ce qu’ils appellent l’imbroglio; leurs pièces sont des chefs-d’oeuvre en cegenre, pour lequel il faut beaucoup d’esprit, de finesse et d’invention. Ce n’est pas là la bonnecomédie; elle n’a ni caractères ni moeurs; mais lorsqu’on a donné toute la journée aux occu-pations et aux affaires, elle est bien propre à amuser et à délasser le soir».DB Cat., pp. 404-405: «bien intrigué & rempli de scènes excellentes».
200 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
canevas en troisactescomédie italienne endeux actes (MF)canevas italien entrois actes (DB)comédie italienne endeux actes à canevas(AD)comédie en deuxactes à canevas(CM1)(cfr. anche n° 182)
168 Le rendez-vousnocturne [< I Centoe quattro accidentiin una notte o Lanotte critica, n° 13]Parigi, 7/91764(1764: 11, 14, 17 e25/9; 17/10. 1765: 6e 7/2. 1768: 26/7;20/8; 20 e 29/10;31/12. 1769: 18/1;10/3; 9/5; 21/6;12/8; 25/11; 10 e27/12. 1770: 15/3;31/5; 29/9. 1771:3/1; 19/6; 2/10.1772: 8, 19 e 21/1;19/8; 5/10; 12 e26/11. 1773: 19/5;11/8; 2/9; 18/12.1774: 4/3 [Versail-les]; 10/12. 1775:28/12. 1776: 27/4;13/11. 1777: 20/1.1778: 6/8. 1779:26/4)315
D’O II, p. 27: «on est convenu que la Comédie de M. Goldoni, intitulée: le Portraitd’Arlequin, est parfaitement intriguée, & qu’elle renferme d’excellentes Scenes. Les portraitsd’Arlequin & de Célio y occasionnent des imbroilles très amusans».
315 MF octobre 1764, pr. vol., pp. 179-180 (indicato il 6 settembre come data di primarappresentazione): «Cet Auteur célébre [M. Goldoni] s’est permis dans cette Nouveauté delivrer son génie à la plaisanterie ou si l’on veut à la bouffonnerie de la farce. On y retrouve lafécondité d’idées dans le jeu comique qu’il prête à ses Acteurs; mais les Amateurs d’un goût
Per una mappa della produzione goldoniana 201
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
comédie italienne endeux actes (MF)comédie italienne enun acte (AD)comédie en un acteà canevas (CM1)
169 L’inimitiéd’Arlequin et deScapin Parigi,18/91764 (1764:21, 24 e 27/9; 3 e31/10; 19/11; 20 e26. 1765: 21/1; 7/3;30/5; 20/7; 26/10;11/12. 1766: 31/1;22/5; 27/9; 24/11;13/12. 1767: 7/2;6/6. 1768: 4/2; 21/4;25/8; 21/12. 1769:23/1; 11/3 9/4;15/5;26/7; 30/8; 29/11;31/12. 1770: 17/2;3/3; 3/5; 2/6; 10/9;24/10. 1771: 5 e28/1; 18/5; 24/6;10/10; 21/12. 1772:4/2; 2/3; 20/6; 18/7;5 e 20/9; 3/10;21/11; 7/12. 1773:12 e 13/2; 27/5;2/10. 1774: 12/1;21/2; 16/3; 18/3[Versailles]; 23/7;13/10; 26/11. 1775:21/1; 4/2; 22/3; 2 e16/8. 1776: 13/1;28/2; 13/5; 26/8.1777: 2/6; 4, 7 e13/11. 1778: 25/2;
délicat, en reconoissant que les circonstances l’ont forcé peut-être de descendre à ce genre,par complaisance, regrettent l’espéce d’abus que les Auteurs sont quelquefois obligés de fairede plus grands talens».D’O II, p. 27: «On a pensé, le 6 Septembre, que les Rendez-vous nocturnes [il titolo al pluraredocumentato anche in CL e SP] étoient aux autres Comédies de l’Auteur (M. Goldoni) ce queles Fourberies de Scapin sont au Tartuffe».Per la valutazione dell’autore e di CL, cfr. rispettivamente nn. 314 e 316.
202 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
12/3; 13/6; 12 e14/12. 1779: 21/1;29/10; 17/11)316
canevas italien endeux actes (DB/AD)comédie en deuxactes à canevas(CM1)
170 Les métamorphosesd’Arlequin Fontai-nebleau,29/10/1764?317
sujet italien en troisactes, orné de ma-chines, de change-ments et de deuxballets
°Paris,Bibl.Nationa-le, Fondfrançais,ms. 9254
171 Arlequin complai-sant Parigi,
316 MF octobre 1764, pr. vol., pp. 180-181: «a été donnée pour la premiere fois le 18 dumême mois [septembre], & a continué d’être représentée avec beaucoup de succès. Dans cettedernière Piéce, M. Goldoni a trouvé l’art de tourner en incidens très-fertiles ce qui ne paroî-troit devoir produire que des lazzi. Scapin & Arlequin s’étant battus dans la nuit croyentchacun avoir tué son énnemi. Cette idée comique devient, par le génie de l’Auteur, un moyenqui se multiplie pour remplir le plus agréablement les deux Actes de son Drame. Au milieudu comique très-gai qui résulte du Sujet, M. Goldoni, entraîné par son goût vers le genre no-ble & élevé, a placé très-naturellement le pathétique que rend si supérieurement & avec tantde vérité Mlle Camille, inimitable dans son genre».CL octobre 1764 (VI, pp. 90-91): «La troupe italienne de ce théâtre [de la Comédie-Italienne]a donné les Rendez-vous nocturnes et l’Inimitié d’Arlequin et de Scapin, deux petites farcesoù l’on reconnaît les ressources de l’ingénieux et inépuisable Goldoni. La dernière est surtouttrès plaisante».DB Cat., p. 354: «Scapin e Arlequin ne pouvant se souffrir, se querellent sans cesse & se fontchasser de chez Pantalon. Ils se rencontrent de nuit, se battent & croyent chacun de leur côtéavoir tué leur ennemi; cette idée comique produit une foule d’incidens très-plaisans & très-naturellement enchaînés l’un à l’autre. M. Goldoni est l’Auteur de cette Piece, qui fit beau-coup de plaisir».D’O II, p. 28: «Arlequin & Scapin congédiés de chez Pantalon, pour s’être querellés vive-ment, se rencontrent sur le minuit, se battent, & chacun s’imagine avoir tué son ennemi. Telest le fonds d’une Piece Italienne de M. Goldoni, qui fut très applaudie, & dans laquelle uneidée comique produit quantité d’incidens très plaisans et très gais».Per la valutazione dell’autore, cfr. supra, n. 314.
317 Per la problematicità dell’attribuzione goldoniana, e per l’impossibilità di identificareil «sujet» conservato in BNP con l’opera ripetutamente replicata al Théâtre Italien, cfr.quanto segnalato supra, pp. 122-125.
Per una mappa della produzione goldoniana 203
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
20/11/1764comédie italienne enun acte (AD)
172 L’amitié d’Arlequinet de Scapin Parigi,29/11/1764(6/12/64)comédie italienne endeux actes (AD)
173 Les vingt deux in-fortunes d’ArlequinParigi 1763 o1764?318 [<Letrentadue disgraziedi Arlecchino, n°12]pièce italienne entrois actes
° Paris,Bibl.Nationa-le, Fondfrançais,ms. 9254
174 Arlequin philosopheParigi, 1763 o 1764comédie italienneen un acte à canevas(AD: 1763; SP:1764)
175 Le bon et le mauvaisgénie [< Arlecchinoconfuso tra il bene eil male, n° 26]composta nel 1764;non rappresentata319
comédie italienne encinq actes à specta-cle (SP-AD)comédie à spectacleen cinq actes enprose (CM1)(cfr. anche n° 190)
176 Les ruses innocentes
318 Anche in questo caso, cfr. quanto argomentato ibidem.319 Mémoires III, 11: «Dans le courant des deux années de mon engagement avec les
Comédiens Italiens, j’avois présenté à leur assemblée une Piece à spectacle qui avoit pourtitre Le bon et le mauvais Génie. On ne trouva rien à redire sur ce sujet qui étoit à la fois mo-ral, critique et divertissant; mais on se récria contre les décorations qui étoient nécessaires, etqui auroient coûté cent écus en Italie, et mille écus peut-être à Paris. L’Opéra-Comique cro-yoit la dépense inutile pour les Italiens, et ceux-ci qui partageoient avec les autres, n’etoientpas fâchés de l’épargne» (I 488).
204 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
de Camillecomposta nel 1764;non rappresentatacomédie italienne enun acte (AD)
177 Le gondolier amid’Arlequincomposta nel 1764;non rappresentatacomédie italienne(AD)
178 Scapin jalouxcomposta nel 1764;non rappresentatacomédie italienne enun acte (AD)
179 Gli amori di Zelindae Lindoro [< Lesamours d’Arlequinet de Camille, n°158] aut. 1764commedia di tre attiin prosa
°PU2 XV1787Gli amoridi Zelindae Lindo-ro, o sia-no Gliamantifedeli
*I 1788 MA IV1788; BO XI1789; STA4
1791; GR I1793 [1794]
180 La gelosia di Lindo-ro [< La jalousied’Arlequin, n° 160]carn. 1764-65commedia di tre attiin prosa
°PU2 XV1787La gelo-sia diLindoro eZelinda
*III 1789 MA IX1789; BO XI1789; GR II1794
181 Le inquietudini diZelinda [< Les in-quiétudes de Ca-mille, n° 161] carn.1764-65commedia di tre attiin prosa
°PU2 XV1787L’inquie-tudini diZelinda eLindoro
*II 178817892
MA IX1789; BO XI1789; STA4
1791; GR II1794
182 Gli amanti timidi osia L’imbroglio de’due ritratti [< Leportrait d’Arlequin,
*XVII1780 [VIII677]
XXXIV1793 (<(*°)STA)320
BO XX1790; MAXXIX 1793;STA4 1790
320 Esempi di varianti congiuntive: PS Mentre il mio Padrone dipingeva il vostro [scil.: ilritratto del vostro padrone] ] STA Z Mentre il mio Padrone dipingeva quello del vostro(I.4.25); PS L’ha fatto el mio Ritratto […] e adesso el pretende, che ghe lo paga] STA ZL’ha fatto el mio Ritratto […] e adesso el pretende, che lo paga (I.5.2); PS (È bello […] Po-
Per una mappa della produzione goldoniana 205
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
n° 167] carn. 1764-65commedia di tre attiin prosa (PS)
183 Il ventaglio[< L’eventail, n°154] carn. 1764-65commedia di tre attiin prosa
IV 1789 BO XIV1789; MAIX 1789;STA4 1791;GR IV 1794
184 Chi la fa l’aspetta osia I chiassetti delcarneval [< Laburla retrocessa nelcontraccambio, n°165 < La dupe ven-gée, n° 164] carn.1764-65commedia venezia-na di tre atti in prosa
Chi la fal’aspetta osia Laburlavendicatanel con-traccam-bio fra ichiassettidel car-nevalV 1789
BO XIV1789; MAXXXI 1793;STA4 1791;GR V 1794[1795]
185 Arlequin et Camilleesclaves en Barba-rie Parigi, 13/1/1765(1765: 15/1)321
comédie italienne entrois actes (CL)comédie italienne entrois actes avec desdivertissemens (MF-AD)canevas italien en
vera me! Carlotto!)] STA È bello […] Povera me! Carlotto!)] Z È bello […] (Povera me!Carlotto!) (I.9.2); PS A me si fanno di questi torti? A me, che vi amo tanto, e che ho inten-zion di sposarvi? E che posso fare la vostra fortuna?] STA Z A me si fanno di questi torti? Ame, che vi posso fare la vostra fortuna? (I.9.31).
321 MF février 1765, p. 195: segnalata, senza commento, la rappresentazione di questa«Comédie nouvelle».CL janvier 1765 (VI, p. 185): «On a donné sur le même théâtre [de la Comédie-Italienne]Arlequin et Camille, esclaves en Barbarie […]. On dit que c’est la dernière que ce célèbreauteur fera pour Paris, et que nous allons le perdre. Cela fâchera quelques personnes qui ai-ment la langue et la littérature italiennes, et qui se plaisent à voir les pièces de Goldoni; maisce goût n’est pas assez général à Paris pour qu’on s’aperçoive de la perte que l’on va faire».DB Cat., p. 253: «sans succès».D’O II, p. 30: «Arlequin & Camille Esclaves en Barbarie prouverent que l’imagination del’Auteur (M. Goldoni) est d’une fécondité inépuisable».
206 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
trois actes (DB)comédie en troisactes, à canevas,avec un divertisse-ment (CM1)
186 Arlequin jouer Pari-gi, 25/1/1765322
pièce en deux actes(CL)
187 La guerre des ber-gamasquescomposta presumi-bilmente entro il1765; non rappre-sentatacomédie à spectacle,en cinq actes, enprose (CM2)
188 Telle maîtresse, tellesuivantecomposta presumi-bilmente entro il1765; non rappre-sentatacomédie en cinqactes, en prose(CM2)
189 Les noeuds couleurde rosecomposta presumi-bilmente entro il1765; non rappre-sentatacomédie en un acte,en prose (CM2)
190 Il genio buono e ilgenio cattivo [< Lebon et le mauvaisgénie, n° 175 < Ar-
*XXXIV1793 [I489-490]323
STA4 s.d.
322 CL février 1765 (VI, p. 209): «On vient de donner sur le théâtre de la Comédie-Italienne Arlequin jouer […], qui n’a point réussi et qui n’était pas bonne. Ce célèbre poètes’en retournera en Italie dans trois mois».
323 Nel passo dei Mémoires (III, 11) che resoconta del plot drammaturgico originario, siosserva una diversa configurazione dell’atto IV (ambientato a Venezia e non a Tripoli). Forsenella nuova redazione per la stampa (che Ortolani ipotizza dovuta a ragioni di censura: cfr.
Per una mappa della produzione goldoniana 207
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
lecchino confuso trail bene e il male, n°26] febb. 1767[comp. Medebach]commedia di cinqueatti in prosa
191 Il cavaliere di spi-rito, o sia La donnadi testa debole (< n°107) comp. 1764-1765?324
commedia […] tra-sportata dal versomartelliano alla pro-sa
°Venezia,Bibliote-ca Queri-ni Stam-palia,Cod.misc.quer. VI.76, fasc.9
192 Arlequin charbon- °MF juin
VIII 1351) Goldoni ebbe a utilizzare anche uno scenario del ’65, Arlequin et Camille esclavesen Barbarie (n° 185).
324 La datazione indicata a testo è quella definita dal curatore dell’edizione critica dellacommedia (EN 1998, cit., pp. 22-28 e 568), in base alla considerazione che la realizzazione diquesta riduzione in prosa non possa essere ascritta ad un periodo antecedente alla pubblica-zione (1763-64) di PT X (nella dedica di questo volume ad Albergati è infatti richiamato ilprogetto di trasposizione in prosa di tutte le commedie in versi, in via di realizzazione pressol’ormai coeva edizione Pasquali) e non dopo la prefazione del Padre per amore (PS IX,1766; ma il materiale per la composizione del volume era stato inviato all’editore prima delsettembre 1765), in cui si delineerebbe l’acquisizione goldoniana della categoria dell’hautcomique, che legittima l’uso del verso per un determinato genere commediografico (e dunquepoco congrua sarebbe, dopo questa data, la riduzione in prosa proprio del Cavaliere di spiri-to). In realtà, nulla esclude che le riduzioni in prosa delle commedie originariamente in versifossero state portate a termine già ben prima della dedica ad Albergati (che fa riferimentosolo alla realizzazione editoriale di quelle nuove versioni); al riguardo è senz’altro utile se-gnalare che un profondo conoscitore di cose goldoniane come Domenico Caminer, giànell’aprile 1762, parlando dell’edizione Pasquali (avviata da pochi mesi) e dei «cambiamentimolto notabili alle sue Commedie» che l’autore vi aveva introdotto, poteva fra l’altro esem-plificare adducendo il caso di «quasi tutte quelle che erano in versi martelliani [che] le ha ri-dotte in prosa, ciò che gli costò non poca fatica» («Nuova veneta gazzetta», n° 10 mercoledìaddì 14 aprile 1762). È inoltre abbastanza difficile immaginare che nel 1764 un Goldoni va-riamente assorbito dagli impegni parigini pensi proprio alla riduzione in prosa di questacommedia; d’altra parte, se – come Mattioda stesso sottolinea (p. 27) – già nel marzo del ’63Goldoni mostra di conoscere e apprezzare la Poétique française di Marmontel (da cui avreb-be acquisito quella categoria dell’haut comique di cui si diceva), perché mai avrebbe dovutoin data successiva (appunto, il ’64) procedere alla trasposizione in prosa proprio di una com-media che, stanti quelle nuove coordinate estetiche di riferimento, avrebbe dovuto esigere lasola redazione in versi?
208 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
nier (< La congiurade’ carbonari, n°24), Parigi 5/5/1769(1769: 12, 16, 19,24 e 28/5; 7, 20 e23/6; 29/7; 23/8;9/9; 11 e 25/10;24/11. 1770: 22/1;26/4; 2/6; 2/8; 2/9.1771: 6/1; 25/2;26/4; 21/5; 4/7;23/11; 18/12. 1772:23/2; 3/6; 11/12.1773: 28/2; 1/8; 5/9;7/11. 1774: 17/3;5/12. 1775: 13/1;19/10; 23/11. 1776:13/8; 3/9. 1777:25/7; 1/8; 14/10.1778: 28/4; 30/7;1/12. 1779: 19/1;6/2; 11/10)325
comédie Italienneen un acte (AD)comédie en un act àcanevas (CM1)
1769 183-189(estratto)
325 MF juin 1769, pp. 183-189 (indicato il 4 maggio come data di prima rappresentazio-ne): «L’idée la plus avantageuse qu’on en pourroit donner [de cette petite piéce] seroit depeindre, s’il étoit possible, le jeu naïf & naturel de M. Carlin [Bertinazzi]; sa gaïté si vraie, sibien ajustée au caractere qu’il représente, & ses mouvemens, toujours si pleins de grace & dejustesse; mais nous nous contenterons du court extrait qui pourra donner aux amateurs de cegenre le desir de voir cette jolie bagatelle. [...] Cette petite piéce, jouée avec beaucoupd’esprit & de feu, a déjà été donnée plusieurs fois, & se voit toujours avec un nouveau plai-sir».D’O II, p. 59: «On représenta le surlendemain [de le 2 Mai] avec beaucoup de feu,d’intelligence & de succès, Arlequin Charbonnier».Per le ragioni che nonostante varie circostanze oppositive hanno indotto a introdurre nel no-vero della produzione goldoniana propriamente detta questo che in realtà dovette essere unadattamento di esclusiva paternità del Bertinazzi, cfr. supra, pp. 121-122.
Per una mappa della produzione goldoniana 209
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
193 La bague magiqueParigi, 20/7/1770(1770: 24, 27 e31/7; 3/8. 1771:26/4; 10/5; 30/8.1772: 22/7. 1776:27/8; 3/9. 1778:17/2; 10/3; 28/8; 17/10)326
comédie italienne en
°Paris,Bibl.Nationa-le, Fondfrançais,ms.9254327
326 MF aoust 1770, pp. 171-173: «Le 20 Juillet les Comédiens Italiens ont donné la pre-mière représentation de la Bague Enchantée, canevas Italien en trois actes de M. Goldoni.Arlequin veut se précipiter dans la rivière par la douleur que lui cause l’infidélité de sa fem-me, dont il n’a cependant d’autre preuve, qu’une lettre sans signature & sans adresse: un ma-gicien veut le détourner de ce funeste dessein; mais Arlequin qui ne peut vivre sans mourir,persiste dans son projet; le magicien lui offre la ressource d’une bague dont le pouvoir est defaire oublier tout ce qui s’est passé. Arlequin accepte ce présent précieux dans la situation oùil se trouve; il en éprouve l’effet sur le champ; il méconnoît son bienfaiteur; il oublie ses det-tes. Jusque-là, la bague ne produit que des choses très-ordinaires; mais ce qui prouve davan-tage son pouvoir, c’est qu’Arlequin ne se souvient pas davantage de ce qui lui est dû: safemme qui se présente devant lui, paroît un nouvel objet à ses yeux; il en devient amoureux;mais comme on lui a dit que les femmes qui vont audevant des hommes pour leur prodiguerdes cajoleries, sont des femmes dangereuses, il se méfie de la sienne, qui le comble de cares-ses par la joie qu’elle a de son retour; la conduite qu’il tient avec elle la confirme, & surprendtous les spectateurs; mais Pantalon plus sage que les autres, prétend que la douleur lui a tour-né la tête; il se prête à sa manie, approuve son inclination, & la remarie avec sa femme. Arle-quin pour faire un cadeau de nôces à sa prétendue, veut lui donner sa bague, comme le seuljoyau qu’il possède; mais il ne l’a pas plutôt tirée de son doigt, qu’il reconnoît sa femme, &que le désespoir se rempare de son ame: cependant on parvient à lui prouver l’innocence deson épouse, & la pièce finit par leur reconciliation. Si M. Goldoni avoit eu plus de connois-sance de notre théâtre, il se seroit apperçu que son sujet rentre trop dans celui d’Arlequin Co-cu imaginaire, que son oubli de nos usages les plus familiers ressemble à l’ignoranced’Arlequin Sauvage; que sa nouvelle inclination pour sa femme, lorsqu’il ne la reconnoîtpoint, & son désespoir lorsqu’il la reconnoit, reviennent au Strabon de Démocrite; enfin, iln’auroit point traité un sujet qui ne lui a fourni qu’une pièce peu digne de sa plume, mais quine prouve rien contre les talens & la réputation justement méritée de ce célèbre auteur: quel-ques scènes cependant ont fait plaisir par la vivacité d’Argentine & par le jeu toujours naturel& vrai du sieur Carlin: cet acteur si justement aimé du public, vient d’obtenir une récompensebien flatteuse de ses talens, dans la médaille d’or qu’il a reçue des mains de notre augusteDauphine, qui ne cesse d’encourager les arts, de combler de ses bontés tous ceux quil’approchent; enfin, de se faire adorer de tous les cœurs».D’O II, p. 68: «Le sujet de la Bague magique, de M. Goldoni, ne fut pas jugé digne de sa plu-me, & l’intrigue a de grands rapports avec Arlequin Sauvage & Arelquin cocu imaginaire».
327 Scarsamente verosimile l’ipotesi di autografia formulata dal Soleinne per questo ma-noscritto, come già evidenziato da P. Toldo, Tre scenari francesi..., cit., p. 378.
210 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
trois actes (ancheAD)canevas italien entrois actes (MF)comédie en deuxactes à canevas(CM1)
194 Les cinq âgesd’Arlequin Parigi,27/9/1771 (1771: 1,4 e 8/10; 16/11.1772: 20/3. 1773:11/5)328
Canevas […] enquatre actes (CL)comédie italienne encinq actes (MF-AD)pièce à spectacle, encinq actes, à cane-vas (CM1)
195 Le bourru bienfai-sant Parigi, nov.1771
Parigi,Paris, Bi-bl. de la
Bruxelles,chez J. Van-den Berghen,
328 MF octobre 1771, pp. 174-175: «Cette pièce offre le tableau assez naturel de la viehumaine dans les différentes passions & sentimens qui affectent Arlequin enfant, adolescent,homme, vieillard & décrépit. Il paroît sous ces différens états dans le cours de cette pièce. Lemoyen de lui faire parcourir si rapidement sa carrière est le don qu’un Magicien donne à Ar-gentine de rendre plus vieux de 20 ans celui qu’elle embrasse, &, par jalousie contre la fem-me d’Arlequin, que ne veut pas lui confier son fils; elle l’embrasse, & d’enfant il est adole-scent; elle se marie avec lui, & autant d’embrassemens qu’elle lui fait le conduisent àl’extrême vieillesse; enfin le Magicien lui rend la jeunesse. C’est la fable de Titon avecl’aurore, mise heureusement en action. Le jeu de M. Carlin rend le rôle d’Arlequin trèsagréable & très-divertissant. Il a été bien secondé par Argentine & par Pantalon».CL novembre 1771 (IX, pp. 381-382): «Rien n’est comparable à la facilité de M. Goldonipour combiner le canevas d’une pièce de théâtre; il vient d’en donner un au Théâtre Italien,intitulé le Cinq Ages d’Arlequin, en quatre actes, qui a été joué pour la première fois le 27septembre, et qui a eu tout le succès qu’il mérite auprès des amateurs de ce genre de specta-cle. L’idée de ce canevas est tirée de la fable de Titon et de l’Aurore; mais il y a dans toutcela un mélange de folie et de pathétique qui en rend la représentation très-intéressante. Tousle points et le mots de ralliement indiqués par l’auteur sont originaux et d’une morale profon-de, et quelques bouts de scènes écrites font regretter que M. Goldoni, sans renoncer à ce gen-re, ne se soit pas livré de préférence à travailler pour le Théâtre-Français. On nous fait cepen-dant espérer d’y voir incessamment représenter une pièce de lui, intitulée le Bourru bienfai-sant. Elle est attendue avec impatience».D’O II, p. 74: «Le 27, les cinq Ages d’Arlequin, canevas italien de M. Goldoni, rappellerent lesouvenir de la jolie Fable de Titon & l’Aurore, ou le Rajeunissement inutile».
Per una mappa della produzione goldoniana 211
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
comédie en troisactes en prose (cfr.anche n° 196)
ComédieFrançaise,ms. 276
Paris,Veuve Du-chesne,1771329
(17722;17863; a.VII[1797]4)
1772; Vien-na, Ghelen,1772; Napo-li, J. Gravier,1773; Livor-no, Masi,1774 [Col-lection deTragédies,Comédies etdrames choi-sis des pluscélebres au-teurs moder-nes, t. VII];Paris, Ruault,1778; Paris,Vente, 1778;Londres, T.Hookham,1785; Paris,Delalain,1789
196 Il burbero di buoncuore (< Le bourrubienfaisant, n° 195)commedia di tre attiin prosa
Paris, Du-chesne,1789;°[trad. E.Caminer;rapp. S.Angelo,carn.1772] Ilcollericodi buoncuore,Venezia,Colomba-ni, 1772(Venezia,Savioni,
Il burberobeneficoVIII 1789(<°Can-doni)
G2 I 1774(<°Candoni);VE XXIV1777(<°Caminer);PU1 XIII1787(<°Candoni);BO X 1789(<°Candoni);MA VII1789(<°Candoni);GR VIII1795(<°Candoni);
329 Esce simultaneamente, sempre per conto della Duchesne ma con i tipi «de L’Impri-merie de la Veuve Simon et Fils» (e non con i propri), una pubblicazione elegante inserita nelRecueil des fêtes et spectacles données devant Sa Majesté, à Versailles, à Choisy et à Fontai-nebleau pendant l’année 1771, Ballard, 1771 (cfr. P. LUCIANI, «Le Bourru bienfaisant» e«L’Avare fastueux...», cit., pp. 214-215).
212 ANNA SCANNAPIECO
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
17742);°[trad. P.Candoni]Il burberobeneficoo sia ilbisbeticodi buoncuore S1
XIII 1772e Vene-zia, An-gelo Ge-remia,1772
197 L’avare fastueux(comp. 1772-1776)Fontainebleau, ott.1776comédie en cinqactes en prose(cfr. anche n° 198)
*Paris,Bibl. dela Comé-die Fran-çaise, ms.290[1789]
198 L’avaro fastoso[comp. pre ott. 1776< L’avare fastueux,n° 197] 1776 [Ac-cademia letterario-drammatica veneta,formata dai quattrofratelli Querini, figlidi Giovanni]commedia di cinqueatti in prosa
IX1789330
BO XIX1790; STA4
1791; MAXXVII 1792;GR IX 1796
199 La metempsicosiossia La pitagoricatrasmigrazione 1776
XXXI1793
BO XXXI1793
330 «Ognuno avrà veduto con noi che Goldoni non ha grandi obbligazioni al suo tradutto-re», poteva osservare la Caminer dalle colonne del «Nuovo Giornale Enciclopedico d’Italia»,Luglio MDCCXC, all’atto di recensire l’inedito del t. IX Zatta (pp. 19-30). Pur non dispo-nendo di elementi documentari sufficienti per mettere in dubbio (come la Caminer) la pater-nità goldoniana della traduzione, giova tuttavia segnalare che anche nel caso del Bourru, aproposito del quale Zatta avrebbe ben potuto avvalersi della traduzione dell’autore edita daDuchesne nel 1789 (cfr. n° 196), l’editore aveva preferito seguire la più sbrigativa strada diristampare la traduzione Candoni (pur essendone stati a suo tempo rilevati i grossolani errori:cfr. la recensione di Domenico Caminer in «L’Europa letteraria», t. III, p. I, Gennaro 1772, p.82).
Per una mappa della produzione goldoniana 213
B/ Do PA PT PS Z Altreedizioni
[Accademia lettera-rio-drammatica ve-neta]commedia di tre attiin versi
200 Il disinganno incorte comp. 1775-1780rappresentazione indue partiintermede en deuxactes en vers (CM2)
XXVI1792
BO XXXI1793
5. Prospetto sintetico delle edizioni goldoniane
Per consentire un’immediata visualizzazione dei contesti editoriali com-plessivi entro cui si situarono, di volta in volta, le pubblicazioni delle sin-gole opere, in questa sezione si è offerta descrizione essenziale delle 23raccolte che dal 1750 al 1798 vennero proponendo il teatro goldoniano astampa331.
Di ciascuna edizione si sono illustrati:a) frontespizio generale del primo tomo. Si avverte che l’identità biblio-
grafica di alcune edizioni – consegnata appunto al frontespizio generale delvolume inaugurale e poi solitamente replicata, salvo i necessari aggiusta-menti cronologici, nelle partizioni successive – può in taluni casi subire va-riazioni, di cui non è parso opportuno in questa sede fornire descrizione;
b) numero, datazione e contenuto dei singoli volumi. Data la finalitàdella presente sinossi, non è si è fatta rientrare, nella descrizione del conte-nuto, anche quella di eventuali spazi paratestuali; si avverte inoltre che,laddove un’edizione sia apparsa – almeno relativamente alla struttura deivolumi – chiaramente descripta, non si è proceduto a spiegata descrizionedel contenuto, ma si è indicato attraverso ricorso alle consuete abbreviazio-ni l’edizione (nelle sue varie partizioni) da cui risulta derivata. Si è tuttaviaritenuto di dover ugualmente esplicitare il contenuto in tutti quei casi (STA,VE e S), in cui la necessità di segnalare specifiche ristampe delle commedieinterne a ciascun volume ha reso appunto necessaria la menzione distesa dei
331 Resta invece inteso che la segnalazione di edizioni di singole opere viene effettuataesclusivamente nella precedente sezione.
214 ANNA SCANNAPIECO
titoli. In qualche caso infine (cfr. S2), l’opportunità di mettere in evidenza lacoincidenza dei contenuti, ma l’attuale impossibilità di verificare in estesol’effettiva derivazione da un’edizione (< PT) piuttosto che da un’altra (<STA< PT), ha indotto ad escludere l’utilizzo del consueto simbolo di deri-vazione (“<”) a favore di uno più generico di uguaglianza (“=”). Per quantoriguarda la datazione, si è proceduto a segnalare tra parentesi quadre, im-mediatamente di seguito a quella desunta dal frontespizio, la data reale dipubblicazione (laddove, naturalmente, si è avuto modo di riscontrarne do-cumentariamente una difformità rispetto a quella dichiarata); eventuali ri-stampe dei singoli volumi sono state indicate, di seguito alla princeps, conil relativo anno di pubblicazione (e l’indicazione in esponente del numeroprogressivo di riedizione); si avverte peraltro che, in taluni casi, l’indi-cazione di “ristampa” è equivoca, dandosi la possibilità che un editore piùche ripubblicare un testo già stampato in precedenza, produceva in realtà lanuova redazione che di una commedia avevano nel frattempo garantito leedizioni d’autore. Nel caso di edizioni che praticavano il doppio canale divendita (per cui cfr. supra, pp. 67-69 e passim) e che allestivano dunquevolumi con commedie destinate anche allo smercio individuale (e in quantotali munite di un frontespizio proprio completo di note tipografiche), oltreall’indicazione cronologica del volume si è registrata anche – laddove dif-forme – quella delle singole commedie.
Al solo scopo di chiarire alcune delle modalità – nonché, talora, deicontenuti stessi – che hanno reso possibile la realizzazione del presente pro-spetto, pare utile far seguire brevi note illustrative relativamente alle edi-zioni la cui ricostruzione bibliografica è apparsa più problematica (e perciascuna delle quali sarà necessario allestire specifiche indagini).
a) Pasquali. I problemi posti dall’analisi del vario valore filologico diquest’edizione (per cui cfr. supra, pp. 103-114) sono riflessi anche nellatormentata definizione della sua cronologia (resa particolarmente ardua dalfatto – rilevato come inspiegabile dagli stessi contemporanei332 – che tutti itomi recano la medesima indicazione di anno, 1761). La necessità di potergarantire in questa sede un tentativo di ricostruzione più attendibile diquanto non avessero sinora offerto le indagini bibliografiche espressesi in
332 Cfr. «Giornale Eciclopedico», t. I, Gennajo 1774, Venezia, Nella Stamperia Fenziana,p. 21 («quantunque [il t. XI] porti la data 1761 (non ben sappiamo il perché) pure è stampatonel pr. scorso anno») e ivi, t. VII, Luglio 1774, pp. 138-139 («Qual motivo abbia il S. Pa-squali di darci sotto la data del 1771 [sic] questo vol. [il t. XII] in questi giorni pubblicati[sic], a noi non è noto»).
Per una mappa della produzione goldoniana 215
materia333 ha indotto a operare un vaglio delle possibili fonti documentarie,identificate non tanto in materiale archivistico (al riguardo molto lacuno-so)334 o in testimonianze autobiografiche (non a caso, i riferimentidell’autore all’edizione diventano radi sino al silenzio dal t. X in poi),quanto nella pubblicistica coeva (sia di area veneta che toscana ed emilia-na)335, nei cataloghi di editori attivi a livello nazionale negli ultimi decennidel secolo336 e nell’osservazione degli sviluppi editoriali di pubblicazioni“pirata” che dalla Pasquali attingevano il proprio materiale di stampa. Laridefinizione cronologica proposta infra, pp. 231-232, riguarda solo tangen-zialmente alcuni tra i primi dieci volumi337, mentre determina consistentiaggiustamenti nella scansione degli ultimi sette (che, come s’è visto, rap-presentano la sezione più problematica dell’edizione, non più sostenutadall’assistenza dell’autore). L’assegnazione dei tt. XI, XII e XIII rispetti-vamente al 1773, 1774 e 1775 è garantita dalle articolate segnalazioni pub-blicitarie che il Caminer ne veniva facendo sul «Giornale Enciclopedico»338,mentre la riconsiderazione dei tempi di pubblicazione dei tomi successivi èstata resa possibile dal vaglio della fonte su cui sinora ci si era erronea-
333 Cfr. A. G. SPINELLI, Bibliografia goldoniana, cit., pp. 97-121 e L. ROSSETTO, TraVenezia e l’Europa…, cit., pp. 103-113.
334 È infatti conservata solo la registrazione della licenza di stampa relativa ai primi duetomi (cfr. Archivio di Stato di Venezia, Riformatori dello Studio di Padova, f. 341, cc. 93[21/7/1761, n° 297] e 106 [29/10/1761, n° 405]).
335 Si è proceduto allo spoglio, per il periodo interessato, dei seguenti periodici: «Nuovaveneta gazzetta », «La Minerva», «Diario veneto», «L’Europa letteraria», «Giornale enciclo-pedico» (anche nelle continuazioni, per quanto esorbitanti il periodo interessato: «Nuovogiornale enciclopedico» e «Nuovo giornale enciclopedico d’Italia»), «Notizie del mondo»,«Progressi dello spirito umano»; «Novelle letterarie» (Firenze); «Annali letterari d’Italia»,«Biblioteca di varia letteratura straniera antica e moderna», «Nuovo giornale de’ letteratid’Italia», «Bibliografia generale corrente d’Europa» (per queste ultime testate, cfr. La biblio-teca periodica. Repertorio dei giornali letterari del 6-700 in Emilia e in Romagna, a cura diM. Capucci, R. Cremante e G. Gronda, Bologna, Il Mulino, 1985-1993).
336 Si è al riguardo consultato tutto il ricchissimo materiale documentario conservatopresso la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia e, soprattutto, la Biblioteca Universitariadi Padova.
337 In particolare, ha consentito una più certa collocazione cronologica dei tt. II-IV laconsultazione della «Nuova veneta gazzetta», che ai numeri 4 (24 marzo), 16 (5 maggio) e 51(18 settembre) ne offre le rispettive segnalazioni. Per quanto riguarda la puntualizzazionerelativa ai tempi di pubblicazione del t. X (solitamente ascritto al 1768), cfr. quanto già argo-mentato in A. SCANNAPIECO, Un editore goldoniano…, cit., p. 68, n. 177.
338 Cfr. «Giornale Eciclopedico», t. I, Gennajo 1774, Venezia, Nella Stamperia Fenziana,p. 21; ivi, t. VII, Luglio 1774, pp. 138-139; ivi, t. IX, Settembre 1775, p. 77.
216 ANNA SCANNAPIECO
mente basati339: ma se oggi è possibile escludere che i tt. XII-XV fosserostati editi nello stesso 1774, e ricondurre con certezza – come s’è visto – ilsolo t. XII a quell’anno e il t. XIII al successivo, non si può fare affida-mento su fonti positive per una precisa collocazione temporale dei tt. XIV-XVI. Lo sviluppo dell’edizione è infatti d’improvviso e completamenteignorato dalla pubblicistica coeva340 e l’unico riferimento temporale certo èquello desumibile da un lettera dell’autore che nel giugno 1777 segnalavacome avvenuta la realizzazione del t. XV. L’osservazione dello sviluppodelle edizioni (in particolare STA e G) che attingevano agli inediti della Pa-squali per la composizione dei nuovi volumi induce a ritenere altamente
339 Nella sua Bibliografia goldoniana (cit., p. 115), SPINELLI assegnava al 1774 la pub-blicazione dei tomi XII, XIII, XIV, XV, sulla base di quanto a suo dire documentato dalla«Gazzetta Toscana» del 1774 (nn. 5, 16, 27 e 37). Il dato – come purtroppo ancora accade,nonostante la notoria debolezza del repertorio bibliografico – è stato assunto come indubita-bile, anche da chi avrebbe voluto, in una rinnovata prospettiva di indagine bibliografica, ana-lizzare proprio lo specifico della cronologia Pasquali (cfr. L. ROSSETTO, Tra Venezia el’Europa…, cit., p. 112 e n.), e pur essendo in deciso contrasto con altri termini documentaridi riferimento (per menzionare solo il più cogente, si veda la citata recensione che al tomoXIII, nel settembre 1775, riserva il «Giornale Enciclopedico, ascrivendone la pubblicazioneall’anno in corso). Ma, qualora verificata la fonte a cui Spinelli attingeva, si sarebbe scopertoche la «Gazzetta Toscana», nei numeri citati dallo studioso, segnalava sì la pubblicazione diun «Tomo 12. [e poi 13 ecc.] delle commedie del Goldoni», facendo però riferimento non avolumi dell’edizione Pasquali, bensì della Guibert e Orgeas. È quanto infatti lascia inequivo-cabilmente intendere l’indicazione «Edizione di Genova» che talvolta accompagna le men-zioni pubblicitarie dei tomi (cfr. ad esempio Tomo nono delle Gazzette Toscane uscite setti-mana per settimana nell’anno 1774, Firenze, 1774, Appresso Giuseppe Pagani Stampatore, eLibrajo dalle Scalere di Badìa, n° 5, 29 gennaio, p. 20: «Ai negozi Pagani si trovano vendibiliai prezzi soliti il Tomo 12. delle commedie del Goldoni, e il Tomo 6. del Metastasio Edizionedi Genova»; ivi, n° 37, 10 settembre, p. 148: «Sono qua venuti da Genova il t. 9 del Metasta-sio e il t. 15 del Goldoni»), e ancor più distintamente quanto segnalato dallo stesso giornale,nel corso dell’anno precedente, allorché annunciava l’immissione sul mercato fiorentino dellanuova edizione torinese (cfr. Tomo ottavo delle Gazzette Toscane uscite settimana per setti-mana nell’anno 1773, n° 43, 23 ottobre, p. 172: «È anco venuto di Genova il quarto, e quintoTomo dell’Opere del Metastasio ultimamente impressi, vendibili anche essi a’ detti NegozjPagani al prezzo di crazie quindici il Tomo, siccome ancora presso i medesimi si vendonocrazie diciotto l’uno Tomi undici sinora usciti alla luce dell’Opere dell’Avvocato Carlo Gol-doni ristampate in detta città di Genova»). Sui rapporti di coproduzione di Guibert e Orgeascon il genovese Gravier e la conseguente possibilità che l’edizione “torinese” venisse indicatacome «di Genova», cfr. quanto segnalato supra, n. 150; per lo sviluppo cronologico dellaGuibert – la prima serie è nella fattispecie quella chiamata in causa dagli Avvisi della «Gaz-zetta Toscana» –, cfr. infra, pp. 234-235.
340 L’ultima recensione rinvenuta nello spoglio dei periodici indicati supra, n. 335 èquella citata del «Giornale Enciclopedico» al t. XIII e risale al settembre 1775. Neanchel’analisi dei cataloghi degli editori (cfr. supra, n. 336) ha consentito di circoscrivere con piùesattezza i possibili tempi di realizzazione di questi volumi.
Per una mappa della produzione goldoniana 217
improbabile che il tomo XIV (in cui figurava come inedito il Todero) etanto più il XV (che offriva la novità de Le baruffe chiozzotte) uscissero nel1776341; un non risolvibile margine di dubbio ha peraltro indotto, nella rico-struzione cronologica proposta di seguito, a segnalare per i due tomi in que-stione un’indicazione più possibilista (1776-1777). Non si dispone neanchedi una menzione diretta nel caso del t. XVI, che si è indotti a collocare in unpossibile fascia 1777-1779, con l’avvertenza che – anche in questo caso – lasua realizzazione appare estremamente imbrobabile entro il 1777, nonchéscarsamente verosimile nell’anno successivo342. Solo per l’ultimo volume sipuò individuare un tempo ben definito di pubblicazione (il maggio 1780),grazie alla preziosa e inequivocabile testimonianza del Catalogo settima-nale con cui il libraio fiorentino Giuseppe Molini veniva periodicamenteregistrando i «libri tanto nazionali, che oltremontani […] che vengono allaluce ogni settimana»343.
341 L’ultimo inedito della Pasquali che l’edizione bolognese utilizza – e pur avendone inprecedenza già offerto una redazione spuria, come per il Todero – è La scozzese, la cui licen-za di stampa viene rilasciata in data 30 dicembre 1776; la sostanziale fedeltà con cui la SanTommaso cerca di seguire l’edizione d’autore, ricorrendo a materiale spurio solo laddove lapenuria di nuovi testi lo rende strettamente indispensabile, fa presumere che se entro il 1776fosse stata dai torchi veneziani prodotta qualche altra novità, essa sarebbe stata immediata-mente replicata nella stamperia bolognese. D’altro canto, solo nel 1777 la Guibert può ripro-durre gli inediti dei tt. XIV-XV Pasquali (rispettivamente nei tt. XI e XII della seconda serie).
342 L’inedito del tomo Pasquali (Una delle ultime sere di carnovale) non viene ripreso in-fatti né dalla Guibert (che per concludere, nel 1777, la sua seconda serie è costretta a riciclareun Rinaldo derivato dalla Savioli, nonché altro materiale, non commediografico, di varia ori-gine: cfr. infra, p. 235), né dalla Savioli, che conclude la sua seconda raccolta nel 1780. Aquanto è dato sapere, la commedia sarà ristampata solo nel 1790, dalla San Tommaso.
343 Catalogo settimanale ovvero Nota periodica dei libri tanto nazionali, che oltremonta-ni, carte geografiche, musica e stampe che vengono alla luce ogni settimana, conl’indicazione degli autori, del sesto, del num. dei tomi, e delle pagine, col respettivo prezzo, el’indirizzo de’ librai, ed altri presso dei quali si trovano in vendita. Tomo primo pubblicatoda Giuseppe Molini mercante di libri, anno MDCCLXXX, Firenze, Per Gaetano CambiagiStampator Granducale. Nel n° 21, 25 maggio 1780, l’art. 2 pubblicizza «Delle Commedie diCarlo Goldoni Avvocato Veneto. Tomo XVII. In Venezia per Giambatista Pasquali con Li-cenza de’ Superiori e Privilegio in 8 di pag. 290. Si continua. Paoli 6» (copia di questo pre-zioso strumento è alla Biblioteca Universitaria di Padova; giova segnalare che gli annunci,pubblicati ogni giovedì, si basavano su note comunicate tempestivamente dagli editori stessi,interessati alla pubblicizzazione immediata delle proprie stampe: da quello che si è avutomodo di verificare nel caso di altre pubblicazioni, essi erano effettivamente concomitantiall’immissione sul mercato dei nuovi prodotti). Notevole il fatto che – come desumibile dallanota in calce a quest’annuncio – dell’edizione Pasquali era prevista esplicitamente, ancora nelmaggio 1780, una “continuazione”; d’altra parte, ancora nel 1787, la prefazione dei Mémoi-res, oltre a confermare l’arresto dell’edizione al t. XVII, non ne escludeva comunque un pos-
218 ANNA SCANNAPIECO
b) Zatta. Gli aspetti variamente problematici con cui quest’ultima edi-zione “d’autore” sempre più viene configurandosi nella ricostruzione stori-co-bibliografica acuiscono particolarmente l’esigenza di uno studio miratoche ne indaghi caratteristiche genetiche e morfologiche. Oltre a quanto giàillustrato in precedenza, in questa sede ci si dovrà limitare a sottolinearne lanatura tipograficamente composita: della Zatta infatti sono identificabilialmeno tre impressioni diverse, ciascuna delle quali si fa naturalmente latri-ce di diverse composizioni tipografiche, con riflessi redazionali talora nonindifferenti. Innanzitutto, come già segnalato dalla recente edizione criticadel Curioso accidente, è dato imbattersi in esemplari che pur configurando-si apparentemente appartenenti ad una stessa tiratura, in realtà sono chiara-mente discendenti da diversi allestimenti tipografici344: sussistendo rilevantidifferenze tanto nell’utilizzo di alcuni caratteri, quanto nella configurazionedelle illustrazioni, quanto nella stessa cura redazionale. L’analisi sistemati-ca di tre esemplari dell’edizione conservati presso la Biblioteca di CasaGoldoni a Venezia ha consentito in particolare di osservare che una serieZatta – edita, a parte il caso di un volume345, negli stessi anni della primaimpressione – presenta, quasi esclusivamente nei soli volumi della primaclasse346, illustrazioni non solo più generiche, ma anche spesso incomplete(alla presenza nell’illustrazione di un tavolo con candelabro corrisponde adesempio solo un tavolo; ad una vignetta con tre persone fa riscontro una console due; altrove, la misura consueta del rame risulta significativamente ri-dimensionata ecc.), nonché i segni di una più frettolosa composizione tipo-grafica (ad una prima campionatura sono apparsi più frequenti i refusi). Piùche pensare «a una sorta di “edizione-campionario”, non del tutto perfezio-nata, sopravvissuta anche dopo la messa punto della più accurata e “finita”»Zatta347, e dunque ad una specie di “copia sperimentale” per forza di cosecronologicamente anteriore alla copia “rifinita”, è probabilmente da ritener-si che questa serie sia una vera e propria ristampa – e dunque posteriore allaprima impressione –, resasi necessaria (e sia pur in termini di stretta con-temporaneità) per il successo incontrato dallo smercio della prima tiratura.Induce a ritenere più verosimile quest’ipotesi non solo la considerazione
sibile sviluppo (cfr. I 6: «l’édition de Venise […] n’est encore […] qu’au tome XVIIe, et je nevivrois pas assez pour voir cette édition terminée»).
344 Cfr. R. RICORDA, Nota al testo, cit., pp. 53-55.345 Si tratta del secondo, per cui cfr. infra, p. 237.346 Ma Laura Riccò, nell’allestimento critico de La castalda, ha offerto descrizione di un
esemplare Zatta della seconda classe che ha le stesse caratteristiche illustrate a testo in riferi-mento a volumi della prima (cfr. L. RICCÒ, Nota ai testi, cit., p. 83).
347 Così l’ipotesi formulata da R. RICORDA, Nota al testo, cit., p. 55.
Per una mappa della produzione goldoniana 219
che, come già accennato, almeno uno dei volumi della serie non rifinitaporta data posteriore (1789 invece di 1788) a quella del corrispettivodell’altra serie, quanto anche l’osservazione che le figurazioni incomplete ola sostituzione di illustrazioni generiche a quelle specificamente inerentil’argomento delle varie commedie, nonché la stessa maggiore incidenza direfusi tipografici, fossero dovuti a dinamiche compositive proprie di unaristampa allestita frettolosamente per bisogno di smercio immediato oltreche per mera convenienza produttiva348: di qui la minore sorveglianza reda-zionale nella composizione dei testi, ma anche l’impiego di illustrazioni in-complete o passe-partout, molto verosimilmente dovuto all’usura dei ramioriginari.
Completamente diverso il caso della cosiddetta Zatta minor, di cui siaveva generica notizia grazie a segnalazioni di Spinelli e di Rasi349, ma dicui solo oggi si è avviata l’effettiva conoscenza grazie all’individuazione dialcuni esemplari superstiti350. Si tratta di un’edizione che – giusta le indica-zioni dei precedenti repertori bibliografici – risulta completamente priva diillustrazioni (ogni atto, al posto del rame allusivo, reca – la stessa ad ogniatto – una cornice con motivi floreali o geometrici che racchiude il titolodella commedia), ma non sembra realizzata su «carta scadente» (comevuole Spinelli), né che spinga la sua qualità di «tiratura popolare» (così ilRasi) al di là della mancanza di illustrazioni. Per quello che si è finoraavuto modo di verificare, la composizione è identica nell’impostazionedella pagina (coincide anche la numerazione dei fogli; fra l’altro il fronte-spizio generale reca ancora l’indicazione «con rami allusivi»), ma – rispettoa quella della ristampa della maior – è spesso più corretta (e difatti, risultanell’insieme simile a quella – come s’è visto, più accurata – della prima ti-ratura). Dovette trattarsi di un’impressione realizzata congiuntamente alla
348 Una volta piazzato il prodotto sul mercato, e dovendosi solo far fronte ad una doman-da già espressa, non era necessario curarne la realizzazione con lo stesso dettaglio con cui neera stato effettuato il lancio commerciale. Come si illustrerà più distesamente in altra sede,Zatta aveva già messo in opera una medesima procedura nel caso della sua edizione metasta-siana.
349 Cfr. A. G. SPINELLI, Bibliografia goldoniana, cit., pp. 143-144; Catalogo generaledella raccolta drammatica di Luigi Rasi, Firenze, L’Arte della Stampa, 1912, p. 396. Recentiindagini bibliografiche hanno appurato che attualmente gli esemplari di cui davano notizia idue studiosi non sono più reperibili nelle menzionate sedi (Spinelli citava copie conservatealla Biblioteca Ambrosiana e a quella della Scala di Milano; la raccolta Rasi dovrebbe nellasua interezza essere stata acquisita dalla Biblioteca del Burcardo di Roma).
350 Copia integrale della Zatta minor è conservata alla Biblioteca Nazionale di Roma; ilDipartimento di Italianistica dell’Università degli Studi di Venezia ne ha recentemente repe-riti e acquistati 18 volumi (8 della prima classe e 10 della seconda).
220 ANNA SCANNAPIECO
maior (lo attestano naturalmente anche le coincidenze temporali riscontra-bili nelle datazioni dei vari volumi), per assicurarsi a tutti i livelli possibiliun mercato che poteva essere insidiato dalla concorrenza – temibile soprat-tutto sotto il profilo economico – delle toscane Masi e Bonsignori: non acaso, l’impressione priva di illustrazioni costava esattamente la metà diquella «bellissima ed elegante […] in carta scelta, adorna di rami allusivi acadaun atto delle Commedie»351.
c) San Tommaso d’Aquino. Analisi mirate e sistematiche ancor più im-pongono l’intrinseca complessità bibliografica e la straordinaria articola-zione e durata di quest’edizione, di cui si possono individuare ben quattroserie e che sostenne per circa mezzo secolo – in modi, come s’è visto, spes-so determinanti anche per la tradizione otto-novecentesca – la diffusione ela recezione del teatro goldoniano. Oltre a quanto già illustrato in preceden-za352, in questa sezione si potranno solo suggerire alcuni elementi, funzio-nali all’utilizzo e all’interpretazione dei dati di seguito proposti. Probabil-mente preceduta nel 1751 da edizioni occasionali di singole commedie353,allestite – sulla scia del successo della veneziana Bettinelli – dagli «Impres-sori del S. Officio»354, l’edizione si inaugurò nel 1752, a immediato ridossodel successo con cui il pubblico teatrale bolognese aveva accolto allesti-
351 Così il Catalogo de’ libri latini, italiani, e francesi che si trovano vendibili presso laditta Antonio Zatta qu: Giacomo di Venezia da esso stampati, e di quelli che nel suo negoziosi ritrova averne in maggior numero, Venezia, 1806, p. 44, che fissava il prezzo dei 44 volumia L. 400; per la versione minor, come informa lo stesso Catalogo, il costo era di sole L. 200.
352 Ma cfr. anche quanto già riferito in altre sedi: A. SCANNAPIECO, Lo statuto filologi-co…, cit., pp. 145-149; Ead., Un editore goldoniano nella Napoli del secondo Settecento, cit.,pp. 8-10 e passim.
353 Con queste stampe sciolte si devono verosimilmente identificare alcuni dei riferimentibibliografici rimasti documentati nella Drammaturgia di Allacci. Di questi (isolatinell’insieme delle informazioni complessive, non sempre – come s’è detto – attendibili) si èdata segnalazione esclusivamente nella sezione precedente, trattandosi appunto di notizie re-lative a stampe individuali. Il fatto che nella Drammaturgia di Allacci le edizioni delle sin-gole commedie siano poi ricondotte alla loro inclusione in un determinato volume, di cui èspecificata la relativa numerazione, non è riprova di nulla, potendosi trattare di assemblaggiseriori (prodottisi a seguito – 1752 – dell’avvio dell’edizione complessiva delle commedie,strutturata in volumi contenenti ciascuno quattro testi).
354 Questa la qualifica ufficiale – esibita dai frontespizi delle relative produzioni tipogra-fiche – degli «Eredi di Costantino Pisarri e Giacomo Filippo Primodì», cui si deve ascrivere(cfr. supra, n. 225) la responsabilità editoriale delle stampe segnalate da Allacci semplice-mente come di «Pisarri». Come si dirà poi, nei primi anni cinquanta, con gli «Impressori delS. Officio» sembra intrattenere dei rapporti societari Girolamo Corciolani, all’epoca condut-tore della stamperia della San Tommaso d’Aquino (di proprietà, come già ricordato, diquell’ordine domenicano presso il cui convento di San Domenico Maggiore era ubicata lasede stessa del S. Officio).
Per una mappa della produzione goldoniana 221
menti scenici di opere goldoniane. Nata come ristampa organica della Bet-tinelli, la San Tommaso seppe tempestivamente rivedere e correggere ilproprio piano editoriale all’atto della clamorosa sconfessione che l’autorefece della sua prima edizione e dell’avvio della nuova iniziativa fiorentina,a cui le stampe bolognesi cominciarono a uniformarsi in quello stesso 1753,non mancando nell’occasione di fregiarsi del titolo di «seconda edizione» (ein effetti premurandosi di riproporre nella diversa configurazione testualepropria della Paperini testi già in precedenza stampati secondo l’originariaredazione Bettinelli). Sin dall’inizio, e poi in tutte le sue successive artico-lazioni, la San Tommaso si distingue per la sistematicità e l’ordine con cuiriproduce i corrispettivi editoriali allestiti dall’autore (un assemblaggio ca-suale dei testi nei volumi potrebbe sembrare propria solo di alcune partidella prima serie: ma in realtà è dovuto alla circostanza del tutto fortuita cheaveva visto l’edizione avviarsi sulla falsariga della Bettinelli, e la mancatacoincidenza del nuovo ordinamento Paperini costrinse gli editori bolognesi,almeno per la scelta combinatoria di alcuni volumi, ad una configurazionediversa da quella del nuovo corrispettivo d’autore). Il successo della primaserie diede sicuramente luogo ad una sua «terza edizione», avviata nel1762, e al prosieguo – come s’è detto, ordinato e sistematico, nonché orga-nizzato in nuove configurazioni editoriali – delle diverse iniziative con cuiGoldoni veniva promuovendo la diffusione a stampa del proprio teatro. Lalettura dei dati di seguito proposti persuaderà facilmente di quanto sinorasinteticamente sottolineato e indurrà a rivedere in profondità tutti i pregiu-dizi che, da Spinelli fino ai giorni nostri, si sono immotivamente raccoltiattorno alle stampe bolognesi del teatro goldoniano355.
Per quanto attiene la lettura dei dati di seguito proposti andrà sottoli-neato, in primo luogo, che una certa disomogeneità nella configurazionedegli stessi (di un volume possono essere attestate tre edizioni, e le comme-die in esso contenute averne documentate in numero diverso, e/o con datenon sempre coincidenti) è in realtà dovuta alle modalità di conservazionedegli esemplari stessi, spesso, come già detto, dovute ad assemblaggi seriorio, anche, alla possibilità – giusta l’originaria condizione di smercio ancheindividuale dei testi – che siano in alcuni casi state preservate solo stampesciolte (attraverso cui non è sempre agevole la ricostruzione dell’insiemeoriginario di riferimento): i dati di seguito raccolti sono insomma relativi a
355 Per Spinelli, cfr. almeno Bibliografia goldoniana, cit., pp. 94, 121-123. Per il perdura-re del pregiudizio storico-critico, cfr. A. ZANIOL, I tempi e le stratificazioni testuali del Gol-doni francese: le «spie» del Matrimonio per concorso, in «PCG», II, 1995, pp. 231-267 (inpart. pp. 234-235 e n. 10).
222 ANNA SCANNAPIECO
ciò che è stato conservato, e non a ciò che è – effettivamente – esistito. No-nostante la sua frammentarietà, la documentazione superstite lascia tuttaviaintravedere non solo il piano originario ma anche le dinamiche evolutivedell’edizione nel suo insieme (per una cui ricostruzione – e sia pure ipoteti-ca – sarà necessario procedere ad un’ulteriore integrazione documentaria oquanto meno ad un vaglio più ragionato dei dati stessi e di possibili fontiintegrative). In secondo luogo, particolarmente per i dati relativi alla primaserie (pp. 225-226; ma cfr. anche p. 230, per il t. I della seconda), andrà e-videnziato che sono stati conglobati nella descrizione degli esemplari STAanche quelli PP, la cui confluenza con i precedenti nella conservazione se-riore di alcuni volumi dovette molto probabilmente essere attiva anche nellaconfigurazione originaria degli stessi. La scelta è stata inevitabile, non soloperché presupposta in moltissimi casi dalla natura stessa del materiale de-scritto (ad esempio un volume con frontespizio STA può contenere ancheesemplari PP e viceversa), ma anche perché molto verosimilmente discen-dente da un’originaria unitarietà editoriale: i Pisarri-Primodì dovettero esse-re in accordi societari per la produzione delle opere goldoniane con la tipo-grafia di San Tommaso d’Aquino, durante gli anni in cui questa venne affi-data alla gestione di Girolamo Corciolani (che alcuni dati documentari in-ducono a considerare come una specie di trait-d’union delle due stampe-rie)356.
d) Savioli. Solo due apparentemente le serie attraverso cui in una dieci-na d’anni (ma con una netta concentrazione nel periodo 1770-1774)l’editore Agostino Savioli venne replicando a Venezia l’operazione avviatagià vent’anni prima dalla San Tommaso, delle cui pubblicazioni goldonianeriproduce non solo la struttura ma molto spesso – come s’è visto – anche gli
356 L’ipotesi, per quanto già sufficientemente corroborata da precisi riscontri (di cui sipotrà dare solo in altra sede relativa giustificazione), è senz’altro bisognosa di approfondi-mento. Va comunque segnalato che è dato riscontrare un diverso comportamento delle istitu-zioni preposte alla censura nei confronti delle due stamperie per il rilascio delle prescritte li-cenze: come già segnalava Roberta Turchi nel caso de La bottega del caffè, mentre per i Pi-sarri-Primodì (1753) l’imprimatur venne concesso senza interventi censori, questi furono in-vece imposti agli stampatori della San Tommaso nel 1762 (R. TURCHI, Nota sulla fortuna, inC. GOLDONI, La bottega del caffè, cit., p. 255); altrettanto significativi mi sembrano i casidella Buona moglie e delle Donne gelose le cui stampe STA (rispettivamente, 1756 e 1763)registrano censure non attive in quelle PP (1752 e 1755). Va peraltro osservato che gli inter-venti censori potevano riguardare anche la ristampa di un testo realizzata dallo stesso editore(cfr. quanto segnalato supra, n. 182 per la Pupilla e n. 262 per il Geloso avaro): è quindi pos-sibile ascriverne la genesi più che ad un diverso rapporto dei singoli editori con i revisori adun evolversi nel tempo delle modalità della revisione stessa (come infatti desumibile da tuttigli esempi allegati, l’intervento censorio si produce sempre all’atto della ristampa dei testi, inuna fase temporale anche considerevolmente successiva a quella della “princeps”).
Per una mappa della produzione goldoniana 223
assetti redazionali. Le due serie in questione distinguono da un lato il cicloBettinelli-Paperini, dall’altro quello Pitteri-Pasquali (inediti), non trascu-rando di immettere in entrambi “novità”, o allestite in proprio (come Il bur-bero benefico, inserito nella prima raccolta) o derivate dalla produzionebolognese (come Il matrimonio per concorso, nella seconda). Se due, pro-priamente parlando, sono in effetti le serie in cui si articolarono le edizionigoldoniane del modesto editore (la cui fisionomia è ancora tutta da indaga-re), in realtà i suoi torchi diedero luogo a diverse impressioni o, anche, aemissioni diverse per identiche composizioni tipografiche. È quest’ultimo ilcaso degli ultimi cinque volumi della seconda raccolta, che furono immessisul mercato tanto con il frontespizio originario357, quanto con quello con-traffatto della Pitteri, di cui si simulava una prosecuzione358; in altri casi –per lo più relativi sempre a stampe della seconda serie – si è avuto modo diverificare, come già segnalato, impressioni diverse (con conseguente diver-sità di composizione tipografica) realizzate nell’ambito dello stesso pro-getto editoriale, presumibilmente dovute a ragioni di differenziata destina-zione commerciale359. Di recentissima individuazione infine l’esistenza diuna terza serie360, allestita nel 1774, probabilmente riassuntiva di entrambe
357 È l’esemplare recensito da Spinelli (Bibliografia goldoniana, cit., pp. 128-133: conl’avvertenza che la datazione dell’ultimo volume, 1770, è un chiaro refuso per 1780), e di cuiè stata recentemente individuata copia presso la Biblioteca Universitaria di Sassari. L’analisicomparativa di alcuni volumi di questo esemplare Savioli con i corrispettivi della cosiddetta“finta Pitteri” ha consentito appunto di verificarne la natura di emissioni. Nella descrizionedella serie offerta infra, pp. 233-234, proprio in forza dell’identica composizione tipograficanon si è operata distinzione tra esemplari Savioli ed esemplari “Savioli-Pitteri”.
358 Cfr. supra, n. 119.359 Cfr. supra, n. 124. In questo caso è invece parso opportuno dare segnalazione, tra pa-
rentesi tonde e preceduto dalla sigla “es”, dell’esistenza di un esemplare “sciolto” , con com-posizione tipografica diversa da quella della stampa inserita in volume.
360 La documentazione di questa presunta terza raccolta è affidata alla preservazione,presso la Biblioteca Comunale di Treviso, di nove volumi in progressione non continua (tt. II,III, V, VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV), di cui l’ultimo di sicuro inserito arbitrariamente nellaserie perché in realtà originariamente facente parte di S2 (e pertanto, nella descrizione propo-sta a testo, ci si è arrestati al t. XIII nell’ipotizzare l’articolazione complessiva dell’edizione).Essendo ancora tutta da indagare la genesi e la reale consistenza di questa rarissima produ-zione Savioli (che sembra peraltro non aver avuto un’identità editoriale specifica rispetto alleprecedenti raccolte, se non limitatamente ad una diversa organizzazione del materiale), non sene è data successiva classificazione; questo comunque il frontespizio del primo volume con-servato: LE / COMMEDIE / DEL SIGNOR DOTT. / CARLO GOLDONI / TOMO SECON-DO / CHE CONTIENE / LA PAMELA FANCIULLA / LA PAMELA MARITATA / I RU-STEGHI / LI INNAMORATI / LI MORBINOSI / LE MORBINOSE / L’APATISTA, O SIAL’INDIFFERENTE / L’OSTERIA DELLA POSTA / [insegna] / IN VENEZIA MDCC-LXXIV / PRESSO AGOSTINO SAVIOLI / CON LICENZA DE’ SUPERIORI.
224 ANNA SCANNAPIECO
le precedenti raccolte, strutturata in almeno 13 volumi, contenenti ciascunootto (e non più quattro) commedie: l’organizzazione è sempre quella con-sueta che prevede l’assemblaggio nei singoli volumi di stampe destinate an-che alla vendita individuale (e dunque dotate di autonoma numerazione dipagine e frontespizio proprio): la qualità di quest’ultime (figurano frequen-temente stampe il cui frontespizio individuale attesta la loro originaria col-locazione nella prima serie, o che addirittura risultano derivate dalla sfasci-colazione di alcuni volumi della Pitteri) fa presumere che questa edizionemettesse in realtà assieme materiale eterogeneo, allineando sia nuove ri-stampe di testi già in precedenza editi nelle altre due raccolte, sia materiale(probabilmente invenduto) derivato da queste stesse, sia – per ragioni dicompletamento dei volumi – giacenze di altri editori361.
BETTINELLI 1750-1757 = B
LE / COMMEDIE / DEL DOTTORE / CARLO GOLDONI / AVVOCATO VE-NETO / FRA GLI ARCADI / POLISSENO FEGEJO / TOMO PRIMO. / [insegna] /VENEZIA, MDCCL. / PER GIUSEPPE BETTINELLI / Con Licenza de’ Superio-ri, e Privilegio.I 1750, 17512, 17523, 17534: La donna di garbo; I due gemelli veneziani; L’uomoprudente; La vedova scaltra.II 1751, 17522, 17533: Il teatro comico; La putta onorata; La buona moglie; Il pa-dre di famiglia.
361 Il rapporto di Agostino Savioli con la bottega Pitteri dovrà essere senz’altro indagato;nel caso specifico, il dato con cui confrontarsi è quello di 10 commedie rudimentalmente sfa-scicolate dagli originari tomi Pitteri senza alcuna attenzione per tutte le incongruenze derivatedall’immissione di quel tipo di realizzazioni tipografiche nel nuovo piano editoriale di riferi-mento (si pensi, oltre alla diversità della composizione fin nell’utilizzo dei caratteri, alla man-canza di autonomi frontespizi e numerazione di pagine, o alla presenza di dediche e prefazio-ni); va inoltre segnalato che a Venezia – tanto presso la Biblioteca Marciana, quanto pressoquella di Casa Goldoni – sono conservati alcuni esemplari di edizioni Savioli di singolecommedie (identificabili cioè per tali solo in virtù dei relativi frontespizi) che smerciano inrealtà originarie stampe Pitteri (sempre attraverso lo stesso sistema della sfascicolazione, esenza nessuna remora per la proposta tipografica di un testo ad esempio dotato di incongruanumerazione di pagine). Forse Savioli – che era innanzitutto un libraio, sprovvisto di propriastamperia (cfr. M. Infelise, L’editoria veneziana nel ’700, cit., p. 324n) – una volta fattosifortunato editore goldoniano e resosi pronto a inondare spregiudicatamente il mercato di“nuovi” prodotti per garantirsi una sorta di tacito monopolio della preziosa merce, non esitò aricorrere anche all’arraffazzonata emissione di giacenze di bottega pur di perseguire il proprioprogetto (e ricavarne molteplici forme di guadagno: disfarsi di prodotti invenduti e al tempostesso fraudolentemente impiegarli per alimentare l’offerta di una “novità” editoriale). Ma sitratta di un’ipotesi da accogliere con beneficio d’inventario.
Per una mappa della produzione goldoniana 225
III 1752, 17532: Il cavaliere e la dama; La famiglia dell’antiquario, o sia La suoce-ra e la nuora; L’avvocato veneziano; L’erede fortunata.IV 1753: Il Moliere; La bottega del caffè; Il bugiardo; L’adulatore.V 1753: Pamela; Il tutore; L’avventuriere onorato; Li pettegolezzi delle donne.VI 1753: La moglie amorosa; Il cavalier di buon gusto; Le donne gelose; Le fem-mine puntigliose.VII 1753, 17552: La gastalda; La locandiera; Il marchese di Monte Fosco; I poeti.VIII 1755: I due Pantaloni; L’impostore; Don Giovanni Tenorio, o sia Il dissoluto;Il servitore di due padroni.IX 1757: La pupilla; L’uomo di mondo; Il prodigo; La banca rotta, o sia Mercantefallito.
SAN TOMMASO D’AQUINO 1752-1757 = STA1 [Eredi di Costantino Pisarrie Giacomo Filippo Primodì 1752-1757 = PP; Primodì 1757 = Pr]362
LE / COMMEDIE / DEL SIGNOR AVVOCATO / CARLO GOLDONI / VENE-ZIANO / FRA GLI ARCADI / POLISSENO FEGEJO. / Tomo Primo / CHE CON-TIENE / LA DONNA DI GARBO. / I DUE GEMELLI VENEZIANI. / L’UOMOPRUDENTE. / LA VEDOVA SCALTRA. / [insegna] / IN BOLOGNA MDCCLII./ Per Girolamo Corciolani, ed Eredi Colli, a S. Tommaso / d’Aquino. Con licenzade’ Superiori.LE / COMMEDIE / DEL SIGNOR AVVOCATO / CARLO GOLDONI / VENE-ZIANO / FRA GLI ARCADI / POLISSENO FEGEJO. / Tomo Secondo / CHECONTIENE / IL TEATRO COMICO. / LA PUTTA ONORATA. / LA BUONAMOGLIE. / IL PADRE DI FAMIGLIA. / [insegna] / IN BOLOGNA MDCCLII. /Per gli Eredi di Costantino Pisarri, e Giacomo Filippo Primo- / dì Impressori del S.Officio. Con licenza de’ Superiori.I 1752 [17532; 17623]: La donna di garbo [1752; 17532; 17683]; I due gemelli vene-ziani [1752; 17532]; L’uomo prudente [1752; 17532; 17783]; La vedova scaltra[1752; 17532; 17563; 17664; 17975].II 1752 (PP) [17532; 17623]: Il teatro comico (PP 1752) [PP/+SSTA 17532; 17603;+17624]; La putta onorata (PP 1752) [PP/+SSTA 17532; 17563; 17664]; La buonamoglie (PP 1752) [PP/+SSTA 17532; 17563; 17744]; Il padre di famiglia (PP 1752)[PP/+SSTA 17532; 17563; 17664; 17925].III 1752 [+S17532; 17543; 17664]: Il cavaliere e la dama (STA/PP 1752) [+S17532;17543; 17664]; La famiglia dell’antiquario, o sia La suocera e la nuora [1752;+S17532; 17543; 17664]; L’avvocato veneziano (PP 1752) [+S17532; 17543; 17654;17905]; L’erede fortunata (PP 1752) [+S17532; 17543; 17664].IV 1753 (PP/+SSTA) [17632]: La Pamela [1753; 17562; 17653]; La bottega del caffè(PP/+SSTA 1753) [17622; 17753]; Il bugiardo (PP/+SSTA 1753) [17622]; La serva
362 Data la dominante editoriale di STA su PP, salvo diversa avvertenza l’esemplare de-scritto si intende sempre STA.
226 ANNA SCANNAPIECO
amorosa [1753; 17622].V 1753 [17632]: L’adulatore [1753; 17622; 17633]; Il tutore [1753; 17622; 17633]; IlMoliere (STA/PP 1753) [17942]; La locandiera (PP/+SSTA 1753) [17592; 17763].VI (PP/+SSTA) 1754 [17632]: L’avventuriere onorato (PP/+SSTA 1754) [17622]; Ilcavaliere di buon gusto (PP/+SSTA 1754) [17622; 17763]; Le femmine puntigliose[1754; 17632; 17743]; Il servitore di due padroni [+S1754; 17612; 17683].VII 1754 [17632; 17753]: La moglie saggia [1754; 17632; 17763]; La finta amma-lata [1754; 17592; 17623]; Il vero amico (PP/+SSTA 1754) [17622; 17753]; Le donnecuriose (PP/+SSTA 1754) [17622; 17753].VIII 1754 (PP/+SSTA) [17632; 17753]: La figlia obbediente [1754; 17632; 17773];L’amante militare [1754; 17632]; Il giocatore (PP/+SSTA 1754) [17622]; I merca-tanti (PP/+SSTA 1754) [17622; 17753].IX 1754 [17632]: I puntigli domestici [1754; 17632; 17893]; Il feudatario [1754;17592; 17763]; La dama prudente (STA/PP 1754) [17622]; L’impostore (STA/PP1754) [17622; 17773].X (PP/+SSTA) 1755 [17632]: Don Giovanni Tenorio, o sia Il dissoluto (PP1754/+SSTA 1755) [17632; 17753]; Il poeta fanatico (PP/+SSTA 1755) [17632;17753]; La donna volubile [1755; 17632; 17773]; La donna vendicativa [1754;17632; 17753].XI 1755 [17642]: I pettegolezzi delle donne [1755; 17632; 17913]; L’incognita[1755; 17632]; Il contrattempo, o sia Il chiacchierone imprudente (PP/+SSTA 1755)[17632; 17913]; La castalda [1755; 17632].XII 1757 [17752]: La pupilla (anche Pr 1757) [1757; 17652]; L’uomo di mondo (an-che PP 1757) [1757; 17652]; Il prodigo [1757; 17662]; Le donne gelose (PP1755/+SSTA1 XIII 1757) [17632; 17963]363.XIII 1757: La banca rotta o sia Mercante fallito (anche Pr 1757) [1757; 17662]; Ilfrappatore (anche Pr 1757) [1757; 17662; 18003].
PAPERINI 1753-1757 = PA
LE / COMMEDIE / DEL DOTTORE / CARLO GOLDONI / AVVOCATO VE-NEZIANO / FRA GLI ARCADI / POLISSENO FEGEJO / PRIMA EDIZIONEFIORENTINA / Dall’Autore corretta, riveduta, ed ampliata. / TOMO PRIMO. /[insegna] / IN FIRENZE. MDCCLIII. / APPRESSO GLI EREDI PAPERINI / ConLicenza de’ Superiori, e Privilegio.I 1753: Il teatro comico; La Pamela; La bottega del caffè; Il bugiardo; La servaamorosa.II 1753: Il cavaliere e la dama; Il Moliere; L’adulatore; Il tutore; La locandiera.III 1753: L’avventuriere onorato; Il cavaliere di buon gusto; La vedova scaltra; Lefemmine puntigliose; Il servitore di due padroni.
363 Spinelli (Bibliografia goldoniana, cit., p. 37) recensisce in questo tomo i contenuti diSTA2 I.
Per una mappa della produzione goldoniana 227
IV 1753: La moglie saggia; La famiglia dell’antiquario, o sia La suocera e la nuo-ra; Il vero amico; La finta ammalata; Le donne curiose.V 1753 [ma 1754]: La donna di garbo; L’amante militare; I mercatanti; Il giocato-re; L’uomo prudente.VI 1754: La figlia obbediente; Il feudatario; L’avvocato veneziano; I puntigli do-mestici; L’erede fortunata.VII 1754: La dama prudente; Don Giovanni Tenorio o sia Il dissoluto; La donnavendicativa; Il padre di famiglia; L’impostore.VIII 1754 [ma 1755]: L’incognita; Il contrattempo, o sia Il chiacchierone impru-dente; La castalda; La donna volubile; Il poeta fanatico.IX 1755: Le donne gelose; I due gemelli veneziani; La putta onorata; La buonamoglie; I pettegolezzi delle donne.X 1755 [ma 1757]: La pupilla; L’uomo di mondo; Il prodigo; La banca rotta, o siaMercante fallito; Il frappatore.
BETTINELLI 1753-1755 = BPA
LE / COMMEDIE / DEL DOTTORE / CARLO GOLDONI / AVVOCATO VE-NEZIANO / FRA GLI ARCADI / POLISSENO FEGEJO / Quinta Edizione Venetasull’Esem- / plare della Fiorentina. / TOMO PRIMO. / [insegna] / VENEZIA, /APPRESSO GIUSEPPE BETTINELLI / MDCCLIII. / Con Licenza de’ Superiori,e Privilegio.I 1753 < PA I; II 1753 < PA II; +III 1754 < PA III; +IV 1754 < PA IV; +V 1754 <PA V; +VI 1754 < PA VI; +VII 1754 < PA VII; +VIII 1755 < PA VIII.
GAVELLI 1753-1757 = GA
LE / COMMEDIE / DEL DOTTOR / CARLO GOLDONI / AVVOCATO VENE-ZIANO / FRA GLI ARCADI / POLISSENO FEGEJO / Corrette, rivedute ed am-pliate dal medesimo / in Firenze. / TOMO PRIMO. / PRIMA EDIZIONE PESA-RESE. / [insegna] / IN PESARO; M.DCC.LIII. / NELLA STAMPERIA GAVEL-LIANA. / Con lic. de’ Sup., e Privilegio.I-II 1753 < PA I-II; III 1753 [ma 1754] < PA III; IV-VII 1754 < PA IV-VII; VIII1754 [ma 1755] < PA VIII; IX 1755 < PA IX; X 1757 < PA X.
VENACCIA 1753-1777 = VE364
LE / COMMEDIE / DEL DOTTORE / CARLO GOLDONI / AVVOCATO VE-
364 Solo il t. I reca frontespizio generale completo di note tipografiche. Come chiarito inA. Scannapieco, Un editore goldoniano…, cit., a Giacomo-Antonio Venaccia va ascritta lasola paternità editoriale della pubblicazione, essendone stata affidata la realizzazione tipogra-fica a diversi stampatori.
228 ANNA SCANNAPIECO
NETO / FRA GLI ARCADI / POLISSENO FEGEJO / SECONDA EDIZIONE DIFIORENZA. / TOMO PRIMO. / LA DONNA DI GARBO. / LE QUATTRO NA-ZIONI, O / SIA LA VEDOVA SCALTRA. / IL CAVALIERE, E LA / DAMA. /L’EREDE FORTUNATA. / [insegna] / IN NAPOLI 1754. / PRESSO ALESSIOPELLECCHIA. / Ed a spese di Giacomo-Antonio Venaccia. / Si vendono nel Cor-ridojo del Consiglio. / CON LICENZA DE’ SUPERIORI.I: La donna di garbo +1753, 17562; La vedova scaltra, o sia Le quattro nazioni1754, 17792; Il cavaliere e la dama 1754; L’erede fortunata 1754.II: La buona moglie +1753, 17582; Il padre di famiglia +1753, 17572; L’uomo pru-dente 1754; Il Moliere 1753, 17582.III: La putta onorata 1754; La famiglia dell’antiquario, o sia La suocera e la nuora1754; L’avvocato veneziano 1754; Il teatro comico 1754.IV: La Pamela +1753, 17562; La bottega del caffè +1753, 17562; Il bugiardo +1753,17572; L’adulatore +1753, 17582.V: La serva amorosa +1753, 17582; La locandiera 1753, 17582; La moglie saggia1753; I due gemelli veneziani 1753, 17582.VI: Il tutore +1753, 17592; Il cavalier di buon gusto +1753, 17592; L’avventuriereonorato +1753, 17602; Le femmine puntigliose +1753, 17592.VII: Le donne curiose 1753, 17592; Il servitore di due padroni 1753, 17592; Lafinta ammalata 1753, 17592; Li pettegolezzi delle donne 1753, 17602.VIII: Il vero amico +1754, 17592; Il giocatore +1754, 17602; L’amante militare1754, 17592; I mercatanti +1754, 17602.IX: La figlia obbediente +1754, 17612; Il poeta fanatico 1756; Il marchese di Mon-tefosco +1754, 17602; La gastalda 1754, 17612.X: La dama prudente 1754, 17602; D. Giovanni Tenorio, o sia Il dissoluto 1754,17602; L’impostore 1754, 17602; I puntigli domestici 1754, 17602.XI: La donna vendicativa +1754, 17612; L’incognita 1755, 17762; La donna volu-bile 1755; Il contrattempo, o sia Il chiacchierone imprudente 1755.XII: Il geloso avaro 1757; Il filosofo inglese 1757; La donna di testa debole, o siaLa vedova infatuata 1757; La sposa persiana 1756; Le donne gelose 1757.XIII (< PA X): La banca rotta, o sia Mercante fallito 1757; L’uomo di mondo1757; Il frappatore 1757; La pupilla 1757; Il prodigo 1757.XIV (< PT II): La madre amorosa 1758, 17732; La cameriera brillante 1758,17722; Il vecchio bizzarro 1758, 17722; Il festino 1758, 17722.XV (< PT III): La peruviana 1758, 17732; Torquato Tasso 1758, 17722; Il raggira-tore 1758, 17732; Terenzio 1758, 17732.XVI (< PT IV): I malcontenti 1758, 17732; Il cavalier giocondo 1758, 17732; Labuona famiglia 1758, 17742; Le massare 1758, 17742.XVII : La vedova spiritosa 1759, 17742; Ircana in Julfa 1759, 17762; Le donne dibell’umore 1759, 17762; La villeggiatura 1758, 17742.XVIII (< PT VI): Il medico olandese 1761, 17772; La donna stravagante 1761,17792; L’amante di sé medesimo 1761, 17782; Ircana in Ispaan 1761, 17782.XIX: La guerra 1766; Un curioso accidente 1766; Gl’innamorati 1766; Il cavalieredi spirito, ossia La donna di testa debole 1766.
Per una mappa della produzione goldoniana 229
XX: La donna di maneggio 1766; L’amore paterno, o sia La serva riconoscente1767; Pamela maritata 1767; L’avaro 1767.XXI: [Il mondo alla roversa, o sia Le donne che comandano 1773; Le donne vendi-cate 1773; La calamita de’ cuori 1773; Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno 1773].XXII: La donna di governo 1774; La bella selvaggia 1774; La donna forte 1774; Ilcampiello 1774.XXIII: Le smanie per la villeggiatura 1777; Le avventure della villeggiatura 1777;Il ritorno dalla villeggiatura 1777 [La buona figliuola maritata 1777].XXIV: Il matrimonio per concorso 1777; Il collerico di buon cuore 1777; La donnasola 1777 [La buona figliuola zitella 1777].
ROCCO FANTINO ed AGOSTINO OLZATI 1756-58 = FO
LE / COMMEDIE / DEL DOTTORE / CARLO GOLDONI / AVVOCATO VE-NEZIANO. / EDIZIONE GIUSTA L’ESEMPLARE / DI FIRENZE. / Dall’Autorecorretta, riveduta, ed ampliata. / TOMO PRIMO. / IL TEATRO COMICO. / LAPAMELA. / LA BOTTEGA DEL CAFFÈ. / IL BUGIARDO. / [insegna] / IN TO-RINO. MDCCLVI. / Per / ROCCO FANTINO, ed / AGOSTINO OLZATI / Comp./ CON LICENZA DE’ SUPERIORI.I 1756: Il teatro comico; La Pamela; La bottega del caffè; Il bugiardo.II 1756: Il cavaliere e la dama; La serva amorosa; Il Moliere; L’adulatore.III 1756: Il tutore; La locandiera; L’avventuriere onorato; Il cavaliere di buon gu-sto.IV 1756: La vedova scaltra; Le femmine puntigliose; Il servitore di due padroni; Lamoglie saggia.V 1756: La famiglia dell’antiquario, o sia La suocera e la nuora; Il vero amico; Lafinta ammalata; Le donne curiose.VI 1756: La donna di garbo; L’amante militare; I mercatanti; Il giocatore.VII 1756: L’uomo prudente; La figlia obbediente; Il feudatario; L’avvocato vene-ziano.VIII 1756: I puntigli domestici; L’erede fortunata; La dama prudente; Don Gio-vanni Tenorio, o sia Il dissoluto.IX 1757: La donna vendicativa; Il padre di famiglia; L’impostore; L’incognita.X 1757: Il contrattempo, o sia Il chiacchierone imprudente; La castalda; La donnavolubile; Il poeta fanatico.XI 1757: Le donne gelose; I due gemelli veneziani; La putta onorata; La buonamoglie.XII 1758: La pupilla; L’uomo di mondo; Il prodigo; La banca rotta, o sia Mercantefallito.XIII 1758: I pettegolezzi delle donne; Il frappatore [Il museo d’Apollo; La veracommedia; Vocabulario o sia Spiegazion de certe parole veneziane; Spiegaziondelle frase veneziane, e modi figurai].
230 ANNA SCANNAPIECO
PITTERI 1757-1763 = PT
NUOVO / TEATRO COMICO / DELL’AVVOCATO / CARLO GOLDONI / POE-TA DI S.A.R. / Il Serenissimo Infante di Spagna / DON FILIPPO / DUCA DIPARMA, PIACENZA, / GUASTALLA, ec. / TOMO PRIMO. / [insegna] / IN VE-NEZIA, / APPRESSO FRANCESCO PITTERI. / MDCLVII. / CON LICENZA DE’SUPERIORI E PRIVILEGIO.I 1757: La sposa persiana; Il geloso avaro; La donna di testa debole, o sia La ve-dova infatuata; Il filosofo inglese.II 1757: La madre amorosa; La cameriera brillante; Il vecchio bizzarro; Il festino.III 1757 [ma 1758]: La peruviana; Torquato Tasso; Il raggiratore; Il Terenzio.IV 1758: La buona famiglia; I malcontenti; Le massare; Il cavalier giocondo.V 1758: Ircana in Julfa; Le donne de casa soa; Il campiello; La villeggiatura.VI 1760: Ircana in Ispaan; Il medico olandese; L’amante di sé medesimo; La donnastravagante.VII 1761: La vedova spiritosa; La bella selvaggia; Il ricco insidiato; La donna so-la.VIII 1761: La sposa sagace; La donna di governo; La donna forte; Le morbinose.IX 1763: La dalmatina; Il padre per amore; Lo spirito di contradizione; I morbino-si.X 1763 [ma 1763-1764]365: Il cavaliere di spirito, o sia La donna di testa debole;L’apatista, o sia L’indifferente; La donna bizzarra; L’osteria della posta.
SAN TOMMASO D’AQUINO 1757-1764 = STA2 [Giacomo Filippo Primodì1757 = Pr]
NUOVO / TEATRO COMICO / DEL SIGNOR AVVOCATO / CARLO GOLDONI /POETA / Di S.A.R. Il Serenissimo Infante di Spagna / DON FILIPPO / Duca diParma, Piacenza, / Guastalla, ec. / TOMO PRIMO / A norma dell’Edizione di Ve-nezia. / [insegna] / IN BOLOGNA MDCCLVII. / Per Girolamo Corciolani, ed ErediColli a S. Tommaso / d’Aquino. Con licenza de’ superiori.I 1757 (< PT I): La sposa persiana (anche Pr 1757) [1757; 17632]; Il geloso avaro(anche Pr 1757) [1757; 17632]; La donna di testa debole, o sia La vedova infatuata(anche Pr 1757) [1757; 17632]; Il filosofo inglese [1757; 17632; 17763].II 1757(< PT II): La madre amorosa [1757; 17632; 17943]; La cameriera brillante[1757; 17632; 17913]; Il vecchio bizzarro [1757; 17652; 17963]; Il festino [1757;17632; 17873].
365 Il volume esce o nel dicembre 1763 o nei primi giorni del gennaio 1764 (STA ha im-primatur per le commedie di questo tomo già nel gennaio 1764). Il t. X, insieme al IX, avevaavuto licenza dei Riformatori dello Studio di Padova il 1° settembre 1763 (cfr. Archivio diStato di Venezia, Riformatori dello Studio di Padova, f. 341, c. 180, n° 990). L’esemplare delt. X è inoltrato ad Albergati tra il 6 e il 18 febbraio 1764 (cfr. XIV 311-312 e 314).
Per una mappa della produzione goldoniana 231
III 1758 (< PT III): La peruviana [1758; 17642; 17683]; Torquato Tasso [1758;17632; 17923]; Il raggiratore [1758; 17652; 17993]; Terenzio [1758; 17652].IV 1759 (< PT IV): La buona famiglia (1758); I malcontenti (1758); Il cavaliergiocondo (1758); Le massare (s.d.).V 1759 (< PT V): Ircana in Julfa [1759; 17642; 17913]; Le donne de casa soa[1759; 17602]; La villeggiatura [1759; 17712]; Il campiello [1759; 17682].VI 1760 (< PT VI): Ircana in Ispahan [1760; 17682]; Il medico olandese (1760);L’amante di se medesimo (1760); La donna stravagante [1760; 17752].VII 1762 (< PT VII): La vedova spiritosa [1761; 17732]; La bella selvaggia [1761;17782]; Il ricco insidiato [1761; 17752]; La donna sola [1761; 17752].VIII 1762 (< PT VIII): La sposa sagace [1762; 17762]; La donna di governo(1762); La donna forte [1762; 17762]; Le morbinose (1762).IX 1764 (< PT IX): La dalmatina (1763); Il padre per amore (1763); Lo spirito dicontradizione (1763); I morbinosi (1763).X 1764 (< PT X): Il cavaliere di spirito, ossia La donna di testa debole [1764;17882]; L’apatista, ossia L’indifferente [1764; 17662]; La donna bizzarra (1764);L’osteria della posta (1764).
FANTINO 1758-? = F
NUOVO / TEATRO COMICO / DELL’AVVOCATO / CARLO GOLDONI /POETA DI S.A.R. / Il Serenissimo Infante di Spagna / DON FILIPPO / Duca diParma, Piacenza, Guastalla, ec. / TOMO PRIMO. / LA SPOSA PERSIANA. / ILGELOSO AVARO. / La Donna Di Testa Debole. / IL FILOSOFO INGLESE. / [in-segna] / IN TORINO, MDCCLVIII. / Per ROCCO FANTINO, Stampatore delleRegie Gabelle / VICINO A’ M. RR. PP. GESUITI IN CASA VERRUA. / CONLICENZA DE’ SUPERIORI.I 1758 < PT I; II 1758 < PT II.
PASQUALI 1761-1780 = PS
DELLE / COMMEDIE / DI / CARLO GOLDONI / AVVOCATO VENETO / TomoI. / [insegna con motto «Describo mores hominum»] / In Venezia / MDCCLXI. /Per Giambatista Pasquali / Con licenza de’ Superiori, e Privilegio.I 1761: Il teatro comico; La bottega del caffè; Pamela fanciulla; Pamela maritata.II 1761 [ma 1762]: Il cavaliere e la dama; Il bugiardo; Il tutore; Gl’innamorati.III 1761 [ma 1762]: I rusteghi; La serva amorosa; Il Moliere; L’adulatore.IV 1761 [ma 1762]: L’avventuriere onorato; Il cavaliere di buon gusto; La locan-diera; L’avaro.V 1761 [ma 1763]: La moglie saggia; La vedova scaltra; Il servitore di due padro-ni; L’amor paterno, o sia La serva riconoscente.VI 1761 [ma 1764]: Le femmine puntigliose; La finta ammalata; Le donne curiose;La guerra.
232 ANNA SCANNAPIECO
VII 1761 [ma 1764]: La famiglia dell’antiquario o sia La suocera e la nuora; Uncurioso accidente; Il vero amico; Il padre di famiglia.VIII 1761 [ma 1765]: La donna di maneggio; L’avvocato veneziano; Il feudatario;La figlia obbediente.IX 1761 [ma 1766]: La donna di garbo; I mercatanti; La buona madre; Il padre peramore.X 1761 [ma 1767]: La dama prudente; I puntigli domestici; L’amante militare; Lacasa nova.XI 1761 [ma 1773]: Terenzio; Le smanie per la villeggiatura; Le avventure dellavilleggiatura; Il ritorno dalla villeggiatura.XII 1761 [ma 1774]: Il filosofo inglese; Il giuocatore; Il geloso avaro;L’impresario delle Smirne.XIII 1761 [ma 1775]: La sposa persiana; Ircana in Julfa; Ircana in Ispaan; Lascozzese.XIV 1761 [ma 1776-1777]: L’uomo prudente; La donna di testa debole, o sia Lavedova infatuata; Don Giovanni Tenorio o sia Il dissoluto; Sior Todero brontolon,o sia Il vecchio fastidioso.XV 1761 [ma 1776-1777]: L’erede fortunata; La madre amorosa; La peruviana; Lebaruffe chiozzotte.XVI 1761 [ma 1777-1779]: Torquato Tasso; La donna vendicativa; La camerierabrillante; Una delle ultime sere di carnovale.XVII 1761 [ma 1780]: La pupilla; L’impostore; Il vecchio bizzarro; Gli amanti ti-midi, o sia L’imbroglio de’ due ritratti.
SAN TOMMASO D’AQUINO 1762-1776 = STA3
DELLE / COMMEDIE / DEL SIGNOR / CARLO GOLDONI / AVVOCATO VE-NETO / TOMO I. / Per servire di continuazione / AL NUOVO TEATRO COMICO/ DEL MEDESIMO AUTORE. / [insegna] / IN BOLOGNA MDCCLXII. / A S.Tommaso d’Aquino. Con licenza de’ Superiori.I 1762: Pamela maritata (1762); Gl’innamorati [1762; 17742]; I rusteghi (1762);L’avaro (1762).II 1765: L’amor paterno o sia La serva riconoscente (1763); La guerra (1764); Uncurioso accidente (1764); La donna di maneggio (1765).III 1775: La buona madre (1766); Le smanie per la villeggiatura (1775); Le av-venture della villeggiatura (1775); Il ritorno dalla villeggiatura (1775).IV 1776: Todero brontolon (s. d., ma imprimatur 28/11/1772); L’impresario delleSmirne (1775); La casa nova (1767); La scozzese [1772; 17772 ma < PS].?: Il matrimonio per concorso 1775.
SAVIOLI 1770-1772 = S1
LE / COMMEDIE / DEL SIGNOR DOTT. / CARLO GOLDONI, / A NORMADELL’EDIZIONE DI FIRENZE, / Dove fu dall’Autore corretta, riveduta, / ed am-
Per una mappa della produzione goldoniana 233
pliata. / TOMO PRIMO. / CHE CONTIENE / IL TEATRO COMICO. / LA BOT-TEGA DEL CAFFÈ. / LA PAMELA. / LA FINTA AMMALATA. / [insegna] / INVENEZIA MDCCLXX. / PRESSO AGOSTINO SAVIOLI / CON LICENZA DE’SUPERIORI.I 1770: Il teatro comico [1770; 17742]; La bottega del caffè [1770; 17742]; La Pa-mela [1770; 17742]; La finta ammalata [1771 17742; +S17753].II 1770: Le donne curiose [1770; 17712; 17733; 17744]; Il vero amico [1770;17742]; La moglie saggia [1770; 17742]; La famiglia dell’antiquario o sia La suo-cera e la nuora (1770).III 1770 [17712]: Il Moliere [1770; 17742]; Il poeta fanatico (1770); La donna vo-lubile [1770; 17752]; I pettegolezzi delle donne [1770; 17752].IV 1770 [17712]: La castalda (1770); L’incognita (1770); Il frappatore (1770); Ilcontrattempo o sia Il chiacchierone imprudente [1770; 17862].V 1771: Il cavaliere di buon gusto [1770; 17712]; L’avventuriere onorato [1771;17752]; La pupilla [1771; 17752]; La donna vendicativa [1771; 17752].VI 1771: Il tutore (1771); D. Giovanni Tenorio o sia Il dissoluto (1771); L’amantemilitare (1771); L’erede fortunata (1771).VII 1771: I puntigli domestici (1771); La banca rotta, o sia Il mercante fallito(1771); Il feudatario (1771); La dama prudente (1771).VIII 1771: L’uomo prudente (1771); L’adulatore (1771); La donna di garbo(1771); I mercatanti (1771).IX 1771: Il servitore di due padroni (1771); Il giocatore (1771); La locandiera(1771); Il cavaliere e la dama (1771).X 1771: La putta onorata (1771); La buona moglie [1771; 17862]; L’avvocato ve-neziano (1771); La vedova scaltra (1771).XI 1771: Le donne gelose (1771); I due gemelli veneziani (1771); L’uomo di mondo(1771); Il prodigo (1771).XII 1772: L’impostore (1772); L’amore paterno, o sia La serva riconoscente(1771); Le femmine puntigliose (1771); La serva amorosa (1771).XIII 1772: Il padre di famiglia (1772); La figlia ubbediente (1772); Il bugiardo(1772); Il burbero benefico, o sia Il bisbetico di buon cuore (1772).
SAVIOLI 1770-1780 = S2366
LE / COMMEDIE / DEL SIGNOR DOTT. / CARLO GOLDONI, / DEL TEATROCOMICO / TOMO PRIMO / CHE CONTIENE / LA SPOSA PERSIANA. / IR-
366 Per le ragioni già accennate in precedenza (cfr. supra, n. 357), nell’ambito della de-scrizione di questa seconda serie (con particolare riferimento agli ultimi cinque volumi) nonsi è proceduto alla distinzione tra Savioli propriamente detta e Savioli-Pitteri. Si sono invecesegnalate, attraverso sottolineatura del relativo numero in esponente, le ristampe che in realtàconsistono in emissioni di pubblicazioni Pitteri sfascicolate (cfr. supra, p. 224 e n. 361). Si fainfine presente che la mancata esplicitazione dell’anno di stampa delle singole commedie staa significare che il frontespizio individuale delle stesse ne è privo.
234 ANNA SCANNAPIECO
CANA IN JULFA. / IRCANA IN ISPAHAN. / IL FESTINO. / [insegna] / IN VE-NEZIA MDCCLXX. / PRESSO AGOSTINO SAVIOLI / CON LICENZA DE’ SU-PERIORII 1770: La sposa persiana [1770; +s17722]; Ircana in Julfa [1770; +s17722; 17743];Ircana in Ispahan [1770; +s17722]; Il festino [1770, 17712, 17743].II 1772: Il Terenzio (1772); La peruviana [1772; 17742]; Il Torquato Tasso (1772);Il raggiratore (1772).III 1772: La buona famiglia (1772); Li malcontenti [1772; 17742]; Le massere(1772); Il cavalier giocondo [1772; 17742].IV 1773: Il geloso avaro (1773); Le donne di casa soa (1773); Il campiello [1773;17742]; La villeggiatura [1773; 17742].V 1773: Il filosofo inglese (1773); La donna di testa debole (1773); La madre amo-rosa [1773; 17752]; La cameriera brillante [1773; 17752].VI 1773: L’amante di se medesimo (1773); La donna stravagante (1773); Il vecchiobizzarro (1773); Il medico olandese [1773; 1775(2)].VII 1773 (= PT VII): La vedova spiritosa [1773; 17752]; La bella selvaggia [1773;17752]; La donna sola (1773); Il ricco insidiato [1773; 1775(2)]].VIII 1773 (= PT VIII): La donna forte [1773; 17752]; La sposa sagace (1773); Ladonna di governo [1772; 17732]; Le morbinose [1773; 17742].IX 1773 (= PT IX): Il padre per amore (1773); La dalmatina [1773; 17742]; Lo spi-rito di contradizione (1773); Li morbinosi (1773).X 1773 (= PT X): Il cavaliere di spirito, o sia La donna di testa debole [1773;+s17752]; La donna bizzarra (1773); L’apatista o sia L’indifferente (1773);L’osteria della posta [1773; 17742; +s17753].XI 1774: Pamella maritata [1774; es1774]; Gl’innamorati [1774; es1774]; I rusteghi(1774); L’avaro [1774; es1774].XII 1774: L’amore paterno, o sia La serva riconoscente [1774; es1774]; La guerra[1774; es1774]; Un curioso accidente [1774; es1774]; La donna di maneggio [1774;es1774].XIII +S1774 [17752]: Sior Todero brontolon, o sia Il vecchio indiscreto [1774;es1774]; Rinaldo di Mont’Albano [1774; es1774]; La casa nova [1774; es1774]; Lascozzese [1774; es1774].XIV 1778: Il matrimonio per concorso; L’impresario delle Smirne [es1775]; LaGriselda [es1775]; La buona madre [1775; es1775].XV 1780: Le smanie per la villeggiatura; Le avventure della villeggiatura; Il ritor-no dalla villeggiatura; Le baruffe chiozzotte.
GUIBERT e ORGEAS 1772-1774 = G1
DELLE / COMMEDIE / DI / CARLO GOLDONI / AVVOCATO VENETO /TOMO I. / IL TEATRO COMICO. / LA BOTTEGA DEL CAFFÈ. / LA PAMELAFANCIULLA. / LA PAMELA MARITATA. / Castigat ridendo mores. / Santeuil. /[insegna] / TORINO MDCCLXXII. / APPRESSO GUIBERT, E ORGEAS.
Per una mappa della produzione goldoniana 235
I-V 1772 < PS I-V.VI-X 1773 < PS VI-X.XI 1773: La donna volubile; Il poeta fanatico; I pettegolezzi delle donne; La pupil-la.XII 1773: La castalda; L’incognita; Il frappatore; Il contrattempo o sia Il chiac-chierone imprudente.XIII 1774: La donna vendicativa; D. Giovanni Tenorio, o sia Il dissoluto; L’eredefortunata; Terenzio.XIV 1774: La banca rotta , o sia Il mercante fallito; Le smanie per la villeggiatura;Le avventure della villeggiatura; Il ritorno dalla villeggiatura.XV 1774: L’uomo prudente; Il giuocatore; La putta onorata; La buona moglie.XVI 1774: Le donne gelose; L’uomo di mondo; La madre amorosa; Il prodigo.
GUIBERT e ORGEAS 1774-1777 = G2
DELLE / COMMEDIE / DI / CARLO GOLDONI / AVVOCATO VENETO / SE-CONDA RACCOLTA / TOMO I. / L’IMPRESARIO DELLE SMIRNE. / IL BUR-BERO BENEFICO. / L’IMPOSTORE. / LA SPOSA PERSIANA. / Castigat riden-do mores / Santeuil / [insegna] / TORINO MDCCLXXIV / APPRESSO GUIBERT,E ORGEASI 1774: L’impresario delle Smirne; Il burbero benefico, o sia Il bisbetico di buoncuore; L’impostore; La sposa persiana.II 1775: Il geloso avaro; I due gemelli veneziani; La donna di testa debole, o sia Lavedova infatuata; L’osteria della posta.III 1775: Il filosofo inglese; Il raggiratore; Ircana in Julfa; Ircana in Ispaan.IV 1775: La donna forte; La donna bizzarra; Il vecchio bizzarro; La camerierabrillante.V 1775: Il medico olandese; Il campiello; Il festino; La peruviana.VI 1775: Il Torquato Tasso; La donna sola; La villeggiatura; I morbinosi.VII 1775: La vedova spiritosa; La bella selvaggia; L’apatista, o sia L’indifferente;I malcontenti.VIII 1776: La sposa sagace; La donna di governo; La buona famiglia; Le donne dicasa soa.IX 1776: Il cavaliere giocondo; Il cavaliere di spirito; L’amante di se medesimo;La dalmatina.X 1776: Il ricco insidiato; La donna stravagante; Lo spirito di contraddizione; Lemorbinose.XI 1777: Sior Todero brontolon, o sia Il vecchio fastidioso; Le massere; La scozze-se; La Griselda.XII 1777: Le baruffe chiozzotte; Rinaldo di Mont’Albano [La fondazion di Venezia;Le avventure del signore Dott. Carlo Goldoni; Il museo d’Apollo; La vera comme-dia; Spiegazion delle frase veneziane, e modi figurai].
236 ANNA SCANNAPIECO
PUCCINELLI 1783-1787 = PU1
LE / COMMEDIE / DEL SIGNOR DOTTORE / CARLO GOLDONI, / A NORMADELL’EDIZIONE DI FIRENZE, / Dove fu dall’Autore corretta, riveduta, / ed am-pliata. / TOMO PRIMO, / CHE CONTIENE / IL TEATRO COMICO. / LA BOT-TEGA DEL CAFFÈ. / LA PAMELA. / LA FINTA AMMALATA. / [insegna] / INROMA MDCCLXXXIII. / A spese de’ Fratelli Gioacchino, e Michele Puccinelli. /CON LICENZA DE’ SUPERIORI.I-III 1783 < S1 I-III; IV-VIII 1784 < S1 IV-VIII; IX-X 1785 < S1 IX-X; XI 1786 <S1 XI; XII-XIII 1787 < S1 XII-XIII.
SAN TOMMASO D’AQUINO 1786-? = STA4 367
1786: Le baruffe chiozzotte; 1790: Gli amanti timidi o sia L’imbroglio de’ due ri-tratti, Una delle ultime sere di carnovale; 1791: Gli amori di Zelinda e Lindoro,L’avaro fastoso, La burla retrocessa nel contracambio, Chi la fa l’aspetta o sia laburla vendicata nel contracambio fra i chiassetti del carneval, Le donne di buonumore, Le inquietudini di Zelinda, Il ventaglio; ? [1787-1805]: Il buon compatriot-to, Il genio buono e il genio cattivo, Rinaldo di Mont’Albano, Zoroastro.
PUCCINELLI 1787 = PU2
LE / COMMEDIE / DEL SIGNOR DOTTORE / CARLO GOLDONI. / DEL TEA-TRO COMICO. / TOMO PRIMO. / CHE CONTIENE / LA SPOSA PERSIANA. /IRCANA IN JULFA. / IRCANA IN ISPAHAN. / IL FESTINO. / [insegna] / INROMA MDCCLXXXVII. / A spese di Michele Puccinelli, nella sua Stamperìa /posta a Torre Sanguigna. / CON LICENZA DE’ SUPERIORII-VIII < S2 I-VIII.IX: Il cavaliere di spirito; Il padre per amore; La dalmatina; L’osteria della posta.
367 Che si possa parlare di una nuova serie STA è forse attestato dalla prefazione edito-riale (Al lettore) dell’Avaro fastoso: «…è la seconda delle Commedie scritte dal Signor Gol-doni per uso del Teatro Francese. Dopo il BURBERO BENEFICO tanto applaudito, e cheebbe tanto incontro alloraché venne rappresentato la prima volta in Parigi, non aveva egli piùfatta alcun’altra composizione Teatrale. Stimolato da suoi amici, cedé alle sollecitazioni loro,e compose la presente Commedia che le procurò nuovi onori, ed applausi. Tradotta poscianella nostra lingua, e stampata in Venezia nella serie delle altre sue Commedie, non lascio didarvela io pur per compimento della presente mia edizione». Come già ricordato supra, n.120, in questo periodo responsabile della gestione della san Tommaso è Giuseppe Lucchesini:nella Biblioteca «Aurelio Saffi» di Forlì si sono recentemente rintracciati due volumi di unasua edizione di goldoniane Opere teatrali (1790), ma l’esiguità del materiale superstite nonconsente di formulare ipotesi più precise sulla fisionomia della pubblicazione, il cui titolosembra ricalcare la nuova formulazione Zatta (ma si è visto come nel caso di almeno duecommedie sia stato invece l’editore veneziano ad attingere a stampe bolognesi: cfr. supra, p.83 e n. 138).
Per una mappa della produzione goldoniana 237
X < S2 XI; XI < S2 XII; XII < S2 XIII; XIII < S2 XIV; XIV < S2 XV.XV: Gli amori di Zelinda e Lindoro, o siano Gli amanti fedeli; La gelosia di Lindo-ro e Zelinda; L’ inquietudini di Zelinda e Lindoro; La donna bizzarra.
ZATTA 1788-1793 = Z368
OPERE TEATRALI / DEL SIG. AVVOCATO / CARLO GOLDONI / VENE-ZIANO. / CON RAMI ALLUSIVI. / TOMO PRIMO / DELLE COMMEDIE INPROSA. / IL TEATRO COMICO. / LA PAMELA NUBILE. / LA PAMELA MA-RITATA. / GLI AMORI DI ZELINDA E / LINDORO, Commedia ined.Frontespizio generale interno del primo volume di ciascuna serie:COMMEDIE / DEL SIG. / CARLO GOLDONI / TOMO PRIMO. / [insegna] /VENEZIA, / DALLE STAMPE DI ANTONIO ZATTA E FIGLI. / CON APPRO-VAZIONE, E PRIVILEGIO. / M.DCC.LXXXVIII.COMMEDIE BUFFE / IN PROSA / DEL SIG. / CARLO GOLDONI / TOMOPRIMO. / [insegna] / VENEZIA, / DALLE STAMPE DI ANTONIO ZATTA EFIGLI. / CON APPROVAZIONE, E PRIVILEGIO. / M.DCC.XC.COMMEDIE E TRAGEDIE / IN VERSI DI VARIO METRO / DEL SIG. / CAR-LO GOLDONI / TOMO PRIMO. / [insegna] / VENEZIA, / DALLE STAMPE DIANTONIO ZATTA E FIGLI. / CON APPROVAZIONE, E PRIVILEGIO. /M.DCC.XCII.– Prima classe: commedie in prosaI 1788: Il teatro comico; Pamela nubile; Pamela maritata; *Gli amori di Zelinda eLindoro.II 1788, 17892: Le smanie per la villeggiatura; Le avventure della vileggiatura; Ilritorno dalla villeggiatura; *Le inquietudini di Zelinda.III 1789: Il cavaliere e la dama; Il padre di famiglia; Un curioso accidente; *Lagelosia di Lindoro.IV 1789: La bottega del caffè; L’osteria della posta; La locandiera; *Il ventaglio.V 1789: Il vero amico; L’avventuriere onorato; L’avaro; (*)Chi la fa l’aspetta, o siaLa burla vendicata nel contraccambio fra’ i chiassetti del carneval.VI 1789: La dama prudente; La donna di maneggio; Gl’innamorati; (*)Le donne dibuon umore.VII 1789: L’impresario delle Smirne; I rusteghi; I malcontenti; *Il matrimonio perconcorso.VIII 1789: La buona madre; La buona famiglia; Il burbero benefico, o sia Il bisbe-tico di buon cuore; *La burla retrocessa nel contraccambio;IX 1789: La villeggiatura; Sior Todero brontolon, o sia Il vecchio fastidioso; La
368 L’asterisco indica inedito dichiarato dal frontespizio; quando racchiuso tra parentesinon dichiarato nella stampa ma incluso come tale nella relativa documentazione archivistica;quando racchiuso tra parentesi e sottolineato, inedito solo rispetto ad edizioni “d’autore”, magià stampato in precedenza (a parte il caso della Bella georgiana), e non necessariamente inredazioni non autorizzate o comunque sostanzialmente difformi da quella Z.
238 ANNA SCANNAPIECO
casa nova; *L’avaro fastoso.X 1789: La guerra; La scozzese; Le baruffe chiozzotte; I mercanti.– Seconda classe: commedie buffe in prosaXI 1790: L’avvocato veneziano; Il feudatario; Il cavaliere di buon gusto; L’amantemilitare.XII 1790: L’uomo prudente; Il tutore; L’amore paterno, o sia La serva ricono-scente; L’uomo di mondo.XIII 1790: Il frappatore; Il bugiardo; L’adulatore; Il prodigo.XIV 1790: L’impostore; Il giuocatore; Il vecchio bizzarro; Il raggiratore.XV 1790: Il contrattempo, o sia Il chiacchierone imprudente; I due gemelli vene-ziani; La donna di testa debole, o sia La vedova infatuata; (*)Il buon compatriotto.XVI 1791: La madre amorosa; La moglie saggia; La buona moglie; La donna digarbo.XVII 1791: Le donne gelose; La donna vendicativa; Le femmine puntigliose; Ledonne curiose.XVIII 1791: La banca rotta, o sia Il mercante fallito; Il geloso avaro; La famigliadell’antiquario, o sia La suocera e la nuora; I puntigli domestici.XIX 1791: La vedova scaltra; La castalda; La donna volubile; I pettegolezzi delledonne.XX 1791: Il servitore di due padroni; L’incognita; Il poeta fanatico; La camerierabrillante.XXI 1791: La putta onorata; L’erede fortunata; La serva amorosa; La figlia ubbi-diente.– Terza classe: commedie e tragedie in verso di vario metroXXII 1792: La sposa persiana; Ircana in Julfa; Ircana in Ispaan; (*)La Griselda.XXIII 1792: Il padre per amore; Il medico olandese; Il ricco insidiato; (*)Rinaldodi Mont’Albano.XXIV 1792: Il filosofo inglese; Il cavaliere giocondo; Il cavaliere di spirito; (*)Lascuola di ballo.XXV 1792: Terenzio; Il Moliere; Il campiello; L’apatista, o sia L’indifferente.XXVI 1792: Il Torquato Tasso; L’amante di se medesimo; D. Giovanni Tenorio, osia Il dissoluto; (*)Il disinganno in corte.XXVII 1792: La donna bizzarra; La donna stravagante; Lo spirito di contraddizio-ne; Le morbinose.XXVIII 1792: La peruviana; La bella selvaggia; La dalmatina; (*)La bella geor-giana.XXIX 1793: La donna sola; La donna forte; La sposa sagace; La donna di gover-no.XXX 1793: Le donne di casa soa; La vedova spiritosa; La pupilla; Le massere.XXXI 1793: Il Monte Parnaso; (*)Gli amori d’Alessandro Magno; I morbinosi; Ilfestino; (*)La metempsicosi, ossia La pitagorica trasmigrazione.XXXII 1793: (*)Belisario; (*)Zoroastro; (*)Giustino; (*)Enea nel Lazio.XXXIII 1793: (*)Rosmonda; (*)Artemisia; (*)Enrico [serenate e cantate: Il corodelle muse; L’amor della patria; L’oracolo del Vaticano; La ninfa saggia; Gli
Per una mappa della produzione goldoniana 239
amanti felici; Le quattro stagioni].XXXIV [= seconda classe, XII] 1793: Una delle ultime sere di carnovale; Gliamanti timidi, ossia L’imbroglio de’ due ritratti; La finta ammalata; (*)Il geniobuono e il genio cattivo.
BONSIGNORI 1788-1793 = BO
DELLE OPERE / DEL SIGNORE / CARLO GOLDONI / AVVOCATO VENETO./ TOMO I / LUCCA MDCCLXXXVIII. / Presso FRANCESCO BONSIGNORI /Con Approvazione.I-III 1788 < PS I-III.IV 1788: L’avventuriere onorato; Il cavaliere di buon gusto; La locandiera; Lamoglie saggia.V 1788: La vedova scaltra; Il servitore di due padroni; L’amore paterno, o sia Laserva riconoscente; Le femmine puntigliose.VI 1788: La finta ammalata; Le donne curiose; La guerra; La famigliadell’antiquario, o sia La suocera e la nuora.VII 1789: L’avvocato veneziano; Il cavaliere di spirito; Il vero amico; Il Terenzio.VIII 1789: Il padre di famiglia; Il padre per amore; Il ricco insidiato; TorquatoTasso.IX 1789 < PS XIII.X 1789: Il feudatario; L’avaro; Il medico olandese; Il burbero benefico, o sia Il bi-sbetico di buon cuore; L’osteria della posta.XI 1789: Gli amori di Zelinda e Lindoro; La gelosia di Lindoro; Le inquietudini diZelinda; Un curioso accidente.XII 1789: La donna di maneggio; La donna di garbo; La madre amorosa; La figliaobbediente.XIII 1789: La buona madre; I mercatanti; La dama prudente; I puntiglj domestici.XIV 1789: L’amante militare; La casa nova; Il ventaglio; Chi la fa l’aspetta, o siaLa burla vendicata nel contraccambio fra’ i chiassetti del carneval.XV 1789 < PS XII.XVI 1789: I malcontenti; Il matrimonio per concorso; L’uomo prudente; La donnadi testa debole, o sia La vedova infatuata.XVII 1789: Le smanie per la villeggiatura; Le avventure della villeggiatura; Il ri-torno dalla villeggiatura; Sior Todero brontolon, o sia Il vecchio fastidioso.XVIII 1790: La donna vendicativa; La cameriera brillante; Una delle ultime seredi carnovale; La burla retrocessa nel contraccambio.XIX 1790: Don Giovanni Tenorio, o sia Il dissoluto; L’erede fortunata; La peru-viana; L’avaro fastoso.XX 1790 < PS XVII.XXI 1790: Il poeta fanatico; Le baruffe chiozzotte; La donna volubile; I pettegolez-zi delle donne.XXII 1790: La putta onorata; La buona moglie; La banca rotta, o sia Il mercante
240 ANNA SCANNAPIECO
fallito; L’uomo di mondo.XXIII 1790: La castalda; L’incognita; Il frappatore; Il contrattempo, o sia ilchiacchierone imprudente.XXIV 1791: La buona famiglia; Le donne di buon umore; Le donne gelose; Il pro-digo.XXV 1791: Il raggiratore; La villeggiatura; I due gemelli veneziani; Il buon com-patriotto.XXVI 1791: Il festino; Le donne di casa soa; Rinaldo di Mont’Albano; L’amante dise medesimo.XXVII 1791: La sposa sagace; La bella selvaggia; La donna stravagante; Il cam-piello.XXVIII 1792: La donna sola; La donna di governo; La donna forte; La donna biz-zarra.XXIX 1792: Il cavalier giocondo; L’apatista, o sia L’indifferente; La vedova spi-ritosa; Le massere.XXX 1792: La Griselda; La scuola di ballo; La dalmatina; Lo spirito di contradi-zione.XXXI 1793: La bella giorgiana; I morbinosi; Gli amori di Alessandro Magno; Lametempsicosi, o sia La pitagorica trasmigrazione; Il disinganno in corte.
MASI 1788-1793 = MA
COLLEZIONE / COMPLETA / DELLE / COMMEDIE / DEL SIGNOR / CARLOGOLDONI / AVVOCATO VENEZIANO. / TOMO I. / TEATRO COMICO. / LABOTTEGA DEL CAFFÈ. / L’AVVENTURIERE ONORATO. / LA LOCANDIE-RA. / Castigat ridendo mores. / Santeuil. / LIVORNO / NELLA STAMPERIA DITOMMASO MASI, E COMP. / 1788.I 1788: Il teatro comico; La bottega del caffè; L’avventuriere onorato; La locandie-ra.II 1788: Pamela fanciulla; Pamela maritata; La vedova scaltra; Il cavaliere di spi-rito.III 1788: La famiglia dell’antiquario, o sia La suocera e la nuora; Il vero amico;L’avvocato veneziano; Il Terenzio.IV 1788: Il padre di famiglia; Il cavaliere e la dama; Gli amori di Zelinda e Lindo-ro; Il Moliere.V 1788: Il bugiardo; La finta ammalata; La guerra; Il padre per amore.VI 1788: Il tutore; L’adulatore; Le femmine puntigliose; Il ricco insidiato.VII 1789: Il feudatario; Il burbero benefico, o sia Il bisbetico di buon cuore;L’avaro; Il medico olandese.VIII 1789: La serva amorosa; La moglie saggia; Gl’innamorati; Il Torquato Tasso.IX 1789: Le gelosie di Lindoro; Le inquietudini di Zelinda; Il ventaglio; La donnadi governo.X 1789: Il prodigo; La sposa persiana; Ircana in Julfa; Ircana in Ispaan.
Per una mappa della produzione goldoniana 241
XI 1789: Le smanie per la villeggiatura; Le avventure della villeggiatura; Il ritornodalla villeggiatura; L’apatista, o sia L’indifferente.XII 1790: Il cavaliere di buon gusto; Il servitore di due padroni; L’amore paterno,o sia La serva riconoscente; Il festino.XIII 1790: La donna volubile; La donna di maneggio; La figlia ubbidiente; D. Gio-vanni Tenorio, o sia Il dissoluto.XIV 1790: Il matrimonio per concorso; La scozzese; La burla retrocessa nel con-traccambio; Il filosofo inglese.XV 1790: Il raggiratore; I mercanti; La buona madre; La donna stravagante.XVI 1790: La donna di garbo; Le donne curiose; Il poeta fanatico; La peruviana.XVII 1790: Il vecchio bizzarro; Un curioso accidente; La buona famiglia; La bellaselvaggia.XVIII 1791: La cameriera brillante; La villeggiatura; I pettegolezzi delle donne;La vedova spiritosa.XIX 1791: La donna di testa debole, o sia La vedova infatuata; La donna vendica-tiva; L’erede fortunata; La donna bizzarra.XX 1791: La madre amorosa; I malcontenti; I rusteghi; La donna forte.XXI 1791: L’impostore; L’uomo di mondo; La banca rotta, o sia Il mercante falli-to; La donna sola.XXII 1791: Il geloso avaro; Le donne gelose; Il frappatore; L’amante di se mede-simo.XXIII 1792: L’uomo prudente; La dama prudente; Sior Todero brontolon, o sia Ilvecchio fastidioso; La dalmatina.XXIV 1792: L’amante militare; L’impresario delle Smirne; Le baruffe chiozzotte;Il cavaliere giocondo.XXV 1792: I puntigli domestici; L’incognita; I due gemelli veneziani; Lo spirito dicontradizione.XXVI 1792: Il contrattempo, o sia Il chiacchierone imprudente; La castalda; Lacasa nova; La sposa sagace.XXVII 1792: L’avaro fastoso; La putta onorata; L’osteria della posta; Le massere.XXVIII 1792: Il giuocatore; La buona moglie; Il buon compatriotto; I morbinosi.XXIX 1793: Gli amanti timidi, o sia L’imbroglio de’ due ritratti; Una delle ultimesere di carnovale; La scuola di ballo; Le morbinose.XXX 1793: Le donne di buon umore; La pupilla; La Griselda; Le donne di casasoa.XXXI: 1793: Chi la fa l’aspetta, o sia La burla vendicata nel contraccambio fra ichiassetti del carnevale; Il campiello; Rinaldo di Mont’Albano [Il museo d’Apollo].
GARBO 1794-1798 = GR
RACCOLTA COMPLETA / DI TUTTE / LE COMMEDIE IN PROSA, / ED INVERSO / DEL SIGNOR / CARLO GOLDONI / AVVOCATO VENEZIANO / Fragli arcadi di Roma Polisseno Fegejo ec. ec. / TOMO PRIMO / DELLE COMME-
242 ANNA SCANNAPIECO
DIE IN PROSA. / I. IL TEATRO COMICO. / II. LA PAMELA NUBILE. / III. LAPAMELA MARITATA. / IV. GLI AMORI DI ZELINDA E / LINDORO, Comme-dia inedi- / ta. / [insegna] / IN VENEZIA, / 1794. / APPRESSO GIAN-FRAN-CESCO GARBO / CON LICENZA DE’ SUPERIORI.I 1794 [1793 ; 1793; 1793; 1793] < Z III 1794: La gelosia di Lindoro; Le inquietudini di Zelida; Il padre di famiglia; Uncurioso accidente.III 1794: Il cavaliere e la dama; Le smanie per la villeggiatura; Le avventure dellavilleggiatura; Il ritorno dalla villeggiatura.IV 1794 < Z IV; V 1795 [1794; 1794; 1794; 1794] < Z V; VI 1795 [1795; 1795;1795; 1794] < Z VI; VII 1795 < Z VII; VIII 1795 < Z VIII; IX 1796 < Z IX; X1796 < Z X; XI 1796 [1796; 1796; 1796; 1795] < Z XI; XII 1796 < Z XII; XIII1797 < Z XIII; XIV 1798 < Z XIV; XV 1798 < Z XV; +XVI < Z XVI.
SOMMARIO
Testi e documenti7 AN D R E A FA B I A N O
Due lettere inedite del Goldoni al «Journal de Paris»13 PI E R M A R I O VE S C O V O
Momolo a Varsavia (Postilla a una postilla goldoniana)
Studi25 AN N A SC A N N A P I E C O
Scrittoio, scena, torchio: per una mappa della produzione goldoniana1. ‘‘Inquadrare’’ un corpus - 2. I difficili contorni dell’esistito - 3. Le trac-ce labirintiche dell’esistente: 3.1 Il filo iniziale della matassa; 3.2 Tessereall’infinito il ‘‘libro’’ della scena; 3.3 Trovare il bandolo? - 4. Per unamappa della produzione goldoniana - 5. Prospetto sintetico delle edizionigoldoniane.
243 PI E R M A R I O VE S C O V OParigi e Siviglia. Spazio e tempo in commedia tra Sei e Settecento e in Goldoni.Primi appunti







































































































































































































































![Volume 5, No. 2 Nopember 2019 [242] Jurnal Al-Lubab ISSN](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63273c31cedd78c2b50d7953/volume-5-no-2-nopember-2019-242-jurnal-al-lubab-issn.jpg)