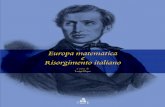Modernità ambigue: l’opera di F.P.J. Peutz
-
Upload
rwth-aachen -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Modernità ambigue: l’opera di F.P.J. Peutz
«tetta
1.11 r if
m m m m .
umt
' i l I I M l • I M i n I M ) < I I M I
"•‘MfJeinjoiffifliiiio
^rttrfrrihf^ir• » l I ( t i l l l M l t H | i | < l M fU U lU lU l l i i lU l i i* ÉjlAflJ.
W iel Arets e W im van den Bergh Modernità ambigue: l’opera di F.P.J. Peutz
Lontana dalle contemporanee esperienze della corrente funzionali- sta e della Scuola di Delft, l’opera di F.P.J. Peutz nell’Olanda degli anni trenta appare come un fatto isolato e inattuale, contraddistinta dalla capacità di attraversare ed utilizzare i diversi materiali della tradizione, del luogo, e della storia dell’architettura. Uno sperimentalismo eclettico, talvolta legato al tema dell’edificio, a volte utilizzato come metodo di progettazione, gli permette di giungere a risultati molto diversi, come la Casa di ritiro, i grandi magazzini Schunck, o il municipio di Heerlen. Non a caso oggetto di lusinghieri giudizi da parte di Oud, questo edificio rappresenta il risultato più personale del lavoro di Peutz, in cui reminiscenze storiche e atmosfera razionalista si fondono in una architettura perfettamente inserita nel suo ambiente.
S. Umberto Barbieri Alla periferia delPimpero
Se al centro dell’Olanda dagli inizi degli anni trenta le linee portanti dello sviluppo architettonico vengono determinate dall’ideologia fùn- zionalista, dalle posizioni dei CIAM e dalla nascente prassi pianificatoria e normativa soprattutto nel settore dell’edilizia popolare, è “ai confini dell’impero” che l’architettura prosegue con ostinazione a ricercare nella continuità il proprio significato d’esistere. Ed è proprio in quest’ostinata ricerca della continuità con le esperienze tardo romaniche sviluppatesi nella seconda metà dell’ottocento in questa parte del paese che verrà a fondarsi una tendenza e una prassi progettuale specifica che si definisce proprio nella “distanza” dai processi di civilizzazione, meccanizzazione e planning, e nella “vicinanza” ad un modello culturale di matrice umanistica e cattolica.
Solo recentemente e forse come reazione all’esaurirsi del potenziale progettuale e ideologico del movimento moderno anche nei paesi nordici, si riscoprono tracce, che poi si dimostrano spaccature profonde, di un’architettura tradizionalista da lungo tempo dimenticata nelle diverse storie. Innanzitutto è forse necessario premettere che a causa della sopravvalutazione della componente fùnzionalista ed espressionista dell’architettura moderna olandese (sopravvalutazione influenzata anche dal significato ideologico che si è dato all’ampia produzione nel settore dell’edilizia popolare e in quello di gestione della città), sono state ignorate o volutamente ridimensionate tutte quelle attività
progettuali e quelle realizzazioni che non rientravano nella dialettica del moderno. Solo parzialmente dunque si ritrovano negli studi sull’architettura olandese accenni alla Scuola di Delft, un importante movimento che ha dominato la scena culturale ed edilizia per più di mezzo secolo. E si tratta di rimandi nel quadro di un discorso critico su quest’architettura bollata di “involuzione tradizionalista” (G. Fanelli, Architettura moderna in Olanda, 1968, pag. 108).
La Scuola di Delfi; non è, né può essere, una reazione involutiva al funzionalismo ma al contrario l’istituzionalizzazione, agli inizi degli anni trenta, di un ampio movimento culturale e di una tendenza e prassi architettonica che nasce e si sviluppa, fin dagli inizi del ventesimo secolo, nelle regioni dell’Olanda del Sud (Lim- burgo e Brabante) e che trova le proprie radici nella lezione architettonica di Cuypers (e dunque nell’interpretazione olandese delle teorie di Viollet-le-Duc), Berlage, Lauweriks e De Bazel da una parte e dall’altra nella cultura delle Beaux-Arts e del neoclassicismo olandese. E solo alla fine degli anni venti, dopo che Granpré Molière è nominato professore al Politecnico di Delft, che si definiscono i connotati di un movimento alternativo, ed in conflitto ideologico, con il funzionalismo. Il risultato di tale presa di posizione esplicita nel contesto olandese è la definizione di un proprio spazio politico basato su un progetto culturale ed architettonico centrato sul tema della tradizione “popolare e cattolica” della popolazione del sud dell’Olanda.
In margine a questi accenni storici è forse utile ricordare che anche “al di fuori” della Scuola di Delft si vengono a delineare verso la(continua a pag. 38)
In the Netherlands o f the thirties, the work o f F.P.J. Peutz appears distantfrom the contemporary functionalist experiences andfrom the School o f Delft: an isolated and out-ofdate phenomenon, characterized by its capacity to traverse and use different materials from tradition, from the site, and from the history o f architecture. This eclectic experimentalism, which is sometimes tied to the theme o f the building, sometimes used as a design method, allows him to achieve very different results, for example the Retirement Home, the Schunck Department Stores, or the Heerlen Town Hall. This last building, significantly praised by Oud, represents the most personal achievement o f Peutz’s work; here historical reminiscences and rationalist experiences melt together in an architecture which is beautifully inserted in the context.
2
Raadhuis Heerlen 1936-1942 1 Municipio di Heerlen. L’edificio, sul bordo della città storica, costituisce con la piazza, l’elemento di definizione della nuova espansione urbana.2 Studio per la facciata principale.3 Veduta dell’edificio negli anni quaranta. (Foto d’Oliveira.)
1 Town-hall o f Heerlen. The building, positioned on the edge o f the historical centre, constitutes, together w ith the square, the element o f definition o f the new urban expansion.2 Study sketch fo r the m ain elevation.3 View o f the building during the forties. (Photo d'O liveira.)
Il municipio di Heerlen, per il suo carattere monumentale, s’identifica non solo con la città ma con tutta la regione di cui Heerlen è considerata il centro. E situato al limite del centrocittà, con la facciata rivolta non verso il centro, come il vecchio municipio, ma verso l’esterno, trasformando così in maniera molto sottile ma efficace l’architettura della città. E uno schema che comporta due volumi principali, dei quali il primo è rappresentativo e contiene l’atrio d’ingresso, la sala principale con la sua enorme scalinata che fungeva anche da anfiteatro per il pubblico, le stanze per il sindaco e gli assessori e, al primo piano, la sala del consiglio, e un
secondo volume costruito più tardi che ospita l’aula magna circondata dagli uffici dei funzionari. Le facciate sono in arenaria francese gialla con infissi in acciaio dipinti in grigio scuro, mentre le pareti in mattoni e la struttura in cemento armato degli interni sono dipinti di bianco in contrasto con i pavimenti in arenaria nera. La parte più sorprendente di questo edificio sono le due colonne sulla facciata occidentale, considerate un riferimento alla storia romana e all’origine di Heerlen, allora chiamata Coriovallum.
The Heerlen town hall is a building that in its m onum ental character not only identifies itself w ith the city but w ith a whole region o f which Heerlen is considered the center.I t is situated a t the border o f the city center notfacing the center area, as the old town hall did, but facing outwards, thus becoming a building that transforms the city's architecture in a very subtle but effective way. It is a design that consists o f two main elements: the fir s t build representational block, in which the entrance-hall' the main- hall w ith its enormous staircase that also acts as an amphitheater fo r the public, the rooms fo r the mayor and aldermen, w ith on the firstflo o r the council-hall; a later build
block houses the public hall surrounded by the offices o f the civil servants.The facades are o f a yellow French limestone w ith steel door- and w indow fram es that are painted dark grey, the interior brick walls and concrete structure were painted white in contrast to the black limestone floors. The most striking part o f this beautifully detailed building is the element w ith the two classical columns a t the west facade; this is considered then a reference to Rom an history and the origins o f Heerlen, then called “Coriovallum ”.
(segue da pag. 36)metà degli anni trenta le prime prese di posizione conflittuali col moderno, che vengono espresse sia nelle polemiche sulle riviste sia in diversi progetti da architetti come S. van Rave- steyn, A. Staal, A. Boeken e lo stesso J.J.P. Oud, che nulla avevano a che fare con le posizioni ideologiche di Granpré Molière, né con la tradizione popolare-cattolica.
NelParchitettura alla “periferia dell’impero” viene sviluppata all’inizio del ventesimo secolo una linea progettuale che nel rapporto con la storia e la tradizione, nella rilettura e nello studio dei classici, nell’attenzione ad aspetti specifici culturali e politici ma anche architettonici del sito, trova le sue matrici e il suo senso. La continuità del linguaggio anche a rischio di ricadute nelPeclettismo, non risulta però in una ripetizione meccanica di forme e stilemi ma, in alcuni casi, proprio nel suo “eclettismo”, in uno spiazzamento, in una diversità dovuta soprattutto all’assenza di un riferimento teorico, ai un “manifesto” a cui dover riferirsi e riferire il pro
prio lavoro. Frits Peutz, nato a Gronigen nel 1896 e morto ad Heerlen nel 1974, è uno dei più importanti rappresentanti di tale modo di fare architettura ed essere architetto. Un architetto sempre inattuale ma proprio per questo sempre presente nelle vicende dell’architettura olandese, anche se non sempre la storia e la critica ha recepito il valore di tale presenza.
Dopo aver conseguito il diploma di ingegnere civile al Politecnico di Delft, Frits Peutz si stabilisce ad Heerlen, una piccola città di fondazione romana ai confini con la Germania e a breve distanza da Aquisgrana, Maastricht e Liegi, dove nel 1920 inizia la sua attività professionale. Le prime architetture di Peutz sono segnate dallo studio autodidattico di testi classici e dall’uso non mediato di modelli formali come lo stile dorico. Il dorico contaminato da riferimenti al romanico, caratterizza un’architettura civile, realizzata in stucco, mattoni e pietra naturale, che si staglia nella natura verde e collinosa del Limburgo. Negli anni venti Peutz sembra
I f fro m the beginning o f the thirties, in the Netherlands, the bearing ideas o f architectural development were determined by the fuctionalistic ideology, the C l A M stand and the rising planning and norm ative praxis, especially as fa r as popular building was concerned’ it was a t the “borders o f the empire” that architecture stubbornly went on looking fo r an existential meaning o f its own w ithin continuity. It was precisely such an obstinate search fo r continuity — through the belated romanesque experience which occurred during the second h a lf o f the 19 th century — that a specific planning trend and praxis was developed and defined exactly a t a “distance”from civilization, mechanization and planning
processes, and w ith a “proxim ity ” to cultural models w ith a hum anistic and catholic m atrix. Only recently some traces o f traditional architecture, long forgot ten by the various histories, have been rediscovered.
The School o f Delft is not, neither can it be, an involutional reaction to functionalism , but, on the contrary, it is the istitutionalization that took place at the beginning o f the Thirties o f both a wide cultural movement and an architectural trend a t the beginning o f this century in Southern H olland (Limburg and Brabant), whose roots are to be fo u n d on the one hand in Cuypers (consequently on the Dutch interpretation o f Viollet-le-Duc), Berlage, Lauweriks and De BazeTs architectural lessons, and in the Beaux A rts and Dutch neo-Classicism on the other.
Besides these historical hints it is perhaps worth
1/4, 7/9 Studi per il municipio di Heerlen, 1936-38.5, 6 Studi per (’organizzazione della nuova piazza, 1936-1938. Il municipio è caratterizzato da due fronti principali: l’uno si affaccia sulla nuova piazza, l’altro su una via del centro.
1/4, 7/9 Study sketches fo r the town-hall o f Heerlen, 1936- 1938.5, 6 Study sketches fo r the organization o f the new p ia zza , 1936-1938. The town-hall is characterized by two m ain elevations: one faces the new p ia zza , the other a street o j the centre.
39
remembering that even “outside” the School o f Delft; around the mid-Thirties, the fir s t conflicts against modernism were delineated and expressed not only through polemic articles in magazines but also by several projects by architects such as S. van Ravesteyn, A . Staal, A . Boeken andJ.J.P. Oud him self who shared nothing w ith either the ideological position o f Granpré Molière or the popular-catholic tradition.
In the architecture a t the “periphery o f the empire” a t the beginning o f the 2 0 th century, a planning line was developed that fo u n d its m ould and meaning in the relationship with history and tradition, in a silent re-reading and study o f the classics and in the attention p a id to specific cultural and political aspects. Linguistic continuity d id not result in a mechanical repetition o f form s and stylemes, but, in some cases, precisely in its “eclecticism ”, in a diversity caused above a ll by the absence o f a theoretical reference, o f a “m anifesto” on which one's work could rely. Frits Peutz, who was born in Groningen in 1896 and died in 1974 in Heerlen, is one o f the most im portant representatives o f the above mentioned way o f m aking architecture and being an architect. He is an ever outdated architect; fo r this even though neither historians nor critics have ever understood the value o f such a presence.
A fir s t homage to the teachings o f Dutch functionalism (the “retirement home” o f1932) was follow ed in 1933 by the reconstruction o f the Schunck department stores, in the center o f Heerlen, in which the references to both Van der Vlugt's
voler esperimentare le possibilità di connettere forme archetipe locali con il linguaggio del classicismo con risultati non sempre felici. Il passaggio graduale ad un uso meno dogmatico del classico e ad una distanza dagli aspetti locali è contemporaneo ad un’attenzione per il discorso razionalista intemazionale e soprattutto per le elaborazioni teoriche e linguistiche dell’avanguardia del “de Stijl”.
Con il progetto per la “Casa di ritiro per anziani” (Reitraitehuis) del 1932 alla periferia di Heerlen, Peutz apre la sua architettura e forza l’ingresso del moderno nella tradizione culturale dell’architettura del Limburgo. Si tratta però di un linguaggio moderno che si manifesta metaforicamente, sia come astrazione e funzionalità sia come tettonica e composizione. I volumi e i rapporti formali in questo edificio rimandano alle prime opere razionaliste di Van der Vlugt con l’aggiunta determinante di elementi compositivi ed “ornamentali” come il portico, le finestrature della cappella e la torre, che per
mettono una lettura delle diverse componenti e dell’insieme in una prospettiva storica, in una continuità di rapporto tra l’oggetto e lo sviluppo della disciplina.
A questo primo omaggio all’insegnamento del razionalismo olandese segue nel 1933 il progetto per la ricostruzione del magazzino Schunck nel centro di Heerlen, in cui i riferimenti all’architettura di Van der Vlugt e della fabbrica Van Nelle sono più che palesi. Questo non solo nella tecnica costruttiva dei pilastri portanti a fungo con solette in cemento armato senza travatura, ma anche nelle chiusure delle facciate con un curtain-wall in vetro continuo e nella “bomboniera” sul tetto dell’edifìcio. Questa architettura entra nella città storica e impone la sua presenza proprio per la sua trasparenza, per il suo essere metafisico. Un’esperienza radicale di un’architettura assente a cui risponde in modo diretto, anche per la sua vicinanza nel centro urbano, il progetto per la sede del Municipio.
• •
Il concorso per il Palazzo delle Nazioni Unite a Ginevra del 1927, dà a Peutz la possibilità di confrontarsi con l’architettura intemazionale. Non è forse azzardato affermare che proprio la diversità delle proposte architettoniche nel concorso, la cacofonia del linguaggi, confermino all’architetto olandese il valore di una posizione individualistica ed eclettica continuamente tesa a sperimentare con materiali preesistenti.
Dalla composizione anodina e rigidamente razionalista di alcune ville, Peutz passa al linguaggio romanico, monumentale e decorativo di una serie di chiese in cui si sentono maggiormente gli influssi del romanico tedesco e del regionalismo olandese che non quelli del classicismo nordico. Nel 1936 Peutz ha l’incarico di
progettare la sede del Municipio di Heerlen in un lotto di terreno tra il centro storico e i resti delle antiche terme romane. Negli studi che precedono il progetto definitivo, Peutz ripercorre a ritroso tutte le più significative tappe dell’architettura olandese ed europea e, senza remore, sperimenta linguaggi, tecniche compositive, materiali, tipologie e temi decorativi ed ornamentali in cui la dialettica tra figurativo ed astratto, tra storico e moderno, gioca un molo determinante.
In quel periodo di “sofferenza” dell’architettura europea, Peutz in Olanda, come Terragni in Italia, Bonatz e Hàring in Germania, As- plund in Svezia, tende a raggiungere nell’opera architettonica quella sintesi tra continuità e rinnovamento che non era più di attualità in
architecture and Van Nelle's factory are quite obvious, not only in the building technique o f the mushroom-shaped bearing pillars w ith reinforced concrete girderless ceilings, but also in the continuous glass curtain w all covering the
facades, as well as in the “candy box" on the building's roofIn 1936 Peutz was to p lan Heerlen's Town H all on a site
located between the historical center and the remains o f an ancient Rom an bath. In the studies preceding the fin a l plan Peutz runs back through a ll the most significant stages o f Dutch and European architecture and he experiments w ithout any restraint on languages, compositional techniques, materials, typologies and decorative themes in which the dialectis between representation and abstraction, historical and modern plays a determining role.
It is not by chance that Peutz's Town H all plan is concomitant w ith his idea o f realizing an Architectural A tlas, a study on Orders and Styles, on ornamental elements and classical buildings and typologies, a work that absorbs him during the war years.
A fter the war, Peutz retraces some stages o f his history, constantly going back, in the end, to his own Town Hall,
1, 2, 3 Veduta della facciata verso il centro e dei due fronti laterali dell’edificio negli anni quaranta.4, 5, 6 Pianta del secondo livello, del primo livello e sezione longitudinale. Il progetto sarà poi modificato durante il cantiere: in particolare non sarà realizzato il portico della facciata verso il centro.7, 8 Disegno di studio e foto della grande hall di ingresso negli anni quaranta. (Foto d’Oliveira.)
1, 2, 3 Views o f the facade facing the centre and o f the two side elevations, in the forties.4, 5, 6 Secondfloor plan, firs t floor plan, longitudinal section. The drawings w ill be later m odified during construction: most importantly the porch on the facade facing the centre w ill not be realized.7, 8 Study sketch and photograph o f the m ain entrance hall, in the forties. (Photo d ’Oliveira.)
8
which remains the touchstone fo r measuring the value o f all his other plans, all o f which confirm the strength o f an architecture whose goal is not the solution o f historical contradictions, but to accept them by encompassing them through a compositional and technical research whose language is always historical defined, though autonomous as
fa r as contingent schemes and models are concerned. This the reason why his is an architecture one can always refer to, outside o f any judgem ent on its ideological value, fro m which he is constantly withdrawing.
quanto al rinnovamento tout court del funzionalismo aveva risposto la radicalizzazione della tradizione e del monumentalismo nell’architettura di regime. Nel Municipio di Heerlen invece si riscopre ora il valore di testimonianza di un dialogo tutto interno all’architettura, legato dunque alle forme ed ai materiali, alla composizione ed alle tipologie, aH’omamento e alle tecniche costruttive.
La distanza dall’attualità politica e culturale, non sfocia però né in posizioni reazionarie né utopiche ma in un non-conformismo che si configura in un’architettura metafisica ora segnata da rimandi e memorie. Non è casuale che il progetto del Municipio sia parallelo all’idea di Peutz di realizzare un Atlante dell’Architettura, uno studio degli Ordini e degli Stili, degli
elementi ornamentali e di edifici e tipologie classiche, a cui egli lavora intensamente negli anni della guerra.
Nel dopoguerra Peutz ripercorre alcune tappe della sua storia ritornando però alla fine sempre al Municipio, che rimane la cartina di tornasole per misurare il valore dei diversi progetti. Progetti che stanno tutti a confermare la forza di una architettura che non si pone come fine la risoluzione delle contraddizioni storiche, ma che le accetta e le ingloba in una ricerca compositiva e tecnica in cui il linguaggio è sempre storicamente definito ma autonomo rispetto a schemi e modelli contingenti. Per questo si tratta di una architettura a cui si può sempre far riferimento al di fuori di un giudizio di valore ideologico da cui essa continuamente si ritrae.
1 M u n ic ip io di H eerlcn. Veduta aerea dell’edifìcio negli anni cinquanta. N el corso degli anni F.P.J. Peutz elaborò una serie di progetti per la sistem azione definitiva della piazza.1 T o w n -b a ll o j H eerlen . A e r ia l v ie w o f the b u ild in g in the fiftie s . F .P .J. P e u tz e la b o ra ted a series o fp ro jec ts fo r the defin ite design o f the p ia z z a .
42
i
-iMLUM
2
2 Progetto per una cappella, 1940. 2 P roject f o r a chapel\ 1940.
3
3 Progetto per il n u ovo teatro, 1949.4 Progetto per la cappella della Pace, 1952.3 P roject f o r the n ew thea tre , 1949.4 P roject f o r the ch a p el o f Peace, 1952.
J.J.P. OudL’architettura nel sudD e Groene, 14 giugno 1947
E stato trovato talvolta un legame tra l’architettura tipica della Scuola di Delft ed il cattolicesimo; il che non è strano, dato che lo stesso professor Granpré Molière, l’anima della Scuola di Delft, ha dato m otivo al formarsi di questa convinzione con le sue dichiarazioni ed i suoi scritti. H o sempre notato in me stesso una resistenza istintiva ad accettare tale legame, ma anche razionalmente, malgrado lo sforzo personale ad essere aperto verso questo ragionamento, non sono mai riuscito a capire in quali aspetti si potesse individuare detto legame.La mia impressione quindi era e rimane quella che si trattasse di un desiderio personale, conseguenza di un’impostazione puramente soggettiva, piuttosto che di una oggettiva conclusione in seguito a considerazioni e fatti concreti. [...] Quando partii per il sud del nostro paese, mi aspettavo, per quanto riguarda le mie convinzioni sulle tendenze architettoniche, di giungere nella tana del lupo. Invece fui felicemente sorpreso quando già subito dopo il mio arrivo feci conoscenza con alcuni autorevoli colleghi, cattolici convinti, che si opponevano duramente, com e me, alla Scuola di Delft e che per di più si seccavano seriamente all’idea di essere considerati appartenenti a questa Scuola solo per il fatto di essere cattolici. Il nostro Limburgo, dicevano, vogliamo tenerlo vivo. I falsi discorsi sui rapporti tra la Scuola di Delft ed il cattolicesimo ci annoiano da molto tempo. Non abbiamo bisogno di tali teorizzazioni. Vogliam o costruire senza discorsi, semplice- mente come ci pare ovvio, e non siamo disposti ad inchinarci al passato con lo scopo di impedire al presente di svilupparsi. Anche noi sappiamo fare qualcosa. I tentativi (che mi fecero poi vedere) per dare all’architettura un nuovo impulso, realizzati soprattutto con l’aiuto del clero locale, mi riempirono di speranza e di fiducia che in questa parte del nostro paese la tendenza conservatrice del vecchio stile non avrà molte possibilità e che potrem o attenderci ancora delle nuove espressioni. [...] Durante il proseguimento del m io viaggio arrivai tra l’altro a Heerlen dove si poteva visitare un edificio che appartiene alle opere in costruzione nel Limburgo. Era il palazzo comunale, progettato dall’ing. Peutz, che si avvicina lentamente e faticosamente alla sua realizzazione. Sapevo dei progetti di questo edificio e mi era noto che i lavori erano da m olto tempo avviati. Eppure mi trovai un attimo stupito quando lo vidi nella realtà. Devo confessare che l’esterno mi poneva alcuni problemi. Vorrei approfondirli per tentare di giungere ad una migliore comprensione di alcuni aspetti: di questi tempi si viaggia di solito troppo velocemente per avere il tempo di penetrare fino al nocciolo di un’opera. Perora quindi mi limito a dirvi che fu una bella esperienza vedere che un’idea talmente diversa dalle tendenze tradizionali (mi sembrava persino di notare un’influenza di Mondrian) abbia prodotto un’architettura perfettamente inserita nel suo ambiente. Si potrebbe addirittura parlare di un’architettura che soddisfa le “caratteristiche regionali”, a condizione di lasciare fuori considerazione il concetto tradizionale di “caratteristiche regionali” e di limitarsi all’essenziale. Entrando nell’edificio fui immediatamente affascinato dall’aspetto imponente e grandioso di questo palazzo comunale comunque non tanto grande. In fondo non conosco nessun palazzo comunale dove l’idea de
mocratica, 1’“essere libero e nello stesso tempo inserito nella collettività”, venga espressa talmente in tutta l’atmosfera come in questo edificio cosiddetto “neorazionalista”. Vi è così poca divisione e separatezza tra gli spazi pubblici e la parte di rappresentanza di questo palazzo comunale che quasi non si sa se ci si trova al pianterreno o su un piano rialzato: talmente graduale è il passaggio dall’uno all’altro. [...] Diversità di livello, non divisione. Una scala senza ringhiera larga alcuni metri, quasi come una strada, collega il pianterreno e il piano superiore: un’immagine impressionante. Una scala che possa svolgere anche il molo di anfiteatro per il pubblico che ascolta il discorso del sindaco in occasioni particolari. Di fronte a questa scala, nel mezzo, si trova in basso la stanza del sindaco con una bella entrata, mentre in alto una maestosa finestra, divisa in modo semplice e ordinata ritmicamente da alcune colonne rotonde di ferro, lascia penetrare generosamente la luce del sole. I pavimenti e la scala sono di lastre di pietra nera. Robuste colonne cilindriche con fini- tura in alto nello stile Mushroom supportano il soffitto. Ben costruite e funzionali le lampade che procurano l’illuminazione serale. [...] Un edificio nel quale riflettiamo con piacere sulla libertà che abbiamo nuovamente conquistato e che ci rende possibili tali espressioni. Non convenzionale, ma un’opera veramente olandese di ampie vedute: dà direttamente forma ai bisogni del nostro tempo. Chi è dell’opinione, come i signori della Scuola eli Delft, che oggi la realizzazione di un edificio che sia caratteristico del presente sia impossibile, vada a vedere questo palazzo comunale a Heerlen. E un esempio edificante anche perché prova che la rigidità, talvolta notata in opere di colleghi meno validi della Nuova Architettura, non ha niente a che vedere con i principi di questa Nuova Architettura. Questo palazzo comunale, comunque, per quanto possa essere generale la tendenza della sua concezione architettonica, è tipico del Limburgo. In Olanda sarebbe stato fatto in un altro modo. Soprattutto all’esterno (il che è normale negli edifici: l’interno è sempre più neutrale nei confronti dell’ambiente naturale dell’esterno) si può notare la “caratteristica regionale” che ho già menzionato. Ma — e desidero sottolinearlo — senza fare alcuna concessione all’immagine stereotipa che questa parola evoca. Questo edificio è un sano argomento contro i luoghi comuni che gli avversari della Nuova Architettura usano esprimere circa il livellamento operato dalla Nuova Architettura. Mi è stato reso chiaro durante il soggiorno nel Limburgo che i nostri compatrioti del sud hanno condiviso pienamente le nostre angosce durante l’inverno della fame e che volevano quasi attaccare gli alleati quando la liberazione del nord veniva ritardata per questioni tattiche. Ho sentito un simile profondo legame nord- sud nel quadro della Nuova Architettura. Possiamo ricevere molto appoggio da parte di questi coraggiosi colleghi del sud per la ricostruzione del nostro paese con uno spirito fresco di un tempo nuovo. Vi ho trovato molto meno scoraggiamento architettonico e rassegnazione rispetto al nord. Che anche questo fatto ci possa indurre a tentare di realizzare la nostra ricostruzione come un’immagine degna delle nostre capacità, anche nei tempi bui che abbiamo vissuto e che viviamo ancora. Facciamo in modo che le prossime generazioni ci possano essere riconoscenti e ci possano prendere come esempio, come noi abbiamo presente i nostri vecchi esempi. Per impararne! non per copiare!
4
Modehuis Schunck, Heerlen 1933 5 L’edificio sorge nel centro della città, accanto alla piazza del mercato e ad una antica chiesa. Oggi risulta notevolmente trasformato, in particolare nelle facciate.6 L’edificio negli anni trenta.(Foto Mantz.)
5 The building is in thè city centre, next to the M arket Square and to an old church. It is today substantially different, particularly in thefagades.6 The building in the thirties.(Photo M antz.)
6
Questo grande magazzino di abbigliamento è situato tra la piazza della chiesa e il mercato, in un punto in cui nel Medioevo sorgevano le mura della città che circondavano l’antica chiesa romanica. Progettato come estensione del vecchio magazzino, divenne un edificio autonomo collegato al precedente mediante una struttura a ponte. Schunck, il proprietario, originariamente vendeva partite su campione, ma nel 1933 decise di riorganizzare l’attività e di vendere su esposizione, come al mercato. Il nuovo edificio è una costruzione in cemento armato con pilastri a forma di fungo e una facciata in vetro a cortina indipendente dai solai, che ha reso possibile una ventilazione
naturale grazie a finestre apribili poste in cima alla fenditura tra i solai e la facciata, creando così un effetto camino controllabile. L’edificio ha due piani sotterranei per magazzinaggio e impianti, uno spazio principale di vendita, alto due piani, al pianoterra, con un corridoio di vetrine e un mezzanino per gli uffici; gli altri piani sono spazi adibiti alla vendita, tranne l’ultimo che è occupato da un laboratorio di sartoria. In cima al negozio, che si trova nel centro della città, sorge un attico a due piani per il proprietario, dalle cui terrazze con giardino si gode una bellissima vista.
This outfitter's store is situated between the church square and the market-place, where in the Middle-ages the city wall, that encicled the old Romanesque church, was situated.In fa c t planned as an extension o f the old store, it became an autonomous building, linked to the old store by bridge-like structures.In form er times Schunck, the owner, sold out o f stock from sample, but in 1933 he intended to reorganize and sell from display, like on the market. The new building is a concrete mushroom construction w ith a free
from the floors hanging glass-curtain fagade, which makes natural ventilation fo r climate control possible by means o f openable windows on top o f the slit between the floors
and the fagade, thus creating a controllable chimney-effect. The building has two basement levels fo r storage and installations, a two stories high m ain selling space on the ground level, w ith a passage o f showcases and a m ezzanine office level; the other floors are selling spaces, except the top flo o r which is a sewing atelier.On the top o f this store, in the city center, a two story penthouse fo r the owner is situated, whose roof garden and terraces have a magnificent view on the surrounding city.
44
1, 2 Foto d’epoca (foto Mantz) e stato attuale dei magazzini Schunck.3 Prospettiva di studio della struttura portante.
1, 2 Period photograph (photo M antz) and present condition o f the Schunck Department Stores.3 Study perspective sketch o f the load- bearing structure.
4, 5, 6 Vedute degli interni e del tetto, negli anni trenta. (Foto Mantz.)7 Veduta notturna dell’edifìcio negli anni trenta. (Foto Cohnen.)
8/11 Piante del piano sotterraneo, del piano terra, di un piano tipo e del tetto. 12 Sezione longitudinale.
4, 5, 6 Views o f the interior spaces and o f the roo f in the thirties. (Photo M antz.)7 N ight view o f the building in the thirties. (Photo Cohnen.)
8/11 Basement floor p lan , groundfloor plan , typical floor p lan , and roo f plan. 12 Longitudinal section.
10 11
r»» 7o • •
46
F.P.J. Peutz, ritratto, 1932.
1896 Nasce a Uithuizen, nel nord-est dell’Olanda. 1910-1914 Studi al collegio del monastero di Rolduc nel sud del Limburgo.1914-1916 Studi di ingegneria a Delft.1916 Studi di architettura a Delft.1919 Realizzazione del suo primo progetto. Inizia a collaborare come critico d’arte per i maggiori quotidiani.1920 Apertura del suo studio di architettura ad Heerlen.1924 Diploma in ingegneria e architettura. Matrimonio.1925 Laurea in ingegneria e architettura.1934 Mostra internazionale d’arte sacra a Roma.1936 XIV Triennale di Milano.1941-1944 Interruzione della sua attività professionale in seguito al rifiuto di entrare a far parte del “Kultuurkamer”. Lavora al suo “Atlante di disegni”. 1946-1950 Conferenze in varie scuole.1950-1961 Professore all’accademia Jan van Eyck di Maastricht.1953 Partecipazione alla Esposizione universale di Bruxelles con il gruppo di architetti Bakema, Boks, Van den Broek e Rietveld.1974 Muore dopo un lungo periodo di malattia.
T’' .. 1 ' . 3tc |ti
i l # Il* *
* M
■S........ " ' t Ài' OliDTH K A I lI t im V M II;
CR1 M yjO'jh-XHDM'
Cattedrale di Crema, rilievo, 1918-1919.| Cathedral o f Crema survey drawing, 1918-1919.
Scuola, Heerlen 1929.School, Heerlen 1929.
Casa di ritiro, Heerlen 1932 (“Casabella” 83,1934). Retirement Home, Heerlen 1932.
Casa Wijnands, Heerlen 1919. W ijnands House, Heerlen 1919.
Scuola, Heerlen 1931. School, Heerlen 1931.
Casa di ritiro, Heerlen 1932. Retirement Home, Heerlen 1932.
Wiel Arets e Wim van den Bergh L’indifferenza per lo stile
L’opera di F.P.J. Peutz1 occupa certamente una posizione unica nella storia del Movimento Moderno Olandese, da quando ne dissolse quell’aura di chiara definizione priva di contraddizioni, rivelatasi una storia fabbricata. Nel dibattito sull’architettura moderna, iniziato nei Paesi Bassi da Berlage, il tema centrale era la ricerca della verità, la questione relativa alla situazione del mestiere. Il dilemma nato dalla separazione tra arte e artigianato, così come dalla divisione degli elementi che componevano la professione dell’architetto, consisteva in un problema che, secondo Berlage, gli architetti moderni dovevano risolvere dall’interno della loro architettura. Per Berlage, tuttavia, ciò significava cercare la verità dall’interno del mestiere, nel rispetto dei valori permanenti che costituiscono la struttura fondamentale della disciplina architettonica, cosicché egli considerava tradizioni, esperienze, leggi e tecniche storiche come una preziosa proprietà collettiva.
Egli era il coraggioso e solitario ricercatore d’una sintesi opposta all’unilaterale punto di vi
sta analitico dei modernisti.Ma le idee di Berlage, a causa del loro in
treccio di razionalità e misticismo, non solo furono il punto di partenza di gruppi tanto diversi tra loro come De Stijl e l’Espressionismo di Amsterdam, ma anche di architetti isolati come Peutz. Mentre l’evolversi dei gruppi ben presto trasformò la discussione in una polemica a senso unico su principi d’ordine moralistico e stilistico, Peutz era libero e si sentiva responsabile unicamente del proprio mestiere, tanto che si rifiutò di abbandonare la propria architettura alla tecnica o all’arbitrarietà speculativa delle mode. Lontano da quel dibattito, Peutz parlò, oltre che nei suoi saggi sull’arte, solo attraverso la sua architettura. Riconobbe la separazione tra arte e professione in tutta la sua chiarezza positivistica e scorse la concreta possibilità di affrontarla nell’assunzione dell’architettura come un mestiere. Pensava a se stesso come a un artigiano che doveva servire gli uomini del suo tempo, e così sapeva che la bouwKunst (con la K maiuscola) esisteva.
Scuola, Heerlen 1921. School, Heerlen 1921.
Cementificio ENCI, Maastricht 1927. Cement factory E N C I, M aastricht 1927.
Concorso per il Palazzo delle Nazioni, Ginevra 1927. Competition entry fo r the Palace o f N ations, Geneva 1927.
Casa di Peutz, Heerlen 1931. Peutz's House, Heerlen 1931.
Scuola, Heerlen 1931. School, Heerlen 1931.
Chiesa, Berg en Terblijt 1931.Church, Berg en Terblijt 1931.
Casa “solare”, Maastricht 1933. “Solar” House, M aastricht 1933.
Casa “solare”, Maastricht 1933. Magazzini Schunck, Heerlen 1933 (“Casabella” 113,1937).“Solar” House, M aastricht 1933. Schunck Department Stores, Heerlen 1933.
Tra gli architetti della sua generazione possiamo considerarlo come il più interessato alla storia dell’architettura, con la quale aveva la più grande dimestichezza. Sapeva di far parte di quella storia, sulla quale si potevano esprimere giudizi solo attraverso l’evoluzione del presente. La sua architettura è radicata nella storia non grazie a una transitoria imitazione di forme storiche, ma attraverso la ricerca dell’essenziale, della verità. Proprio come la storia è presente nelle opere migliori dei moderni, la sua architettura parla dei principi eternamente validi della bouwKunst. Era un maestro costruttore, un architetto tout court, la cui opinione personale era sempre dettata da una risposta alle domande con le quali si scontrava, una risposta formulata dalla sola architettura. Possiamo considerare la posizione di Peutz come una delle più critiche nei confronti sia del moralismo ricorrente dei movimenti architettonici degli anni venti e trenta, sia del loro ottimismo sulla possibilità che l’architettura insegnasse nuovi modi di vivere alla società. In contrasto con il desiderio di
assoluto dei suoi contemporanei, il suo pensiero illuminato probabilmente formò una base più ampia ai problemi architettonici del suo tempo, in cui scorgeva l’abbandono della realtà. Dal suo punto di vista efficienza e funzionalità erano evidenti, ma non lo era il tema principale dell’architettura, e conseguentemente ogni tipo di dottrina funzionalista o meccanicista doveva essere respinto. Per lui l’unica vera architettura era quella che definiva i propri valori e qualità traendoli dalla propria disciplina, cioè dal mestiere. Non solo aveva una forte personalità con una vasta conoscenza costruttiva, un gusto raffinato e una versatile abilità artigianale ma, come si può vedere dalla sua folta biblioteca e dalle note contenute nei suoi libri, era anche un intellettuale erudito e dotato di senso critico: la sua bibliografia spazia dagli scritti basilari sulla nuova architettura di A. Schmar- sow, O. Wagner e H.P. Berlage alle teorie sull’arte di H. Wòlfflin, A. Riegl, W. Worringer e K. Scheffler, da un’ampia lista di trattati filosofici agli antichi scritti di Palladio, Vignola,
Scamozzi, Filarete e Alberti.Il razionalismo connaturato di Peutz rivela
una profonda comprensione spirituale dell’architettura. Il problema dell’architettura è inseparabile dal problema dell’essere. L’architettura non solo deve servire la vita in modo pragmatico, ma anche in modo spirituale: dev’essere la portatrice dell’idea che tocca tutti i livelli dell’esistenza. Per Peutz l’architettura è sempre l’espressione di decisioni spirituali. Solo un’architettura basata su rapporti spirituali — definiti dal punto di vista razionalista come bouwkunst in cui l’idea trasforma la necessità e dove verità e logica rappresentano il primato della forma — dà all’edificio stesso la necessaria autonomia che lo difende dalle influenze esterne. Paradossalmente, un edificio può essere architettura solo quando possiede una propria personalità senza avere bisogno di riferimenti esterni per conquistarsi un significato. L’architettura di Peutz non ha valore di manifesto, ma offre risposte concrete a circostanze mai assolute, ed è in ciò che può acquistare una qualità metafisi-
Banca St. Pancratius, Heerlen 1936. St. P ancratius B ank, 1936.
Negozio Tissen, Heerlen 1939.Tissen shop, Heerlen 1939.
Chiesa, Heerlen 1951.Church, Heerlen 1951.
M unicipio, Heerlen 1936-1942.Tow n-hall, Heerlen 1936-1942.
Cappella della Pace, Heerlen 1952 (progetto). Chapel o f Peace, Heerlen 1952 (project).
ca. Non è un’architettura eterna, ma un’architettura la cui potenza è celata nelle sue qualità generative, quelle che conferiscono una più profonda dimensione al momento della sua esistenza, un’architettura che crede fermamente nella storia architettonica e nel futuro. Il suo centro filosofico è la ricerca dell’essenziale, la ricerca di un’assiologia, poiché i problemi decisivi che l’architetto deve affrontare stanno nell’orbita dei valori. Per Peutz non si tratta soltanto di un semplice scambio di vecchi con nuovi valori, ma del perseguimento delle loro contraddizioni ai livelli più alti: non lo scambio, ma la loro sintesi costituisce l’idea espressa nelle apparenti contraddizioni delle sue opere create simultaneamente nello stesso periodo. Da un lato lavoro e professione, arte e stile dall’altro sono i temi caratteristici del pensiero di F.P.J. Peutz e della sua architettura. Uno dei suoi tratti più cospicui, a differenza dei suoi contemporanei, fu l’indifferenza per lo stile. Afferrava tutte le possibilità del repertorio degli stili e in tal modo respingeva fin dall’inizio ogni
Chiesa, Meyel 1952.Church, M eyel 1952.
critica formale al suo lavoro. Peutz usava lo stile architettonico nello stesso modo in cui usava le tecniche e i materiali; amava la combinazione e la sovrapposizione dei materiali e degli stili, delle tecniche, dell’ingegneria e della storia. Non è dunque difficile capire che le opere di Peutz e, più tardi, quelle di J.J.P. Oud, ponevano difronte ai problemi di stile il corpo dell’architettura, fossero considerate dai modernisti ostruttive e reazionarie. L’opera completa di Peutz riflette la definizione di verità di S. Tommaso d’Aquino, secondo la quale “l’intelletto coincide con l’oggetto”, che egli spesso citò; non v’è distinzione tra sapere e rare e l’architettura è vista come un’espressione di cultura.
L’enorme quantità di prospettive che disegnò può esser vista come una ricerca in cui — come il pittore olandese Willem van Konijnen- burg che egli ammirava — cercava la natura insita nell’ordine e nella concezione degli elementi che gli procuravano emozione. Peutz scrisse numerosi saggi sul lavoro di quel pittore, amato da Berlage per il “carattere architettonico”, co-
Palazzo per uffici LTM, Heerien 1953.L T M office building, Heerlen 1953.
me lo chiamava, dei suoi quadri. “Adaequatio intellectus et rei”: in questa definizione tomistica della verità l’ordine pratico e l’ordine spirituale s’identificano e in questa identità sono radicati l’unità di pensiero e l’oggetto, l’idea e la cosa. È pure il concetto platonico e agostiniano della rivelazione estetica della verità che Peutz condivide con Van Konijnenburg: la bellezza non è una creazione soggettiva dell’individuo ma lo splendore della verità, la realtà ontologica. Il principio di creazione e di progettazione dev’essere indirizzato verso la liberazione delle cose sì da trasformarle in elementi d’un ordine che dia alle parti un significato più alto. Per Peutz un’architettura di rapporti spirituali doveva trascendere l’ordine del costruire stesso. E questo egli chiamò “il più” (l’anima o la bellezza) che si rivela soltanto se l’architettura è Kunst, dove bouwen (costruire), scrisse, è Kunst (l’arte) di comporre o di edificare. È questo profondo rispetto “religioso” per le cose e i materiali che si rivela nell’abilità artigianale e nel trattamento perfetto della materia fin nel più
M unicipio, Heerlen 1936-1942. Tow n-hall, H eerlen 1936-1942.
Atlante di disegni, 1941. A tla s o f drawings, 1941.
Cinema Royal, Heerlen 1937. Cinema Royal, Heerlen 1937.
Deposito V&D, Heerlen 1948 (distrutto). V Ó 'D Depot, Heerlen 1948 (destroyed).
Dormitorio, Heerlen 1954-55. Dormitory, Heerlen 1954-55.
piccolo dettaglio.È naturale che Peutz e Van Konijnenburg
nutrissero un grande affetto per quella regione collinosa che sta nel sud dei Paesi Bassi, che entrambi descrissero come “italiana” e in cui scoprirono la verità nell’infinita complessità delle possibilità di vita espresse in questo naturale e bellissimo paesaggio. In questo paesaggio analogico gli edifici ai Peutz possono esser visti come un tentativo di definire il paesaggio fisico e culturale della città e dei dintorni dfquesta. La sua città è Heerlen, un’antica città romana vicina ai confini con la Germania e con il Belgio, che, durante la sua vita attiva, era il centro dell’industria mineraria olandese. Oltre ai noti esempi di storia architettonica, furono i progetti industriali per le miniere di carbone e l’architettura rurale a formare le immagini dominanti della sua architettura. In questo paesaggio urbano molti dei suoi edifici, da punti di riferimento diventano elementi di memoria nella simultaneità e nella presenza concrete della città. È questa ricerca dell’essenziale nel concetto di or-
Municipio, Tegelen 1938. Town-hall\ Tegelen 1938.
Grande magazzino Kneepkens, Heerlen 1939. Kneepkens Department Stores, Heerlen 1939.
Scuola, Maastricht 1948. School, M aastricht 1948.
Teatro, Heerlen 1949 (progetto). Heerlen Theatre, 1949 (project).
49
dine — il recupero del significato della città e della sua architettura, così come lo scopriamo nell’opera di Peutz — che costituisce il risultato raggiunto dal classicismo nel suo sviluppo storico, una ricerca basata non sulle metafore di natura o di macchina, ma sull’idea di cultura.X *
E un’opera vasta in cui ogni progetto è un edificio unico, come, per esempio, il municipio di Heerlen, i grandi magazzini Schunck, il cinema Royal, la casa di ritiro o la sua propria casa. Ogni edificio costituisce un momento autonomamente architettonico della realtà. Nella sua tendenza a non identificare lo stile con l’etica, né a vedere la tecnica come una condizione restrittiva, egli era libero di usare tutte le variazioni che le diverse situazioni permettevano, perché la sua idea di architettura era univoca, architettura come mestiere, in cui l’architetto doveva usare gli strumenti e i materiali architettonici disponibili con logica e sensibilità. Possiamo considerare tale atteggiamento come uno dei tratti essenziali della modernità di Peutz e in questo senso possiamo chiamarlo un classici
sta-moderno che non appartiene ad alcun gruppo o movimento olandese particolare, ma la cui opera potrebbe esser paragonata, meglio che a qualunque altra, all’architettura di un Loos.
In Peutz i Paesi Bassi hanno un maestro costruttore che considera l’architettura come il suo mestiere, in cui la ricerca della condizione umana fondamentale è fondata sia sugli elementari concetti universali di architettura e sia sulla sua personale creatività d’artista e di artigiano.
Nota1 Cfr. F.P.J. Peutz architekt 1916-1966, a cura di Wiel Arets, Wim van den Bergh, William Graatsma, Eindhoven 1981.
Vittorio Gregotti Lo spettacolo delle consultazioni Displays and consultationsKenneth Frampton N el paesaggio luganese: cinque opere di Mario Campi e Franco Pessina In the Lugano landscape five architectures by M ario Campi and Franco PessinaBernardo Secchi Immaginare la città. 1 Imagining the c ity . 1Mirko Zardini, Johannes Voggenhuber, Luigi Snozzi Dalla città alla rocca: un concorso a Salisburgo From the city to the rock: a competition in SalzburgArgomenti NewsW iel Arets e W im van den Bergh, S. Umberto Barbieri Modernità ambigue: l’opera ai F.P.J. Peutz Ambiguous modernities: the work o f F.P.J. PeutzSilvia Milesi Architetti per gli anni futuri Trenta progetti lungo l’A m o Architects fo r future
years Thirty projects along the A m oJacques Gubler Cartolina 47 Postcard 47
ISBN
88-
289-
0234
-5
Casabella 534
A nno L I1987 A prile /A prii
R ivista internazionale di architettura International Architectural Review
DirettoreVittorio Gregotti Assistente Pierre-Alain Croset RedazioneSebastiano Brandolini, Silvia Milesi, Mirko ZardiniCoordinamento di redazioneAda Myriam Tosoni Segreteria Gisella Forni Grafico Flavio Ranzini
Redazione immaginePierluigi Cerri Redazione esternaJean-Louis Cohen Jacques Gubler Massimo Scolari Bernardo Secchi
Traduzioni in italiano d i d o n i Carpi, E S Assistance English translations by d o n i Carpi and Sebastiano Brandolini
Electa Periodici srlPresidenteMassimo Vitta Zelman Direttore generale Giacomo Pedersini Direttore editoriale Furio Lettich Gestione e diffusione Sergio Vergarli Coordinamento tecnico Gianni Manenti
Direzione redazione amministrazione abbonamenti20134 Milano - via D. Trentacoste 7 tei. 02/215631 (10 linee r.a.) telex 350523 ELEPER 1
Rivista mensile, spedizione in abbonamento postale gruppo III/70.Registrazione presso il tribunale di Milano n. 3108 del 26 giugno 1953.Iscritto in data 5.5.1983 n. 00889 - voi. 9 foglio 705 al Registro Nazionale della Stampa, Div. X, Roma.Direttore responsabile: Vittorio Gregotti
Prezzo di un numero: 9.000 lire.Arretrati: i numeri arretrati vanno richiesti a: Edizioni Electa - via D. Trentacoste 7 - 20134 Milano inviando anticipatamente il doppio del prezzo di copertina. Abbonamento per l’Italia annuale (10 edizioni): 85.000 lire.Abbonamento per l’estero annuale:150.000 lire ($ 110).Pagamento anticipato a mezzo assegno o d e postale n. 42446203 intestato a:Edizioni Electa s.p.a. - Milano.L’abbonamento andrà in corso, salvo diversa indicazione, dal primo numero raggiungibile e può avere inizio in qualsiasi periodo dell’anno.
Concessionaria esclusiva per la pubblicitàG.S.E. - Gestioni S.P.E. Electa20134 Milanovia D. Trentacoste 7tei. 02/2141316telex 350523 ELEPER IDirettore Gianni SacerdottiPromotion Gilda BojardiMilano:Adriana Aureli, Wanda Braggion,Giuliana Fachini, Adriana Pettorali,Alessandra Guja PrioraVito Bracciodieta 70121 Bari - via Sparano 106 tei. 080/214578 Angelo Franceschini 40121 Bologna - via Parigi 2 tei. 051/229569 Rossana Galli50131 Firenze - via Galvani 1 tei. 055/580574 Luciana Giacon35121 Padova - via C. Battisti 29 tei. 049/655187 La Rosa Pubblicità28040 Massino Visconti (NO) - via Belvedere 8tei. 0322/59065Virginio Omiccioli61032 Fano (Pesaro) - via Galantara 1tei. 0721/84627Antonella Crifò - Silvano Tuzi00198 Roma - via Alessandria 26tei. 06/8449111
Distribuzione per l’ItaliaMessaggerie Periodici SpA aderente A.D.N.20142 Milano - viale Famagosta 75 tei. 02/8467545
Esclusiva di vendita per l’esteroA.LE. Agenzia italiana di esportazione 20151 Milano - via Gadames 89 tei. 02/30.12.200 - telex 315367 AIEMII
StampaFantonigrafica Printed in Italy
Copyright © 1987 Electa SpA
2 Vittorio GregottiLo spettacolo delle consultazioni / Displays and consultations
4 Mario Campi, Franco PessinaNel paesaggio luganese: cinque opere In the Lugano landscape: Jive architectures presentazione di Kenneth Frampton
12 Bernardo SecchiImmaginare la città . 1 / Imagining the c ity . 1
14 Mirko ZardiniDalla città alla rocca: un concorso a Salisburgo From the city to the rock: a competition in Salzburgcon uno scritto di Johannes Voggenhuber e un’intervista con Luigi Snozzi
26 Argomenti / NewsIn breve (26)Francesco Tentori, Autoanalisi di una città: Milano Zone (26)Bruno Pedretti, Un libro eterodosso: l’arte moderna di Schapiro (28)Omelia Selvafolta, Egualitarismo e autoemancipazione: case del popolo (29) Enrico Filippini, Storia e storie dei primi moderni (31)Herman Hertzberger, SOS per l’Orfanotrofio di Aldo van Eyck (32)Martin Pawley, Da Londra: per la New Charing Cross, diritti d ’aria sui binari (35)
36 Wiel Arets e Wim van den BerghModernità ambigue: l’opera di F.P.J. Peutz Ambiguous modernities: the work o f F.P.J. Peutz con uno scritto di S. Umberto Barbieri
50 Architetti per gli anni futuri Trenta progetti lungo l’ArnoArchitects fiorfuture years Thirty projects along the A m opresentazione di Silvia Milesi
64 Jacques GublerCartolina 47 / Postcard 47
Innovazione edilizia. Rivestimenti per esternoa cura di Giampiero Bosoni e Fulvia Delfino con il coordinamento tecnico del Centro Edile
In copertina, pianta d i Torino, incisione anonim a su disegno (1674) d i G iovanni Tommaso Borgonio (da Theatrum Sabaudiae, Voi. I, a cura d i Luigi Firpo, C itta d i Torino - Archivio Storico, Torino 1984). Torino è una delle città oggetto dell'esposizione “Le città immaginate: un viaggio in Italia. N ove progetti per nove città” alla Triennale d i M ilano.
L'im m agine riprodotta sulla copertina deln. 531-532 d i “Casabella”, monografico dedicato a Le Corbusier, è stata tratta dal libro d i Jean Petit, Le Corbusier lui-mème. Editions Rousseau, Geneve 1968.