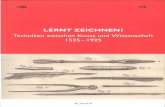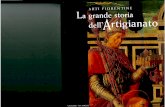Fiorentini, Erna: Scambio di Vedute : lo sguardo sulla natura e la camera lucida tra i paesaggisti...
Transcript of Fiorentini, Erna: Scambio di Vedute : lo sguardo sulla natura e la camera lucida tra i paesaggisti...
?.
Fä
),*rfi
,'t
]1
latuoqlz oulNl puB uralrapug zusro'I
nlueS Qluasleurl{ eqt JoH}srlc eq] Euunp eIIIou ur
Er{f,xg lBruf,elle}q putr f,l}sluY
I{OIIYTOSI dO SNTOIISId&*
1,
I t?.
"* ,
I
. .',,,: ll::i,f
.dc1 pallpa
Provided for non-commercial research and education use. Not for reproduction, distribution or commercial use.
Author's personal copy
ANALE,CTA ROMANA INSTITUTI DANICI
Supplementum XXXWIFictions of Isolation
edited byLorenz Enderlein and Nino Zchomelidse
Artistic and Intellectual Exchangein Rome during the First Flalf
of the Nineteenth Century
Papers from a conference heldat the Accademia di Danimarca
Rome, 5-7.fune 2003
..L'ERN/L\', di BRETSCHNE,IDER
ROMAE MM\II
Provided for non-commercial research and education use. Not for reproduction, distribution or commercial use.
Author's personal copy
Contents
PrefaceLorenz Enderlein and Nino Zchomelidse
La "maestit" internazionalc di Roma tro, motiui lettuari e politica d,ella scienza,: spunti prin.cipalmente
tratti da Mme de Staäl e Wilhelm xon HumboldtPierangelo Schiera
Le mostre in Campidoglio durante il periodo napoleonico..Susanrre Adina Merer
Gius eltp e Melc hioni do,ll' an tiquaria alla stori aGiuseppe Izzi
The biench and German Debate on "Allegory" in the l9tt' Centun: Allegory and Stmbol in the
Works oJ Wiedewel| Carstens and ThorualdsenF,lse Marie Bukdahl
Ingt"es and the |{azarenes: A Historiographical Stu$...Mitchell B. Frank
Die schwierige Gebuft eines Bildtheologen: Klassizismus a,ls formale Option im Frühwerh Joha,nnFrietl;rich Ouerbecks
Michael Thimann
"Wie der Faden in einem reichen Blumengezuinde": ZtLr AusJb'rmung des Historienbildes beiJulius
Schnon uon Cnrolsfeld ................Lorenz Enderlein
Hippolyte Fkrndrin und die Erneuerung der christlichen Bildsprache: Ein Vergleich mit den
cleutschen lr{azarennn.. 149
Sabine Fastert
Der Salone Rosso lm spanischen Priesterkolleg aon Santa Maria di Mon.seryato: Religtöse Kunstztu is c hen l{ ati o n ali s mu s un d rö mi s c h er Tr a d,it i on t67A-ngela \Vindholz
Scambio di Vedute: lo sguarrlo sulla natura e la camera lucida tra i paesaggisti internazionali a
Roma intorno al 1820 195
Erna Fiorentini
t7
29
49
59
67
79
97
Provided for non-commercial research and education use. Not for reproduction, distribution or commercial use.
Author's personal copy
Land in der Feme: Zur Bedeutung der ltalienbilder im Werk Christen KBbkes
Nino Zchomelidse
"Lieber Hen Professor": Die römischen Briefe des Stipendiaten Ditln Conrad Blunck an seinen
Lehrer (1829-1831)
Lorenz Enderlein and Nino Zchomelidse
Lost in Rome: Thorualdsen, his Successors and the Morlernization of Sculpture
Mikkel Bogh
Plates .........
Illustration References
215
239
Scambio di Vedute:Lo sguardo sulla natura e la camera lucid a tra i
paesaggisti internazionali a Roma intorno al 1820
or EnNe FroRnNrnr
Due sguardi su Roma: David Pierre GiottinoHumbert de Supenille (Fig. 1), poco prima didover lasciare la cittä eterna nel 1800, riportauna colonnata con edifici.' Giacinto Cigante,iu,ece, si concentra nel maggio 1826 su Llnaspetto del Colosseo (Fig. 2).'?
De Superville, commentando i sr-roi Äo-meinse Schetsboek, descrir,e cosi il propriometodo di disegnare dal vero: "gli studiconservati in questo piccolo album li facevodi notte a casa, ricopiavo gli schizzi che ave-vo fatto camminando per Rorna ... dise-gnando in modo casuale e approssimatir.oper poterli poi correggere geometricamen-te".3 Le esperienze visive, annotate durante
il giorno, r'enivano a posteriori rettificate acolpi di righello.+ La linea affilata del dise-gno risulta cosi dalla supremazia della ra-gione e della tecnica di riproduzione suglieffetti dell'esperienza. Giacinto Gigante,inr,ece, ö orgoglioso di disegnare integral-mente 'dal vero' e di trasporre, senza solu-zione di continuitä, I'esperienza del luogoin segno. Eppure per questo come per in-numerer,oli altri schizzi dal vero, Gigante siserve di un supporto strlrmentale, specifica-tamente di una camera lucida.5
Il tratto di questa breve impressione roma-na perö non appare come un'ereditä dei "pae-saggi della ragione" di fine settecento.d La li-nea non costruisce, come nel caso di Supen'il-le, forme a posteriori, ma Ie seleziona imme-diatamente, interpretandole mentre modellaur-ro spazio riconoscibile come ritaglio dell'e-sperienza cliretta del visibile. La ricerca dell'e-sperienza estetica sr.rl luogo diventa qui un co-sciente processo di confronto tra impressioner,isir,a e il suo fissaegio 'oggettivo' nel disegno,nel tentativo di riconoscere e tradurre imnre-diatamente in forme il 'vissuto' individuale.
Una profonda differenza di valori dividequindi questi due schizzi. Essa ö rilevabile sianelle nozioni estetiche che nelle pratiche arti-stiche collegate all'ossenazione e alla rappre-sentazione della Natura nei primi due decennidell'Ottocento. Valori e pratiche tradizionaliassimilano nuovi orientamenti scientifici che
+ Sul mctodo cli Humbelt de Supenille si I'eda AtrnaOttani Clavina, I paesaggt della ragione. La dttri n.eotlassica daDrnid a Hunbert de Supenille (Torino, 1994), 80-85.
:' Sull'uso delkr stmmento presso Gip;ante e sul suo si-gnilicato relati\,amentc a una lllro\:a qualitä dell'ossena-zione clal r,ero si r,eda Erna Fiorentini, "Nuori punti di i'i-sta. Giacinto Ciigante e Ia carnera lucida a Napoli", in Pit-tura italiana nell'Ottocento, ed. N,Iartina Hansmann &\I:rx Seidel (Venezia, 2005), 535-557.
6 Ottarri Catina, I paesaggt della rngtone.
Fig. 1. Dar.id Pierre Giottin Humbert de Supen'ille,Roma, Colonnata con edifici. Matita, penna, pen-nello in marrone, 16,9 x 21,6 cm. Annotato in alto asinistra "Rorne", in alto a destra "10". Leiden, Pren-tenkabinet der Rijksuniversiteit (inr,. Nr. PK 1343).
' Clr. Ulrich Thieme & Felix Becker (eds.): AllgerLeines
Lex iho n det lilrlen dc n Künstler X\III (Lcipzig, 1 925 ), I 23.2 Il clisegno risale probabilmcnte al soggiorno cli Gi-
gante a Roma presso l'acqualcllista tedesco.]ohann.facobWolfensberg;er. Si r,eda Francis Napier, Notes on modnnpainting at Naples (l.ondon, 1855), 29, e Gonsaho Carelli,Giatinto Glgan le (Napoli, 1876) come citato in Serg,^io Or-tolani, (]iru:inkt Giganle e kt piLlura di ltaesaggto a Napoli e inILalia dal'600 all'800 (Napoli, I970), 204.
3 Robert \{. Scheller, "Humbert cle Supen,ille's Rc>
mcinse sclietsboek", in llisrellanen I.Q. uan Retgertn ,\Itcna(Anstcrdam, 1969), 210-213.
Provided for non-commercial research and education use. Not for reproduction, distribution or commercial use.
Author's personal copy
196
Fig. 2. Giacinto Gigante, Il Colosseo, ca 1826. Matitaripassata a inchiostro nero, 27 x 36, 50 cm. Napoli,Museo Nazionale di Capodimonte, Gabinetto di Di-segni e Starnpe, CollezioneAstarita, Inr,. Nr. 1817.
sottolineano l'importanza della presenza del-l'osservatore non solo sul luogo, ma anche nellarappresentazione. Questi nuo\.i orientamentirivalutano concetti e pratiche dell'osservazioneempirica; "l'art d'observer"? diviene fonda-mentale anche nelle arti e si pone, a partire daltrattato di Pierre-Henry de Valenciennes, comecondizione necessaria, anche se non sufficien-te, per fare della pittura di paesaggio un genereartisticamente e intellettualmente autonomo.E
7 I metodi di ossen'azione empirica vengono conside-rati un'arte in diversi trattati sul metodo scientifico, ad
esempio inJean Senebier, L'art d'obsenrer et de faire du ixpe-
riezces (Genöve, 1802).8 Pierre Henry de \"alenciennes. Eliments de pnspertiue
pratiq'ue ä I'usage des rtrLisles. Suiuis tle RiJlexions et conseils ä,
un eline sur la peinture, et parliculierunent sur Ie genre du paysage (Paris, an VIII [1800]).
I "Non sapremmo . .. raccomandare rnai abbastanza a
chi si dedica a dipingere il paesaggio di non essere neghit-toso e restio ad abbandonare i propri focolari ma bensi disalire sui colli, d'internarsi nelle valli, di varcare i monti, diarrestarsi ai piani, e sempre delineando e foss'anche di-pingendo per via farsi corredo di tanti sorprendenti e va-
riati quadri della Natura ....". Cfr. Giovanni Pietro \rieus-
seux, "Suila esposizione dei cosi detti piccoli premi, fatta
Intorno al 1820, il nuovo gusto per la ripresa'dal vero' si riflette sia nelle ossenrazioni teori-che di carattere generale e dir'ulgativo chenelle pratiche artistiche.e
A Roma in particolare, l'ossewazione diret-ta assume il valore di elemento innoYativo nel-l'ambito della pittura di paesaggio, e si artico-la inoltre come reazione al corsetto accademi-co, che viene considerato inibitorio a una ge-nuina relazione con la Natura.
Massimo d'Azeglio, intorno al 1820 ap-prendista presso il paesaggista fiammingoMartin Verstappen, si riconosce in: "questateoria cosi semplice in apparenza, ed in so-stanza cosi spesso negata: esser l'arte il ritrat-to del vero; n6 potendosi far ritratto verunosenza conoscere I'originale, doversi studiarequesto vero e metterselo in capo quanto öpossibile".to
In questo, d'Azeglio si identifica con artistiche, come "Voogd, Verstappen, Bassi, Ther-link, ... i nuovi, stavano scrupolosamente at-taccati al vero".rr GIi studi dal vero assumonoparticolare importanza: "si scorge in essi laprima e piü vergine impronta lasciata dallanatlrra sull'intelligenza dell'uomo".r2 A Roma,d'Azeglio si sente cosi liberato dagli schemi di"quella solita lezione di disegno di tutte leeducazioni", che egli considera "con la sua fri-cassea d'orecchie, di nasi, di bocche etc. ...una triste pedanteria". r3
Anche tra gli artisti di lingua tedesca si cri-tica il curriculum accademico ufficiale pro-prio perch6 esso, come ossenraJohann DavidPassavant, non prevede "l'ossen'azione e lostudio della Natura" nella formazione dell'ar-tista: secondo Passavant, vengono tolti in que-sto modo all'artista i soli strumenti che gli per-mettono di sviluppare la sua forza creati-va.ra Impegnandosi nello studio della Natura,
nell'I. e R. Accademia di Belle Arti in Firenze nel mese diOttobre 1824", Antologia X\rI (1824): 9t1109, qui 100. L'ar-ticolo ö ristampato in Paola Barocchi (ed.): Gli stitti d'at'te
delkt Antologta di G.P. Vieusseux 1821-183), II (Firenze,1975), 516.
r0 Massimo d'Azeglio, I miei ücordi. A cura di AlbertoM. Ghisalberti (Torino, 1949), 270.
tt Ibid., 154.12 Annotazione autografa su uno studio dal vero con-
sen'ato alla Galleria di Arte Moderna (GAM) di Torino,cfr. \'irginia Bertone (ed.): Massimo d'Azeglio e I'inxenzionedel paesaggio istoiato (T orino, 2002), 77 .
13 Azeglio, I rniei dcordL ).b4.la "Bei der gänzlichen Hintansetzung des Geistigen
(so zu sagen der Seele) in einem Kunsfiverke, hat man ge-
giaubt, die Schönheit der Formen und das gute Colorit.ja
sottolinea Passavant, i giovani pittori tedeschiattivi a Roma dimostrano di cercare un'alter-nativa individuale all'arido e poco creativostudio delle opere del passatc per il quale era-no stati criticati.l5 Anche Julius Schnorr vonCarolsfeld ritiene, durante la sua permanenzaromana, che gli studi basilari per i pittori dipaesaggio sono quelli fatti sul luogo. Schnorrlamenta che questa pratica venga raramenteapplicata, mentre ci si accontenta di copiarestudi esemplari eseguiti da altri, abitudine,questa, "che impedisce una viva e caratteristi-ca rappresentazione della Natura".l6 Simile ilcommento di Ludwig Richter, che ricorda la"massa di forme e regole stereotipe" sulle qua-li i paesaggisti dovevano esercitarsi in ambitoaccademico, che impedivano "la vera e sem-plice ossewazione e comprensione delle co-se".17 Non ö cosi casuale che giovani artisti co-me Carl Wagner, i quali tendevano a liberarsida questi schemi accademici per interpretarele forme naturali "come le avevano davanti",18godessero di una generale ammirazione. Sin-tomaticamente, in Wagner viene apprezzatalanuova connotazione dello sguardo sulla Natu-ra, il fatto che egli "vedeva con i propri occhi",
selbst der gute Geschmack, sei allein durch das Copierenvorzüglicher Kunstwerke zn erlangen. So fiel damals Nie-mandem ein, daß solche \rorzüge einen n'eit tiefern in-nern Zusammenhang haben, rvelcher vielmehr in der See-
le des Künstlers liegt, dessen Geist, durch die Betrachtungund das Studium der Natur aufgeklärt, vermöge der ihminnewohnenden schöpferischen Kraft, eine neue Schöp-fung hen'orbringt". Cfr. Johann Dal'id Passavant, Ansichtenübn die bildenden Künste und Darstellung des Ganges derselben
in Toscana zur Bestimmung des Gesichxpunhtes, aus wekhem
die neudeutsche Malprschule zu betrachten ist. Von einem deut-
schen Känstlns in Rom (Heidelberg, Speyer, 1820), 100.15 "... der Verfasser ... erklärt aber, daß man ge-
genwärtig von nichts weiter entfernt sei, als tibelbeschaf-fene Ar.rßerlichkeiten der Maler der Vorzeit zur Nach-ahmung zu empfehlen, sondern vielmehr in dieser Hin-sicht eines treuen studium der Natur sich befleißigte",ibid.. \rI.
16 "Ich zeichnete ... eine Studie ..., die ich gründlichnennen darf. Die Ansicht auf eine Reihe von Clpressenvon sehr verschiedenem Charakter ist an Ort und Stellemit der Feder gezeichnet ... Ich halte dafür, daß derglei-chen Studien von den Landschaftsmalern viel zu selten ge-
zeichnet werden. Sehr viel Anfänger begnügen sich mitden Studien, die andere gemacht haben, und über denBaumschlag der Schule setzt sich leicht ein Schlagbaumfest, welcher der lebendigen charakteristischen Erfassungder Natur hinderlich isC'. Cfr. Julius Schnorr von Carols-feld, "Zwölf Briefe, Herausgegeben von Franz Schnorrvon Carolsfeid 1867" in ... ein Land der Vnheisutng: JuliusSchnon uon Carolsfeld zeichnet ltalien, ä cura di Petra Kuhl-mann-Hodick e Claudia Valter (Köln, 2000), 89-90.
17 "Wir rvaren ... in einem Wust von Regeln und ste-
t97
non offuscati da "lenti accademiche".le Un at-teggiamento con il quale ancora nel 1828 ilpaesaggista Ravmond Brascassat dichiarerä daRoma il suo programma di indipendenza dal-I'accademia, rispondendo alle critiche del di-rettore dell'Accademia di Francia, Pierre Nar-cisse Cuerin, con un deciso: "farö la natura co-me la vedo e come la sentirö".20
Negli anni 1820 ossenare 'dal vero' diven-ta quindi una colonna portante dell'attivitädei paesaggisti. Il pittore deve applicarsi siste-maticamente allo studio diretto del mondo vi-sibile, essendo esso "la sola guida da seguirecostantemente",zr " sperimentare dal veroproducendo, come Julius Schnorr von Carol-sfeld, "recht eigentliche Studienblätter".22
Ma la Natura, da reseroer di motivi da co-piare, ö diventata ora oggetto di studio criticoper s6 stessa, non ö piü tema da svolgersi ma la"fonte da cui scaturisce ogni originalitä".23
Questa nuova valutazione dell'osser-vazio-ne del vero naturale si innesta negli sviluppigenerali della cultura visiva del periodo. L'os-seryazione individuale e l'unicitä dell'espe-rienza sul luogo venivano gradualmente rico-nosciute come categorie estetiche a s6 stanti,24
reog.?en Formen und Formeln dermaßen einp;eschnürt,daß ein lebendiges Naturgefühl, die rvahre und einfacheAnschauung und Auffassung der Dinge sich gar nicht re-gen, wenigstens nicht zum Ausdruck kommen konnte. Wirplagten und mühten uns ab, die schablonenartigen For-men ... einzuüben ...". Cfr. Ludwig Richter, LebensErinne.-
rungen eines deutschen N[alers (Leipzig, 1909), 45-46.18 "Dagegen erblickten wir in Wagners Naturstudien
die Naturfbrmen, nie r'yir sie in derWirklichkeitvor uns hat-ten und nicht nach einer Schablone ribersetzt" , ibid.,46.
le "So sah Wagner also mit eigenem Auge und nichtdurch eine der vielen akademischen Brillen, welche derLehrer ... glaubte seinem Schüler auf die Nase setzen zumirssen", ibid., 46.
20 Citato in P. Miquel, Le payage frangais au NXime sü-ck 1821-1871. LEcole de la Nature (MaursJaJolie, 1975),250. Si veda anche Vincent Pomaröde, "La Rappresenta-zione della Natura intorno al 1820", in Un Paese incantato,ed. Anna Ottani Car.'ina (Milano, 2002), XXX\TI-XL\TI.
2lJean-Baptiste Deperthes, Thöorie du Paysage ou con-sidöration.s glnfuales sur les beautös de Ia nature que I'at't peutimiter et sur les moyens qu'il doit employer pour riussir dans cette
imitation (Paris, 1818), XI; XII.2? Schnorrvon Carolsfeld, ht)ölf Briefe,92.23 ". . . still Nature is the for.rntain's head, the source from
whence ali originality must spring". Cfi. Lettera a JohnDunthorne, 29.5.1802 in R.B. Beckett (ed.): lohn Constabk'sConesporulence, II (Ipswich,zSuffolk, I 962-1 975), 31-32.
21 Lo dimostra ad esempio il fiorire dei compendi illu-strati di liaggio. Si veda Barbara Maria Stafford, "TowardRomantic Landscape Perception: Illustrated Travels andthe Rise of 'Sigulariq" as an Aesthetic Category", At't Quar-led1, New Series I (1977): 89-124. Inoltre Maria Rosaria
Enxl FronnxrrNr Sclvsro DI VEDUTE: Lo scLrenno sULLA N,\TURA E IA cAMERA r.ricrDA
Provided for non-commercial research and education use. Not for reproduction, distribution or commercial use.
Author's personal copy
198
che richiedono alla rappresentazione dellaNatnra non solo di fissare immagini secondoil principio di mi'mesis, ma soprattutto di im-mortalare spazi in situazioni specifiche, pro-prie solo al singolo ossernatore. Questo mo-dello era stato proposto giä agli inizi del seco-
lo da Richard Payne Knight: la pittura di pae-saggio, in r.rn processo circolare mediato dallapercezione e dalla ratio dell'artista, deve evo-
care, secondo Ihight, la realtä oggettiva macontemporaneamente le sensazioni che essa
ha procurato.2sOra, intorno al 1820, questa massima viene
messa in pratica e considerata atteggiamentoscontato per il pittore di paesaggio, che vedenella sua prodr,rzione uno strumento per co-municare esperienza vissuta: Julius Schnorrvon Carolsfeld scrive ad esempio al suo men-toreJohann Gottlob von Quandt, a propositodi una scena dipinta da Ernst Ferdinand Oeh-me sulla base degli schizzi dal vero approntatidurante una comune escursione sul golfo diNapoli, che "forse anche Voi potrete goderedell'attimo meraviglioso che abbiamo vissutosul luogo rappresentato, come anch'io ammi-rando il quadro sono stato riportato a quelmomento".26
A questa nllo\ra situazione, il cr,ri fascinoconsiste nel "segreto dell'interagire della per-cezione sensibile con i suoi oggetti",27 e al nuo-vo compito della rappresentazione del paesag-gio viene data una formula teorica da AntoineQuatremöre de Quincy, per il quale la riprodu-zione della realtä esterna deve essere in grado
Nappi, "I1 Viaggio Pittorico nel Regno delle Due Sicilie",Dialoghi di Storia dell'arte8-9 (1999): 11t168.
25 Cfr. Richard Payne Iiright, An Anabtical Inrluiry int.o
the Principles oJ Taste (London, 1 805) , I 52- l 53.26 li\rielleicht rverden auch Sie dann dcr herrlichen
Ar,rgenblicke Gedenken, die nir selbst an dem r,orgestell-ten Ort erlebten, so lic ich lebendig in jene Zeit versetztwurde". (lfi. lettera da Roma del 19 maggio 1824 in FranzSchnorr v<-rn Carolsfeld (ed.): Briet'e uus Italien uon .luliusSclrnon'uon Carolsfeld gesrlniehen in den..lahren 1817 bis 1827.
Ein Beitrng zur Geschit:hte seines Lebens und der Kunstbestrebun-
gen seiner Zeit (Gotha, 1f186), II,/22, 463.:r ". . . geheimnisvolles Ineinar.rdenuirken des Sinn-
lichen und Außersinnlichen", cfr. Alexander von Hnm-boldt, Ansichten dn Natu,r, mil ui,ssenschnflliclten hliiute-rungen. I (Stuttgart, T[rbingen, I826, I 1808), \r.
2'J " [...] quc de crEations enfin dont nous delons I'cxi-stence ä cette imitation, non pas quelle qui se borne a
nous montrer ce qui est r€el, rnais celle qui, ä I'aide de ce
qui est, nous montre ce qtti n'est r6ellcment pasl". Clfr'. An-
toine Qrratremöre de Qrrincy, E.ssai sur kt, Nnlttre, le but et les
nqetts tle I'imitation rians ks benux-arls (Paris, 1823), 175.2e lbid., 174. Il libro di Quinc,vviene reccnsito ampia-
mcnte a piü riprese da l,eopoldo Cicognara nell'Altolo-
di mostrare "con I'aiuto di ciö che ö, [...] quelloche non ö realmente esistente",28 cioö "idee,impressioni, sensazioni e desideri".2e
In questo nuovo regime visivo, I'ossen'ato-re cerca quindi coscientemente di conciliarele impressioni soggettive e la registrazionedella realtä fisica, per rendere non solo visibi-li, ma anche comprensibili il luogo e il tipo diesperienza che esso ha procurato. Non sor-prende cosi constatare che, in risposta alle ne-cessitä formulate dalle teorie sulla rappresen-tazione del paesaggio, che si chiedono "conqlrale arte il pittore saprä riprodurre ... gli ef-fetti di tutte le diverse emozioni che la vistadelle solitudini sa sempre ispirare",30 si affer-mino nuove tecniche pittoriche che tendonoa 'oggettivare' il processo di r.isione e rappre-sentazione per rendere nello stesso tempo ri-conoscibile l'esperienza individuale di un de-terminato luogo.
La piri popolare e diffusa di queste tecni-che comprende l'adozione di nuovi strlrmentiottici come la camera lucida, perch6 essi coa-diuvano proprio in questo senso il disegno dalvero.31 Per chiarire questo punto ö necessarioricordare alcuni tratti salienti dello strumentoe dell'esperienza visiva che esso trasmette.32La camera lucida \.iene spesso confusa per ilsuo nome con la camera oscura, e di conse-guenza considerata, per analogia, uno stru-mento che riproduce meccanicamente le im-magini. Ma mentre la camera oscura ö un ap-parato di proiezione, la camera lucida non ö
altro che un piccolo prisma quadrilatero, op-
gia di \rieusseux nel I824. Clfi. Barocchi, ()li scriui d'arte d.el-
Ia Antolngi.a tli G.P. \'ieusseux, II, 213-233, 257-2t-6,298-320.:]0 I)eperthes, 'L-höorie dtt Payage,246.:]1 Lo strumento r,iene brevettato nel 1806 da \4lilliam
Hvcle \Vollaston come "An instmment whereby any per-son mav dran in perspcctive, or may copy or reduce an,v
print or drarving", cfr. British patent No 2993, december1806, in The repetktn of Arls, llanuJactures, and AgicultttreNS LVII (1807), I6l-164. La descrizione dello strunentoviene pubblicata nel 1807 contemporaneamente in piülingr.re, si veda \{illiam Hvde \\'ollaston, "Description ofthe camera lucida", Journal of natural ph,ilosophl, clnmistryand th,e tdsX\\I (1807): 1-5; William Hvde \Vollaston, "De-scription of the camera lucida", Philosophical magazineX*\{I (1f107): 343-347: \{illiam Hvde \follaston, "Descrip-tion cle l'appareil appell6 Camera l,ucida", BibliothöqueBritannique XXX\'' (1807) : 255-264.
32 Si veda anche Erna Fiorentini, "Subjective Objecti-ve. The Camcra Lucida and Protomodern Obsen'ers",Biklruelten des llrissens 2,2 (20041: 58-66, inoltre Erna Fio-rentini. "Instrument des Urteils. Zeichnen nit der camcraltrcida als Komposit", in The pitcture's im.age. WissenschaJili-
the l/i.sualisierung rils Komposit, eds. Inge Hintenvaldner &N{arkus Buschhaus (München, 2006), 4+5U.
pure, a seconda del tipo, un prisma triangola-re applicato ad una lastra trasparente (Fig. 3).Paragonato alla camera oscura, lo strumentoha un vantaggio non indifferente, perch6 puöessere comodamente trasportato durante leescursioni all'aperto come accessorio di mini-mo ingombro per un album di schizzi (Fig. a) .
Il principio della camera lucida ö tanto ge-niale quanto semplice. L'immagine ossen'ataviene riflessa prima dalla superficie a specchiodel prisma (Fig. 3 punto A), poi nuovamentedalla superficie della lastra (Fig. 3 punto B).Da qui, l'immagine r.iene riflessa, non capo-volta grazie alla doppia riflessione, nell'occhiodell'ossen'atore, che in veritä ö costantementediretto alla carta da disegno (Fig. 3 punto F) enon alla scena ossen/ata (Fig. 3 punto O).
Per illusione ottica, I'immagine riflessa sul-la retina dell'ossen'atore sembra sovrapporsialla carta da disegno sottostante, sulla quale lamano del disegnatore puö seguirne le forme.L'immagine quindi non esiste in veritä sullacarta, ma ö solamente virtuale. L'osseryatoresegue con il lapis immagini che non sonoproiettate meccanicamente, ma ricreate fisio-logicamente dal suo apparato visivo. Questeimmagini percepite e solo l.irtualmente esi-stenti sul foglio da disegno non possono venirquindi semplicemente ricalcate: per poterletrasporre soddisfacentemente in segno, l'os-senratore deve contemporaneamente analiz-zarle e discriminarne Ie forme e i loro rappor-ti nello spazio.
La camera lucida crea cosi solo "l'illusio-ne" di un processo di rappresentazione ogget-tiva. Se la riflessione speculare del prisma puögarantire "l' oggettir,'itä" d.Uu percezione, I' in-terpretazione e la rappresentazione dell'im-magine non vengono automatizzate, ma affi-date al giudizio soggettivo. L'immersione visi-va nel reale della Natura attraverso la cameraIucida ö quindi anche un'immersione nellapercezione indir''iduale, e chi usa lo strumentosi pone coscientemente in bilico tra la ripro-duzione oggettiva della scena osserrata e lanecessitä di riconoscere, escludendole o in-corporandole, le variazioni do'r''r"rte all'espe-rier'za singolare nel luogo e nell'ora dell'os-senrazione.
La camera lucida rappresenta cosi anche
33 Si veda Erna Fiorentini, Camera obscura as. Catneta
hu:ida. DistinguishingEar\ Nineteenth Century X'hdes of Seeing
(Max-Planck-Institute fbr the Histor-v of Science, Preprint307; Berlin, 2006).
:ia Si veda Fiorentini, Nuori punti di vista, 535-b57.
199
Fig. 3. Principio della Camera Lucida di Giovan Bat-tista Amici. 1840.
un'intrigante metafora del nuovo sguardo sul-la Natura che si instaura nei primi due decen-ni dell'Ottocento nel quadro dell'inquietudi-ne collegata allo studio, alla percezione e allarappresentazione dei luoghi.33 Questo nuovosguardo sulla Natura, per quanto riguarda lapittura di paesaggio, diventa palpabile nellasua dimensione di fenomeno epidemico diportata europea soprattutto a Roma intornoal 1820, dove lo si registra contemporanea-mente in comunitä artistiche di diversa nazio-nalitä.
Focalizzare I'uso della camera lucida in ter-mini di pratiche e aspirazioni artistiche inquesto contesto internazionale e variegatopermette di circoscrivere storicamente il nuo-vo orientamento, e contribuisce a una piü pre-cisa definizione del carattere di questi annicruciali per il genere del paesaggio.
Lo scorcio del Colosseo di Giacinto Giganteconsiderato in apertura fornisce un indizioiniziale per rintracciare l'uso della camera lu-cida nelle cerchie di artisti romani interessatial paesaggio.
A Napoli, cittä natale di Gigante, la cameralucida era particolarmente popolare.34 Essaveniva prodotta in laboratori locali al piü tardidal 1818,35 ma era stata introdotta in cittä giä
35 Cfr. Alberto Meschiari. "Giovanni Battista Amici e ilReale Officio Topografico di Napoli: Corrispondenza coni Colonnelli Visconti, De Sauget, Melorio", PÄ1sds NSXXXX (2002):187.
Enx,q FronnxrrNr Sc.q-vero DI VEDUTE: Lo sctt*no sULLA N,\TURA E L{ cA-N,IERA LUcIDA
Provided for non-commercial research and education use. Not for reproduction, distribution or commercial use.
Author's personal copy
l
200
/ -'*--"ir-- .''Fig. 4. Cornelius Varle,v, Disegnatore alla cameralucida, 1830. In basso si legge "Drawn by CorneliusVarley for G. Dollond with the camera lucida".
nel 1817 dall'astronomo Giovanni BattistaAmici, il quale costruiva una speciale versionedi questo strumento nel suo laboratorio mo-
36 Si veda Giovanni Battista Amici, "Sopra le camerelucide", Opus c oli Scientif ci III / 73 ( 1 8 1 9) : 25-35.
37 I nominativi e le attivitä dei numerosi acquirenti si
deducono dal dettagliato libro dei conti del laboratorio diAmici. Si veda Alberto Meschiari. "Il Libro de' Conti de1
Laboratorio di Giovanni Battista Amici", Atti della Fondazio-
ne Giorgio RonchrL\rI(1) (2001): 55-114, inoltre Fiorentini,Camera obscurtt, as. Camera lucida.
38 Un dettagliato resoconto si trova nei diari di viaggiostesi da Teresa Amici, la moglie di Giovanni Battista. Cfr.Giovanna Anici Grossi, "I Diari dei riaggi e altri docu-menti della vita di Giovan Battista Amici", Atti delh l-onda-zione Giorgio RonchiLl(6) (1996): 873-919.
3e Ibid.. 88G889.40 "La mattina del 16 ... vennero le seguenti persone a
vedere le macchine. Il Marchese Origo, I'abate Capaccini, ilProf.e Ciccolini. I'abate Vanucci astronomo e le Pr-ussiane . ..
La mattina del 29 r.'ennero piü di trenta persone a casa nostraper veder le macchine. .. . Il Cardinal Naro, Monsignor Ma-
cherani, ... la Baronessa Piccolomini, la Senatrice PatrizjPrincipessa di Sassonia, il celebre Matias Autore inglese . . . AMezzogiorno ci portammo dalla Marchesa Sacrati che at'er.a
inlitato piü di quaranta persone pervedere le nostre macchi-
denese.36 Da qui egli avrebbe venduto tra il1817 e il 1840 almeno 265 esemplari ad artisti,archeologi, ingegneri e architetti, a scienziatidi diversi orientamenti, a militari e numerosinobili e principi europei.3T Scienziato di chia-ra fama, Amici era stato richiestissimo daimaggiori personaggi della r,'ita pubblica napo-letana durante il suo soggiorno in cittä, so-
prattutto per pubbliche dimostrazioni deisuoi strumenti.3s
Ma prima di arrivare a Napoli Amici avevafatto sosta a Roma nell'ottobre 1817,3e e avevapresentato, su richiesta di numerose persona-litä della vita scientifica, artistica e sociale del-la cittä, "le sue macchine".lo Tra queste, inparticolare la camera lucida era diventata il te-ma piü attuale in cittä, risvegliando anche I'in-teresse degli artisti.al Tra le molte ordinazionidello strumento negli anni che seguono lapermanenza di Amici a Roma,a2 alcune for-niscono un trait d'union con la comunitä in-ternazionale dei paesaggisti attivi nella cittäeterna.
Una testimonianza diretta ö Ia corrispon-denzatraAmici e Cesare d'Azeglio, che nell'a-prile 1822 aveva ordinato una camera lucidadestinata al figlio Massimo, allora residente "aRoma, ove studia la pittura".a3 Se Massimod'Azeglio nei suoi ricordi non parla di questoregalo del padre, ö probabilmente perch6 es-
so faceva parte di uno strumentario d'ordi-fiarrza'. il marchese d'Azeglio sembra infattiesprimere un'opinione diffusa, se non sconta-ta, quando sottolinea nella sua lettera all'Ami-ci che "con un figlio paesista, la di lei Came-
ne. In questa occasione Battista fece molte conoscenze, perti-colarmente quella del Prof.e Morichini, Scarpellini ec. Vi eraanche il Principe di Saxe-Gotha che restö come gli altri moltosoddisfatto. . . .1122 . . . Battista si portö dal Conte di S.Leu 1exre d'Ollanda) che ave\a fatto dimandare di venire al nostroalbergo pervedere le macchine, il quale restö molto conten-to e fece alcune ordinazioni... I 2 [novembre] ... Battista si
portö dal Santo Padre colle sue machine. . ..", irid., 88G889.11 "Il 20 ... venne a ritrovarci il sig.r Minghetti pittore
Reggiano che restö incantato dalla camera lucida, e pregö\dvamente Battista a permettergli di condurre la sig:ra Me-lanchini brava pittrice, che avendone sentito parlare si eramolto invogliata di vederla", ibid.,887.
a? Nel dicembre 1817 sono annotati. il pagarnento del"Sig Scaccia ingegnere Romano per una camera lucida" (Gi-rolamo Scaccia era architetto e ingegenere esperto in mate-matica) , nonch6lavendita di camere lucide a due degli ospi-ti di Amici in Roma, il Marchese Sacrati e i1 conte di San Leu,e all'Universitä La Sapienza, nel lug1io 1818 "al MarcheseLongi di Roma". Siveda Meschiari, Librc de'Conti,63-64.
13 Lettera dell'aprile 1822 (Biblioteca UniversitariaEstense di Modena, Fondo Giovanni Battista,{mici, cartel-la 304, carte 1608-1614).
ra Lucida ö oggetto per me di speciale atten-ziol:.e".aa
Significativamente, quando nel 1822 quat-tro paesaggi romani di Massimo d'Azeglio era-no stati esposti all'Accaemia di Pittura e Scul-tura di Torino,a5 l'iniziatore dell'esposizioneera stato l'amico di famiglia e mentore di Mas-simo, il dirtettore dell'Accademia CiovanniBattista Biscara. Le informazioni sulla cameralucida come nuovo strumento potevano esse-
re arrivate ai d'Azeglio attraverso di lui, vistoche egli non solo era stato ritratto daAmici conla camera lucida,aG ma ne aveva acquistata luistesso un esemplare nel 1821. Nella stessa occa-sione, anche il disegnatore torinese AngeloBoucheron aveva comprato una camera luci-da,a7 la quale, si constata, "sbalordisce ITorino]sotto il magico, e furibondo lapis" dell'artista.as
Avendo conosciuta personalmente la ca-mera lucida attraverso questi contatti, o venu-tone a conoscenza attraverso il regalo del pa-dre, ö presumibile che Massimo d'Azeglio di-scutesse le possibilitä dello strumento all'in-terno della comunitä di artisti fiamminghi dicui faceva parte come apprendista di MartinVerstappen.ae Questi, per parte sua, sperimen-tava tecniche e pratiche di studio dal vero chevenivano considerate innovative o quantome-no poco convenzionali, come considera d'A-zeglio, annotando che Verstappen "benchöartista provetto, ed uomo sui cinquant'anni,... soleva tuttavia passare ogni estate tre oquattro mesi a studiare dal vero come un prin-cipiante".50 Si puö immaginare che la curiositädi Verstappen come cultore del vero e uno deipittori di paesaggio piü in vista della cittä po-tesse venir risvegliata, se non dal rumore pro-vocato dal nuovo strumento a Roma dal 1817,almeno dalla presenza della nuova tecnica trai suoi allievi.5l
Anche le occasioni di conoscenza diretta
al Ibid. Cesare d'.\zeglio avrebbe saldato il conto perla camera lucida nel gennaio 1823, cfr. Meschiari, Libro de'
Conti,69.a5 Tra questi anche un "Interno del Colosseo", si veda
Bertone, Massimo d'Azeglio, 255-251-.a6 I1 ritratto a matita si trova a Modena, Biblioteca
Estense, Fondo Amici-Grossi, Cassetta 2, fasc. 19, disegnon.27.
a7 Cfr. Meschiari, Libro d,e' Conti,67.a8 Lettera di Nicola Crosa di Vergagni a Giovanni Bat-
tista Amici (Biblioteca Universitaria Estense di Moden,Fondo Giovanni BattistaAmici, cartella 291).
ae Azeglio, I miei ricordi,202.50 Ibid., 262.t'r Cfr. Kunstblatt 11 (1820): 42; inoltre Kunstblatt 25
207
non mancavano, visto che Verstappen fre-quentava assiduamente il salotto romano dellegato olandese Johann Reinhold, aperto adartisti di diverse nazionalitä, che qui non solovenivano a contatto con molti committenti,ma anche con colleghi di diversa provenien-za. Frans Ver-vloet, assiduo frequentatoredel salotto, e giä dal 1822 in stretto contattocon Verstappen,s2 testimonia nei suoi diariche questi era ospite fisso di Reinhold comeanche gli olandesi Abraham Teerlink e An-toni Sminck Pitloo.53 In questo punto discambio, le informazioni sulle nuove tecni-che per il disegno dal vero potevano facil-mente diffondersi tra questi rappresentantidella corrente naturalista di stanza a Roma.E significativamente pochi anni piü tardi, aNapoli, Antoni Sminck Pitloo avrebbe anno-verato tra i suoi alllievi Giacinto Gigante,che giä giovanissimo usava i nuovi strumentiottici. Pitloo sarebbe inoltre stato, abitandonello stesso stabile al nr. 15 di Vicoletto delVasto, in stretto contatto con Carl-WilhelmGötzloff.5l
Quest'ultimo aveva a sua volta conosciutola camera lucida probabilmente giä durante isuoi anni di studio, essendo stato allievo di Ca-spar David Friedrich, che usava la camera lu-cida per i suoi rilevamenti dal vero.55 Götz-loff, perö, avrebbe al piü tardi potuto venirea contatto con lo strumento a Roma, quan-do, prima di trasferirsi a Napoli nel 1825 alseguito del collezionista Karl von Uxkull-Gyllenband56 gravitava nella cerchia di JuliusSchnorr von Carolsfeld.5i
Indirettamente, infatti, le ordinazioni dellostrumento presso Giovanni Battista Amici indi-cano che Schnorr dovesse conoscere Ia came-ra lucida almeno dal 1818: Franz Freiherr vonKoller, intendente generale austriaco, avevaacquistato lo strumento presso Amici l'8 gen-
(1820): 100, dove si restringe a Martin Verstappen, Hen-drick Voogd e Franz Catel il gruppo dei piü eminenti pae-sisti a Roma.
52 Cfr. Denis Coekelberghs, Les peintres belges d Rtme de
1700 a 1$0 (Bruxelles/Roma, 197il,743.53 Eliinoor Berg'-e1t, fuizen naar Romz. Italiä als Lea'
school xoor Nederlandse Kunstenaars (Roma, 1984), 82-83.5a Ernst-Alfred Lentes, Carl Wilhelm Götzlo;ff. Ein Dresd-
ner Romantiker mit neapolitanischer Heimat. Monographie mitWerha erze ic hnis dn C,emälde ( Stuttgart/ Zürich, 1 996) .
55 Si veda Werner Bwsch, Caspar Dauid Fiedrich. Ästhe-
tik und P,eligion (München, 2003),52-54.56 Richter, Lebenserinnerungen, 51.3.57 Cfr. Schnorrvon Carolsfeld, Briefe aus lto,lien, II,/&i0.
F,nNr FronnNrrxr ScxNrsro DI VEDUTE: Lo scuenno suI-Lq \.,ITURA E L,\ ciArMER{ LUCIDA
Provided for non-commercial research and education use. Not for reproduction, distribution or commercial use.
Author's personal copy
9rl9
Con entrambi questi personaggi, JuliusSchnorr von Carolsfeld aveva regolari contattiproprio nello stesso periodo. II 23 settembre1818 egli scrive da Roma al padre decrivendogli incontri con Ramdohr, che avr,renivano"piü r'olte Ia settimana" presso gli Humboldt,inoltre le visite di Ramdohr e Koller al suo ate-lier e l'apprezzamento che essi avevanoespresso nei confronti del suo lavoro.or Comepensare che questi eminenti critici, che si era-no lasciati entusiamare dalla camera lucidapochi mesi prima, non avessero discusso conil loro protetto le potenzialitä di questa tecni-ca, che faceva furore non solo a Napoli e a Ro-ma, ma in tutta Europa?62
Sappiamo inoltre della permanenza diSchnorr a Napoli nella primavera del 1820.ti3In questa occasione, essendo al seguito dellacoppia von Quandt, Schnorr era venuto certa-mente a contatto con i circoli della cultura cit-tadina nei quali la camera lucida continuava afar parlare di s6. Sicuramente doveva aver re-gistrato I'uso dello strumento a Posillipo, dovepassava le mattinate a disegnare,6a tra i giova-nissimi paesaggisti che lä, come Ciacinto Gi-gante, usavano approntare vedute con la ca-mera lucida per i visitatori stranieri.65
Questi possibili contatti con Ia nuova tecni-ca erano certo stati discussi nella cerchia dipaesaggisti che praticavano lo studio dal verocon i quali Schnorr era in stretti rapporti in-torno al 1820: Oltre a Carl-\Alilhelm Götzloffper esempio Franz Horn|, Johann ChristianReinhart, Adrian Ludwig Richter, HeinrichReinhold, Franz Catel, Ferdinand Olivier edErnst Ferdinand Oehme. Con tutti loro Sch-norr non solo intraprendeva escursioni nellaCampagna Romana, ad Olevano e sulla CostaAmalfitana, ma discuteva il valore delle comu-ni attivitä di disegno e pittura dal vero.66
di Soho Square, cli. Wollaston, Desoiption PhiktsophicnlMagazine,347; a Parigi a Place de I'Horloge presso.|eanChevallier, cfr.Jearr G. A. Chcvallier, Le consenrateur de Iarue (Paris, 1815), 303-309; a Benediktbeuren e Monacodi Bar,iera nei laboratori di Utzschneider e Fraunhofer,cfr. Anzeiger Jür Kunn- und GewerhJleiJJ itn Königreicheßrz1em, Dritter .fahrgang, Monatliche Anzeigc, N.ro 2(1817):27.
63 Schnolr ne fa un brer,e riassunto al padre in unalettera del 23 maggio 1820 (Schnorr von Carolsfelcl, Bly'änrts ltal,ien, I / 32, h' 2-U- 9) .
6a "Dcinen Geburtstas feierte ich auf dem Posillipo,nohin ich in aller Frrihc gegangen tvar, Lrm zu zeichnen",ibid., r/32, 175) .
6:' Railaello Causa, La Stuokt d,i Posl1./i1o (N{ilano, 1967) .
66 Clfi. Schnnrr von Carolsfelcl, Bnele aus It aüen, lL8, 9, 78.
Enxl FronExrrNr Sclql'rsro Dr VEDUTE: Lo sc;uaruo suLL\ NATURA. E L\ c;{x{ERA, LUCIDA 203
Fig. 6. Löon Cogniet, Autoritratto dell'artista nella sua stanza di Villa Medici, alla parete un Miroir de Clau-de, 1817. Olio su tela, 44,5 x 37 cm. Scritta sul telaio: "Ma chambre ä la reception de la premiöre letter dema famille, 1817". Cleveland, Museum of Art, Inv. CNtrA 1978. 51.
,-
t,:t'larrr.,. ,
Fig. 5. Giovanni Battista Arnici, Ritratto del BaroneFriedrich Wilhelm Basilius von Ramdohr esegr,ritocon la camera lucida. Matita, 74 x 22 cm. Modena,Biblioteca Estense, Fondo Amici, Raccolta Arnici-Grossi, Cassetta 4, fasc. 52, fbglio Nr. 4.
naio 1819,58 dopo che nell'aprile 1B1B ne ave-\ra rice\-Lrta una a Napoli attraverso Ferdinan-do Visconti.5e Anche a \Arilhelm von Ramdohr,che era stato ritratto da Amici stesso con la ca-mera lucida durante Ia visita a Napoli del di-cembre 1817 (Fig. 5), era stato inviato Io stru-mento tramite ilVisconti il 9 aprile 1818.60
!'8 Cfi. Meschiari, Libto d,e'Conti.,65.5e Lettera di Amici a Ferdinando Visconti del 9 aprile
I818, cfr. Meschiari, Giotanni Battista Amid, 18+I85.60 Lettera cli ,\nici a Ferdinando Visconti del 9 aprile
1818, ibid., 18+185.6l "Ich soll viele Grü13e von Ramdohr an Dicir ausrich-
ten, er ist mit seiner Frau in Rom. Ich sehe ihn die Wochemehrere Malc bci Hurnboldts, auch nar el mit seinel Frauund dem Ceneral Koller (demselben welcher, als Napo-leon nach Elba geschickt rurde, zurn österreichischenKonmissar ernannt rvar) bei mir uncl schien Freude anmeinen Arbeiterr zu haben" (Sclurorr yon Carolsfeld, Brir.-
fe aus ltalien, I/17 , 100) .
62 La camera lucida veniva larganrente ofTerta giä dalprimo anno dopo il brer,etto in nurnerosi laboratori di ot-tica e strumenti scientifici: a Londra presso Nerunan al 24
Per completare il quadro delle comunitäinternazionali di paesaggisti a Roma, anchenell'ambito dell'Accademia di Francia, dovegiä strumenti ottici come il cosiddetto Miroirde Claude6? avevano fatto parte del corredodel paesaggista (Fig. 6) , si era certamente datempo preso atto della camera lucida. Giä nel1813 Jean-Auguste-Dominique Ingres avevainfatti eseguito i suoi schizzi romani con que-sto strumento (Fig. 7;.n^
Sulla base di questi indizi, l'ipotesi che lacamera lucida fosse presente o per lo menoche ne venisse discusso I'uso nelle diverse co-munitä nazionali di paesaggisti a Roma sem-
bra piü che plausibile.Per la maggior parte, purtroppo, i singoli arti-sti tacciono ostinatamente su questo punto.
Cosa non inaspettata, se si presta fede alla dia-gnosi del naturalista John Herschel, teoricodell'empirismo inglese e appassionato dise-gnatore alla camera lucida, che dopo il suoviaggio a Roma nel 1824 ossen/a che I'artista'empirico', quello che come i paesaggistiprende spunto diretto dal confronto con lanatura, volendo sorprendere per mezzo dei ri-sultati della sua arte, tenda, al contrario delloscienziato, a nascondere i processi di produ-zione, trattandoli come "misteri accessibili aisoli adepti".6s
Per individuare un eventuale uso della ca-mera lucida tra i paesaggisti attivi a Roma in-torno al 1820, e per cosi valutare la misura incui la loro attivitä en pletn air corrisponde alnuovo regime visivo che la camera lucida me-
67 Su questo strumento si veda Arnaud Maillet, 71e 1790-1830, eds. Margaret Stuffmann & Werner Btrsch
Clnude Glass. LIse and meaning of the black minor in uestern ar7 (Köln, 2001), 160-191.
(NewYork, 2004); inoltre Lars Kiel Bertelsen, "The Clau- sv "1hs $'hsl6 tendency of empirical art, is ... to place
cle Glass: a modern metaphor benveen rcord and image", its pride in particular short cuts and m1'steries knorvn onlyI(ord ü Image20,3 (2004): 182-190. to adeps, to surprise and astonish by results, btrt to con-
68 Cfr. Urve Fleckner, "Porträt und Vedute. Strategien ceal processes", cfr.John Friedrich \{illiam Herschel, Przlz:
der \\rirklichkeirsaneignung in den römischen Zeichnun- minary Discourse on the Study of Natural Philosoplr1 (London,
gen Jearr-Auguste-Dorninique Ingres", in kichnen in Rom 1830), 70-72' n. 64.
Provided for non-commercial research and education use. Not for reproduction, distribution or commercial use.
Author's personal copy
205204 EnN,q. Froru,rvrrNr
Fig. 7.Jean-Auguste-Dominique Ingres, San Martino ai Monti, dopo il 1813. Matita su carta 16,2 x 21, 3 cm.Montauban, Mus6e Ingres, Inv. Nr. 867.4378.
)4
Scur.vero DI VEDUTE: Lo scLtenno sULLA NATURA E Lq c,AMERA LUCIDA
9. Abraham Teerlink, Orvieto. Gesso nero, pennello in grigio e marrone, 23,3 x 32,6 cm. Annotato al
tro in alto: "in Orvieto". Amsterdam, Rijksprenten Kabinet, Inv.72:65.
:..':.
Fig'cen
taforicamente rappresenta, ö necessario qurn-di confrontare singoli prodotti con quelli sicu-ramente eseguiti con questo strumento. Que-sti ultimi hanno diverse particolaritä caratteri-stiche, per cui nella maggior parte dei casi ö
possibile risalire all'uso di questa tecnica conrelativa sicurezza.
La prima particolaritä dei disegni eseguitialla camera lucida ö una generale marrcanzadi profonditä di campo. Tutti i piani di distan-za, cioö, sembrano proiettati in questi disegnisullo stesso piano, che corrisponde alla super-ficie del foglio da disegno. Questo effetto ö daun lato doluto all'ottica dello strumento, per-ch6 Ie perfette superfici piane del prismadella camera lucida eliminano le aberrazio-ni da curvatura tipiche delle lenti, e rendo-no possibile la focalizzazione delle immagi-ni su tutte le distanze. Dall'altro lato I'effet-to dipende dai principi legati alla fisiologiadella vista: nei modelli di inizio Ottocento,la camera lucida veniva usata monocular-mente (Fig. a), per cui la tridimensionalitäe la profonditä di campo che si instauranonella percezione individuale attraverso la vi-sione binoculare veniva a mancare.
La seconda particolaritä ö la modificazio-ne, a causa della riflessione prismatica, di ca-ratteristiche rilevabili correttamente ad oc-chio nudo nella scena naturale: le proporzio-ni di oggetti lontani, come per esempio mon-
70 "In attempting to drarv an extended view n'ith thecamera lucida, lve are surprised at the smallness of the distant objects; neither can we [...] give them the impor-tance they assume in nature". Cfr. Anonymus, "The came-
ra lucida", The Athenaeum Journal CXL\TII (August 28,
1830):540.7r I disegni diJohn Herschel, in particolare le vedute
tagne o alture, risultano alla camera lucidapiü basse di quello che sono in realtä, impe-dendo al disegno che ne deriva di "renderegiustizia all'importanza clte queste forme as-
sumono in natura".To
Questi effetti, che si rilevano per esempioin una veduta di Sorrento eseguita alla cameraIucida da Giacinto Gigante (Fig. 8), caratteriz-zano anche i libri di schizzi di Abraham Teer-link (Fig. 9), molti disegni di Franz Horny(Fig. 10) e di Massimo d'Azeglio (Fig. 11).Non casualmente, il formato di questi disegnivaria di poco, da ca. 20 x 30 cm a ca. 30 x 40cm, che sono significativamente le misureideali per il disegno su tavola trasportabile e
ricorrono nei disegni alla camera lucida di Gi-gante e diJohn Herschel.''1
Il comune uso dello strumento divienestraordinariamente evidente se si confronta laveduta del Monte Solaro a Capri eseguita conla camera lucida da Giacinto Gigante (Fig. 12)con quella disegnata contemporaneamente,ma indipendentemente, da Carl-WilhelmGötzloff (Fig. 13) nel 1823. A prescindere dalpunto di osservazione, che in Götzloff ö piübasso e piü rar.vicinato, i due disegni sono infat-ti quasi identici nel segno come anche negli ef-fetti di appiattimento e bidimensionalitä, e cor-rispondono inoltre nel formato. La vicinanzaformaie di queste due vedute non ö solo testi-mone di un possibile uso della camera lucida
italiane, misurano di regola circa 20x30 cm, come peresempio la veduta di Roma dalla Lerrazza pinciana de1
1824, che porta l'iscrizione '.f.F.W. Herschel del. Cam.Luc. August 8, 1824. Rome from the Pincian TerraceBevond the Villa Medici". Cfr. t,arryJ. Schaaf , Tracings of Lt-ght: Sir.John Herschel U the Camera Lucida (San Francisco,1989), plate 16. n. 367.
..-.. '.:
,il', ,
Fig. B. Giacinto Gigante, Capo di Sorrento (Maddaloni), intorno al 1825. Penna e inchiostro acquerellato,41,5 x 30 cm. Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte, Gabinetto di Disegni e Stampe, Collezione Asta-rita, Inv. Nr. 1810, Foto N. 11458.
t-:r"
Provided for non-commercial research and education use. Not for reproduction, distribution or commercial use.
Author's personal copy
207206 ERN,q. FroRrNrrxr
Fig. 10. Franz Horny, Vista panoramica di Olevano con montagne, ca. 1817/18. Matita ripassata a penna inmarrone su carta a coste, 19,7 x 30 cm. Annotazione a matita in basso a destra:"Oler,ano". \Areimar, Krrnst-sammlungen, Inv. Nr. KK 1776.
Fig. 1i. Massimo d'Azeglio, Veduta della campaena rornana, 1819 ca. Olio sr.r carta trasportata su tela,40 x50 crn. Torino, Galleria di Arte Moderna (GAM), inr'. P,/143.
Sri$,rsro Dr VEDtrrE: l,o sc;uenoo sur-r-\ N..ATURI E L.{ c"\N{ER{ LLrcrDA
Fig. 12. Giacinto Gigante, La Certosa vista dall'alto ed il monte Solaro. Matita e penna, 26 x 41 cm, anno-tato "punto generale di Capri - disegnato ad Achille Vianelli 29 luglio 1823 - Certosa - Ischia - strada checonduce alla casa di Tiberio". Napoli, N{useo Nazionale di San Martino, collezione Ferrara Dentice, inr'.19233.
Fig. 13. Carl Wilhelm Götzloff, Sito del Palazzi di Giulia vor Monte Solaro a Capri, 1823. Matita su carta,
26.2 x 10 crn. collezione prirata.
^fi.{ l;r.3 1.{ *i
- \"--' "/".u-7):'.
Provided for non-commercial research and education use. Not for reproduction, distribution or commercial use.
Author's personal copy
208
n^ttl'
EnN,q. FroRlNrrNr
Fig. 14. Giacinto Gigante, Vedutacon l'Arco narurale. Penna e mati-ta, 29 x 23 cm. Annotato: luglio1823. Napoli, Museo Nazionale diSan Martino, collezione FerraraDentice (inr'. 19110).
Fig. 15.Julius Schnorr von Carol-sfeld, Küste bei Terracina, 1820.Matita ripassata a penna e pen-nello con inchiostro marrone,I3,2 x 2I cm. Annotato sopra a
destra: "Terracina d. 7 t. Aprill /1820", sotto al centro: "TERR{CI-NA". Annotazioni sul colore: "r,io-let / grün / gra:u und u'eißerScharrm". Nrrmerato sotto a sini-stra: (61); sotto a destra: 80. Sulrorescio uno schizzo di paesag-gio. Dresden, Staatliche Kunst-sammlungen, Kupferstich-Kabi-nert, Inv. Nr. C l908-801.
Scrlmro Dr VEDLrrf,: Lo scueruo sut-Ll NATURA E LA cA.N,IERA LUCIDA 209
presso Götzloff, ma indica anche un suo possi-bile rapporto diretto con Gigante durante glianni romani.72 Di conseguenza si delinea quianche una possibile fonte diretta di informa-zione su e di confronto con Io strumento per lacerchia di lingua tedesca a Roma che Götzlofffrequentava, in particolare per Julius Schnorr\,on Carolsfeld, che dal 1821 seguiva attenta-mente i progressi del giovane collega, partico-Iarmente a riguardo del disegno dalvero.Ts
Non sorprende quindi incontrare, confron-tando molti disegni di Schnorr con quelli ese-
guiti alla camera lucida da Giacinto Gigante, lastessa corrispondenza di effetti (Fig. 14, Fig.l5) . Questa corrispondenza non ö da attribuiread un processo di costruzione della prospettivadurante il disegno coadiuvato da uno strumen-to, come ha proposto Werner Busch,Ta un pro-cesso che eventualmente ö pensabile solo colle-gato all'uso di una convenzionale camera otti-ca. Invece, la somiglianza tra questi disegni na-sce dalla ricorrenza di appiattimento e ricon-giungimento dei campi di distanza come carat-teristiche dorute alle particolaritä del prisma e
alla fisiologia dell'ossenatore. Sono proprioqueste caratteristiche a produrre l'effetto cheBusch definisce efficacemente Lrno "strarrcr
compenetrarsi di spazio e superficie".T5
Potrebbero derivare quindi dall'uso della ca-
mera lucida gli intriganti "tratti comuni" cheElisabeth D6cultot rintraccia nei disegni della"seconda generazione dei Nazareni": non soloi tratti fini, precisi, schematici, ma anche daun lato l'uso particolare dell'acquarello conLln numero limitato di colori e dall'altro la di-latazione della prospettiva.T6
Per quanto riguarda il colore, la camera lu-cida veniva infatti spesso usata anche per sele-zionare effetti cromatici e luministici prima
t? Che (l.ijtzloff cooperassc con Gigante durante glianni napoletani, cioö dal 1825 in poi, ö dirnostrato dal co-mune contributo alle illustrazioni per la dispensa del 1829del Viaggio Pittor-ico delle Due Sicilic (si veda Nappi, 1l\linggio Pittotico, 63, n. 64).
t3 Cfr. Schnorr r,or.r Carolsfeld, Btiefe aus ltalien, II,/GI0.7a Cli. \\rerner Busch, "Trennendes und Verbindcrr
des in der Zeichnungsauflässung von Caspar Darid Fricd-rich rrndJulius Schrtorr r,on Carolsfelcl",./a/züttch tlet Staat-
lic he n Kunst.sttmmlungen Dresde n 29. 2001 ( 200,1) : 99-1 09.;i Ibid.. 109.tG Si veda Elisabcth D6cultot, "Rome 1820. Les naza-
r6ens et le parsaee" , Studiola2 (2003): 43-75, in particolare 53.7; "In sketching with this instr.rment [...] it is not ab-
solutelv necessarl' to begin rvith Ithe outlinc], as in ordi-nan'drarving; ancl I conceive this change in the order ofshade and outline, one of the great adr.antages of the il-
della stesura della linea.77 Giacinto Gigante peresempio sembra adottare proprio questo prin-cipio nello scorcio delle falde del Vesul'io (Pr-.X\r) dove la macchia segue a volte la linea, matalvolta ö la linea a sovrapporsi, rimodellando-la, alla macchia. Certi schizzi di Franz Hornl'(Pr-. X\rI), fondamentalmente diversi da quellieseguiti "ad occhio nudo" (Fig. 16) che porta-no solitamente annotazioni scritte slri toni os-ser"\'ati, dimostra che anch' e gli probabilmentesperimentava sr.rl luogo il rapporto tra forma e
colore selezionando le ossenrazioni con uncrstmmento simile a quello usato da Gigante.
Riguardo all'ampliamento prospettico, ilprisma della camera lucida, se correttamenteposizionato, permette di cogliere istantanea-mente, senza dover costruire un apparato geo-metrico portante, grandi contesti di spazio inuna vista d'insieme, riconoscibile ma nello stes-so tempo selettivamente essenziale (Fig. B-10).
In questo, lo strumento soddisfava le esigen-ze estetiche della nuor.a generazione di paesag-gisti, che cercavano di raggiungere con il dise-gno dal vero non la "pedissequa imitazione"della Natura ma la scelta di elementi per rag-giungere un "effetto d'insieme", r.isto che"l'armonia dell'insieme ö ciö che rende I'og-getto \,erosimile e bello nella natura e sulla te-1a".78
Non ö escllrso quindi che anche la famosis-sima veduta della costa sorrentina disegnatadaJulius Schnorr ton Carolsfeld nel maggiodel 1820 possa essere stata ripresa con la ca-rnera lucida (Fig. 17). Vediamo qui infatti cheSchnorr riduce la sconvolgente maestä delColfo alle lir-ree fondamentali, r.rsandole nonper astrarre Ie forme naturali, ma per renderel'effetto d'insieme delle masse piü rilevantidella costa, che ö ulteriormente sottolineatodalle pennellate monocrome.Te Un'altra carat-
strnrnent". (lfi. Basil Hall. Trauel.s i.n Norlh Ametica i.n the
yars 1827 and l 828, lll, Appendix on the use of the came-ra lucida (Edinbr.rrgh, 1830), 6.
78 "Die.jcni5Jen, rvelche die Natur ganz sklavisch nach-ahmen, fast jedes Blättchen und.jedetr Bruch im Felsennachzeichnen, u'ertlen gerade am \fenigsten natürlich er-scheinen, ncil sie die \{irkung im ganzen verfehlen. Aufdiese rnuss m:rn hauptsächlich sehen, \\ienn man nach derNatur zeichnet. Die Harrnonie des Ganzen ist es. n'elcheden Gegcnstand in der Natur uncl au{ der Leini.vand r.ahrund schön macht", cIr. LudtLtig Rit:htas Tageltiichm und. lah-rtshefte 18217883. Ausgervählt r.on Robert Walter (Ham-bnrg,1924),20.
te Secondo Pia Müller-Tamn'r si riconoscerebbe inquesto l'impepJno di Schnorr nel contesto di una nozioneclassicist:r cli paesaggio corne linea di contorno, cfr. PiaMüller-Tamm, "Bemerkunsen zur nazarenischen Land-
i
!.,
r l.:-l
?:,c*&
rlL
\ur'..-2,
:li,',rf.-* i
Provided for non-commercial research and education use. Not for reproduction, distribution or commercial use.
Author's personal copy
210 EnN,A. FroRrNrrr,,rr
Fig. 16. Franz Horny, Fernsicht auf Berge. Bleistift 22,1x 33,3 cm. Annotazioni sui colori e sotto a sinistra"gelber Zug über Horizont". Rirckseite: Ausblick auf eine Burg. Lübeck, Mrrserrm fiir Krrnst- rrnd Kulturge-schichte der Hansestadt Lübeck, Lascito Theodor Rehbenitz, Inr'. Nr. AB 2134.
Sc,cx,rero DI VEDUTE: Lo scuenlct sur-r-d NATURA E r,\ cAMERA r rrcrDA 211
-a' ]t tl n^.zd olq "'. ',
Fig. l7.Julius Schnorrr,on Carolsfeld, Kr,iste in Sorrent, 1820. N{atita ripassata a pennello in marrone, ca 17x ca 29 cm. Annotato in basso al centro: "Die Küste von Sorrent, in der Ferne der Vesuv. Sorr. d. 5 t März1820". Collezione privata, Monaco di Bar-iera.
teristica di questa vedlrta coincide con l'usodella camera lucida, ed ö I'evidente processodi selezione e di sintesi formale durante il di-segno, che proprio negli schizzi di Schnorr di-mostra secondo Ludrvig Richter come un "no-bile stile si possa conciliare con le caratteristi-che della realtä naturale", quando I'artista sia
in grado "di captare Ia Natura distinguendoI'essenziale dal super{Iuo".80 Questo processodi sintesi e scelta \.iene a sua volta consideratodai contemporanei necessario per usufruire
sclraftszeichnung", in Zeichnen in Rom. 1790-1834 303-321,
c1.ri p. 317. Personalmente mi oriento invece all'opinionedi Robert Rosenblum, Tlrc IntmaLionril Style of 1800. AStu(b in linear Ab.straction (Nel York/London, 1976), cheper questo periodo diagnosticizza Ia fine dell'astrazione 1i-
neare neoclassica 1ä, dove nel disegno la linea di contornonon viene piü letta come riflessione teorica e costruzionerazionale. ma cerca di conciliarsi con tcndenze naturalisti-che anche allo stadio di prodr.rzione. E questo era sicura-mente il caso nella cerchia di Schnorr, che considera 1a li-nea l'unico elemento in grado di rendere la varietä e la na-
trtralez.:za del paesaggio: "Xilannigfaltigkeit bringt Leben indas Landschafrsbild. Sie entsteht durch die verschiedenenzahl- und namenlosen Linien, aus n'elchen die Form jedes
Dinges sich zusammensetzt. Alle diese Dinge fließen
in maniera effettiva del potenziale offerto dal-la camera lucida.81
Sotto questa luce, in questa veduta Schnorrnon ha teso alla creazione di un'armonia linea-re di gusto classcista. Egli sembra piuttosto avercercato una formula che ricapitolasse, conci-liandole, Ie forme fondamentali dell'oggettoossenrato con il processo di percezione e inter-pretazione visiva. Nell'opera, questa formulaaveva poi il compito di rendere riconoscibile lapresenza dell'artista e la sua esperienza estetica
zusammen in Massen u<hen dann harmonisch in Har-rptli-rrien tiber. ... Durch die Verschiedenheit der Linien ent-steht Leben und Bervegung" (Richter, Tagebiicher,20).
80 "wie ein edler Stil mit charakteristischen Na-turxahrheiten zu verbinden sei: wie der Künstler mit feinausgebildeten Schönheitssinn die Natur zu erfassen unddabei das Wesentliche vom Unrvesentlichen zu scheidenhabe" (Richter, Lebenserin,nuungen, 278).
tt "[...] an attention to details is not so necessart'i.norder to produce the desired effect [...] I should there-fore recommend sketchers with this instruments to ar,oidminute particulars. [. . . ] in this way the sketch lvill conr,e,v,
upon the rvhole, a more correct idea of the object [...]than if twice the pains had been taken to render a1l itsparts rigidll' correct" (Hal1, Trar,els, 9).
del h-rogo.82 "Chi ossen'a il libro", commenta ln-fatti Schnorr il suo 'Landschaftsbuch', in cui ol-tre alla veduta sorrentina parecchi altri esempiindicano strutturalmente I'uso della camera lu-cida, "immagina volentieri di essere stato vici-no a me ... A parte un paio di rami o alberelli,tutto quello che ho disegnato I'ho anchevisto".83 E riferendosi ad una particolare vedutadi Genzano, si ritiene sicuro che I'apprezza-mento di un osser-r''atore "entusiasta de lla Natu-ra" aumenterä sapendo che "ho disegnato il fo-glio a penna proprio sul luogo".s+ Significativa-mente, Schnorr rimanda in maniera esplicitaanche alla relazione emotiva ed estetica trasc}l'izzie luoghi: riferendosi ai disegni dellaVal-le Egeria (Fig. 18), che dalla struttura sembra-no essere stati altrettanto prodotti con la came-ra h.rcida, egli dichiara infatti che "i disegni del-I'ottobre nellaValle Egeria mi sono cari a calrsadel luogo da cui derivano. Lavalle, in cui anda-
82 Petra Kuhlmann-Hodick & Claudia \ralter (eds. ) : .. .
ein Land der \rn'heisstutg:.luli'us Schnon uon Oarolsfeld zeichnet
It alien (Kö\\, 2000), 21-22.8:i "Der Beschauer des Buchs denkt sich rvohl manch-
mal gern in meiner Nähe. . .. \\'as ich gezeichnet, habe ichbis auf ein Paar Zi.veige ocler Bäumchen auch gesehen"( Sclrnorr r' on Carolsfeld,'Lr i; ( Bri efe, 9 1) .
8a "Als ein begeistelter Fleuncl der Natur u.irst Dr.r
vo spesso, ö cosi dolce e silenziosa, che vi resta-vo volentieri".ss
La camera lucida e l'ambi.r,alente connota-zione dell'esperienza r.isiva che essa trasmette,a cavallo tra registrazione obbiettir,a e reazio-ne individuale, sembra cosi inserisi perfetta-mente nell'orizzonte del nuovo sguardo sulvero degli artisti attivi a Roma intorno al 1820,in particolare quelli di lingua redesca. Lo di-mostra anche una piccola tavoletta ad olio diCarl Wilhelm Götzloff (Fig. 19), che meritaparticolare attenzione per l'importanza cheassume nelle testimonianze contemporanee.L'er,idente carattere 'piatto' di questo piccolopaesaggio deriva dalla mancanza di profon-ditä tipica dei disegni alla camera lucida, cheannulla gli effetti prospettici legati alla r.istanaturale: I'orizzonte dal quale si alzano lemontagne diventa una linea che non si trovaal di dietro, ma spostata sullo stesso piano al di
dich aber hinlänglich entschädigt frndcn durch den An-blick von Genzano, dem See urrd den hübschen Bäurnerrim Vordergrunde, besonders nenn ich Dir sage, daß ichdas Blatt an Ort und Stelle, bis aul die Figiirchen, mit derFeder gezeichnet habe", ibiil., 96).
85 "Die Blätter, die im oktober [1820] im Thal der Ege-ria entstanden sind mir zum Theil des Gebietes tvegen,dem sie entrlommen rvorden, sehr lieb. Das genannte
Provided for non-commercial research and education use. Not for reproduction, distribution or commercial use.
Author's personal copy
272 ERx,c FroRnxrrr.,rr
Fig. lB.Julius Schnorr von Carolsfeld, \'alle Egeria con acquedotto, 1820. Matita ripassata a penna e pen-nello in marrone, 20,6 x 26, 6 cm. Annotato sotto a sinistra: "Im Thal der Egeria. / f820", annotato sul re-tro sopra a destra: "33"; sotto a sinistra: "86". Dresden, Staatliche Krrnstsammhtngen, Kupferstich-Kabinett,Inv. Nr. C 1908-853.
sopra di elementi che, come il ponte, dovreb-bero apparire piü vicini all'osserlratore. Il sen-tiero a sua volta sembra snodarsi verticalmen-te verso il basso, invece di definire prospettica-mente la distanza del ponte dall'osservatore.Visto che il formato della tavoletta corrispon-de alla media dei disegni alla camera lucida, ö
plausibile pensare che Götzloff avesse esegui-to sul luogo un abbozzo preliminare diretta-mente sulla tavoletta con l'aiuto dello stru-mento, per poi rifinirla in colore.86
La tavoletta era stata preparata "con infinitafedeltä", come commentaJulius Schnorr vonCarolsfeld,sT per venir esposta alla "Kunstaus-stellung" a Dresda nell'estate del 1822. Questamostra era stata particolarmente significativa,perch6, come riporta Ludwig Richter:
portö piccoli dipinti da Roma, che molto rivelanosulla nuova direzione in cr"ri la generazione piü gio-vane si muoveva. ... Per me di particolare interessefurono il quadretto della campagna romana diGötzloff e quadri di Klein e Catel. La differenza diqueste produzioni a confronto di Klegel, Klaß e deiFaber... era sorprendente: Sdegnavano tutte le ri-cette e le regole valide nell'arte fino ad allora, ma si
attenevano alla Natura con grande rigore e amore-volezza, nobilitati dal sicr,rro senso stilistico trasmes-so dallo strrdio degli antichi maestri."'
Nel riflesso del piccolo paesaggio di Cötzloffsi riconosce quindi alla generazione romanala cosciente sperimentazione di valori nuor-inella produzione della pittura di paesaggio. Icommenti uffrciali sulla tavoletta dimostrarrcrulteriormente che l'approccio alla Natura deigiovani paesisti e il carattere delle loro tecni-che di ripresa individuale sul luogo non coin-cidevano con le aspettative dell'accademia di
Thal, in welchem ich mich häuhg einfand, ist so lieblichund so stille, daß ich gern daselbstver-weilte", ibid., 92).
8b I-'8 marzo l822Julius Schnorrvon Carolsfeldscrive a
von Quandt che il piccolo paesaggio era "abbastanza avan-zato": "Götzlof... zeigtjetzt eine ziemlich vorgerückte, fürBaron Preuß bestimmte kleine Landschaft" (Schnorr vonCarolsfelcl, Briefe aus Italien, Il / I , 407) .
8i "Er hat die Ansicht auf Ponte Nomentano und das
Sabinergebirg zu seinem Gegenstand genommen. Mitr.rnendlicher Treue und Zartheit hat er sein Vorbild gefaßtund wiedergegeben" (ibid., IIl9, 401 ) .
88 "Die Kunstausstellung im Sommer 1822 fin Dre-sdenl brachte einige kleinere Gernälde aus Rom, die eini-gen Außchluss geben über die neue Richtung, rvelche diejunge Generation eingeschlage hatte. Für mich naren vonbesonderem Interesse ein Bildchen aud der Campagna diRoma r''on Gözloffund Bilder von Klein und Catel. Der Un-terschied dieser Produktionen gegen Klengel und Klaß, dieFabers rar überraschend: Ein \rerschmähen der bisher gel-
2t3
Dresda. La scena, si critica infatti, ö riportata:"con molto amore, pazienza, esattezza, colora-zione originale e in generale fedelmente allaNatura, ma proprio questa fedeltä diventaquasi apprensiva, per cui il quadro ö piü un la-voro scientifico, uno studio piü che una crea-zione artistical La natura stampata fsic!] su te-la non ö ancora un'opera d'artel"Ee
La piccola tavoletta ö cosi testimone dellareazione della giovane generazione di paesag-gisti che in questi anni invade Roma. Essa sioppone alle regole e ai rigidi schemi praticidell'accademia, preferendo asserire un nuovosentimento generale per I'approccio alla na-tura, di stampo fenomenologico e nello stessotempo introspettivo.
Se questa sfida consisteva anche nell'adotta-re nuove pratiche pittoriche basate sull'osser-vazione e rappresentazione dal vero, la cameralucida sembra esserne stata parte integrante.
Lo sguardo armato di camera lucida si inse-risce nella ricerca di una sintesi tra oggettivitägrafico-formale e individualitä di percezioneregistrabile nel primo Ottocento a livello euro-peo.e0 Sia il carattere di questa ricerca che Iapratica strumentale ad essa collegata contrad-dicono decisamente la posizione di Sergio Or-tolani, per il quale gli artisti impegnati nella ri-cerca sul luogo, "lungi dall'affermare libera-mente la propria originalitä individuale, cerca-rono anzi di negarla, sottomettendola al servi-gio di codesto comune, impersonale oggettodel 'r'ero' ...n6 la loro tecnica ebbe altro com-pito che enunciare pittoricamente ... le loro'appercezioni' o constatazioni di euel 'r'ere"'.ot
Se per certi versi, infatti, la camera lucida sod-disfava le esigenze del realismo topografico,
tenden Kr-rnstrezepte und Regeln, aber ein um so strengeresund höchst liebevolles Anschließen an die Natur, geadeltdurch ein gewisses Stilgeftihl, I'elches sie den ältesten Mei-stem abgelenrt hatten" (Richte r, Lebms ninnerungen, 771) .
8!r "Die kleine Landschaft so der Kammerherr Preul3von ihm in Rom gemalt, zur Ausstellung gegeben, war mitvieler Liebe, Geduld, Reinlichkeit, wahrem Farbenton wieüberhaupt der Natur get-rer.r rviedergegeben, allein ebendiese Treue ging bis ins Angstliche, daher das Bild mehrein wissenschaftliches Werk, ein Studium als Kunstschöp-fungl Die Natur auf l,einwand abgedruckt ist noch keinKrrnsnverk!" (Commento del Professor Friedrich Matthäibei der Ausstellung 1822, citato in Lentes, Carl WilhelmGötzkff,37, n.37).
e0 Cfr. Erna Fiorentini (ed.), The Osmotic Dyn,atnics ofRomantit:isrn. Obsmting Nalure - fupresenting Experience I800-7850 (Max-Planck-Institue for the Histor-v of Science, Pre-print 304; Berlin, 2005).
el Ortolani, Giacinto Gigante,32.
Sc.lvero DI VEDUTE: Lo scLreruo suI-t-d NATURA E LA cAr{ERA LUCIDA
_ ,,t: -
I
Fig. 19. Carl \Alilhelm Götzloff, Campagna con ponte, monumento funerario e montagne, 1822. Olio su ta-
rola. 29. 3 x 39 crrr. Collezione prirata.
:;{'
Provided for non-commercial research and education use. Not for reproduction, distribution or commercial use.
Author's personal copy
214 Enx.q. Froru,xrrNr
essa offriva anche Ia possibilitä di liberare la li-nea, come rrrezzo di espressione artistica, daiIegami della razionalitä illuminista, e di incor-porarla nelle soluzioni di quella produzioneartistica che sperimentava un nuovo concettodi osservazione e registrazione della Natura.Nel quadro di questo concetto, il disegno e lalinea potevano venire infatti, con I'aiuto dellacamera lucida, elidenziati come portatori direaltä ontologica e restare fulcro della rappre-sentazione dal vero; ma con questo strlrmentoessi potevano anche esser messi in manierapit) o meno accentuata al sewizio dell'impres-sione, a seconda delle esigenze individualidell'artista.
Nel contesto romano intorno al 1820, lenuove vedute che trasportano questi esperi-menti di sintesi tra corrispondeza formale ed
esperienza personale come momento di ricer-ca artistica, e segnano il progressivo passaggioad un paradigma "privato" nelle pratiche pit-toriche, soppiantano le vedute settecentesche.Negli "intrecci reciproci di un variegato grup-po di punta"e3 della pittura di paesaggio, le di-verse comunitä artistiche condividono la di-scussione delle nuove strategie di approccio alreale. Che la camera lucida venisse adottata inmaniera pen'asiva tra i paesaggisti di dir,ersaprovenienza lascia intravedere la presenza diun dibattito sul valore dell'ossen'azione comepratica sintetica di esperienza e rappresenta-zione.
A Roma quindi, come punto focale del na-scente nuovo paesaggismo, intorno al 1820r.rno scambio di vedute ö in corso in tutti isensi.
e? Stefano Susinno, "Il successo di 'Francesco' Cateltra pittura di genere e di paese nella Roma della Restaura-
zione", in li'anz Luduig Catel e i suoi antiti a Roma. Un album
di disegni dell'Ottocento, ed. Elena Di N{ajo ('Iorino, 1996),1l-20, qui 17.
Provided for non-commercial research and education use. Not for reproduction, distribution or commercial use.
Author's personal copy