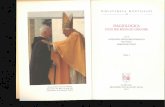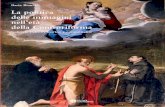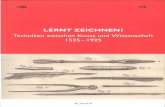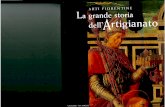Savonarolismo e antisavonarolismo a Modigliana: Gabriele Biondo contro i magistrati fiorentini,...
Transcript of Savonarolismo e antisavonarolismo a Modigliana: Gabriele Biondo contro i magistrati fiorentini,...
MICHELE LODONE
SAVONAROLISMO E ANTISAVONAROLISMO A MODIGLIANA:
GABRIELE BIONDO CONTRO I MAGISTRATI FIORENTINI *
Modigliana. 28 aprile 1498. Così Gabriele Biondo, priore della Pievedi Santo Stefano, scrive a «Strinato Strinati citadino fiorentino»:
La vostra venuta qua me serà sempre gratissima, non obstante che io scrivessedesiderare la vostra stantia là per fino ch’el frate fusse examinato, perché nonmancaranno advisi de dì in dì a diverse persone. El vostro castellano me havevapreso odio mortale, et per quel che sento haveva ordinato farmi mal capitare, sele cose fusseno successe in favor de li coniurati et subscripti, perché lui sento direesser stato uno de quelli. Qualche volta ha havuto a dire volermi amazzare conuna bombarda, quando io predico nella chiesia de sotto, sperando dar dirictoper la qualità del loco che de fuora se vede. Dio ha rotti li desegni; comunicossiexcomunicato per favorire publicamente el frate, et ha messo in questo locomolta heresia et datomi molti affanni perché ce è stato un frate de San Domenicoche ha predicato dentro, al quale lui se confessò poi che da me non era absolu-to, perché voleva che lui renegasse el frate, et ello non voleva. Questo predica-tore a sua instantia nelle sue prediche più volte me punse laudando coperta-mente frate Hieronymo, et biasimandomi che diceva mal de lui; pure doe volteapertamente lo laudò per homo bono et iusto et sancto [...], per qual cosa elloincorse nella medesima excomunicatione che frate Hieronymo, secondo el teno-re del breve ultimo contra el frate mandato [...].
* Si pubblica, con qualche leggera modifica e con l’aggiunta delle note, il testo della rela-zione letta a Modigliana il 27 ottobre 2013.
MICHELE LODONE72
La lettera – che si legge in un ms. della British Library di Londra 1 –è molto lunga: sarà quindi opportuno, intanto, fermarsi e cominciare adanalizzarla. Anzitutto la data: 28 aprile 1498. Venti giorni prima, nellanotte tra l’8 e il 9 aprile, era stato arrestato a Firenze GirolamoSavonarola; e altri non è che il «frate» di cui si parla. Biondo chiede dun-que al suo corrispondente di attendere in città ch’egli «fusse examinato»(due dei tre processi cui il profeta di San Marco fu sottoposto si eranogià chiusi 2), perché sa che gli «advisi» che si sarebbero fatti a Firenze perregolare la questione lo avrebbero riguardato direttamente. Come si èvisto e come si legge nel seguito della lettera, egli aveva infatti presoesplicitamente e pubblicamente posizione in merito alla scomunica diSavonarola; e – non senza qualche rischio, se è vero che il castellano diModigliana aveva minacciato di prenderlo a colpi di bombarda mentrepredicava – si era impegnato con irremovibile fermezza a difendere l’au-torità papale. Cerchiamo di ricostruire i dettagli. Biondo non fa nomi. Cisfugge dunque quello del frate Predicatore che, col sostegno del castel-lano, aveva difeso Savonarola dal pulpito (il pulpito probabilmente dellocale convento domenicano di Santa Maria delle Grazie 3). Non è inve-
1 LONDRA, BRITISH LIBRARY, Addison 14088, c. 190r-v (vd. il testo completo della missi-va in “Appendice” al presente contributo). Per un’adeguata descrizione dei codici contenentiopere di Gabriele Biondo, siamo costretti a rinviare a un lavoro ancora in corso. I principalial momento noti – oltre al citato ms. londinese – sono: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale,Magliab. XXXV, 214; Forlì, Biblioteca Comunale, ms. 412; Siviglia, Biblioteca Capitular y Co -lom bina, ms. 325 (7-1-9) – quest’ultimo ci è stato segnalato da Sylvain Piron, che ringraziamovivamente.
2 Tra il 9 e il 19 aprile, e tra il 21 e il 25 il frate era stato sottoposto a due processi civili;tra il 20 e il 22 di maggio si sarebbe tenuto poi il terzo ed ultimo processo, ecclesiastico; sul-l’intera vicenda vd. I. G. RAO, P. VITI, R. M. ZACCARIA (a cura di), I processi di GirolamoSavonarola (1498), Firenze 2001.
3 Esistevano allora a Modigliana due conventi domenicani (uniti poi nel 1541): quello diSanta Maria Maddalena, fondato nel 1390, a circa un miglio di distanza dal paese; e quello diSanta Maria delle Grazie, più recente – la costruzione cominciò nel 1460 – ma presto eretto aconvento principale: vd. S. L. FORTE, Le provincie domenicane in Italia nel 1650. Conventi ereligiosi. V. La «Provincia utriusque Lombardiae», «Archivum fratrum praedicatorum», XLI(1971), pp. 325-458: 405-06. Tra 1497 e 1499 era stato trasferito nel secondo di essi BattistaCarioni, meglio noto come Battista da Crema, futuro maestro spirituale dei primi Barnabiti(vd. la voce di S. PEZZELLA, in Dizionario Biografico degli Italiani [d’ora in poi DBI], vol. XX,Roma 1977, pp. 115-18; E. BONORA, I conflitti della Controriforma. Santità e obbedienza nel-l’esperienza religiosa dei primi barnabiti, Firenze 1998, pp. 127-129). Non si conoscono né imotivi né la durata della permanenza del domenicano cremasco a Modigliana (dove sarebbestato il superiore del convento, secondo P. F. GRENDLER, Man is Almost a God: Fra BattistaCarioni between Renaissance and Catholic Reformation [1993], in ID., Renaissance EducationBetween Religion and Politics, Aldershot 2006, pp. 227-249: 229); si torna ad avere sue noti-
GABRIELE BIONDO CONTRO I MAGISTRATI FIORENTINI 73
ce difficile risalire all’identità del magistrato fiorentino: come attestatodai registri delle tratte, nell’Archivio di Stato di Firenze, fu castellano diModigliana dal 15 dicembre 1497 al 15 giugno 1498 Marco di Bernardodi Piero Vespucci 4. Con tanto cognome, non poteva non giungerci qual-che notizia sul suo conto. Figlio di uno dei più ricchi banchieri fiorenti-ni, questo Marco Vespucci – da non confondere col quasi omonimo con-temporaneo Marco di Piero, marito della Simonetta Cattaneo immorta-lata nella poesia e nell’arte dell’epoca, dal Magnifico a Poliziano a Bot ti -cel li – Marco Vespucci, dicevamo, era nato nel 1452, e aveva ed avrebbericoperto a Firenze diverse cariche pubbliche fino al 1527, l’anno dellasua morte 5. Non conosciamo la natura e le ragioni del suo tanto accesosavonarolismo; e tuttavia l’accenno di Biondo ai «subscripti» di cui ilcastellano faceva parte rimanda a un episodio preciso: ossia alla petizio-ne firmata da oltre trecento fiorentini e rivolta nel luglio 1497 a papaAlessandro VI perché liberasse il frate ferrarese dalle censure. La si puòleggere in appendice al pregevole studio di Lorenzo Polizzotto sul movi-mento savonaroliano: tra i firmatari, Marco di Bernardo Vespucci 6. Se lapetizione avesse raggiunto il suo scopo, questi avrebbe certo fatto «mal
zie solo nel 1522, quando sarà a Padova. Nulla sappiamo di un suo possibile incontro conGabriele Biondo.
4 Archivio di Stato di Firenze [d’ora in poi: ASFi], Archivio delle tratte, Uffici estrinse-ci, reg. 987, c. 106.
5 In ASFi, Raccolta Sebregondi, 5454 è conservato un utile dossier sulla famigliaVespucci. Di Marco di Bernardo – del Quartiere di Santa Maria Novella, Gonfalone Uni-corno – ricaviamo che fu castellano del Cassero vecchio di Borgo San Sepolcro nel 1479-1480,potestà di Terranova nel 1482-1483, tra i Dodici Buonomini nel 1485, castellano della rocca diMarradi nel 1485, di Campiglia nel 1491-1491, di Modigliana (come sappiamo) nel 1497-1498,tra gli Otto Priori di libertà nel 1494, ancora castellano del Cassero vecchio di Borgo SanSepolcro nel 1500, della Fortezza nuova di Livorno nel 1501, di Firenzuola nel 1503, tra iSedici Gonfalonieri di Compagnia nel 1506, ancora castellano a Marradi nel 1507 e ivi capi-tano nel 1521, potestà di Castiglion Fiorentino nel 1525, e di Tizzana nel 1526-1527. Si sposòcon una Caterina di Domenico di Niccolò nel 1484, poi con Lucrezia Boccacci nel 1512 e conLucrezia Rimbaldesi nel 1526; ebbe tre figli di nome Luigi, Giovambattista e Giulia. Un suofratello, Piero, era proprio allora, tra il 1497 e il 1498, commissario per la Romagna fiorenti-na. Il nostro Marco è menzionato anche in un documento catastale riportato da A. F. VERDE,Lo studio fiorentino 1473-1503: ricerche e documenti, vol. III/2, Pistoia 1977, p. 1073.
6 L. POLIZZOTTO, The Elect Nation. The Savonarolan Movement in Florence, 1494-1545,Oxford 1996, pp. 446-460 per il nome di Marco di Bernardo (sulla petizione vd. anche ivi, pp. 12-15); G. PAMPALONI, Il movimento piagnone secondo la lista del 1497, in M. P. GIL MORE(ed. by), Studies on Machiavelli, Firenze 1972, pp. 335-347; G. GUIDI, La corrente savonaro-liana e la petizione al Papa del 1497, «Archivio storico italiano», CXLII (1984), pp. 31-46; S. DALL’AGLIO, Savonarola e il savonarolismo, Bari 2005, pp. 61, 202.
MICHELE LODONE74
capitare» al nostro pievano; ma le cose andarono diversamente, e allafine di aprile del 1498 Biondo poteva ben scrivere che «Dio» aveva«rotto li desegni», aspettando e pretendendo che venisse debitamentesanzionato il fazioso castellano; il quale peraltro col suo comportamento,insieme al già menzionato (a noi ignoto) Predicatore, era incorso «nellamedesima excomunicatione che frate Hieronymo». Infatti con il «breveultimo contra el frate mandato», il 9 marzo Alessandro VI aveva di nuovoingiunto alla Signoria fiorentina – poiché il precedente breve del 26 feb-braio era rimasto inascoltato – che impedisse a Savonarola di continuarea predicare, e al frate di presentarsi a Roma: pena l’interdetto sulla città,la confisca dei beni posseduti da fiorentini nello Stato Pontificio e l’in-carceramento dei mercanti fiorentini che ivi si trovavano 7. Naturalmenteerano anche rinnovate le implicazioni della scomunica contro Savonaroladel maggio 1497 – che sarebbe incorso, cioè, nella censura chiunqueavesse frequentato il domenicano o ascoltato le sue prediche. Firenze visse allora un periodo di profonda tensione. I cittadini cono-
scevano il tenore dei brevi, tempestivamente ed ampiamente divulgatidai pulpiti 8; molti, anche tra chi aveva riposto speranze ed aspettativenel profeta di San Marco come il cronista Luca Landucci, preferironotenersi in disparte 9. Altri, non solo in città, ma anche nel dominio, con-
7 Il testo del breve in A. GHERARDI (a cura di), Nuovi documenti e studi intorno a G. Savonarola, Firenze 18872, pp. 194-196; sui provvedimenti di Alessandro VI contro Firenzevd. anche R. C. TREXLER, The Spiritual Power: Republican Florence under Interdict, Leiden1974, pp. 173-178.
8 Vd. L. LANDUCCI, Diario fiorentino dal 1450 al 1516 continuato da un anonimo fino al1542, a cura di J. DEL BADIA, Firenze 1883 [rist. anast. con pref. di A. LANZA, Firenze 1985],pp. 152-153: «E a dì 18 di giugno 1497 venne dal Papa una scomunica che scomunicava frateGirolamo, la quale si gittò in questa mattina a Santo Spirito, in Santa Maria Novella, in SantaCroce, nella Badia e ne’ Servi. La quale sentii io leggierla e gittarla in Santo Spirito, nel per-gamo di coro, infra due torchi acesi e più frati; e letta e gettata per le mani di un frateLionardo, loro predicatore e aversario di detto Frate Girolamo. La quale conteneva che ‘ldetto frate non aveva ubidito a un certo brieve a lui mandato insino di novembre 1496 che locitava in santa ubidienza che andassi al Papa; e non volendo ubidire lo scomunica, e che nonsia chi gli dia aiuto o sussidio, e che non si possa andare a udire, né andare a luogo dove sia,sotto pena di scomunicazione». Sul «frate Lionardo» menzionato dal cronista vd. S. BONDI,Leonardo Vallazzana da Fivizzano, agostiniano, teologo, predicatore ed avversario di G. Savo na -ro la, «Analecta augustiniana», LX (1997), pp. 7-48.
9 LANDUCCI, Diario fiorentino, cit., pp. 161-162: «E a dì 11 di febbraio 1497, cominciò apredicare frate Girolamo in Santa Maria del Fiore, [...] e andovvi molta giente, e molto si par-lava di lui ch’era scomunicato, e molti mancorono d’andarvi per temenza della scomunica dicen-do: giusta vel ingiusta, timenda est. Io fui di quegli che non vi andavo». Sullo speziale fioretinoe il suo peculiare savonarolismo vd. la voce di S. CALONACI, in DBI, LXIII, 2004, pp. 543-546.
GABRIELE BIONDO CONTRO I MAGISTRATI FIORENTINI 75
traddissero la volontà del papa e presero pubblica posizione a favore diSavonarola: tra questi, Marco Vespucci. E tuttavia il castellano di Mo di -gliana non aveva previsto che il priore della pieve si sarebbe opposto inmodo tanto risoluto, pretendendo che i brevi pontifici fossero scrupolo-samente osservati. E anche il podestà del luogo – definito da Biondo uno«socco», nel seguito della lettera – non aveva certo considerato che il pie-vano avrebbe divulgato e fatto «legere in piazza» le missive della Signoriariguardanti «el caso del frate», che il podestà stesso «non publicava»(missive che purtroppo non siamo riusciti a rintracciare 10). Ad ognimodo, forte della sua condotta irreprensibile quando i giochi ancora nonerano fatti, sul finire di aprile Biondo era ormai disposto ad andare finoin fondo contro «li laudatori publichi et defensori del frate»; sia sulpiano secolare («etiam che quella non sia stata la mia intentione in dirmal del frate», teneva tuttavia a sottolineare), sia su quello spirituale. Epoiché il castellano Marco Vespucci aveva «pestilentiato» e reso «rebel-le» la cittadinanza contro di lui, il pievano chiedeva anche garanzie dalnuovo governo insediatosi a Firenze. Preoccupazione che rimanda a unconflitto non solo personale, ma tale da coinvolgere tutta la comunitàmodiglianese; una comunità che, storicamente, era nata proprio attornoai due poli del castello e della pieve, del castrum e della plebs 11.
10 Podestà di Modigliana dal 19 dicembre 1497 al 19 giugno 1498 fu Niccolò di Luigi diGiovanni Quaratesi (ASFi, Archivio delle tratte, Uffici estrinseci, reg. 987, c. 34 – o anche ivi,reg. 1045, c. 10r), di cui sappiamo ch’era nato nel 1454 ed era stato tra i Dodici Buonomininel 1494; dopo che a Modigliana fu podestà di Greve nel 1499, e morì a Livorno – dov’eradoganiere – nell’agosto 1509 (ASFi, Raccolta Sebregondi, 4374a, tav. IX). Nel suo carteggio conil governo fiorentino non si trovano i dispacci cui accenna Gabriele Biondo: vd. comunqueASFi, Dieci di Balìa, Missive, reg. 57, cc. 32v-33r (1° gennaio 1497 [ossia ’98], informati delpassaggio da Modigliana di «dua staffieri di Piero de’ Medici» i Dieci scrivono a Quaratesi di«fare ogni opera per haverli nelle mani»), 142r-v (22 maggio 1498, i podestà di Castrocaro,Marradi e Modigliana provvedano affinché i loro sudditi contribuiscano «alla spesa del bar-gello anchora per sei mesi»); ivi, reg. 58, cc. 28v-29v (23 dicembre 1497, Quaratesi provvedaalla restituzione del bestiame rubato da un suddito fiorentino residente presso Modigliana aun abitante di Cotignola, suddito del Duca di Milano), 136v-137r (1° giugno 1498, contenutoanalogo a quella del 22 maggio); ivi, Responsive, reg. 57, cc. 248 (4 giugno 1498, risposta aidispacci del 22 maggio e del 1° giugno), 308 (7 giugno, sul radunarsi di soldati a Ravenna).Non interessa Biondo neppure il carteggio di quei mesi tra il castellano e i Dieci: ASFi, Diecidi Balìa, Missive, reg. 58, c. 86r (i Dieci a Marco Vespucci, 7 marzo 1497 [ossia ’98]: il castel-lano è elogiato per aver inoltrato a Firenze delle notizie giunte da Venezia, per quanto esse nonfossero «di molto conto»); ivi, Responsive, reg. 57, cc. 309, 314, 352 e reg. 58, c. 30 (Vespucciai Dieci, le prime due del 7, la terza senza data, l’ultima del 14 giugno 1498: tutte sui movi-menti militari di Romagna).
11 Vd. L. MASCANZONI, L’organizzazione civile ed ecclesiastica fra alto e basso Medioevo, inN. GRAZIANI (a cura di), Storia di Modigliana, la città della Romagna toscana, Modigliana 2010,vol. I, pp. 117-138: 128-135.
MICHELE LODONE76
Ma chi era Gabriele Biondo? Figlio del grande umanista BiondoFlavio, Gabriele era nato forse a Ferrara tra la fine degli anni Trenta e iprimi anni Quaranta del Quattrocento. Cresciuto a Roma, in un conte-sto familiare strettamente legato alla Curia, già sul finire degli anni Ses-santa poteva appellarsi a lui chi, come il medico romano Agapito Porcari,giudicava con severità la fastosa città dei Papi, nei quali si stentava a riconoscere gli eredi dell’originario messaggio cristiano 12. Pievano diModigliana a partire almeno dal 1473 13, per circa un trentennio fu quin-di guida spirituale di una comunità che dalle pendici dell’Appennino siestendeva fino a Firenze, Forlì, Bologna, Venezia. Se si eccettuano le suelettere ai discepoli e quelle, molto interessanti, a lui inviate dal Padregenerale dei Ca mal do lesi Pietro Dolfin, resta ben poco di questa purlunga permanenza; ma non si deve escludere, e anzi si può sperare chequalcosa di più, a livello locale, possa ancora emergere 14. Non è questa
12 Sulla sua figura, oltre al pionieristico, magistrale studio di C. DIONISOTTI, Resoconto diuna ricerca interrotta, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», s. II, XXXVII (1968),pp. 259-269 (ristampato in ID., Scritti di storia della letteratura italiana, a cura di T. BASILE, V. FERA, S. VILLARI, vol. II, Roma 2009, pp. 325-336), vd. ora M. LODONE, L’eredità dei fran-cescani spirituali tra Quattro e Cinquecento. Una ricerca in corso su Gabriele Biondo, «Oliviana.Mouvements et dissidences spirituels. XIII-XIV siècles», IV (2012), on-line [URL: <http:// oli - viana.revues.org/index487.html>].
13 Vd. la lettera di Gabriele Biondo, datata 24 febbraio 1473, in ASFi, Corporazioni reli-giose soppresse, 78 (Badia di Firenze, 1412-1595), vol. 321, p. 315. In essa Biondo – anche anome del fratello Girolamo, pievano della vicina Castrocaro – scrive a Diociaiuti de Moritis,canonico fiorentino, a proposito del carico eccessivo di decime da cui entrambi erano gravati.La pieve di Santo Stefano, documentata a partire dalla fine del IX sec. ed originariamente sot-toposta a Ravenna, si trovava a partire dal XII sec. nell’orbita faentina; ma, al tempo di Biondo,Modigliana (come anche Castrocaro) rientrava politicamente sotto il dominio fiorentino, e ipievani rischiavano di dover pagare le stesse imposte due volte, a Faenza e a Firenze. Proprionell’anno precedente alla lettera in questione, in effetti, la Repubblica fiorentina aveva infor-mato il vescovo di Faenza del diritto concessole dal Papa di imporre una tassazione al clero residente nel proprio dominio (ASFi, I Cancelleria, missive, 46, c. 82r-v, lettera del 10 maggio 1472). Della permanenza di Biondo sulle pendici dell’Appennino tratteremo piùdiffusamente altrove; sulla pieve vd. intanto A. VASINA, La pieve di Modigliana e la distrettua-zione nella valle del Marzeno (secoli IX-XIII), «Studi romagnoli», XXVIII (1977), pp. 3-15; F. MAN CORTI, La pieve di S. Stefano papa in Modigliana, «Ravennatensia», XIII (1991), pp. 79-84; L. SA VELLI, La cripta della pieve di S. Stefano di Modigliana, ivi, pp. 109-111.
14 Tra i verbali dei dibattiti del Consiglio generale di Modigliana, si trova copia di unaSuplicatio domini prioris plebis Sancti Stefani (non datata), in cui si legge come «miser Ga -briello Biondo priore de la pieve de sancto Stefano de Modigliana», avendo «intentione devenire in qualche bona proprietà, e cusì successivamente de fare qualche buono fructo», aves-se richiesto alle autorità locali la cittadinanza modiglianese (d’«esser chiamato, tenuto, repu-tato e fatto homo dil comune de Modigliana» – Modigliana, Biblioteca comunale Don Gio -vanni Verità del Comune e dell’Accademia degli Incamminati, Archivio storico, Fondo preu-
GABRIELE BIONDO CONTRO I MAGISTRATI FIORENTINI 77
la sede per ricostruire poi nei necessari dettagli il processo per eresia cuifurono sottoposti a Ve ne zia, nel 1501, un seguace di Biondo – un medi-co bolognese – e un libretto del priore di Modigliana, intitolato Ricordo.Il processo, ad ogni modo, si risolse con un’assoluzione, per quantocauta. Di lì a pochi anni di Biondo si perdono le tracce; egli morì, pro-babilmente, nel 1511 15.Ma torniamo alla sua opposizione nei confronti di Savonarola; una
opposizione cominciata almeno dalla prima metà degli anni Novanta 16,e – co me abbiamo visto – intransigente anche sul piano pubblico. Tutto
nitario, Partiti del Consiglio generale, I (1475-1483), c. 345r-v; il II (1502-1521) non interessa).In altra sede si renderà conto poi della documentazione notarile faentina.
15 Siviglia, Biblioteca Capitular y Colombina, ms. 325 (7-1-9), c. 81v.16 Si leggano le lettere scritte da Biondo a Giovan Battista Bartoli il 16 maggio e il 13 giu-
gno 1492 («De li frati che là giù si fanno poco mi maraviglio: Dio ha dato in preda de suoiadversarii la sua infidele sposa, intanto che non già como inimici ma como sposo son permes-si da lui adulterar cum quella. El parto chiarirà el padre bianco o nero, como advene a ledonne de qua, che commetteno adulterio cum servi ethiopi ingannate da notte nel sonno, per-ché voluntariamente li hanno lasciati dormire in camera contra el comandamento et honoredel marito. Vederannosi li fructi, che daranno iudicio de l’arbore; el facto sta in posser expec-tare patientemente che passi la estate de questi permessi fervori et venga lo autunno et vernocon venti et brine et ghiacci et neve, et vederassi chi starà al martello et al cenerazzo. In que-sto meggio faciam conto de esser Samaritani, perfino che a Dio piace liberarci da lo incurso etdemonio meridiano»); a Strinato Strinati il 26 luglio («Quando piacerà a Dio aprirà gli ochiiad una parte remasta de quel populo, et farà conoscere le tenebre palpabile che sono stateprese per meridiana luce. Ascenda in alto quanto alzare el possono li principi infernali princi-panti hoggi dì nelli principi terreni; a suo tempo caderà confuso senza speranza de relevarsi,et la sua confusione serà al mondo notissima et carissima») e il 22 agosto 1495 («Ho havutauna vostra a me gratissima, per quale intendo quanto scriveti de lo officio havuto et vostrodubio de acceptarlo, et anco de lo invito factovi et conforto de li amici che andati a visitarefrate Silvestro, et dico quanto a la prima parte che io ve conforto acceptare [...]. A l’altra partedel frate remitto in vostro arbitrio et iudicio, secondo che el Signor ve spira posser resistere ale loro venenose persuasione, nelli quali et con li quali opera el Diavolo como in casa propriaet como instrumenti a sé aptissimi. Serìami grato ogni subsidio havesti etiam de là, purché eltemporal subsidio non fusse nocumento spirituale. Udir non noce a chi non crede et non con-sente, et le elemosine se posso chiedere etiam a li inimici de la fede, mancando quelle de fide-li; ma la loro conversatione è prohibita però che è suspetta de veneno. Maxime quando sonotali che a fine de subvertire fanno le elemosine, como son certo faranno questi se alcuna nefaranno in voi. Porìa esser sì breve il tempo de li rasonamenti et cum tanta industria tirato inaltri parlari che poco o niente porìa nocere a chi havesse puncto de fermezza. Hora Dio ve illu-mini, et faccia pigliar partito secondo el suo beneplacito»): vd. Londra, British Library,Addison 14088, cit., rispettivamente cc. 180v, 181r-v, 189v-190r. Il «frate Silvestro», cui si fariferimento nella seconda missiva riportata, altri non è che il domenicano Silvestro Maruffi.Fiorentino, sostenitore entusiasta del profeta di San Marco, in quegli anni egli fungeva spessoda intermediario tra i propri concittadini ed il ferrarese, anche se questi non riponeva pienafiducia nel suo visionario seguace; tuttavia frate Silvestro gli sarebbe rimasto devoto fino a con-dividerne nel maggio 1498, insieme al confratello Domenico Buonvicini, la triste sorte: vd. lavoce di I. G. RAO, in DBI, LXXI, 2008, pp. 384-387.
MICHELE LODONE78
ciò rende poco plausibile l’ipotesi di Carlo Dionisotti che le invettiveantisavonaroliane presenti nei trattati di Biondo, ed anche nel trattatoincriminato, fossero un semplice pretesto «per esporre e divulgare unadottrina che per sé e in altre condizioni non sarebbe sfuggita ad un’im-mediata repressione» 17. Ad ogni modo la natura teologica, oltre e piùche politica, dello scontro di Biondo con il frate ferrarese meriterebbe undiscorso a parte. E tuttavia l’episodio – la microstoria, verrebbe da dire– che si è appena tentato di delineare permette intanto di scorgere l’op-portunità, anche e forse proprio a partire dagli episodi più significativi digrandi storie cittadine, di connettere i centri di maggior spicco con leperiferie circostanti. Il caso di Savonarola, degli scontri tra i suoi segua-ci e i suoi oppositori (scontri politici e religiosi – politici perché religio-si? – ch’ebbero il loro centro a Firenze, ma che non mancarono eviden-temente nel dominio), mostra come in questa direzione potrebbe restareancora molto da fare 18.In chiusura non sarà superfluo un cenno, proprio in questa sede, alla
storia degli studi (pochissimi) su Gabriele Biondo. La prima ricerca sulfiglio del grande umanista fu intrapresa da tre grandi nomi: DelioCantimori, Augusto Campana, Carlo Dionisotti. L’impulso partì da que-st’ultimo, che alla metà degli anni Cinquanta si era imbattuto «per merocaso, ossia per la norma che presiede alla ricerca dell’ignoto» – com’eb-be a dire 19 – in alcuni documenti fondamentali per la vita e l’opera diBiondo. I tre amici e maestri si misero al lavoro, ognuno secondo le pro-prie competenze (a Campana i dati biografici ed eruditi, a Cantimori ladottrina religiosa, a Dionisotti l’analisi linguistico-letteraria); non riusci-rono tuttavia a portare fino in fondo la ricerca per la morte di Cantimori.Nel dicembre 1967, commemorando a Pisa, presso la Scuola Normale,l’amico scomparso, Dionisotti e Campana parlarono appunto del pieva-no di Modigliana, in due interventi dal comune sottotitolo di Resocontodi una interrotta ricerca a tre. Ma fu poi soltanto lo studioso piemontesea dare alle stampe il proprio contributo. Campana non pubblicò il suo;
17 DIONISOTTI, Resoconto di una ricerca interrotta, cit., p. 330.18 Una buona messa a punto da cui partire potrebbero costituire i contributi raccolti in
A. F. VERDE, R. M. ZACCARIA (a cura di), Il santuario di Santa Maria del Sasso di Bibbiena dallaprotezione medicea al Savonarola, Firenze 2000.
19 DIONISOTTI, Resoconto di una ricerca interrotta, cit., pp. 325-326. Sulla «ricerca inter-rotta» vd. anche G. MICCOLI, L’insegnamento di Campana alla Normale, in R. AVESANI (a curadi), Testimonianze per un maestro. Ricordo di Augusto Campana, Roma 1997, pp. 27-41: 40-41.
GABRIELE BIONDO CONTRO I MAGISTRATI FIORENTINI 79
restano però tra le sue carte – conservate presso la Biblioteca Gam ba lun -ga di Rimini – alcuni appunti interessanti, per quanto brevi ed ellittici(presi soprattutto sulla base di documentazione faentina e vaticana), e unpaio di riproduzioni di manoscritti 20. Ma soprattutto, resta il carteggiocon Dionisotti riguardante Gabriele Biondo: cinque lettere in totale,quattro di Dionisotti (tra le quali la minuta di una indirizzata a GiuseppeDe Luca), e la minuta dattiloscritta della risposta di Campana 21. Da que-st’ultima, datata 13 luglio 1955, emerge con evidenza lo speciale interes-se del grande erudito romagnolo per il pievano di Modigliana. «Per unpo’ di giorni quasi non mi ha fatto dormire tanto è attraente», confessa-va Campana. E, dopo aver segnalato a Dionisotti un importante ms. for-livese (Biblioteca Comunale, ms. 412), in cui si leggono lettere ed estrat-ti di lettere di Gabriele Biondo, aggiungeva:
Questa tua ricerca, oltre che beninteso per il suo grande interesse e le ovvie con-nessioni romagnole, mi ha affascinato per un legame tutto mio: Modigliana.Modigliana è terra romagnola, romagnolissima, a 20 km da Faenza, e oggi in pro-vincia di Forlì, ma per più di cinque secoli, e dunque anche a<l> tempo del tuoBiondo, la sua storia è stata fiorentina e toscana, e mio padre vi nacque nel 1854suddito del Granduca, e un prete liberale come l’amico di casa dei miei vecchi donGiovanni Verità non avrebbe potuto viverci se non come suddito del Granduca, equando io ci andavo bambino era ancora in provincia di Firenze e mi sembravaquasi di andare all’estero (aggiungi la parlata romagnola del dialetto, ma risonantedi accenti toscani nell’italiano [...]). Con tutto ciò, puoi ben immaginare se la tualettera non mi ha fatto mettere sottosopra tutti i libri di storia modiglianese di cuidisponevo, con una ripresa intensa di ricordi infantili e famigliari, di curiosità e diricerche giovanili, di voglia di ritornare lassù come non faccio da anni [...] 22.
Mi si perdonerà la lunga citazione. Sul contributo fondamentale cheAugusto Campana portò, nel 1949, per la fondazione della Società che
20 Del citato codice di Forlì (Biblioteca Comunale, ms. 412); e dei Carmina di PaoloPorcari dedicati a Biondo del ms. V E 57 della Biblioteca Nazionale di Napoli (cc. 52v, 75v,83v, 87r, 88v; segnalati da P. O. KRISTELLER, Iter Italicum, vol. I, London-Leiden 1963, pp. 417-18). Di Paolo Porcari, fratello del già menzionato Agapito, è da vedere anche la rac-colta poetica conservata nel ms 274 della Biblioteca Classense di Ravenna (i carmina dedicatia Biondo alle cc. 8r-v, 15v-16r, 73r-v). Sui due fratelli vd. A. MODIGLIANI, I Porcari: storie diuna famiglia romana tra Medioevo e Rinascimento, Roma 1994, pp. 107-108, 455-459, 498-501.
21 Rimini, Biblioteca Civica Gambalunga, Carte Augusto Campana, busta 118, fasc. 13 (B IV 3): Gabriele Biondo e altri figli di Biondo (con carteggio Dionisotti-Campana).
22 Il passo è riportato in parte da C. DIONISOTTI, Augusto Campana [1996], in ID., Ricordidella scuola italiana, Roma 1998, pp. 533-572: 534-535.
MICHELE LODONE80
oggi offre l’occasione di questo incontro, non è il caso d’insistere 23. Inconclusione, semplicemente, la storia della storiografia porta con séun’ulteriore ragione per cui è stato un piacere, oggi e in questa sede, par-lare di Gabriele Biondo, pievano di Modigliana.
23 Vd. L. LOTTI, Cinquant’anni della Società di Studi Romagnoli, «Studi Romagnoli», L (1999), pp. 9-16, e soprattutto C. PEDRELLI, Come è nata la Società di studi Romagnoli, ivi, pp. 17-21; oltre alla testimonianza dello stesso A. CAMPANA, Le origini della Società di Studi Romagnoli, discorso pronunciato a Cesena in occasione del XL Convegno di StudiRomagnoli (1989), ora in C. PEDRELLI (a cura di), Omaggio ad Augusto Campana, “Saggi erepertori”, n. 31, Cesena 2003, pp. 491-503.
GABRIELE BIONDO CONTRO I MAGISTRATI FIORENTINI 81
APPENDICE
Lettera di Gabriele Biondo a Strinato Strinati (Modigliana, 28 aprile 1498) 24
A Strinato Strinati citadino fiorentino. Spectabilis vir tanquam frater honorandum salutem. Per Rombello hebbi una
vostra a me gratissima, a le parte de la quale occorre poca resposta, et però seròbreve. La vostra venuta qua me serà sempre gratissima, non obstante che io scrives-se desiderare la vostra stantia là per fino ch’el frate fusse examinato, perché nonmancaranno advisi de dì in dì a diverse persone. El vostro castellano me havevapreso odio mortale, et per quel che sento haveva ordinato farmi mal capitare, se lecose fusseno successe in favor de li coniurati et subscripti, perché lui [190v] sentodire esser stato uno de quelli. Qualche volta ha havuto a dire volermi amazzare conuna bombarda, quando io predico nella chiesia de sotto, sperando dar diricto per laqualità del loco che de fuora se vede. Dio ha rotti li desegni; comunicossi excomu-nicato per favorire publicamente el frate, et ha messo in questo loco molta heresia etdatomi molti affanni perché ce è stato un frate de San Domenico che ha predicatodentro, al quale lui se confessò poi che da me non era absoluto, perché voleva chelui renegasse el frate, et ello non voleva. Questo predicatore a sua instantia nelle sueprediche più volte me punse laudando copertamente frate Hieronymo, et biasiman-domi che diceva mal de lui; pure doe volte apertamente lo laudò per homo bono etiusto et sancto, de che seguiva favore a lui et multiplicatione de devoti et diminutio-ne de la verità, de la auctorità de la fede apostolica, et de la fede catholica, per qualcosa ello incorse nella medesima excomunicatione che frate Hieronymo, secondo eltenore del breve ultimo contra el frate mandato. Per qual cosa nel dì de Pasquaamonì el populo che chi fusse dal predicatore confessato guardassi como se comu-nicassi, perché a me pareva fusse excomunicato per el favore el quale intendeva nellesue prediche lui haver dato a frate Hieronymo; de che lui fece poi gran querele emenaciommi far gran cose, ma pure al fine se partì per timore de peggio. Per qualcosa molto haverìa caro domandasti là a persona intelligente se sono stati reputatiexcomunicati in quel loco li laudatori publichi et defensori del frate; et se così fusse– como credo – molto haverìa caro facesti che qualcuno scrivesse a me quello è statoobservato là in tal caso, et quello li pare sia da observare in questo loco. Io per mede tali non ho absolto alcuno né absolverò, se non ho la auctorità de là, como expec-to. Vorìa anco intendere se bisognando [191r] favore contra questi frati domenichi-ni che hanno laudato el frate, la Signoria lo prestasse a chi è entrato a defensione dela fede catholica et de la verità contra quelli che facendo el contrario 25 venevanoanco a ablevar el populo contra el stato; perché è assai iusto che sia favorito chiopera in favore, etiam che quella non sia stata la mia intentione in dir mal del frate
24 Londra, British Library, Addison 14088, cc. 190r-191v (nella trascrizione ci siamo limi-tati a sciogliere le abbreviazioni, uniformare l’interpunzione e l’accentazione all’uso moderno,e inserire i necessari segni diacritici).
25 Cancellato: venendo.
MICHELE LODONE82
et in publicar al populo le lettere quale la Signoria mandò a questo socco de pode-stà, che pubblicasse a questi homini quando fu el caso del frate; le quale letterecostui non publicava, se non che io, havuta da lui in secreto et toltane copia, man-dai la copia a legere in piazza, et feci ch’el populo andò da lui et forzollo a mostra-re le lettere. Credo non bisognarà tal favore; non bisognando vorìa sapere se crede-sti se possesse havere contra de questi frati, per impaurire li devoti loro et de quellaparte. Fui per mandar là, a dì passati, a questo effecto; poi questi frati hanno chie-sto perdono et sonomi restato: dubito che non stiano a le mosse, et però domandoaviso. Similmente vorei sapere se bisognando procedere contra de loro per via spiri-tuale, fussi in quel loco persona che possesse procedere contra de loro, o commet-tere qua che se procedesse a publicarli excomunicati se non se pentono. Et questofavore me piacerìa più che quello de la Signoria; pure dati aviso de vostro parere deltutto, perché porebbe bisognare, perché questa cosa me dà gran pena, perché que-sto castellano ha pestilentiato et fattomi rebelle questo mio populo in molti capi –così Dio li dia gratia de farne salutare penitentia. Noi siamo tutti sani, Dei gratia,benché stracchi. Se ve scontrasti in frate Pietro Paulo da Urbino et frate Malatestada Rimino 26 racomandatimi a loro paternità, et diteli che benché li possa parere[191v] essere hoggimai chiari de frate Hieronymo, che non seranno però in modoche io non possa chiarirli anco più, se a Dio piacerà che mai possiamo star insemequalche dì, et loro desiderino intendere el vero. Altro non mi occorre. Christo damal vi guardi.Ex plebe Mutilliane, die XXVIII aprilis 1498
26 Ossia: “penso che attendano con impazienza qualche novità”.27 Pietro Paolo da Urbino († 1504), «medico riputato e di buoni costumi» stando a
Francesco Guicciardini (Storie fiorentine, a cura di A. MONTEVECCHI, Milano 20062, p. 279),era entrato nell’Ordine dei Predicatori nell’aprile 1496. Malatesta Sacramoro da Rimini, giàcanonico della Cattedrale a Firenze dal 1489, aveva pure vestito l’abito domenicano, a SanMarco, nel maggio del 1496. Non è chiara la natura della sua successiva opposizione aSavonarola; ad ogni modo il 19 aprile 1498 sottoscrisse – come anche Pietro Paolo – il primoprocesso cui fu sottoposto il ferrarese, e da allora fu una delle voci antipiagnone più attive edautorevoli. Bollato come “il Giuda di san Marco”, morì nel 1511, dopo essere stato Vicariodella Congregazione dei Predicatori per la Toscana e Procuratore dell’Ordine. Vd. RAO, VITIe ZACCARIA (a cura di), I processi di Girolamo Savonarola, cit., pp. 23-24, 119, 136; su frateMalatesta vd. anche BENEDETTO LUSCHINO, Vulnera diligentis, a cura di S. DAL L’AGLIO,Firenze 2002, pp. 248, 362-363 nota.