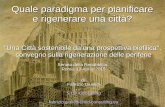"Incapsulare" l'innovazione nel modello: il caso della scripta notarile mediolatina napoletana
DOPO LA CRISI, QUALE MODELLO TERRITORIALE?
Transcript of DOPO LA CRISI, QUALE MODELLO TERRITORIALE?
L’AR
CHIT
ETTU
RA
DEG
LI S
PAZI
DEL
LAV
OR
O a
cur
a di
Ber
tagn
a, G
asta
ldi,
Mar
ini
24,0
0orue
QS
ISBN 978-88-7462-498-0
In copertina: xxxxxxxxxxxxxx
Alberto Bertagna è ricercatore in Urbanistica presso l’Università degli Studi di Genova. Ha pubblicato La città tragica. L’(an)architettura come (de)costruzione (Reggio Emilia, Diabasis 2006) e Il controllo dell'indeterminato. Potëmkin villages e altri nonluoghi (Macerata, Quodlibet 2010)e, con Sara Marini, The Landscapes of Waste (Milano, Skira 2011).
Francesco Gastaldi è ricercatore e docente di Urbanistica presso l’Università Iuav di Venezia. Insieme con Valeria Fedeli ha curato Pratiche strategiche di pianificazione (Milano, Franco Angeli 2004) sulle sperimentazioni di pianificazione strategica in Italia.
Sara Marini è ricercatore in Composizione Architettonica e Urbana presso l’Università Iuav di Venezia. Tra le sue numerose pubblicazioni ricordiamo Architettura parassita. Strategie di riciclaggio per la città, (Macerata, Quodlibet 2008) e Nuove terre. Architetture e paesaggi dello scarto (Macerata, Quodlibet 2010) e, con Alberto Bertagna, In Teoria. Assenze, collezioni, angeli (Macerata, Quodlibet 2012). Ha inoltre curato, insieme con Pippo Ciorra, Re-cycle. Strategie per l’architettura, la città e il pianeta (Milano, Electa 2011).
«E il lavoro dovrebbe essere una grande gioia ed è ancora per molti tormento, tormento di non averlo, tormento di fare un lavoro che non serva e non giovi a un nobile scopo [...] Il lavoro solo ha trasformato il mondo e siamo alla vigilia di una trasformazione definitiva».Adriano Olivetti, Città dell’uomo, 1960
Il libro affronta il tema del lavoro che, nel quadro articolato delle trasformazioni sociali ed economiche in atto, assume una centralità rinnovata anche per le discipline che si occupano del disegno degli spazi che lo accolgono. Da un lato si assiste alla riorganizzazione del sistema egemone negli ultimi trent’anni: gli spazi del lavoro non sono più semplici edifici industriali ma nuove realtà dotate di laboratori, centri studi, spazi di relazione con il pubblico e con il paesaggio. Prende dunque corpo una revisione del modello di città sociale che in Italia ha segnato profondamente la progettazione architettonica e urbana, sulla scia di quanto accaduto per la Olivetti. Il Diesel Village a Breganze e le diverse factory che nascono oggi occupando complessi industriali dismessi rappresentano il controcampo della crisi dei capannoni diffusi. Dall’altro lato la dismissione della produzione fisica di materiali ed oggetti crea una diversa strutturazione di reti per la produzione immateriale di idee o servizi: nuovi spazi del lavoro si costruiscono in luoghi marginali o abbandonati del territorio, possibili motori latenti di uno sviluppo alternativo.
QUODLIBET STUDIO CITTÀ E PAESAGGIO
L’ARCHITETTURA DEGLI SPAZI DEL LAVORO NUOVI COMPITI E NUOVI LUOGHI DEL PROGETTO
a cura di Sara MariniAlberto BertagnaFrancesco Gastaldi
QUODLIBET
L’ARCHITETTURADEGLI SPAZI DEL LAVORONUOVI COMPITI E NUOVI LUOGHI DEL PROGETTO
a cura diSara MariniAlberto BertagnaFrancesco Gastaldi
spazi lavoro_STAMPA.qxp:quod 14/11/12 17.57 Pagina 5
CITTÀ E PAESAGGIOL’ARCHITETTURA DEGLI SPAZI DEL LAVORO
prima edizione novembre 2012ISBN 978-88-7462-498-0
© 2012 Quodlibet s.r.l.via Santa Maria della Porta, 43 Maceratawww.quodlibet.it
Volume pubblicato in occasione del convegno L’architettura degli spazi del lavoro. Nuovi compiti e nuovi luoghi del progetto(Venezia, 16-11-2012, a cura di Sara Marini, Alberto Bertagna, Francesco Gastaldi)con il contributo dell’Università Iuav di Venezia e della Fondazione Francesco Fabbri
La Fondazione Francesco Fabbri non persegue fini di lucro, il suo ruolo è quello diessere strumento di sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità. La mis-sione è perseguita attraverso lo sviluppo di programmi ed azioni da ideare, coordina-re e promuovere in una logica di rete orientata alle forme del Contemporaneo. Operanell’ambito del territorio veneto ma con uno sguardo aperto al sistema nazionale, neisettori dell’assistenza, dell’istruzione e formazione, della promozione e valorizzazionenel campo artistico, culturale, storico, dell’innovazione e, in particolare nel presenteperiodo, del paesaggio in attuazione della Convenzione Europea di riferimento.www.fondazionefrancescofabbri.it
progetto fotograficoLavoro_Sissi Cesira Roselli_Brescia 2012 (in copertina, pp. xx, xx, xx...)Padiglione olandese_Sissi Cesira Roselli_Venezia 2012 (pp. xx, xx, xx...)
progetto graficoFranco Nicole Scitte
stampaBieffe s.p.a.
spazi lavoro_STAMPA.qxp:quod 14/11/12 17.57 Pagina 6
INDICE
08 PresentazioniGiustino Moro, Daniele Marini
12 PremesseSara Marini, Alberto Bertagna, Francesco Gastaldi
I ARCHITETTURE E COMMITTENZE PER PRODURRE LUOGHI
18 Le ali dell’architettura. Spazi del lavoro ed altre alchimieSara Marini
24 Luoghi di lavoro, paesaggi del XX secoloLuigi Latini
30 SSIC, GordolaDurisch + Nolli Architetti
36 Là, dove il Paesaggio si fa. Esperienze e confronti nella terra del lavoroClaudio Bertorelli
46 Spazi condivisi, luoghi ritrovatiMarco Ragonese
50 Milano e la sfida post-fordista. Logiche localizzative e idee di cittàLaura Montedoro
II DALL’IMPRESA NEL TERRITORIO AL PAESAGGIO COME IMPRESA
56 Alto lo spread città/territorio. Dettagli in cronacaAlberto Bertagna
62 Rigenerare paesaggi in declino: progetti, risorse e strategie per tornare a crescere. Il caso di Napoli estMichelangelo Russo
72 Reload: riattivare il capitale territoriale per re-immaginare lo sviluppoMaurizio Carta
82 Più cose alla voltaMosè Ricci
90 Territori ed architetture del Made in ItalyRosario Pavia
96 Hashima: economie produttive tra rovine post-industrialiGiulia Menzietti
100 Productive Landscapes. Common GroundsEmanuele Sommariva, Jeannette Sordi
III IL NORD EST, FRA CRISI E NUOVA DOMANDA DI GOVERNO DEL TERRITORIO
106 C’è un Nord Est oltre il mito?Francesco Gastaldi
112 Dopo la crisi, quale modello territoriale?Michelangelo Savino
118 Scenari e territori per un nuovo sviluppo del Nord EstGiancarlo Corò
130 Le ragioni del lavoro artigiano nell’economia globaleStefano Micelli
136 Riqualificare lo sprawlLaura Fregolent
140 Oltre il capannone: metamorfosi del Nord Est produttivoMarco Ferrari
spazi lavoro_STAMPA.qxp:quod 14/11/12 17.57 Pagina 7
DOPO LA CRISI, QUALE MODELLO TERRITORIALE?
Michelangelo Savino
1
1!Dolo, Venezia
spazi lavoro_STAMPA.qxp:quod 12/11/12 11.24 Pagina 112
113
BODY OF EVIDENCEChe il territorio fosse uno dei vantaggi competitivi del modellodi sviluppo del Nord Est era evidente e che questo fattoreponesse dei problemi di efficienza e di costi crescenti era se -gnalato già ai tempi della crisi del ’92. Non è il caso in questa sede di riprendere gli aspetti che variediscipline hanno a lungo esplorato1 dimostrando come il terri-torio2 abbia rappresentato qualcosa di più di un contesto fa-vorevole allo sviluppo della piccola e media impresa. La lette -ratura sui distretti ha sufficientemente sottolineato natura,potenzialità e limiti di queste relazioni, ne ha registrato l’epo -pea, l’apogeo come il progressivo declino. E se spesso alla vo -ce degli imprenditori (sempre pronti a minacciare una hir -schmanniana exit dal territorio) non si è voluto dare credito(anche per il loro facile cedere alle malie della politica e allesue false promesse), non sono stati certo incunaboli accade-mici (di difficile reperibilità o di ardua comprensione) tan-tomeno astrusi rapporti di fondazioni e di centri di ricerca asegnalarlo, bensì documenti ufficiali e puntuali della Regione(ma non solo in Veneto), relazioni ben fondate del Ministeroche nel corso degli ultimi due decenni hanno delineato conestre ma chiarezza le difficoltà del sistema Nord Est, le misureda prendere e gli investimenti necessari. Erano noti quali ri-tardi ci fossero da parte delle istituzioni nel provvedere contempestività e con cospicui finanziamenti pubblici ai problemidel sistema, per quanto ad una “lettura globale” delle pro -blematiche si siano spesso preferite disposizioni normative,provvedimenti economici, opere pubbliche “molto locali”. In-sorgenti distorsioni del mercato del lavoro, distribuzione sub-ottimale delle unità produttive, crescenti defaillances delletradizionali relazioni di conto-terzismo e sub-fornitura, scarsainnovazione tecnologica, bassa propensione alla R&S, diffi-coltà del ricambio generazionale erano lamentate da più par-ti, ma nessuna azione correttiva delle disfunzioni che la mac -china “territorio” mostrava è stata concretamente intrapresa:il sistema del Nord Est mostrava di essersi adagiato su sestesso, di aver perso il suo slancio e la sua vitalità, per viveredi una supposta rendita conquistata con l’ingente sforzo deidecenni precedenti.Ma anche il territorio denunciava le sue prime difficoltà: i pri-mi costi ambientali dovuti agli insediamenti produttivi disse -minati con problemi di smaltimento dei residui industrialispesso risolti in modo illegale e non appropriato; l’incremento
dei costi del trasporto e la congestione, l’inadeguatezza dellarete stradale e il generale deficit infrastrutturale regionale,l’assenza di servizi ed attrezzature di eccellenza, le disfunzionidi un processo di urbanizzazione non debitamente controllatoe qualche intralcio nel regolare andamento del mercato im-mobiliare.Ma quale è stata la riposta a queste evidenti tensioni?La crisi del territorio del Nord Est, ancor prima che la crisieconomica che attanaglia la sua società, ha quindi origini lon-tane, ma documentabili, mostra omissioni e colpevoli man-canze, ha responsabili e correi. Ma soprattutto ha ancorasoluzioni percorribili e opportunità per tornare ad essere unfattore competitivo dello sviluppo, ma solo se ci saranno rigoree vigore nell’attuazione di una consapevole e condivisa rego-lazione dell’organizzazione del territorio.
MALFUNCTIONINGVittima del suo successo, dunque, il territorio regionale ha fat-to registrare più di un decennio fa i segni di un cattivo funzio -namento. I rapporti statistici regionali puntualmente indicanocome traffico privato e traffico commerciale-industriale nonriescono più a convivere come agli albori dello sviluppo su unsistema infrastrutturale debole, la cui capillarità nel territorio(una delle condizioni favorevoli allo sviluppo produttivo diffuso)diventa un fattore di limite per l’impossibilità di un suo gene -rale ed omogeneo potenziamento come per l’impossibilità didistinguere e privilegiare le modalità di uso, in un sistemainsediativo in cui impresa e residenza si confondono. L’«incre-mentalismo infrastrutturale» diventa uno dei fattori di ritardodel Nord Est rispetto ad altri contesti europei più competitivi.La rete ferroviaria (che del sistema strategico disegnato dopola prima guerra mondiale ha registrato dismissioni, con-trazioni e tagli) appare inadeguata e insufficiente (e non sarà lapromessa AV a rispondere alle esigenze del sistema produtti-vo) e per la logistica si registrano scarsi interventi, per lo più“di rimbalzo” per le politiche attuate nei paesi confinanti,mentre porti ed aeroporti vengono potenziati in chiave preva-lentemente turistica.Se è vero che la miopia regionale si allinea alla scarsa lun -gimiranza nazionale nel campo degli investimenti infrastrut-turali, è anche vero che il Nord Est perde in questa occasionel’opportunità di diventare un attore dirompente nel mo destodibattito nazionale sullo sviluppo3: invece di farsi promotore di
spazi lavoro_STAMPA.qxp:quod 12/11/12 11.24 Pagina 113
114
IL N
OR
D E
ST, F
RA
CR
ISI E
NU
OVA
DO
MAN
DA
DI G
OVE
RN
O D
EL T
ERR
ITO
RIO
una politica infrastrutturale rivoluzionaria (per un paese checoncepisce le infrastrutture solo in termini di numero di ap-palti, cantieri e posti di lavoro alla stessa stregua dell’ediliziaresidenziale) e innovativa (non era forse il Veneto primus interpares con la Baviera e le altre regioni nord-europee più avan-zate?) preferisce soluzioni tradizionali e di portata limitata. Lacostruzione del Passante autostradale – ammirabile per tem-pi di esecuzione – è una riposta modesta e già inadeguata alproblema che non sembra aver migliorato le sue prestazioni,come lo saranno la terza corsia della Mestre-Trieste o il com-pletamento della Valdastico, della Strada del Santo e dellaPedemontana che non riusciranno a risolvere il problema diuna mobilità sofferente. I ritardi nella realizzazione del SFRMdimostrano la totale assenza di una visione strategica del si -stema ferroviario, lasciando sospettare un distaccato ossequioa retoriche istanze ambientaliste4.Allo stesso modo, il processo di urbanizzazione del territorio,nelle corone dei grandi centri come nelle frattalità dei centriminori e nelle macchie di urbano sparse in una campagna or-mai priva del suo carattere rurale, non ha subito alcun arresto,nonostante fosse evidente che alla quantità andasse neces-sariamente sostituita una strategia di qualità. I vuoti nei gran-di centri urbani, ma insorgenti anche nei centri minori già allafine degli anni ’80, sono il risultato di processi ben diversi dal-la deindustrializzazione della fine degli anni ’70: erano gli esi-ti della prima fase di riorganizzazione produttiva e di inter-nazionalizzazione di molte grandi aziende da cui solo relativa-mente un indotto di piccole e medie imprese si era reso in-dipendente; la ricerca di condizioni insediative migliori, vuoiper una maggiore accessibilità, vuoi per una maggiore qualitàterritoriale, vuoi per contenere i costi ambientali che impiantiproduttivi vecchi ed obsoleti avrebbero reso insostenibili. In-sorgeva una prima evidente sottoutilizzazione delle aree in-dustriali disseminate nella città diffusa ma nessuna azione dicontenimento è stata avviata, così che ora le superfici urba -nizzate inutilizzate fanno bella mostra di sé; i capannoni vuotie alcuni avveniristici edifici direzionali troneggianti in unacampagna ferita, invece di essere emblemi dello sviluppo, netestimoniano gli errori. E anche quando la produzione ediliziaè risultata comunque eccessiva rispetto alla reale domanda,nessuna inversione di tendenza è stata registrata sul territo-rio: i PIRUEA come il temporaneo congelamento della nuovalegge urbanistica regionale hanno rappresentato l’ultimo
quanto recente atto di una gestione politica che si è rifiutata diinvertire rotta. Lo dimostra anche il costante insediamento esviluppo dei centri commerciali, proliferati su tutto il territorio,aggravando le condizioni di alcuni poli già sovraccarichi (sipensi a Padova Est, Treviso Sud o piuttosto a Vicenza Est ol’anello commerciale che è andato espandendosi attornoMestre), mentre outlet e poli commerciali minori (non unacostellazione ma una vera nebulosa di attività commerciali)contribuiscono all’incremento della congestione altrettantodiffusa. Quindi i costi (pubblici e privati) determinati dai disa -stri naturali le cui cause sono risultate prevalentemente dicarattere antropico. Anche qui i segni di una fragilità di quel“territorio dei capannoni” erano evidenti ma sono stati voluta-mente ignorati, così gli effetti delle escavazioni o i rischi am -bien tali delle discariche abusive di materiali tossici non sem-pre smaltiti al Sud, ma spesso nascosti in casa (nonostante ledenunce di Legambiente).Della sopravvivenza delle vecchie logiche territoriali è testi-monianza poi “il caso Barcon”5 che a sua volta segnala l’insor -gere di un’emergenza paesaggio, oltre a mostrare la naturadel dilemma politico, sociale ed economico che opprime ilNord-Est e che non sembra trovare una riposta: il sacrificiodella cornice paesaggistica della palladiana Villa Emo e laconversione di un altro pezzo di campagna ancora intatta innome dello sviluppo. In un’area già sovraccarica di attività in-dustriali, congestionata dalla presenza di un grande centrocommerciale-direzionale-residenziale viene proposta la co s -truzione di una vasta zona produttiva (macello ed una cartiera)tra Vedelago e Fanzolo, bloccata però da un comitato di citta-dini, mentre già si parla della follia di una tale decisione intempi di crisi occupazionale e produttiva. Ma non è solo il de-grado del paesaggio che inquieta. Preoccupa l’evidenza che iprogetti di sviluppo produttivo sembrano ripercorrere sentierigià conosciuti e frequentati, senza che nessuna nuova strate-gia venga perseguita e che lo sviluppo economico – come nelpassato – debba necessariamente passare attraverso ulterioreconsumo di suolo. Preoccupa che la ricerca di valide “alterna-tive” praticabili (come ha dimostrato la retromarcia degli im-prenditori sul progetto, che hanno optato per lo spostamentodi alcune lavorazioni in altre aree nella stessa provincia, perl’ampliamento dello stabilimento esistente, ecc.) sia avvenutasolo dopo l’insorgere del conflitto e dopo la mobilitazione del-la popolazione residente.
spazi lavoro_STAMPA.qxp:quod 12/11/12 11.24 Pagina 114
115
FIXING AND CONCEIVINGDegrowth, Downsiszing, Growsterity, Smart shrikage, Smartcities: che senso hanno in questo contesto simili proposte?Che possibilità hanno nuove filosofie per la crescita urbana ela trasformazione del territorio, se nulla sembra cambiare purin presenza di una congiuntura così drammatica come quellache stiamo vivendo? Davvero augurarci uno scenario apocalit-tico perché si creino concretamente le condizioni di un radicalecambiamento?Molti iniziano a guardare alla crisi con preoccupazione ma an-che con speranza, perché la crisi rende inevitabile la svolta. Edè per questo cambiamento che molte azioni andranno intra -prese e trovano già adesso – nelle azioni delle più accorte isti-tuzioni e dei più intraprendenti attori privati – alcuni elementiche permettono di avanzare delle ipotesi di intervento.In primo luogo, sembra possibile auspicare l’individuazione diinterventi finalizzati a rimediare ai ritardi del passato, agli er-rori commessi e alle disfunzioni che sono emerse; un’azionesul territorio per eliminare i fattori di rallentamento dellosviluppo, che pur non avendo ancora chiaro quale sarà l’oriz-zonte economico e sociale del post-crisi, intervenga sui fattoridi inefficienza del sistema fin qui riconosciuti:a) innanzitutto, attraverso un ravvedimento nelle politi che ter-ritoriali che riesca a determinare un rallentamento dei proces-si urbanizzativi e controvertire la consolidata propensione alconsumo di suolo. Questo non solo in un’ottica ambientalistadi contenere il depauperamento delle risorse naturali, ma an-che perché in questo modo si possano favorire i processi divalorizzazione dell’esistente, il recupero del patrimonio (resi-denziale, produttivo) inutilizzato e sostenere la riqua lificazionedel territorio ormai compromesso dall’urbanizzazione. Sonoaspetti che dovrebbero divenire determinanti nelle politicheurbanistiche dei grandi come dei comuni medi e piccoli delleregioni del Nord Est. In questo caso, torna ad essere centraleil ruolo di indirizzo della Regione e l’azione attuatrice dei Co-muni; e il riordino delle competenze che seguirà alla riartico-lazione degli enti territoriali non potrà non costituire un’im-portante opportunità per riscrivere poteri e mansioni e l’occa-sione per riformulare politiche e strategie. In questo modo èfacile supporre una radicale revisione di quel modello dissipa-tivo dell’insediamento che ha sostenuto lo sviluppo di questiultimi decenni e l’elaborazione di un diverso scenario per ilterritorio che accoglierà il ciclo economico prossimo venturo;
2
2!Dolo, Venezia
spazi lavoro_STAMPA.qxp:quod 12/11/12 11.24 Pagina 115
116
IL N
OR
D E
ST, F
RA
CR
ISI E
NU
OVA
DO
MAN
DA
DI G
OVE
RN
O D
EL T
ERR
ITO
RIO
b) è necessario, poi, provvedere ad un potenziamento ma inchiave strategica del sistema infrastrutturale, che dovrà anchequesto essere diretta conseguenza della nuova visione territo-riale. La nuova visione territoriale dovrebbe poter prevedere lanecessaria riorganizzazione degli insediamenti intorno aspecifiche polarità in modo da garantire non solo una ridu -zione dei costi di insediamento (grazie anche ad economie discala) ma anche il maggiore controllo (e contenimento) degliimpatti ambientali; deve poter favorire la corretta proget-tazione dell’accessibilità ed il collegamento dei poli allagrande viabilità (l’esperienza dei “Poli funzionali” previsti nelPTCP di Bologna ed i suoi esiti sono un buon esempio da emu -lare!). Quindi, una volta completate le opere ormai avviate, di-venterà necessario concepire un diverso sistema di mobilitàdelle merci (rendendo indispensabile una seria riflessione sul-la logistica e sui nodi intermodali che dovranno essere con-cepiti in un’ottica che travalichi i confini nazionali) e delle per-sone, riformulando il sistema di mobilità metropolitana; rive-dendo il progetto del SFRM e soprattutto valorizzandone alcu-ni nodi (si pensi a quella che doveva essere la “Porta est” diMestre), combinando i nuovi insediamenti con le nuove formedi mobilità integrata. Il sistema della mobilità così concepitodovrebbe diventare lo scheletro della riorganizzazione insedia-tiva regionale, secondo un inquadramento strategico di ampiorespiro territoriale che fino ad oggi è mancato;c) una decisa politica di riqualificazione del paesaggio e di re-cupero del territorio, che dovrà inevitabilmente sposarsi conenergici provvedimenti per la sua messa in sicurezza. L’obiet-tivo deve poter implicare anche inusuali (perché mai praticatenon perché improponibili) azioni di intervento su buona partedel patrimonio edilizio esistente e che probabilmente resteràinutilizzato, contemplando anche demolizioni, ripristino delpreesistente laddove questo giustifichi – in termine di sicurez-za e di restauro ambientale – la complessità delle opere ed icosti. Questo significa anche specifiche strategie di ricompo-sizione degli spazi periurbani, una concreta attuazione dellepolitiche di salvaguardia dei “corridoi ecologici”, la messa asistema delle aree ad alta naturalità liberandole dalla lorocondizione di “insularità”, solo per fare alcuni esempi. Se guardiamo nel complesso agli interventi proposti, possiamoconvenire che non si tratti poi di azioni così innovative e quiparadossalmente potremmo affermare che la costruzione delnuovo modello territoriale passa innanzitutto dalla ripropo-
sizione di un’azione di pianificazione la cui straordinarietà enovità consisterà nella sua concreta applicazione, nel perse -guimento pervicace da parte delle istituzioni ma soprattuttonella condivisione più ampia e generale dei suoi principi daparte della società come degli attori principali della trasfor-mazione territoriale.Non riusciremo forse ad indicare quali debbano essere i carat-teri essenziali del nuovo modello territoriale, ma possiamo si-curamente stabilire adesso quali debbano essere alcuni deisuoi presupposti irrinunciabili:a) come per esempio una categorica e generale condivisionedello scenario territoriale da costruire, attraverso la for-mazione di un “ciclo virtuoso della conoscenza” tra tecnici, es-perti e la politica, tra politica e società civile e tra società civileed esperti e tecnici. Una condivisione che dovrebbe garantirenon solo una sostanziale coerenza nelle diverse politiche comenelle tante pratiche (individuali o collettive) che interessano ilterritorio, ma che dovrebbe poter permettere lo sfruttamentodelle rilevanti potenzialità di alcune risorse locali (un notevolecapitale sociale che può ancora essere determinante nellosviluppo dell’area; un capitale cognitivo che deve ancora espri -mere tutta la sua forza creativa) pur presenti ma oggi sottouti-lizzate se non penalizzate da questo contesto;b) una diversa, nuova e più produttiva sinergia tra istituzioni,attori privati (imprenditori, associazioni di categoria, ecc) e so-cietà civile in cui il territorio non verrà inteso più come unsemplice e banale mezzo di produzione inesauribile e a costonullo, bensì come una risorsa peculiare, preziosa e strategicada valorizzare ed usare con estrema cura; il territorio do -vrebbe non più essere considerato come l’esito eventuale delledinamiche economiche e sociali, ma piuttosto l’obiettivoperseguito con forza e coerenza dalle forze economiche comedalle politiche (economiche, sociali, urbanistiche, ecc) pro-mosse a diverso livello;c) dovrà essere nuovamente rilevata e misurata la domandadei bisogni sociali a cui il nuovo modello territoriale dovràrispondere. Una domanda stabilita non più basandosi su as-sunti (spesso ideologici) poco aderenti alla realtà o piuttostomodellata su inte ressi particolari e per specifici campanili,come non dovrà risultare frutto di scambi negoziali o l’esito in-congruo dell’accoglimento di ogni istanza (anche e spesso inderoga alle norme) in cambio di consenso politico. Dovrà piut-tosto essere improntata sulla definizione univoca e rigorosa
spazi lavoro_STAMPA.qxp:quod 12/11/12 11.24 Pagina 116
117
dei beni comuni, sulle necessità concrete e su grandi obiettividi benessere collettivo, scevro da facili compromessi. E nuoviapprocci (disciplinari e politici) devono essere ricercati perdare risposte a questi nuovi bisogni. La crisi (per tacere diquanto sta emergendo dai vari scandali in molti ambiti di go -verno) non può non avere come prima conseguenza una diver-sa consapevolezza di governo, un diverso rapporto tra politicie società, un diverso e nuovo processo creativo, un diversoslancio progettuale che contribuisca alla definizione di un di-verso modello territoriale.d) quindi, un rilancio del processo politico e tecnico della pia -nificazione. Risulta paradossale proporlo, soprattutto perché ilrichiamo alla pianificazione sembra essere quanto di più vec-chio e datato, nonostante siano noti ed evidenti i limiti e la de-bole volontà con cui la pianificazione è stata condotta nel nos-tro paese – e nondimeno nel Nord Est. Eppure il nuovo model-lo territoriale non potrà prescindere dalla pianificazione nonsolo perché non potrà essere lasciato alle dinamiche sponta-nee e auto-regolative che hanno caratterizzato il model loprecedente (quelle, lo abbiamo visto, hanno funzionato nelbreve-medio periodo deteriorando le basi stesse dello svilup-po) ma dovrà essere costruito con basi solide in grado anchedi poter fronteggiare la rapidità ed imprevedibilità dei muta-menti (rispetto ad un certa lentezza e anche inerzia dei pro-cessi del passato), sapersi confrontare con la natura esogena(e spesso fin troppo remota) e con la scala (globale) dei fattoridi sviluppo. Una pianificazione nella quale istituzioni come leRegioni ed i Comuni (chissà che ne sarà delle Province e dellecittà metropolitane in questo dibattito a tratti insensato esconclusionato) ricostruiscano la loro credibilità anche attra-verso un nuovo rigore ed un stile di governo.Quello che si propone, dunque, come primo passo decisivo peruna rinascita dopo la crisi, è allora un ripensamento ed una ri-formulazione del processo di pianificazione certamente rinno-vato nelle sue regole e nei suoi obiettivi come nei suoi stru-menti, magari riutilizzando i sistemi esistenti ma sicuramentecon uno spirito nuovo che ci permetta – oltre questa crisi – dipoter arrivare concretamente alla produzione di un adeguato efavorevole contesto per lo sviluppo della società e soprattutto– con la convinzione che la pianificazione possa davvero esserelo strumento strategico per la cos truzione del futuro – di po terdare origine ad una nuova capacità progettuale perché l’azionesul territorio risulti vigorosa ed efficace.
1 I riferimenti ad una letteratura veramen -te ampia sono più che noti, a dir pocoscontati, a partire dal celebre testo di Ba -gnasco del 1977, per finire ai Rapporti del-la Fondazione Nord Est. Mi permetto di ri-mandare per una completa e argomentatabibliografia a M. Savino, L’insostenibilitàterritoriale della “Terza Italia”, in I. Vinci (acura di), Il radicamento territoriale dei siste-mi locali, Franco Angeli, Milano 2005.2 Territorio da intendere come complessointreccio di risorse naturali, organizzazionesociale, matrice insediativa, capitale fissosociale prodottosi nel tempo, e qualeespressione di macro- e micro- processieconomici, strutture sociali ancestrali main veloce mutamento, cultura e indoledelle comunità presenti, spirito imprendi-toriale e condizioni regolative come endo-gene forme di auto-organizzazione.3 Il testo di R. Mazzaro, I padroni del Vene-to, Laterza, Bari 2012, sta facendo moltodiscutere in questi mesi sul ruolo mar-ginale del Veneto (alla luce del suo suc-cesso economico) nella determinazionedelle politiche del Paese, sia da parte dellasua classe imprenditoriale (nonostante ilsuo peso nella formazione del PIL nazio -nale) sia da parte della sua classe politica(nonostante il forte ed omogeneo consen-so elettorale ed il sostegno garantito alleforze di governo nell’ultimo decennio).4 Su questo tema, per una trattazione dimaggiore ampiezza, mi permetto di riman-dare a M. Savino, Infrastrutture nel Veneto.Quali i problemi?, «Economa e società re-gionale», n. 94, 2006 e a L. Fregolent, M.Savino, Quando la soluzione diventa un nuo-vo problema. Prospettive della dispersioneveneta tra politiche infrastrutturali e con-sumo di suolo, in M. Pezzagno, S. Docchio(a cura di), Vivere e camminare in città. Lametropoli lineare. Atti della XVII Conferenzainternazionale “Vivere e cammi na re in città”,EGAF Edizioni srl, Forlì 2011.5 Per un breve riepilogo si veda S. Madiot-to, Caso Barcon, capannoni e 600 posti. Ma ilComune dice no, «Il Corriere del Veneto»,10 ottobre 2012.
spazi lavoro_STAMPA.qxp:quod 12/11/12 11.24 Pagina 117












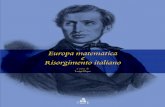



![Quale skoteinotes? Sul rapporto che Eraclito instaura col suo uditorio potenziale [ 1992 ]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63224206078ed8e56c0a5291/quale-skoteinotes-sul-rapporto-che-eraclito-instaura-col-suo-uditorio-potenziale.jpg)