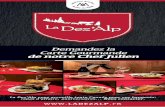Aspetti della complementazione frasale in alcune carte notarili della Longobardia minore (fine IX...
Transcript of Aspetti della complementazione frasale in alcune carte notarili della Longobardia minore (fine IX...
AccAdemiA di ArcheologiA lettere e Belle Arti
La Lingua dei documenti notariLi aLto-medievaLi deLL’itaLia meridionaLe
bilancio degli studi e prospettive di ricerca
a cura di rosanna sornicola e paolo greco
con la collaborazione di giovanna pianese
TAVOLARIO EDIZIONI MMXII
143
aspetti della complementazione frasale in alcune carte notarili della longobardia minore
(fine iX secolo)
Paolo Greco
The aim of this study is to analyze the most important features of the complement clauses that occur in the sales contracts written between the year 882 and the year 897 and stored in the archive of the Badia della S.ma trinità (cava de’ tirreni). in particular, we shall focus our at-tention on the interplay of semantic, syntactic and pragmatic factors that seem to be involved in the alternation of the different types of complement clauses (accusativus cum infinitivo, quod-, quia-, and ut-clauses) occurring in our corpus. Furthermore, this analysis will also lead to some consideration on the complex relationship between the “formulaic” and the “free” sections of our documents, as well as on the different linguistic abilities of the notarii.
1. introduzione
in questo contributo discuteremo alcune caratteristiche dell’uso della subordinazione com-pletiva in tutti i contratti di vendita rogati nel quindicennio 882-897 e conservati nell’archivio della badia della s.ma trinità di cava de’ tirreni (si tratta dei documenti 11, 13, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27 e 31 editi nel volume 52 delle chartae Latinae antiquiores)1.
Quest’analisi ci permetterà in particolar modo di mettere in evidenza le diverse motivazio-ni (di ordine sintattico, stilistico, semantico e pragmatico) sottese all’alternanza delle strutture completive, e di riflettere sul rapporto tra formulaicità e libertà compositiva. i testi che inda-
1 i testi che analizzeremo sono stati composti da 7 diversi notai (accone, adelmari, alhoini, dausdedi, inghelpran-dus, ramipertus e ursus) operanti tra salerno, nocera e, in un caso, benevento (i documenti 13, 19, 22, 23 e 27 sono stati rogati a nocera, il 26 è stato redatto a benevento, mentre tutti gli altri sono stati prodotti a salerno).
paolo greco
144
gheremo, composti secondo il modello della cartula2, mostrano infatti una sintassi in generale poco complessa, caratterizzata da una subordinazione piuttosto scarna e limitata a brevi frasi relative o completive (più rare sono invece le subordinate di tipo avverbiale), spesso di natu-ra stereotipica. proprio quest’ultimo aspetto, quello della formulaicità e della ripetitività di certe strutture, gioca un ruolo non secondario nella strutturazione dei testi da noi indagati. la ripartizione tra le sezioni fisse e quelle libere degli atti è infatti, in questi documenti, tutta a vantaggio delle prime, che occupano nelle vendite del nostro corpus la maggior parte del documento, e in alcuni casi arrivano a rappresentare la quasi totalità del testo3. solo i notai che appaiono dotati di maggiori abilità scrittorie rogano dei contratti in cui si ritrovano più cospicue parti di testo libere (e si noti che, in maniera interessante, questi testi sono gli stessi in cui le parti fisse presentano maggiori micro-differenze rispetto al formulario ricorrente negli altri documenti). in questo senso, dunque, l’analisi della subordinazione completiva rappre-senta anche, nelle vendite da noi analizzate, un utile strumento per valutare le diverse capacità linguistiche dei notai.
2. aspetti della subordinazione completiva
2.1. Questioni generali riguardanti la subordinazione completiva nel nostro corpus
secondo una definizione largamente condivisa, la subordinazione completiva rappresenta «the syntactic situation that arises when a notional sentence or predication is an argument of a predicate» (noonan 1985, p. 52)4. le frasi completive in latino possono essere caratterizzate da verbi di tipo finito o non finito. tuttavia, fino al ii secolo d.c. almeno, la subordinazione di tipo infinitivale, in particolar modo in dipendenza dai cosiddetti verba dicendi et sentiendi, ha rappresentato in maniera molto chiara il tipo subordinativo più diffuso5. la costruzione completiva denominata accusativus cum infinitivo (d’ora in poi aci) ha in effetti costituito una delle strutture subordinative più tipiche del latino di ogni epoca, e anche in seguito alla diffusione di forme di complementazione a verbo finito (come le frasi introdotte da quod, quia o quoniam), il suo uso non è mai venuto meno. come sottolinea lavency (2003, pp. 97-99), aci si trovano attestati nelle iscrizioni più arcaiche provenienti da roma così come nei
2 sulla struttura delle cartulae del iX secolo nell’italia meridionale longobarda si vedano galante 1982, pp. 87-92, pratesi 1983, pp. 764 e soprattutto magistrale 1991, pp. 260-262.
3 sulla distinzione tra le parti fisse e quelle libere nei documenti altomedievali il rimando è al classico sabatini 1965.4 una definizione più ampia e interlinguisticamente valida è fornita da sonia cristofaro: «[c]omplement relations
link two soas (sc. States of affairs) such that one of them (the main one) entails that another one (the dependent one) is referred to)» (cristofaro 2003, p. 95).
5 fino a quell’altezza cronologica le completive a verbo finito introdotte da complementatori come quod o quia sono infatti attestate solo marginalmente in dipendenza da verba dicendi et sentiendi (un elenco delle attestazioni si può trovare in Hofmann-szantyr 1965, p. 576 e in cuzzolin 1994, p. 106-130. Quest’ultimo volume si può inoltre utilmente consultare su tutta la questione della nascita e della diffusione di queste subordinate).
La comPLementaZione FraSaLe neLLe carte SaLernitane
145
testi più tardi che la latinità ci ha lasciato. tuttavia, a dispetto dell’ampia diffusione di questo costrutto, in maniera per certi versi sorprendente, l’aci scompare pressoché completamente nelle lingue romanze, e viene sostituito in molti contesti da subordinate completive a verbo finito introdotte da complementatori come che o que. il fenomeno della nascita e della diffu-sione delle completive con quod è stato considerato come una delle più importanti evoluzioni di tipo sintattico avvenute nel corso della storia della lingua latina. si tratta infatti non solo di una trasformazione strutturale di enorme portata, con il passaggio da un tipo subordinativo a verbo non finito verso una forma di complementazione dotata invece di verbo finito, ma anche di un cambiamento che ha avuto fondamentali ripercussioni sulla sintassi delle lingue derivate dal latino.
nelle carte che abbiamo indagato compaiono essenzialmente due tipi di frasi completive a verbo non finito (gli aci e gli infiniti completivi)6 e tre che invece presentano verbi di tipo fini-to (si tratta delle subordinate introdotte dai complementatori quod, quia e ut). come vedremo nei prossimi paragrafi, questi differenti tipi di subordinate vengono utilizzate nelle carte in sezioni e con funzioni diverse. per il momento ci limitiamo a sottolineare che nel nostro corpus compaiono pochi aci, di cui uno solo con soggetto espresso7; gli infiniti completivi sono in-vece più frequenti, si trovano quasi esclusivamente nelle sezioni fisse delle carte e sono sempre stereotipati in formule ricorrenti. Quanto alle completive a verbo finito, è interessante notare che le frasi introdotte da quia ricorrono solo in alcuni contesti e sempre con la stessa funzione, mentre quelle con ut (che sono spesso governate anche da verba dicendi, oltre che da verba voluntatis come in latino classico) sono più frequenti e compaiono in quasi tutti i documenti da noi analizzati con valori maggiormente variegati; c’è infine un’unica completiva introdotta da quod (che si ritrova in un tipo di contesto che in tutte le altre occasioni favorisce la selezione del complementatore quia).
nei nostri documenti si ritrova dunque una situazione che, da questo punto di vista, sem-bra non essere troppo dissimile da quella che si riscontra nei testi romanzi di epoca medievale: ampia diffusione della subordinazione completiva a verbo finito, e riduzione di quella a verbo non finito ad alcuni ambiti funzionali ben delimitati (ed in particolar modo quando il rappor-to tra la reggente e la subordinata è più stretto dal punto di vista semantico o testuale)8 o ai rari aci prodotti dai notai dotati di maggiori abilità scrittorie.
6 sulla differenza tra aci e infiniti completivi si vedano i lavori di bolkestein 1976a, 1976b, 1977 e pinkster 1990, pp. 126-127. in questa sede basti ricordare che un aci è una subordinata infinitiva dotata di un soggetto (non necessa-riamente identico a quello della reggente) espresso in accusativo (es. dico | te venire); gli infiniti completivi sono invece strutture infinitivali il cui soggetto, in base alla caratteristiche semantiche del verbo che le governa, è obbligatoriamente coreferente con quello della reggente o con il destinatario dell’azione che ha luogo nella sovraordinata. in genere, un eventuale elemento in accusativo presente in un periodo che contiene un infinito completivo costituisce il destinatario dell’azione veicolata dal verbo della reggente (es. admoneo te | venire).
7 si tratta anche dell’unico caso in cui il soggetto dell’aci non è coreferente con quello della reggente. Questa struttu-ra ricorre per altro in uno dei testi che presenta maggiore complessità tanto nella parte fissa quanto in quella libera (chla lii, 31). sugli aci privi di soggetto formalmente espresso si veda invece de melo 2006.
8 si tratta di casi in cui il soggetto della reggente e quello della subordinata sono coreferenti, oppure di infiniti “com-pletivi” in dipendenza da verbi desiderativi o di manipolazione (per questa classificazione dei predicati si veda noonan 1985).
paolo greco
146
si noti tuttavia che nei nostri documenti l’introduttore di frase completiva più diffuso è ut, un subordinatore che è attestato solo molto marginalmente nelle lingue romanze (rohlfs 1949-1954, §309, §335 e §945). Questo aspetto ci spinge a sottolineare l’importanza di non cadere nella tentazione di proiettare sic et simpliciter su questi documenti schemi e interpre-tazioni valide per le lingue romanze (o, allo stesso modo, per il latino classico). Queste carte, come molti altri documenti alto-medievali, sono caratterizzate da una lingua che deve essere analizzata in sé. e d’altronde forse proprio in questo aspetto risiede lo straordinario fascino di un codice il cui funzionamento sembra continuamente nascondersi e svelarsi ai nostri occhi, come un filo d’arianna spezzato ancora in troppi punti perché lo si possa seguire fino in fondo.
2.2. La subordinazione infinitiva tra formulario e libertà compositiva
2.2.1. la subordinazione completiva a verbo non finito nelle vendite da noi indagate è rappresentata quasi esclusivamente da infiniti semplici (o completivi) e da frasi infinitive il cui soggetto (non espresso) è coreferente con quello della reggente. come segnalato in chiusura del paragrafo precedente, abbiamo infatti riscontrato soltanto un aci dotato di soggetto for-malmente realizzato (e non coreferente con quello della sovraordinata):
(1) unde nec mihi nec cuilibet hominibus nichil restitit nec dicimus remanere sortjiones (ursus, salerno, agosto 897, chla lii, 31, 19-20)
la costruzione evidenziata in (1) è composta dai soli elementi nucleari, l’aci segue il suo verbo reggente e gli è linearmente contiguo (ma si noti l’ordine interno dei costituenti della costruzione infinitiva, in cui il verbo precede il soggetto)9. si tratta dunque di una struttura piuttosto semplice, che tuttavia rappresenta una rarità nel nostro corpus. non è d’altronde probabilmente un caso che questa costruzione ricorra proprio in un testo rogato dal notaio ursus. Quest’ultimo, infatti, verga sia carte di natura privata sia un preceptum concessionis principesco: opera dunque sul doppio versante della documentazione pubblica e di quella privata. si tratta, come sottolinea pratesi (1958, pp. 200-202), di una caratteristica (comune anche ad alcuni altri notai salernitani attivi tra il iX e il X secolo) che segnala un legame diretto tra questi scriventi e il potere principesco. indipendentemente dal fatto che si tratti di «veri e propri ufficiali di cancelleria, chiamati in circostanze speciali a prestare la loro opera anche fuori del proprio ufficio» (pratesi 1958, p. 201), oppure di semplici «notai aventi giurisdizio-ne nella città, chiamati di volta in volta a redigere i precetti principeschi» (pratesi 1958, p. 201), è in ogni caso chiaro che questi scriventi si pongono su un piano sensibilmente diverso da quello dei rogatari di documenti esclusivamente privati. d’altronde, come segnalato da pe-trucci/romeo (1983, pp. 62, 76, 77 e 89), ursus rappresenta uno dei rari notai (insieme con
9 si noti inoltre l’interessante vocabolo sortjiones ‘Hereditatis portio ad alqm pertinens’ (limal, p. 775).
La comPLementaZione FraSaLe neLLe carte SaLernitane
147
dausdedi, anch’egli produttore sia di carte private che di documenti pubblici) operanti nel iX secolo in area salernitana ad utilizzare la scrittura beneventana cancelleresca, ed a essere in grado di variare la grafia adottata in base alla tipologia di documento rogato10 : questa vendita (come quella di dausdedi inclusa nel nostro corpus) è infatti vergata nella comune scrittura beneventana documentaria, mentre per il preceptum concessionis principesco che entrambi i notai producono viene utilizzata la più evoluta beneventana cancelleresca11. appare dunque plausibile, e coerente con il quadro storico e socio-culturale più ampio, che la lingua utilizzata da notai dotati di tali abilità scrittorie presenti maggiore complessità e un più alto grado di sofisticatezza rispetto a quella dei comuni notai rogatari di documenti privati.
nella stessa vendita rogata da ursus, inoltre, ricorrono due costruzioni al congiuntivo che meritano a nostro avviso di essere discusse in questa sede poiché presentano numerosi tratti in comune con gli aci:
(2) ideeoque ego mulier nomine ametruda religiosa femina, quoniam declarata sum a super dicta potestatem per brebem sigillatum concessum aberet omnia rebus qui fuit radelchis filio meus qui sine heredibus defunctus est (ursus, salerno, agosto 897, chla lii, 31, 3-4)
(3) in presentjia super dicti iudici, meam vona et utilis {de} declaravit esset volumtas (ursus, saler-no, agosto 897, chla lii, 31, 11-12)
nell’esempio (2) la struttura aberet omnia rebus qui fuit radelchis filio meus qui sine heredi-bus defunctus est segnala che la contraente è stata ritenuta effettivamente proprietaria dei beni che intende vendere. la costruzione ha dunque una funzione per così dire a metà strada tra il completivo e l’aggettivale.
il brano presentato in (3) occorre in una sezione della vendita che è tipica dei contratti in cui il venditore è una donna. si tratta di una parte del documento in cui, secondo il costume longobardo12, la contraente segnala di aver dichiarato davanti a un giudice la sua volontà di vendere il bene di cui è oggetto il documento. come vedremo più chiaramente nel paragrafo 2.3., tuttavia, nelle altre carte da noi indagate la struttura della dichiarazione è leggermente diversa (in particolar modo il verbo della reggente ha una forma analitica del tipo participio + sum) e la subordinata completiva è realizzata attraverso una frase introdotta da quia (e in un caso da quod):
10 particolarmente chiara ci sembra la formulazione di questo principio che si ritrova in petrucci/romeo 1983, p. 77: «appare degna di segnalazione la tendenza [...] a collegare direttamente il tipo o il livello di esecuzione della scrittura con la natura del documento e le qualità dell’autore o anche del destinatario di esso; [...] all’interno di una attenta inter-pretazione del loro ruolo professionale, [alcuni notai] erano in grado di distinguere esattamente la natura giuridica degli atti e il peso determinante delle singole parti contraenti».
11 si confrontino i documenti 25, 27 e 31 del volume 52 delle chla con le carte 24 e 34 dello stesso tomo.12 si vedano le norme longobarde, oggi raccolte in leges iv, pp. 117-119 e 121, che regolano le vendite da parte di
donne.
paolo greco
148
(4) tunc in eius presentjia manifesta sum quia nulla violentjia pateos a nullos quempius homines, set bona mea bolumtates (alhoini, salerno, aprile 882, chla lii, 18, 7-9)
il confronto tra gli esempi (3) e (4) evidenzia la sostanziale equi-funzionalità tra le due diverse tipologie di subordinate completive nel quadro dei documenti in cui sono incluse.
in effetti, l’occorrenza di frasi completive al congiuntivo prive di introduttore è attestata (sia pur con alcune restrizioni sintattiche) in tutta la latinità, ed in particolar modo a partire dal primo medioevo13. tuttavia, frasi come quelle presentate in (3), per la loro struttura, sem-brano potersi meglio interpretare come delle subordinate infinitivali in cui il verbo prende una forma apparentemente congiuntivale (o, altrettanto plausibilmente, in cui l’infinito viene flesso, dando luogo ad un apparente congiuntivo). Questo tipo di frasi è piuttosto diffuso nel latino medievale e, come si può dedurre dall’elenco di attestazioni proposte da stotz (1998, p. 403), ricorre in particolar modo nei documenti notarili ed in area longobarda14.
nella carta rogata dal notaio adelmari a nocera nel dicembre dell’882 compare un’altra costruzione che può essere considerata un aci con soggetto espresso; anche in questo caso l’atto è rappresentato da una vendita operata da una donna, e il documento si conforma al modello di tale tipo di transazioni15.
(5) ideoque ego mulier nomine vuiletruda filia vuineperti et uxor fuit mauri filio ermemari declarata sum quod a sarracenis sumus circumdati et a periculis famis nos perire cogitamus (adelmari, nocera, dicembre 882, chla lii, 22, 2-4)
come si vede, la costruzione evidenziata in (5) può essere interpretata in almeno due diverse maniere: il costituente nos può essere considerato sia come il soggetto di cogitamus che come quello di perire. la coreferenza tra i soggetti delle due frasi, insieme con l’identità formale tra il nominativo e l’accusativo del pronome nos, rende infatti impossibile azzardare ipotesi sull’appartenenza sintattica di questo elemento. in altre parole è impossibile stabilire quale delle due frasi abbia il soggetto non espresso. in ogni caso, è chiaro che la gestione sin-tattica di questa struttura, rispetto a quella di un aci dotato di soggetto non coreferente con quello della reggente, è caratterizzata da una minore complessità. d’altronde, tutto il periodo
13 si vedano almeno le osservazioni di Hofmann/szantyr 1965, pp. 528-529 e il contributo di sznayder 2003.14 sull’argomento ci sia permesso di rimandare a quanto da noi sottolineato in greco 2012.15 una particolarità molto interessante di questo testo (l’unico del nostro corpus, per altro, a contenere una completiva
introdotta da quod) è, come segnala galante 1982, p. 77, il fatto che viene indicata la presenza di un giudice. Questa caratteristica rappresenta una rarità nel quadro delle carte del iX secolo conservate nell’archivio della badia della s.ma trinità di cava de’ tirreni e, ad esempio, solo altri e due documenti tra quelli da noi indagati indicano la partecipazione di un giudice all’atto della vendita. in realtà, come segnalato in precedenza (si veda la nota 12), le norme del diritto lon-gobardo prescrivevano che le vendite operate da donne fossero registrate alla presenza di un giudice. in molti casi però, il funzionario presente è un gastaldo, un vicedomino o uno sculdais. la partecipazione di un giudice all’atto della vendita (non esclusivamente nei casi in cui il venditore è una donna, si veda anche magistrale 1991, p. 264) diverrà frequente nei secoli successivi, ma non se ne ha traccia prima dell’853, e comunque nel cinquantennio successivo solo in 13 carte viene fatto riferimento ad un giudice (galante 1982, pp. 77-78).
La comPLementaZione FraSaLe neLLe carte SaLernitane
149
è contraddistinto da una certa semplicità della struttura sintattica, con il circostanziale che dà informazioni di sfondo (a periculis famis) posto in prima posizione e gli elementi nucleari dell’aci adiacenti tra loro e contigui con il verbo reggente, il quale chiude il periodo. tanto in questo caso, come in quello esaminato in precedenza, dunque, l’aci è costituito dai soli soggetto e predicato, linearmente contigui.
a dispetto della semplicità dell’organizzazione dei rapporti sintattici intrafrastici, la com-pletiva evidenziata in (5) si segnala per il suo livello di incassamento: nel quadro di una sintassi interfrastica sempre piuttosto semplice, che solo in poche occasioni supera il primo grado di subordinazione, l’occorrenza di una struttura rara come l’aci al secondo grado di subordina-zione rappresenta comunque un indizio di un livello sociolinguistico più elevato del testo. la frase infinitiva dipende infatti da cogitamus, che costituisce il predicato di una coordinata alla subordinata completiva quod a Sarracenis sumus circumdati (la quale rappresenta anche l’unica completiva introdotta da quod di tutto il nostro corpus). come si vede, dunque, il brano in (5) mostra numerose peculiarità, e in questo quadro non ci sembra di poter escludere che l’aci compaia in opposizione al quod della frase sovraordinata, in una sorta di variatio che garan-tisca maggiore eleganza al documento non solo nell’alternanza della tipologia di subordinata completiva, ma anche nella selezione di una struttura rara.
2.2.2. al contrario degli aci con soggetto espresso, le strutture infinitive il cui soggetto (non realizzato formalmente) è coreferente con quello della reggente o con il destinatario dell’evento che ha luogo nella sovraordinata compaiono nei nostri testi con una certa frequen-za, in particolar modo nelle parti fisse dei documenti. le formule contrattuali, pur varian-do sensibilmente nella realizzazione ortografica dei singoli costituenti, risultano infatti quasi uguali in tutti gli atti del nostro corpus, ed anche in numerose altre carte di tipologia identica o affine a quella delle vendite. ad esempio, le seguenti formule che si ritrovano in una dona-zione rogata a salerno nel novembre dell’877 compaiono, fatte salve le specificità del singolo documento, e declinate secondo numerose alternanze nell’ortografia16, in quasi tutti i contratti di vendita da noi analizzati:
(6) ut amodo et semper tu et tuos erede ipsa abere et possidere baleatis, de quibus me repromicto ego qui supra radoaldus donator et hobligo me et meus heredes tibi qui supra ursi et ad tuos heredes ista mea donatjone, sicut superius legitur, ab omnis homine inantistare et defendere promictimus (ioanne, salerno, novembre 877, chla lii, 6, 13-16)
le parti da noi evidenziate in corsivo (che contengono per altro tutti gli infiniti completivi presenti nel brano) ricorrono con una certa regolarità nelle vendite del nostro corpus.
le formule ut amodo et semper tu et tuos heredes ipsa abere et possidere baleatis e de quibus me
16 la questione delle alternanza grafiche nei documenti conservati nell’archivio della badia della s.ma trinità di cava de’ tirreni, delle loro regolarità e delle loro ricadute sul piano morfosintattico, è molto complessa e non può essere trattata in questa sede. ci limitiamo a rimandare al lavoro di fiorentino 1994.
paolo greco
150
repromicto et hobligo me et meus heredes tibi et ad tuos heredes ista mea donatjone/vinditjone ab om-nis homine inantistare et defendere promictimus si ritrovano, con numerose variazioni ortografiche, morfologiche e qualche volta anche lessicali (frequente è ad esempio l’alternanza tra spondeo e promitto, ma anche la selezione dei pronomi di ripresa varia da documento a documento) in tutte le vendite da noi analizzate. tuttavia, il formulario non è del tutto rigido, e oltre a variazioni come quelle appena segnalate, se ne riscontrano anche altre di maggiore portata: nei documenti 18 e 23, ad esempio, manca la parte in cui compare l’infinito habere et possidere valeatis; nelle carte 13, 19, 22 e 27, invece, la formula ab omnis homine inantistare et defendere promictimus è introdotta dal complementatore ut:
(7) de quibus me repromitto ego qui supra mauru et meosque heredes colligo bobis qui supra angelberti presbiteri bel ad bestros heredes ut istam binditjonem bobis ab omnis nomine inantestare et defendere spondimus (adelmari, nocera, marzo 882, chla lii, 13, 19-21)17
in due documenti, il 25 e il 26, manca del tutto il verbo spondeo/promitto. d’altronde, se, come sembra, quest’ultimo deve essere posto in dipendenza dai verbi repromitto e obligo, la sua presenza appare sintatticamente non necessaria. il documento 25, inoltre, è di particolare interesse per questo studio anche perché presenta un’ulteriore modifica alle formule che stia-mo discutendo:
(8) ea ratjonem ut ammodo et semper tu tuisque heredibus suprascripta nostra binditjone abe-atis et faciatis quid bolueritis; de quibus me repromitto et heredes meos obligo tibi et tuis heredibus ex ipsa nostra binditjone ab omnis homines inantestare et defendere (dausdedi, salerno, marzo 890, chla lii, 25, 10-13)
come si vede, dausdedi, oltre a modificare la sintassi della parte finale della formula elimi-nando il verbo ‘promettere’, sostituisce al più frequente habere et possidere valeatis l’espressione et faciatis quid bolueritis, una formula non altrimenti attestata nei documenti del iX secolo conservati a cava de’ tirreni (e che invece si ritrova in alcune carte del X secolo)18. l’unico altro notaio, tra quelli da noi indagati, che evidenzia una simile attitudine è ursus, rogatario del documento 31:
(9) eam vero ratjionem ut a presentis dies et in perpetuis temporibus predicta nostra bindictjio-nem tu predictus iohannes presbiter quam et tuis heredibus in omnibus possideatis et faciatis quem vellet volueris; de quibus me repromicto et hobligo heredes mea vobis qui supra io-hannis presbiteri quam et ad tuis heredibus ut ea que nostra bindictjio, ut dudum prelegitur, nos vobis ab omnis nomine inantestare et defensare promictimus (ursus, salerno, agosto 897, chla lii, 31, 24-29)
17 su queste formule torneremo in maniera più distesa nel paragrafo 2.3.18 si vedano ad esempio le carte cXviii (903) e cXXXiii (917) del cdc, i.
La comPLementaZione FraSaLe neLLe carte SaLernitane
151
ursus modifica il formulario più diffuso in maniera ancora più decisa di quanto non faccia dausdedi. l’impronta della parte fissa è ancora chiaramente rintracciabile, ma la libertà dell’espressione del notaio rispetto alle formule che si ritrovano negli altri documenti del iX secolo è sensibile. si noti tuttavia che, se le variazioni prodotte da dausdedi sembrano tendere verso una maggiore chiarezza e coerenza sintattica, quelle apportate da ursus appaiono legate al desiderio di realizzare un testo forse più elegante, ma meno conciso (si pensi ad esempio all’interessante espressione faciatis quem vellet volueris, caratterizzata dalla reduplicazione del verbo velle).nelle parti fisse delle vendite compaiono anche alcune altre strutture infinitive più brevi di quelle presentate in precedenza. ricorrono ad esempio con una certa frequenza le espressioni retornare quesierimus e conponere spondimus (in questa formulazione nel documento 13 del volume lii delle chla), che si ritrovano nelle sezioni delle carte in cui sono indicate le penali che il venditore dovrà pagare se vorrà infrangere il patto di vendita:
(10) Quid si non potuerimus, aut si nos ipsi per quolibet ingenio retornare quesierimus, duplo suprascripto pretjum nos bobis conponere spondimus (adelmari, nocera, marzo 882, chla lii, 13, 21-23)
Queste formule sono più regolari di quelle esaminate in precedenza e, fatte salve le variazio-ni legate all’alternanza ortografica i/e, le uniche modifiche di rilievo riguardano la locuzione in cui è inclusa l’espressione retornare quesierimus, che può comparire nelle forme quid sit menime inantistare aut defendere bel retornare quesierimus (chla lii, 11; chla lii, 15), et qui sit minime inantistare non potuerimus, aut per nos ipsi per quolibet ingenio retornare quesierimus (chla lii, 23), remobere quesierimus (chla lii, 25; chla lii, 26), remobere aud retornare quesierimus (chla lii, 27; chla lii, 31). È interessante notare che i documenti 11 e 15 sono stati en-trambi rogati dal notarius inghelprandus, e le carte 27 e 31 sono invece state prodotte da ursus: entrambi i notai si mostrano dunque coerenti con il proprio formulario (lievemente diverso da quello adoperato da altri rogatari) in tutte le vendite da loro vergate che ci sono giunte19. i do-cumenti 25 e 26 sono invece stati prodotti rispettivamente da dausdedi e da accone; d’altronde la formula completa non è identica nei due testi: nel primo si ritrova la seguente dizione quid si vobis ipso defendere non potueimus, aut si nos ipsi eos remobere quesierimus (dausdedi, salerno, marzo 890, chla lii, 25, 14-15); nel secondo invece si riscontra nam si ego ipse teodemari aut meos heredes aliquando qualitercumque de supra dicta nostra vinditjone tecum eodem ermetanco aut cum tuos heredes qualitercumque causaverimus, vel eam remobere quesierimus (accone, benevento, marzo 892, chla lii, 26, 19-20). come si vede, la variazione apportata da dausdedi è di entità minore, e anche in questo caso appare più diretta ad una maggiore compattezza della formulazio-
19 i due documenti rogati da inghelprandus costituiscono le uniche carte prodotte da questo notaio oggi note. di ursus ci sono giunti invece anche alcuni atti vergati nel X secolo tra salerno e nocera (si tratta dei testi 115, 116, 117, 119, 120, 124, 130, 135, 137 e 144 editi in cdc, i); tra questi, il numero 124 e il numero 137 sono delle vendite. in queste carte ricorre sempre la formula remobere aud retornare quesierimus (sia pure con variazioni ortografiche che, in assenza di una nuova edizione dei documenti del X secolo, non è possibile ascrivere con certezza alla mano del notaio).
paolo greco
152
ne del vincolo; al contrario il testo prodotto da accone è sensibilmente diverso da quello che si ritrova negli altri documenti da noi indagati. Questa differenza nel formulario si riscontra anche in molte altre parti della carta e si può probabilmente ascrivere al luogo di produzione: si tratta infatti dell’unico documento da noi analizzato che è stato rogato a benevento.
la costruzione conponere spondimus si ritrova invece in tutte le vendite da noi indagate, tranne nelle tre più recenti (carte 26, 27 e 31): nella prima (si tratta dell’unica carta del nostro corpus rogata a benevento, la quale, come abbiamo sottolineato in precedenza, presenta un formula-rio sensibilmente diverso da quello che si ritrova negli altri testi da noi indagati) la formula è sostituita dal futuro semplice componamus, in accordo con la linea seguita dal notaio in tutto il documento, in cui le promesse sono sempre realizzate attraverso verbi al futuro:
(11) si non potuerimus, nichil aliut vobis persolvamus, nisi solummodo ad dei sanctam dei evangelia vobis iurare faciamus dicendo ut eadem mea vinditjone absque omnem colludium vobis defendere voluissemus et non potuissemus, post datum hoc sacramentum, reddamus vobis supra dictos duos solidos constantinos bonos [...]; et quod apud vos eadem mea vin-ditjone remeliorata paruerit, sub estimatjone pretjii vobis restituamus (accone, benevento, marzo 892, chla lii, 26,17-19)
nelle carte 27 e 31, entrambe rogate dal notaio ursus, invece, spondimus è sostituito dal verbo promittimus. si tratta di un’alternanza che, in altre formule, si ritrova anche in altri documenti del iX secolo conservati nell’archivio della badia di cava de’ tirreni; il significato di questa variazio-ne appare, tuttavia, allo stato attuale della ricerca ancora da determinare.
vi sono infine due ulteriori espressioni che contengono infiniti completivi e ricorrono in ma-niera molto regolare: una è la formula della rogatio (te X notarium scribere rogavi), sostanzialmente invariabile, che ricorre in tutte le vendite da noi analizzate20; l’altra, che compare esclusivamente nelle transazioni in cui il venditore è una donna, costituisce invece parte della formula con cui viene accertata dal notaio la volontà della venditrice (vindere volo).
2.3. La subordinazione completiva a verbo finito nelle vendite
2.3.1. la distribuzione delle subordinate completive a verbo finito nelle vendite da noi analizzate evidenzia una chiara suddivisione nell’uso dei diversi introduttori in base all’identità del venditore. i complementatori quod e quia sono piuttosto rari, e compaiono solo nelle carte
20 le uniche variazioni in questa formula sono legate, oltre alla consueta alternanza b/v (sebbene in questo caso la realizzazione scribere rogabi sia nettamente più frequente), alle realizzazioni del predicato rogo, che compare nelle forme rogavi, rogavimus e rogavit. in maniera forse un po’ sorprendente, poiché il valore sintattico del verbo è sempre quello di una prima persona, la variante con la t è nettamente più frequente. in un solo caso (carta 31) l’infinito scribere presenta una s finale. si tratta di un particolare di un certo interesse, se teniamo in considerazione che l’allocuzione è fatta alla seconda persona, e che dunque questo infinito risulta accordato con il suo soggetto. ma si tratta, nel nostro corpus, di un caso isolato e, in assenza di altri riscontri, la forma scriberes deve essere, a nostro avviso, più prudentemente legata a questioni meramente ortografiche.
La comPLementaZione FraSaLe neLLe carte SaLernitane
153
in cui il venditore è una donna. i documenti di questo tipo presentano in effetti, come abbia-mo accennato nel paragrafo precedente, un formulario e una struttura peculiari. le norme del diritto longobardo prevedono infatti che questa tipologia di transazioni avvenga alla presenza di un giudice, il quale, secondo la procedura, deve provvedere ad interrogare la contraente per assicurarsi che la vendita non avvenga in seguito a violenza21. nell’atto di vendita, dunque, la donna segnala di aver dichiarato davanti al giudice di non essere stata costretta alla vendita del bene con la violenza. Questa affermazione viene realizzata, in tutti i documenti da noi analiz-zati tranne uno (su cui torneremo più avanti), attraverso una completiva introdotta da quia:
(12) tunc in eius presentjia manifesta sum quia nulla violentjia pateos a nullos quempius homines (alhoini, salerno, aprile 882, chla lii, 18, 7-8)
(13) tunc in eius presentjiam me diffamabit quia nullam biolentjam sum patibola a quabis homi-nem (adelmari, nocera, maggio 882, chla lii, 19, 5-6)
(14) ecce in eius presentja me diffamabit quia nullam biolentjam sum patibolam a quabis hominem (adelmari, nocera, dicembre 882, chla lii, 22, 10-11)22
come si vede, negli esempi (12)-(14) lo schema seguito dai notai alhoini e adelmari è molto simile, e tanto la forma quanto la funzione della completiva con quia è del tutto com-parabile.
in ogni caso, è bene sottolineare che, a dispetto della perfetta sovrapponibilità formale tra gli esempi (13) e (14), i due documenti rogati da adelmari da cui sono tratti i brani presen-tano alcune sostanziali divergenze nell’impostazione generale. la carta 22 contiene infatti un breve inserto iniziale in cui vuiletruda, la venditrice, spiega quali eventi la hanno portata nello stato di bisogno che la spinge a alienare l’ottava dei beni materiali da lei posseduti in nocera e altrove. in questa parte libera dal formulario compare l’unica certa subordinata completiva introdotta da quod che si ritrova nel nostro corpus (si tratta del brano che abbiamo mostrato in (5) nel paragrafo precedente, e che riproponiamo qui nella parte iniziale del passo in (17)). la dichiarazione riguardante la volontà esplicita della donna di vendere il proprio bene è dunque formulata in maniera diretta. Questa affermazione è seguita da una domanda del giudice, che chiede alla venditrice se sia stata costretta con la forza ad alienare il bene. la riposta della donna è rappresentata proprio dalla frase che abbiamo evidenziato in (14). nel documento 19
21 in realtà, come accennato nel paragrafo precedente, la presenza di un vero e proprio giudice si riscontra nelle carte conservate nell’archivio della badia di cava de’ tirreni solo a partire dalla seconda metà del secolo iX. in precedenza le figure che provvedevano all’interrogatorio della donna erano di vario tipo e nei documenti si alternano in questa funzione personaggi come lo sculdais, il gastaldo o il vicedomino.
22 si noti che in questi tre documenti viene segnalato che la transazione è avvenuta alla presenza di un giudice. si tratta, come abbiamo sottolineato nella nota precedente, di un evento non frequente nella longobardia minore nel iX secolo, e d’altronde, tra gli atti da noi indagati, oltre che nei tre documenti che stiamo discutendo, solo nella carta 31 si segnala la presenza di un giudice.
paolo greco
154
la domanda del giudice verte invece sulla volontà della donna di vendere il proprio bene, e la risposta è costituita dal brano mostrato in (13). l’interpretazione della carta 18, infine, è più complessa: non è infatti del tutto chiaro, a nostro avviso, se il giudice domanda alla venditri-ce se ha subito una violenza che la ha spinta alla vendita, oppure se il giudice domanda alla donna se ha subito una violenza e se vuole vendere la sua terra23. in ogni caso, la risposta della venditrice è rappresentata dal passo evidenziato in (12). negli atti 18 e 19, dunque, la volontà della venditrice non è affermata in maniera diretta, e risulta sufficiente la dichiarazione che la donna non è stata costretta alla vendita con la violenza.
(15) ideoque ego mulier nomine magelchisa religiosa femina [...] interrogatas sum iustam legibus et esquisita aba trasenandum gastaldum et iudicem nec aliquod violentjia patere quod ipsa modica hoctaba mea de terra bindere boleos (alhoini, salerno, aprile 882, lii, 18, 2-5)
(16) ideoque ego mulier nomine lioperga [...] dum benimus in presentjam leomperti iudices filii leoni et ab ipso interrogata bel inquisita sum diligenter quia in aliquantulum de ipsa mea octabam ratjonem bindere bolo (adelmari, nocera, maggio 882, lii, 19, 2-4)
(17) ideoque ego mulier nomine vuiletruda [...] declarata sum quod a Sarracenis sumus circumdati et a periculis famis nos perire cogitamus et nihil habeo aliquid remedium qualiter bibere possam nisi ipsam octabam portjonem meam de rebus bindere bolo. et dum benior in presentja erchemperti iudices filii ermeperti et ab ipso interrogata bel inquisita sum diligenter ut ne aliquam biolentjam patere a quabis hominem (adelmari, nocera, dicembre 882, lii, 22, 2-6)
come si vede, i primi due brani presentano un’interrogativa indiretta (governata in un’oc-casione da interrogatas sum et esquisita e nell’altro da interrogata bel inquisita sum diligen-ter), che viene realizzata in un caso (esempio (16)) da una subordinata introdotta da quia e nell’altro attraverso una frase infinitiva cui segue una seconda subordinata introdotta da quod. Quest’ultima struttura, in particolare, può essere interpretata, a nostro avviso, tanto come un’altra interrogativa indiretta (sul modello, quindi, della frase introdotta da quia in (16)), quanto come una subordinata con valore relativo. non ci sembra infatti da escludere che il quod che introduce la frase ipsa modica hoctaba mea de terra bindere boleos abbia un valore paragonabile a quello dell’espressione italiana ‘per la quale’ e che dunque l’intera subordinata debba legarsi al costituente violentjia. la frase introdotta da quod avrebbe dunque la funzione di rendere esplicito che la vendita non è la conseguenza di un atto di violenza, e non sarebbe una semplice ulteriore affermazione che si aggiunge al nec aliquod violentjia patere senza che tra le due frasi si stabilisca una vera e propria relazione di tipo causa / effetto.
nel passaggio presentato in (17), invece, la dichiarazione della volontà da parte della donna di vendere il bene oggetto della transazione è, come accennato più sopra, esplicitamente affermata, e viene realizzata attraverso una sorta di frase relativa priva di introduttore: bindere bolo è infatti
23 come vedremo più avanti, questo dubbio interpretativo è legato ai diversi valori che può assumere, a nostro avviso, la frase introdotta da quod evidenziata in (16).
La comPLementaZione FraSaLe neLLe carte SaLernitane
155
sicuramente da riferirsi al costituente ipsam octabam portjonem meam de rebus della frase sovraor-dinata qualiter bibere possam nisi ipsam octabam portjonem meam de rebus. la domanda del giudi-ce (introdotta da interrogata bel inquisita sum diligenter, con una formula identica a quella usata dallo stesso notaio nel passo presentato in (16)) riguarda invece esclusivamente l’accertamento che la donna non abbia subito alcuna violenza che la abbia costretta alla vendita; il quesito viene linguisticamente realizzato attraverso una frase interrogativa indiretta introdotta da ut.
come si vede, le tre interrogative indirette presenti negli esempi (15), (16) e (17) sono in-trodotte da tre complementatori diversi: se però lo statuto del quod del brano in (15) è, come abbiamo avuto modo di evidenziare più sopra, leggermente diverso (e la frase stessa potrebbe non essere una vera e propria interrogativa indiretta), l’alternanza di quia e ut nei documenti 19 e 22 (vergati per altro dallo stesso notaio), appare più interessante. evidentemente non è possibile stabilire con certezza le motivazioni di una tale variazione sulla base di questi due soli esempi; tuttavia è opportuno notare che la subordinata introdotta da quia verte sulla volontà dell’original speaker (cioè della venditrice)24, mentre quella con ut concerne eventi in cui questo aspetto non ha alcun peso. come vedremo più avanti, questa differenza sembra iscriversi perfettamente nel quadro delle diverse caratteristiche delle completive introdotte dai due complementatori.
2.3.2. notevolmente più frequenti delle subordinate introdotte da quod e quia sono invece le completive con ut. Quest’ultimo tipo di frasi, nei nostri documenti, si trova tanto in dipen-denza da predicati di manipolazione e aggiunzione, quanto da verbi di dire e di acquisizione di conoscenza25, cioè anche da predicati che possiamo far rientrare nelle classi tradizionali dei verba dicendi et sentiendi. com’è noto, le attestazioni di subordinate introdotte da ut governate da quest’ultima tipologia di predicati iniziano a diffondersi a partire dal iv secolo26. secondo Herman (1963, pp. 46-47), questa «tournure reste toujours rare» (Herman 1963, p. 46) almeno fino all’epoca di ambrogio, mentre in età tarda le completive con ut che rimpiazzano un aci diventano «exceptionnellement fréquentes». d’altronde, «[c]ontrairement à quoniam qu’on ne rencontre pratiquement pas dans cette fonction après la chute de l’empire, ut se retrouve même dans des textes très tardifs» (Herman 1963, p. 46)27.
24 per la nozione di original speaker, in relazione a quella di actual speaker, si veda palmer 2001, p. 134. l’original speaker rappresenta il personaggio cui viene attribuita l’opinione o l’attitudine riguardante il contenuto proposizionale o l’evento veicolato dalla completiva; l’actual speaker corrisponde a colui che riporta l’opinione o l’attitudine. nelle vendite da noi analizzate, il rapporto tra original speaker e actual speaker è piuttosto complesso: i documenti sono infatti redatti in prima persona come se a parlare fosse il venditore, e la voce del notaio rogatario scompare dietro quella del venditore. nel nostro corpus, dunque, original e actual speaker in un certo senso coincidono.
25 le classi dei verbi di manipolazione, di acquisizione di conoscenza e di dire rimandano alla categorizzazione pro-posta da noonan 1985.
26 l’elenco delle prime attestazioni è fornito da Hofmann/szantyr 1965, pp. 645-646. panchón 2003, pp. 370-372 presenta anche quattro esempi di ut in dipendenza da dico in contesti non iussivi tratti da cicerone e plinio. lo studioso spagnolo evidenzia però che si tratta di casi piuttosto peculiari. utili notizie sul fenomeno si trovano già in mayen 1889, pp. 57-62.
27 in effetti, le occorrenze di frasi introdotte da ut in dipendenza da verbi di dire o sentire sono piuttosto frequenti anche in altri documenti notarili di area meridionale del medioevo centrale (si veda sornicola 2012), così come nel chronicon Salernitanum (si veda greco 2012, p. 58). alcuni studi hanno sostenuto che, almeno in certe tradizioni
paolo greco
156
nel nostro corpus, queste subordinate sono particolarmente frequenti (anche se, come vedre-mo più avanti in questo paragrafo, sono caratterizzate da una serie di peculiarità) e rappresentano quasi il 50% delle completive con ut da noi ritrovate (6 casi su 13). ci sono dunque, al contrario, sette occorrenze di ut utilizzato come introduttore di una completiva dipendente da un predicato che non sia un verbo di dire o di sentire. in sei occasioni la subordinata è governata da obligo ed in una da adiungo:
(18) eam ratjiones hobligos me que supra binditrices et meis eredibus tivi suprascripti emtoris meis et ad vestris eredibus ut ista suprascripta mea vinditjione nos bovis ab homnis omines defensares spondimus (alhoini, salerno, aprile 882, lii, 18, 21-23)
(19) de quibus me repromittimus nos qui supra radipertus et lioperga binditores et nostrosque heredes hobligamus tibi qui supra angelberti presbiteri bel ad tuos heredes ut dicta nostra binditjione bobis hab omnis hominem inantestare et defendere spondimus (adelmari, nocera, maggio 882, lii, 19, 25-28)28
(20) adque adiungimus ut ipsam octabam meam tibi in defensionem damus (adelmari, nocera, dicembre 882, lii, 22, 33-34)
(21) eam ratjone obligo me qui supra audipertus […] tibi qui supra adelmanni diacono et ad tuis heredibus ut ipsa nostra binditjone in integrum nos vobis ab omnis homines inantistare et defendere promittimus (ramipertus, nocera, in atreo Sancte marie, aprile 884, lii, 23, 20-23)
(22) obligavit me vobis ut ubicumque me inbenieritis, vos vel misso vestro sine calumnie licentja me abeatis prindere (ramipertus, nocera, in atreo Sancte marie, aprile 884, lii, 23, 33-35)
(23) heam vero ratjione hobligo mee qui supra petrus et meis heredibus tivi nominatus ragimper-ti et ad vestris heredibus ut ea que mea bindictjonem sicut super legitur, nos vobis hab homnis homines inantestare et defensare promictimus (ursus, nocera, agosto 893, lii, 27, 16-19)
(24) de quibus me repromicto et hobligo heredes mea vobis qui supra iohannis presbiteri quam et ad tuis heredibus ut ea que nostra bindictjio, ut dudum prelegitur, nos vobis ab omnis nomine inantestare et defensare promictimus (ursus, salerno, agosto 897, lii, 31, 26-29)
scrittorie, l’uso di ut fosse connotato sociolinguisticamente. il possibile utilizzo di questa variante in testi tardi come «Hyperurbanismus» è stato ad esempio sottolineato da norberg 1944, p. 114 n. 2; anche stotz 1998, pp. 401-402 insiste sul carattere «hyperurbanus» del letterario ut rispetto a quello «volkstümlich» di quod e quia.
28 si noti che il documento da cui è tratto il passaggio è molto deteriorato e presenta molte lacune: la formula evi-denziata in (20) è infatti in realtà ricostruita dall’editore del volume lii delle chartae Latinae antiquiores sulla base del testo che si ritrova in un altro documento vergato dallo stesso notaio (si tratta del documento 7, rigo 14, dello stesso volume lii).
La comPLementaZione FraSaLe neLLe carte SaLernitane
157
le formule presentate in (18), (19), (21), (22), (23) e (24) sono comparabili a quelle del tipo me repromicto et hobligo me et meus heredes tibi et ad tuos heredes ista mea vinditjone ab omnis homine inantistare et defendere promictimus che abbiamo discusso nel paragrafo 2.2. (e d’altronde già in quella sede avevamo accennato al fatto che nei nostri documenti questa formula alterna realizzazioni con l’infinitiva e con frasi introdotte dal complementatore ut)29. le due tipologie di formule sembrano equifunzionali e la selezione dell’una o dell’altra è apparentemente casuale30.
il passaggio evidenziato in (22), pur essendo caratterizzato da una completiva con ut dipen-dente da obligo, ha uno statuto sensibilmente diverso da quello delle subordinate appena discusse. il brano ricorre infatti in una porzione di testo che va oltre il formulario “standard”. come molte altre carte, in effetti, il documento 23 termina con una sezione in cui si indica la punizione che dovrà essere inflitta al venditore in caso di opposizione. tuttavia, in luogo del canonico “doppio sopraindicato prezzo” che il venditore si impegna a versare se verrà meno ai suoi impegni, nella carta 23 il venditore invita l’acquirente a prenderlo ubicumque me inbenieritis perché possa ren-dere giustizia. il periodo presentato nell’esempio (22) ci attesta dunque la vitalità, nella lingua dei nostri notai, della struttura obligo ut anche al di là del formulario più diffuso (in cui questa costruzione alterna con la semplice frase infinitiva).
in (20), infine, compare l’unico caso di tutto il nostro corpus in cui una completiva introdotta da ut è governata dal verbo adiungo. anche in quest’occasione si tratta di una frase che compare in una sezione posta al di fuori delle parti formulaiche del documento. il periodo presentato in (20), infatti, occorre al termine dell’atto, come una sorta di aggiunta posta oltre le espressioni scribere rogabit e actum noceria, e persino oltre il Feliciter che segue queste formule.
2.3.3. le altre sei occorrenze di subordinate introdotte da ut nel nostro corpus sono invece governate in cinque occasioni da verba dicendi e in un caso da un verbum sentiendi. a differenza però delle completive con ut dipendenti da verbi di manipolazione, che compaiono in sei docu-menti vergati da quattro diversi notai, le subordinate su cui ci stiamo ora soffermando ricorrono soltanto in quattro carte, redatte da tre notai. in particolare, come vedremo a breve, ben cinque frasi con ut su sei si trovano in atti vergati da due scriventi: inghelprandus e adelmari31.
29 in tutte queste formule si noti anche l’alternanza, che si ripete secondo uno schema costante e canonico, tra le forme sintetiche e analitiche con cui vengono indicati i beneficiari dell’obbligo (sempre tibi et ad tuos heredes). in tutte queste frasi, inoltre, appare impossibile stabilire se il verbo della subordinata governata da obligo sia inantistare (e dunque defendere spondimus/promittimus sia una coordinata), o se sia invece spondimus/promittimus. evidentemente, secondo la prima interpretazione, le occorrenze in cui compare ut sarebbero caratterizzate da una subordinata introdotta da un complementatore ma dotata di verbo all’infinito (queste frasi rientrerebbero dunque in una casistica diffusa in numerosi testi medievali, come si può ricavare, ad esempio, dalle pagine dedicate a questo fenomeno da bonnet 1890, p. 668, löfstedt 1911, p. 251, vielliard 1927, p. 231, pei 1932, p. 295 e uddholm 1953, pp. 154-155. utili in questo senso anche Hofmann/szantyr 1965, p. 578 e stotz 1998, p. 402).
30 È tuttavia possibile che la variante con ut fosse caratterizzata da uno statuto sociolinguistico più elevato: la ritro-viamo infatti nella carta 23, uno dei testi più interessanti del nostro corpus perché vergato da un notaio che si mostra in grado di andare oltre il formulario standard nella redazione del documento; la costruzione compare inoltre anche nelle vendite irogate dal notaio ursus che, come abbiamo sottolineato nei paragrafi precedenti, rappresenta uno degli scrittori più sofisticati tra quelli operanti in area salernitana alla fine del iX secolo.
31 si noti inoltre che tre di queste sei frasi compaiono in carte che rappresentano vendite operate da donne. Questo
paolo greco
158
inoltre, le completive con ut dipendenti da verbi di dire o di sentire compaiono soprattutto nelle parti che sembrano meno rigidamente legate ad un formulario, e dunque nelle occasioni in cui il notaio ha maggiore libertà.
(25) set dum audibit per ecdoctos et sapientissimos omines ut mulier, quando rebus suas bindere boluit, nam non absconse, set faciat notitjam inter duos bel tres parentes suos (inghelpran-dus, febbraio 882, salerno, lii, 11, 5-7)
(26) ego eis dixit ut aberet duos filios meos, uno predatus esseret a saraceni, altero bero non est ic quia habitat in nuceria (inghelprandus, febbraio 882, salerno, lii, 11, 14-15)
(27) de quibus me repromitto ego qui supra mauru et meosque heredes colligo bobis qui supra angelberti presbiteri bel ad bestros heredes ut istam meam binditjonem bobis ab omnis ho-minem inantestare et defendere spondimus (adelmari, marzo 882, nocera, lii, 13, 19-21)
(28) et iterum tangimus adque antiposuimus ut, si uxori mee aut quacumque homo introieri in ista mea binditjone et bobis exinde tuleri, et bos et bestros heredes liceam introire in ipsa medietate (adelmari, marzo 882, nocera, lii, 13, 25-27)
(29) de quibus me repromitto ego que supra vuiletruda binditrices et meosque heredes colligo tibi suprascripti angelberti presbiteri emptori meo bel ad bestros heredes ut predicta meam binditjonem bobis hab omnis hominem inantestare et defendere spondimus (adelmari, di-cembre 882, nocera, lii, 22, 25-28)
(30) si non potuerimus, nichil aliut vobis persolvamus, nisi solummodo ad dei sanctam dei evangelia vobis iurare faciamus dicendo ut eadem mea vinditjone absque omnem colludium vobis defendere voluissemus et non potuissemus, post datum hoc sacramentum, reddamus vobid supra dictos duos solidos constantinos bonos, sicut superius a te accepimus (accone, marzo 892, benevento, lii, 26, 16-18)
i brani che ricorrono nei documenti vergati da adelmari presentano in almeno due casi (esempi (27) e (29)) notevoli affinità con le strutture che abbiamo ritrovato in (18), (19), (21), (23) e (24): l’unica differenza riguarda il verbo che governa la completiva. se infatti negli esempi (18), (19), (21), (23) e (24) il predicato da cui dipende la subordinata è obligo, nei brani presentati in (27) e (29) è repromitto. la differenza semantica tra i due verbi è sensibile, ma dal contesto risulta evidente la contiguità dei loro significati, e d’altronde in due occasioni (esempi (19) e (24)) il predicato obligo occorre in coordinazione proprio con repromitto. si noti per altro che il brano evidenziato in (19) compare in un documento vergato dallo stesso
tipo di testi, come abbiamo già avuto modo di accennare nel paragrafo precedente, presentano un formulario e un’or-ganizzazione del documento leggermente diversi da quelli che si ritrovano in atti che sanciscono vendite in cui i due contraenti sono uomini.
La comPLementaZione FraSaLe neLLe carte SaLernitane
159
adelmari, ed è dunque possibile che questo notaio abbia in alcuni casi ritenuto sufficiente l’u-so del solo verbo repromitto. l’unico altro esempio di completiva con ut nei documenti redatti da adelmari è quello evidenziato in (28). si tratta di un caso in cui la coppia di predicati tangi-mus adque antiposuimus ha in effetti un valore simile a quello dei verbi di dire, ma non lontano da quello dei verbi di aggiunzione. la frase tangimus adque antiposuimus ut, si uxori mee aut quacumque homo introieri in ista mea binditjone et bobis exinde tuleri, et bos et bestros heredes liceam introire in ipsa medietate risulta d’altronde a nostro avviso comparabile, dal punto di vista della relazione semantico-sintattica tra la reggente e la subordinata, alla frase adiungimus ut ipsam octabam meam tibi in defensionem damus che si trova in un altro documento vergato da adelmari. in ogni caso, è chiaro che le subordinate introdotte da ut in dipendenza da verbi di dire nelle carte rogate da adelmari possono tutte iscriversi nel quadro delle abitudini scrit-torie di questo notaio. È altresì evidente che il valore di verba dicendi dei predicati repromitto e tangimus adque anteposuimus è discutibile e comunque almeno strettamente contiguo a quello di verbum voluntatis nel primo caso e di verbo di aggiunzione nel secondo.
un quadro del tutto diverso è offerto invece dai due esempi che si ritrovano nella carta 11, vergata dal notaio inghelprandus. si tratta infatti di brani in cui i verbi reggenti sono chiaramente connotati come “di sentire” in un caso, e “di dire” nell’altro. l’uso delle completive introdotte da ut in dipendenza da verba dicendi et sentiendi sembra però essere connesso più con le caratteristi-che di questo singolo documento che con le abitudini scrittorie di inghelprandus; nell’altra carta vergata da questo notaio a noi giunta non c’è infatti traccia di un tale uso del complementatore ut. tuttavia, è bene sottolineare che, mentre il documento 11 costituisce un contratto in cui il venditore è donna, l’altra carta redatta da inghelprandus è una vendita in cui entrambi i con-traenti sono uomini; come abbiamo avuto modo di vedere in questo paragrafo, i testi in cui il venditore è donna, per la loro stessa struttura e per le loro diverse caratteristiche, presentano un più alto numero di verba dicendi (che in molti documenti si concretizza in una maggiore presenza di completive introdotte da quia). la carta 11 presenta però un formulario sensibilmente diverso da quello che si ritrova in altri documenti in cui il venditore è donna. in questo testo, infatti, la venditrice ricapitola la normativa riguardante le vendite in cui il venditore è una donna, e passa poi a descrivere una serie di peculiarità specifiche della transazione che la vede protagonista; il no-taio inghelprandus, dunque, racconta (prendendo, come è abitudine in questo tipo di contratti, il punto di vista del venditore)32 con una certa libertà dal formulario più diffuso le caratteristiche proprie di questa vendita. in un tale contesto “anomalo”, rispetto alla sostanziale standardizzazio-ne dei contratti di vendita, compaiono le completive con ut che abbiamo proposto in (25) e (26).
dal punto di vista linguistico, l’aspetto forse più interessante di queste due subordinate è il loro carattere “narrativo”, e in un certo senso “riportivo”, in confronto con quello più propria-
32 su questo aspetto si vedano galante 1982, p. 88 e magistrale 1991, pp. 260 e 267. in quest’ultimo lavoro, in particolare, viene così descritta la struttura generale di una cartula: «[l]a cartula è sempre impostata a nome dell’autore dell’azione giuridica che, in prima persona e in forma soggettiva, descrive l’antefatto, disponde per cartulam di vendere, di donare o di concedere al destintario beni di diversa natura, afferma di aver ricevuto la controprestazione reale o simbolica, enuncia clausole di cautela con puntuali sanzioni a proprio carico e, infine, riferisce la richiesta avanzata al rogatario circa la stesura del documento» (magistrale 1991, p. 267).
paolo greco
160
mente “assertivo” e dotato di forte commitment delle subordinate introdotte da quia (si vedano gli esempi (12)-(14)). si confrontino ad esempio le frasi presentate in (25)-(26) con il seguente periodo (in cui compare l’unica completiva con quia del nostro corpus che non avevamo ancora discusso), proveniente dallo stesso documento:
(31) ideoque ego rodelenda filia rodelaupi et uxor fuir polcari filii lupi declaro eo quia ipse nominatus Polcari vir meus [...] secundum ritum et consuetudo gentis nostre Langobardorum, traditum habuit mihi morgincapum (inghelprandus, febbraio 882, salerno, lii, 11, 2-4)
in (31) la venditrice dichiara, attraverso una completiva introdotta da quia, di aver ricevu-to il morgincap dal proprio marito nel giorno delle nozze, secondo la consuetudine longobar-da; i passi presentati in (25) e (26), al contrario, compaiono in una sezione del documento in cui la donna ripercorre alcuni eventi passati: in particolar modo, nell’esempio (25) racconta di aver sentito da alcuni ecdoctos et sapientissimos omines che se una donna vuole vendere i propri averi, deve renderlo noto alla presenza di duos bel tres parentes suos con i quali deve presentarsi ante nubiliores omines. la venditrice narra dunque di essersi recata con due parenti presso il gastaldo nandiperto, e di aver ricevuto una domanda da parte di quest’ultimo in merito alla possibilità che lei avesse parenti più prossimi con cui presentarsi dinanzi a lui. a questo punto (si veda l’esempio (26)) la donna racconta di aver risposto che uno dei suoi due figli era ostag-gio dei saraceni e l’altro abitava a nocera e non poteva raggiungere salerno pro ista generatjones barbaras Saracenorum unde in cibitate ista Salernitana circumclusi sumus. se dunque in (31) il valore “assertivo” della completiva introdotta da quia, così come il coinvolgimento della locutrice, è evidente, nella subordinata introdotta da ut presentata in (26) questo stesso valore è smorzato dal fatto che si tratta del resoconto di un’affermazione piuttosto che di una vera e propria asserzione, e dal fatto che le circostanze descritte nella completiva sono chiaramente al di fuori della volontà della locutrice; in (25) la frase con ut ha una funzione sostanzialmente “riportiva”, e presenta comunque informazioni (per altro sempre poste all’interno di un rac-conto) sulle quali la volontà della locutrice non può incidere.
la subordinata che abbiamo evidenziato in (30), infine, veicola un evento di tipo non fattua-le futurale (il verbo dico introduce il contenuto del giuramento operato dal venditore in favore dell’acquirente): si tratta in effetti di una casistica di uso delle completive introdotte da ut in dipendenza da verba dicendi che è stata da noi ritrovata anche nel chronicon Salernitanum33.
in definitiva, la complementazione frasale a verbo finito nelle vendite da noi analizzate è realizzata nella maggioranza dei casi da subordinate introdotte da ut, che sono governate sia da verbi di manipolazione e di aggiunzione (come in latino classico) sia da verba dicendi et sentiendi. in dipendenza da quest’ultimo tipo di predicati compaiono però in competizione con le frasi
33 si veda greco 2012, pp. 57-70. nel chronicon Salernitanum le completive con ut dipendono in più occasioni da verbi che significano ‘promettere’. in quest’ottica, anche le frasi che abbiamo presentato in (27) e (29) possono essere in-terpretate all’interno di un quadro più complesso (che coinvolge anche altre tipologie testuali) della produzione scrittoria di area salernitana tra il iX e il X secolo.
La comPLementaZione FraSaLe neLLe carte SaLernitane
161
introdotte da quod e quia. la selezione di queste varianti sembra regolata da motivazioni di na-tura testuale e pragmatica: in contesti decisamente assertivi, in cui l’original speaker è fortemente coinvolto ed in cui è molto chiaro il suo impegno circa la verità dell’affermazione viene preferito il complementatore quia (o quod nell’unica sua occorrenza); al contrario, quando il coinvolgi-mento del locutore negli eventi descritti nella subordinata è nullo o quando si tratta comunque di eventi di natura non fattuale (ad esempio di tipo futurale, come una promessa o un giuramento), la variante selezionata è ut34.
3. conclusioni
in questo contributo abbiamo analizzato le caratteristiche della complementazione frasale in alcuni documenti contenuti nell’archivio della badia della s.ma trinità di cava de’ tirreni. più precisamente, abbiamo indagato tutte le vendite vergate nel quindicennio che va dal feb-braio 882 all’agosto 897.
si tratta di contratti piuttosto stereotipati, in cui larga parte del testo è occupata dal formu-lario e le brevi parti libere sono in genere limitate alla descrizione delle caratteristiche del bene venduto. anche questi, insomma, come le carte altomedievali di area napoletana analizzate in questo volume da vera von falkenhausen, «sono testi che in genere seguono un formulario tra-dizionale che lascia poca libertà alla struttura sintattica e alla scelta del vocabolario». tuttavia, l’analisi delle microvariazioni che si possono osservare nei documenti del nostro corpus permette di intravedere, dietro l’apparente regolarità e monotonia del formulario, le diverse qualità dei no-tai e le loro differenti abitudini stilistiche. abbiamo infatti potuto osservare che alcuni scriventi (come ad esempio ursus e dausdedi) più degli altri paiono in grado di discostarsi dalla rigidità del formulario più diffuso e, a volte, di aggiungere parti di testo che rendano il contratto più aderente al caso specifico.
l’indagine delle proprietà semantiche e pragmatiche delle completive presenti nei nostri do-cumenti, inoltre, ci ha permesso di evidenziare alcune differenze nella selezione dei diversi tipi di subordinate in base al verbo reggente e alla funzione pragmatica della subordinata. in particolar modo, in dipendenza da verbi di manipolazione abbiamo ritrovato soprattutto infiniti comple-tivi, che in alcuni casi sono in competizione con frasi introdotte da ut: alcune formule (come ad esempio de quibus me repromicto et hobligo me et meus heredes tibi et ad tuos heredes ista mea vin-ditjone ab omnis homine inantistare et defendere promictimus, con tutte le sue varianti) compaiono infatti a volte con l’infinito e altre con la subordinata introdotta da ut. in dipendenza da verba dicendi et sentiendi, invece, fatte salve un paio di strutture che potrebbero rappresentare dei veri e propri aci dotati di soggetto espresso (le quali compaiono solo in alcuni documenti più sofistica-ti), l’alternanza delle completive introdotte da quia (e da quod in un solo caso) e quelle introdotte da ut sembra essere legata a questioni di tipo pragmatico: se la volontà del locutore, o il suo
34 una simile differenziazione degli usi di quia e ut con valore completivo è stata notata in alcuni altri documenti notarili altomedievali di area campana da sornicola 2012 e da greco 2012, pp. 57-70 nel chronicon Salernitanum.
paolo greco
162
commitment, è coinvolto nell’affermazione che viene presentata nella subordinata, allora il subor-dinatore preferito è quia; se invece l’evento che viene descritto nella completiva è indipendente dalla volontà del locutore o è di tipo non fattuale futurale, allora il complementatore selezionato è ut35. una simile ripartizione degli usi di queste congiunzioni, come abbiamo sottolineato nel paragrafo 2.3., è stata da noi ritrovata nel chronicon Salernitanum ed è stata segnalata anche per altri documenti notarili altomedievali di area campana da sornicola (2012).
Fonti e BiBLiograFia
Fonti
cdc = i-viii: morcaldi, m. / schiani, m. / de stefano, s. (a cura di). 1873-1893. codex diplo-maticus cavensis. vol. i. napoli, petrus piazzi. volumi ii-viii. milano – pisa – napoli, Hulricus Hoepli; iX-X: leone, s. / vitolo, g. (a cura di). 1984 e 1990. codex diplomaticus cavensis. volumi iX e X. cava dei tirreni, badia di cava.
chla lii = m. galante (a cura di). 1998. chartae Latinae antiquiores, volume lii (italia XXiv), cava dei tirreni, archivio della badia della ss.ma trinità, dietikon, urs-graf verlag .
du cange gloss. lat. = ch. du fresne. 1883-1887. glossarium mediae et infimae latinitatis, (cit. da ed. online, disponibile al seguente indirizzo internet: http://ducange.enc.sorbonne.fr/. consultato il 24/10/2011).
leges iv = g. pertz (a cura di). 1868. monumenta germaniae Historica Legum tomus iiii. Hannover, Hahn, .
limal = f. arnaldi / p. smiraglia. 2001. Latinitatis italicae medii aevi lexicon, firenze, edizioni del galluzzo.
Bibliografia
bolkestein, a. m. 1976a. «a.c.i.- and ut-clauses with verba dicendi in latin», in «glotta», liv, pp. 263-291.
bolkestein, a. m. 1976b. «The relation between form and meaning of latin subordinate clauses governed by verba dicendi», in «mnemosyne», XXiX, pp. 155-175 e 268-300.
35 a questo proposito, desideriamo sottolineare che, benché nei nostri dati la ripartizione degli usi di ut e quia sia netta e regolare, riteniamo che questa generalizzazione debba essere considerata in senso tendenziale. non ci sembra infatti improbabile che, allargando il corpus, si possano ritrovare controesempi, sia pur marginali. suddivisioni di questo tipo, basate su aspetti pragmatici e sulle intenzioni comunicative dello scrivente (e che quindi insistono, in un certo senso, anche su questioni stilistiche), non possono infatti a nostro avviso essere considerate alla stregua di regole rigide.
La comPLementaZione FraSaLe neLLe carte SaLernitane
163
bolkestein, a. m. 1977. «part ii: The difference between free and obligatory ut-clauses», in «glotta», lv (3-4), pp. 231-250.
bonnet, m. 1890. Le latin de grégoire de tours. paris, Hachette (rist.: Hildesheim, georg olms verlags-buchhandlung, 1968).
cristofaro s. 2003. Subordination. oxford, oxford university press (cit. da ii ed., 2005).
cristofaro, s. 2008. «utterance complement clauses», in Haspelmath, m. / m. s. dryer / d. gil / b. comrie (a cura di). The World atlas of Language Structures online. munich, max planck digital library. capitolo 128. disponibile all’indirizzo http://wals.info/feature/128 (consultato il 17/3/2011).
de melo, W. d. c. 2006. «if in doubt, leave it in. subject accusatives in plautus and terence», in «oxford university Working papers in linguistics, philology & phonetics», 11, pp. 5-20.
fiorentino, g. 1994. «aspetti della morfosintassi nominale nelle carte cavensi del iX secolo», in «ar-chivio glottologico ita liano», lXXiX, pp. 23-50.
galante, m. 1982. «il notaio e il documento notarile a salerno in epoca longobarda», in aavv. Per una storia del notariato meridionale. roma, consiglio nazionale del notariato, pp. 73-94.
greco, p. 2012. La complementazione frasale nelle cronache latine dell’italia centro-meridionale (secoli X-Xii). napoli, liguori.
Hofmann, J. b. / szantyr, a. 1965. Lateinische Syntax und Stilistik. münchen, c. H. beck.
löfstedt, e. 1911. Philologischer Kommentar zur Peregrinatio aetheriae. uppsala, almqvist & Wiksell (rist., 1936).
magistrale, f. 1991. «il documento notarile nell’italia meridionale longobarda», in vitolo, g. / f. mottola (a cura di). Scrittura e produzione documentaria nel mezzogiorno longobardo, badia di cava, edizioni 10/17, pp. 257-272.
mayen, g. 1889. de particulis Qvod Qvia Qvoniam Qvomodo vt pro acc. cum infinitivo post verba sentiendi et declarandi positis. Kiliae, ex officina H. fiencke.
noonan, m. 1985. «complementation», in shopen, t. (a cura di). Language typology and syntactic description. vol. 2. complex constructions. cambridge, cambridge university press (cit. da ii ed. rivista 2007), pp. 42-140.
norberg, d. 1944. Beiträge zur Spätlateinischen Syntax. uppsala, almqvist & Wiksells.
palmer, f. r. 2001. mood and modality. cambridge, cambridge university press (i ed., 1986).
panchón, f. 2003. «les complétives en ut», in bodelot, c. (a cura di). grammaire fondamentale du latin. vol. X. Les propositions complétives en latin. leuven, peeters, pp. 335-481.
pei, m. 1932. The Language of the 8th century texts in northern France. new York.
petrucci, a. / romeo, c. 1983. «scrittura e alfabetismo nella salerno del iX secolo», in «scrittura e civiltà», 7, pp. 51-112.
pinkster, H. 1990. Latin Syntax and Semantics. london/new York, routledge.
pratesi, a. 1958. «la diplomatica dei principi longobardi di salerno», in Pubblicazioni dell’archivio di Stato di Salerno. 5 (cit. da id. tra carte e notai. Saggi di diplomatica dal 1951 al 1991. roma, società romana di storia patria, 1992, pp. 197-211).
paolo greco
164
pratesi, a. 1983. «appunti per una storia dell’evoluzione del notariato», in aavv. Studi in onore di Leopoldo Sandri. firenze, le monnier, pp. 759-772.
rohlfs, g. 1949-1954. Historische grammatik der italienischen Sprache und ihrer mundarten. 3 vol. bern, francke (cit. da trad. it., id. grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti. 3 vol. torino, einaudi. 1966-1969).
sabatini, f. 1965. «esigenze di realismo e dislocazione morfologica in testi preromanzi», in «rivista di cultura classica e medioevale», 7 (studi in onore di a. schiaffini), pp. 972-998 (cit. da ed. rivista, id. italia linguistica delle origini. Saggi editi dal 1956 al 1996, raccolti da v. coletti / r. coluccia / P. d’achille / n. de Blasi / L. Petrucci. lecce, argo, pp. 99-131).
sornicola, r. 2012. Bilinguismo e diglossia dei territori bizantini e longobardi del mezzogiorno: Le testi-monianze dei documenti del iX e X secolo, Quaderni dell’accademia pontaniana, 57, napoli, presso l’accademia.
stotz, p. 1998. Handbuch zur lateinischen Sprache des mittelalters. vol. iv. Formenlehre, Syntax und Stilistik. münchen, c. H. beck.
sznajder, l. 2003. «les complétives au subjonctif sans conjoncteur», in bodelot, c. (a cura di). gram-maire fondamentale du latin. vol. X. Les propositions complétives en latin. leuven, peeters, pp. 13-95.
uddolm, a. 1953. Formulae marculfi. Études sur la langue et le style. uppsala, almqvist & Wiksell.
vielliard, J. 1927. Le latin des diplômes royaux et chartes privées de l’époque mérovingienne. paris, cham-pion.