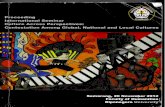Lo spazio dell’assenza
Transcript of Lo spazio dell’assenza
i tJlo-c oi0
LO SPAZIO DELL'ASSENZA
Richard A. Etlin
Ii tema del presente saggiol d un tipo di luogo la cui cuatteristica distintiva consiste in ma misteriosa solemiti che ci trasportaaI di fuori di questo mondo in ma sorta di limbo. Un luogo & paadossi che non appartiene n6 a questo n6 a-Il'altro mondo, n6 allospazio dei vivi, n6 a quello dei morti: un woto iI cui opprimente messaggio coincide con l'assenza della persona scomparsa, la guale,tuttavia, i presente in qualche modo entro I'aua del monumento. I progetti che ho raccolto sotto il titolo 'spazio dell'assenza" sonotutti cmatterizzati dalla ricerca dell'esseuiale e del primordiale. Essi definiscono uno spazio separato dal mondo dei vivi. sia attrayer-so Ia costruzione di m recinto in forma di tempio, sia mediante l'apertma di ua cayiti nel suolo, sia raccogliendo ula densa massadi pietre attomo ad mo spazio ristretto. Spesso comportaf,lo ma discesa nel teneno o m'ascesa verso il cielo; a volte {mo mo di unaluce particolare, ora brillmte e cristallina, ora cupa e spettrale.
Lo spzio dell'assenza d associato alla comemorazione. Deriva il suo caattere dal pmto & vista mentale e spiritialedell'Ilhminismo, momento in cui gli uchitetti amavmo configmare spazi ruoti in temini di recinti templri dedicati a qualche con-cetto astratto. Iiingresso in questo spzio aveva il compito. per cosi dire, di stabilire una comunione con uri alto ideale e di conferirepreseua all'astratto medimte l'aua evocata da m recinto appositmente progettato. Non d m caso che il grande mchitetto neoclas-sico Etieme-Louis Boull6e fosse, nella sua epoca, maesko sia degli spazi concepiti come templi per I'architettura del mondo dei yivi,sia dell'rchitettrra delle ombre evocmte qualcosa di incorporeo e, cid non di meno, capace di apparire assai reale. l"aspetto simbolico & questo spazio si basa sulla stessa intuizione d'ula presenza astratta in quanto carattere simbolico'. Costituisce a:rche ua specieentro il pii mpio genere dello spazio "nminoso"'. Tuttavia differisce da entrambi perch6 il suo soggetto e estremanente personale.Si stabilisce tra due o pii spiriti o anime in m modo che trascende la ragione. A partire dall'Illuminismo sino ai giorni nostri. il temadello spazio dell'assenza ha sostenuto alcme delle architetture pii profondamente spirituali in Occidente- Sebbene riconente comeforza motivante nei progetti destinati alla commemorazione, non i chiaro se Io spzio dell'asseua sia stato soggetto ad un chiaro svi-luppo cronoiogico. Piuttosto, come spesso awiene in ma materia che torca Io spirito cosi intimmente, sembra essere sorto in diverseforme ampimente in reluione alla personaliti creativa dell'artista. In ogni caso, questo non significa sostenere che i progetti indivi-duali non ingenerassero m'intera serie di sviluppi conelati. A volte capitava anche questo. Il mio approccio in questo capitolo, comm-que, sri pii tematico che cronologico. Esminerb il soggetto secondo il tipo.
Ree inti in foma di tempioForse non sorprende che uno dei pir) raffinati spazi in foma templare immaginato come mausoleo sia un progetto dei 1799 circa
dell'architetto tedesco Friedrich Gill-v, il quale impmd bene lo spirito e i principi del neoclassicismo fomcese proprio attraverso u viag-gio a Parigi. Dayid Watkin e Tilmm Mellinghoff, nel loro studio sull'architettura neoclassica tedesca. notano che: <questo mausoleocon pilastri quadrati, in cui le decorazioni convenzionali degli ordini sono eliminate, d conosciuto come una delle fichiarzioni pir)aymzate dello stile esseuialeggiante che si ritrova in diversi centri europei dell'inizio del 1800. Legato al rifiorire della grecitd nellasua foma pir) immaginosmente austera - contiauano gli autori - questo stile si esprime nelle scame incisioni di Custens. di Flmm,di Percier e Fontaine, di Hope; nei caratteri bastoncino adottati ad esempio da Soane; e nelf incorporea uchitettua lineme di Dmceil giovane e del suo allievo Soane,n. Sebbene tutto cid risponda a veriti, esiste anche m altro criterio di spieguione dell'aspetto primi-tivo di questa composizione, Ia cui particolariti consiste nel suo essere costruzione tuabeata di travi e pilastri monolitici, privi d'oma-mentuiotre e caatterizzati da solide proporzioni. Si tratta della ricerca di m aspetto primordiale. ma sorta & Ur-Architektur ritenu-ta la pii adeguata al tipo d'edificio. Imediato d il rimando al disegno di Boull6e per ma cappella {rmeraria nella forma d'una sem-
plice e disadorna piramide ritratta nel mezzo di ma tempesta;. ln entrambi i casi, il tentativo degli architetti 6 quello di conferire pre-seua alla dimensione cosmica della natura atEaverso rm'mchitetfma dal carattere primitivo.
..]f
736
.., .* JffiTffi
FRA.\X LLoID WRrcHT, Tempio U^nitariano .e Cenotafa (progetto), Taliesin la-ilev (Spring Green), Wisconsin, luglio 1958.Nella pagina afianco da sinisrro: FRTEDRICH Gtrtt. Progetto pei un maioleo, 1799 cica;
Peu Psr,ppn Caar, Bushy Run Battlefield Mimorial (progetto). 7927.
Si d visto ir precederzao a quale grado l'architetto Beau-Arts Paul Philippe Cret imbevesse le architetture istituionali dello spi-rito del cilattere simbolico di mmca tardo settecentesca. Non deve quindi sorprendere che egli trasferisse il senso dello spazio deil'as-senza nei uar memorials. Ad esempio, nel Pemsvlvmia State Shr Menorial a Varemes, Frmcia7924, progettato in collaborazionecon Thomas Atherton Jr., Cret utilizza il reciato templare dell'architettura neoclassica per creile mo spazio simbolico. Questo monu-mento, u-bicato sul bordo d'ma roccia scoscesa. crea un pimo definito da due file di pilastri classici trabeati disposti sul perimetoo. Ilpassaggio che Cret compie - da spzi caratterizzati simbolicamente ad uno spazio dell'assenza pir) primitivo e ctonio - awiene col pro-getto del Bushv Rm Battlefield Memoriai del 7927 . Qui Cret si imerge in un mondo primordiale con pilastri di pieta grezza, cliipo-sti su ma linea retta o sn una circonferenza. che rimandmo ai monoiiti di Stonehenge nella piana di Salisburv?.
Precedentemente8, ho fatto notre che Frank Llovd \flright rivestiva i suoi edifici istituionali - organizzai attorno a cid che eglichimava noble Room - con lo stesso tipo di cmattere simbolico rinvenibile nell'rchitettrra di Boull6e e Cret. Gurdmdo i suoi edifi-ci comemoraiivi, troviamo una grurde ricchezza nel senso dello spazio dell'assenza. I1 suo lavoro appmird in modo prioritmio in que-sto capitolo. Sotto la voce "recinti in forma templue" va amoverato il progetto lon realizzato di ma sua cappella fmeraria: il TempioLinitriano e Cenotafio, m progetto degli ultimi ami di vita dell'architetto, quasi novanteme. Il progetto ha m duplice grado di inte-resse: da m lato rappresenta rm bell'esempio di spazio dell'assenza costruito nelle fome di un recinto templare; dall'altro mostra l'im-piego dell'rchitettua trabeata in pietra. Wright ha speso tutta Id sua vita prof-essionale ad inveire contro la tecnica costruttiva a-llagreca & archihave e coloma e ad inventre sistemi alternativi circa la costrrzione e la foma. uSe dawero la foma si adeguava allafmione ._ aveva comentato in An Autobiography - perch6 non rinunciare completamente ai suggerimenti della coionria, il verticale,e della have, l'oizzontafe? Fre a meno delle travi e delle colonne che si amonticchiaao come m lavoro di "falegnameria". E dellemodanatue,e. In un momento successivo della vita di Wright, tuttavia. la pii appropriata foma per ma cappeila funeraia appffie,alla mente deli'rchitetto, quella templtre basata su m sistema costuttivo lrave/pilastro: uno spazio che seguiva Ia hadizione dei pro-getti non realizzati di Gilly e Cret e, piri specificamente, traeva vmtaggio da m possibiie precedente noto a V'right, owero il cremato-rio di Gmm Asplmd (1935-19,10) ubicato nel Woodland Cemetery di Stoccolma,o.
Dopo aver sperimentato una sequenza di tre cappelle con profondi pofiicati sostenuti da un'architettua primitiva trabeata-Asplmd introdusse la soluzione della grmde loggia singola. aperta in posizione centrale verso il cielo, analogamente ad m anticoimpludum romano. Visto alla sommiti. del pendio, con un muro basso a sinistra e una grande croce sufla destra, questo spazio templa-re ha un potente effetto che scatuisce in parte dalla primitiva sempliciti delle fbrme- in parte dalla capaciti di dar luogo ad ma scenapaesaggistica di cilattere cosmico. Lo schema iniziale & Wright segue l'esempio del progetto di Asplmd, combinando mo spazio tem-plare quadrato - definito in modo analogo da file di pilastri lungo il perimetro - con un monumento verticale; quest'ultimo assme ilruolo di cenota-fio con nomi incisi e presenta una lmterrra di brouo svettante. In questo pdmo schema del Gmpio Unitariano, V/rightdispose questi due elementi in modo assiale". Il Tempio Unitariano doveva essere ubicato vicino al terreno di sepoltura e alla cappelladella fmiglia Lloyd-Jones. L'ln luogo ricco & significato per SLright che aveva il culto della iremoria dei suoi antenati dei Galies e che
amaya la valle in cui era cresciuto. Ad essa fece ritorno nel 1911 per cremi il proprio quartier generale: Taliesin, termine gaelico che
significa "ciglio radioso,". Il nuovo edificio progettato da Wright doveva chiamarsi Tempio Unitariano, con m ri{erimento er-idente
allo *Unitarianismo dei Lloyd-Jones... [che] era m tentativo di diffondere, lel]a corrfusione delie sette del ioro tempo, il concetto delia
vita quale dono della Divina Fonte, di un Dio omipotente in cui si identificano tutte le cose,'3. Tra la vecchia cappella e il progettato
Tempio Llnitariano sorse il boschetto di a.beti che lo zio & Wright, Thomas. aveva pimtato, come si legge nella autobiografia: uaccan-
to alla cappella, in modo che le futue merende all'aperto della domenica potessero svolgersi all'ombra,. oA levante, di fimco alla cap-
pella con-le preti fasciate di tavole, continua \['right ucol pittoresco campmile di fronte a]l'abetaia. era il camposanto in cni u sem-
137
,%
ETIE\-l\x-LoLls Botil,tft, Progetto di cimitero, seconda varimte, corpo d'ingresso, Pris, 1785 circa.
plice obelisco di marmo bianco onotava la memona dt "EinTad" e dt "EinMam", gli equivalenti gallesi di padre e madre fowero, i nomidel Galles, pionieri e imigrati, che hmo fondato il clm Llovd-Jones nel1a valle]. Raggmppate attomo all'alto e snello obelisco cen-trale, si trovano le tombe dei familiari. Ogni domenica, nella primavera e nell'estate di quegli mi giovmili, fino al cinque settembre,iraguzo indossava g1i a-biti della festa e mdava a mettersi su una sedia in queste riunioni nella cappella..- Questa cappella & fami-glia era il semplice tempio in legno in cui il clan della valie adorava imagini da esso stesso armoniosamente create,l{. 11 TempioUnitriano di \Iright era destinato alla sua seconda fmiglia - la comuniti di Taliesin - i cui membri awebbero dovuto essere sepoltiir ura fila di tombe nelle imediate adiacerze della cappella funerria. Neilo sviluppo del pmgetto, Wright lavord su tre temi: la formadella cappella fmerria; la natua del sepolcro; la relazione con la cappella di famiglia e il suo teneno cimiteriale. Il progetto, datato1 settemlre 195?, presenta il cenotafio a guisa d'obelisco slittato sulla sinistra del Gmpio Unitarimo: tregli schemi successiyi, questafoma verticale sparisce completamente. Quanto alla planimetria, il disegno datato luglio 1958 mostra come W.right avesse ruotato dinoranta gra& la fila dei sepolcd della comuniti di Taliesin in mmiera che essa e l'adiacente passeggiata fossero allineate con l'obeli-sco dei nomi a-1l'a-1rro lato dell'abetaia. Una seconda passeggiata prallela doveva condure dalla vecchia cappella di famiglia all"in-gresso del Tempio Llnitrimo. Il cambimento pii rilevante nella pianta del progetto datato luglio 1958 consiste nell'introduione dima doppia fila di pilastri di pietra squadrata fommti l'anello intemo che defirrisce 1o spzio templile della cappeila e di pilastri ret-tmgolari verso l'estemo. Su tre angoli dell'edificio sorge ua yegetazione esterna; al di sopra di essa sono poste ''lanterne'" di cristallo- per usare un'espressione dello stesso Wright - pirmidi luminose in vetro con profilo scalettato e vertice rivolto verso il basso. I sedi-ci quadrati in cui d ripartito lo spazio centra-1e della cappeila frmerria sono illminati dall'alto, in mmiera maloga a quanto alveni-va nel Tempio Unitariano coshuito da Wright presso Oak Park all'inizio del XX secolo. I1 pavimento della cappella fmeraria doveyaessere in mmo nero. Una scala awebbe condotto alla cripta posta a1 di sotto del santuario dov'era pret"isto i} luogo di sepoltua per'Wright
e la moglie".La cappella fmeraria di Wright del 1uglio 1958 risultava come una combinazione fra ii tempio greco e Stonehenge, {i}trata atta-
verso la personaliti. creativa di questo inimitablle achitetto organico. Le forme trabeate in pietra sorgevano al di sopra di ma piat-tafoma a gradini eyocarlti lo stilobate del tempio greco. Lo spazio centrale, definito da un duplice mel1o di pilastri in pieila dispostisu m perimeto qua&ato e privo di qualsiasi omamentazione o ulteriore articolazione, richima l'immagine di Stonehenge. Gli ango-li aperti verso I'estemo, la copertura a sbalzo. il soffitto con lucemario. ermo elementi caratteristici dell"mchitettura di Wright. Cid nondi meno, l'uchitetto non era soddisfatto di questo schema. Ad rmo dei iati della yista prospettica. egli schizzd m nuoyo dettaglio alfine di articolare la girmtura fta il pilastro e la trave. Nella serie successiva di disegni, Wright conferi ai pilastri l'aspetto d'un capitel-lo classico rir-isitato in chiave modema. Si tratta di una foma "pizzicata", piri sottile del pilastro e rivestita in legno con ma decora-zione dal motivo geometrico. La lineriti del primo schema, con travi in pietra supportate da pilastri anch'essi litici, si'd ilasforanatain rma fascia ligaea ad elementi sowapposti che foma rma sorta di trabeazionel6. La sempliciti dei dettagli di Stonehenge a stata dm-piazzata da una sofisticata e astratta riedizione degli ordini greci. Tirtti questi dettagli appaiono irilevanti rispetto alla potenza delsilenzioso spzio ruoto contenuto nella selva di colonne, col pavimento in marmo nero e l'illminazione proveniente dall'a-lto.
La discesa nella terraV'i ma qualiti rassicura,nte nei recinti in forma di tempio dedicati allo spazio dell'assenza non presente nei progetti fmermi che
portano il visitatore alf intemo del teneno. In precederza" si d fatto nolare che i1 grmde insegnante Jacques-Frmqois Blondel. versola meta del XVIII secolo, invitava i propri a-llievi ad albassre il livello del cimitero di qualche passo rispetto aI pimo di campagna alfine di comunicare rm monito riferito al "teribile, ma ineludibile luogo che dobbimo abitare dopo la morte,18. Abbimo mche vistoche questo consiglio E stato applicato da Louis-Jean Desprez rel suo progetto vincitore de1 1766 per un cimitero parocchiale, da PieneFontaine risultato secondo a\ Crand Prh del 1785" da Boull6e che non solo si awalse di tale principio nei progetti di cimiteri, ma nrisea fuoco questo tema nei suoi disegni dove la tena sprofonda improwismente e a precipizio alf ingresso del cimitero o all'intemo delrecinto. Non d solo 1a differenza di livello" ma mche il sentimento kinestetico del caminae alf interno della tena che sollecita m'in-quietante emozione. Se si guarda la sezione di rmo dei progetti di cimiteri proposti da Bou1l6e, oppure l'inealizzato progetto di concor-so di Alvu Aalto del1952 per il cimitero di Lwgby in Dmimarca, ritrovimo rm intero mondo rimosso dallo spazio della quotidianiti
138
A sinlstro: Jacqms Roussuu_, capoella sepolcrale, sezione. Terzo premio, Crand PrLr,77SS.A destro.: HF.NEI LABRousrE . Tomba di Napoleone Bonaparte (progetto)- proposta di concorso, 1841.
dove la discesa nella tena, aprendosi verso il cielo, awebbe collocato u osseroatore in m perfetto spazio dell'assema. Tanto qumtoin ul qualsiasi spazio templare costruito al di sopra del livello del suolo, l'ahnosfera attomo-al visitatire srebbe apprsa come pema-sa dalla premonizione della morte e del caro estinto. Owiamente, nello schema di Aalto. le fasce verdi e i corsi dlcqua preposti adaccompagnare il visitatore nel percorso fi discesa awebbero mitigato lo stato d'animo.
Una delle prim: ragioni dell'efficacia del Vietnm Veterans Memorial (Washington, D.C., 1982) di Maya Lin i la dolce discesa nelcmeo spaziale a foma di \'. A questo potente effetto di kinestesia, Lin aggirmse mche il piri comovents senso tattile at6averso cui,con m singolo dito della malo, si pub percepire la vita asse[te contenuta in m oo*" - *o delle decine di migliaia di nomi iscritti sulmuo di lucido mrmo nero. Quasi l'opposto di cid che awiene ne La creazione d.i Adamo di Michelangelo,
"rlipinta sul soffitto della
Cappella Sistina, poich6 non.si tratta d'm tocco che di Ia vita, ma del suo contrario, m'evocazione di vit-a perduta, stroncata nella sua$ovitezza, ut'esistema percepita atfaverso la pmta del dito, ma impossibile da raggitmgere, data ia pietra posta a bmiera.Lesperieua d anche pii misteriosa qumdo il riflesso del cielo azzuro attraversato da nuvole fu.."gg"r" d stampatosul muro.
La tomba come squarciaMuoversi per procedere verso il basso all'intemo del tereno d analogo al guardae in basso all'intemo di ma cayiti che evoca il
regrro della morte e del caro estinto. Si tratta dell'equivalente sottenmeo del tempio frmerario sul tipo di Stonehenge al di sopra delsuolo. Non mi riferisco alla cripta totalmente sottenmea" quanto piuttosto ad m'apertrra nel pavimento che rivela uriambiente imme-diatamente sottostante. Nel concorso del Grand PrLr del 1755 per ma cappella sipolcrale, il primo e il terzo premio furono assegnatia progetti che aprivano il pavimento in prossimiti della cripta posta al di sotto, coronaldola con m anello di colonne in foma &iem-pio. I-lintero quadro era posto sotto ma cupola emisferica. Per chiurque fosse interessato allo spazio dell'asseua, comunque, era lamppella sepoloale di Jacques Rousseau a meritare il primo e non il terzo.premio. Charles Mar6chau, il progettista vincito;e, fece siche il sepolcro si alzasse nella cmiti centrale sino agli occhi dell'osservatore'e. Differentemente, Rousseau *rrt"*" il sepolcro al disotto del livello del pimo principale. Circa rm secolo pii tadi, nel 1841, Ludovico Visconti utilizzd la stessa idea di operare u'aper-tura nel suolo verso Ia uipta sottostante occupata da un sepolcro esposto, al fine di vincere il concorso indetto per la tomba diNapoleone prevista sotto Ia cupola di Les Inoalides2\. Tirttavia E da chiedersi se la considerevole ampiezza dell'apeftur; nel pavimento,cosi come la mole del sepolcro, non diminuissero l'effetto generale: questo awebbe potuto essere pii potente a&ma scala pii intima emodesta.
La proposta & Hemi Labrouste nello stesso concorso presenta ura variante del tema del regtro della morte evocato.da ma cavitinel suolo. Egli dispiegd m gigantesco scudo_ & metallo sospeso aI di sopra dell'apertura all'intemo della quale il sepoicro d'ebmo diNapoleone doveva essere intravisto - come dissc C6sm Daly - in uparziale oscuriti.,. nl-a rimarchevole idea sottesa alla composizione- affemd - E assohrtmente nuova: non v'6 nulla di essa nell'mtichiti, n6 in nessm'altra epoca,21. Forse Daly si espresse corettamen-te rispetto all'originaliti della tomla, ma dimenticd il pragone con il Cmpidoglio, non solo rispetto alla gigmtesca supe#icie cwadello scudo, ma anche all'anello di tre gradini che mette in risalto lo spzio dello scudo rispetto aI pavimento circostmte. Chi abbiamai indugiato per qualche attimo sul Colle Capitolino a meditare sulla genialiti della composizione di Michelangelo - come si suppo-ne possa aver fatto Labrouste nei suoi cinque ami di permmenza all'Accademia francese & Roma - rimm" .o.f."ro dal modo iniuii due cerchi della siala che scendono verso l'ovale isolano la superficie centrale convessa in modo tale da allontanae l,osseroarore,facendo apparire come una trasgressione l'attraversamento della soglia e il calpestio del suolo sacro da essi delimitato. Una volta per,cepito tale sentimento, si 6 pronti ad esperire il potere del piano ova-le sollevato che appme come l'omphalos mundi. Si d faccia a ?ac-cia con m mondo totale de.ll'achitettma e peftanto l'ovale, dolcemente curvato, sembra sollevare da sotto la superficie circostante.Tirtto il potere del centro di quella speciale collina, come una forza della natura, i presente & fronte agli occhi dell'osseroatore.
Labrouste aveva serza drrbbio compreso il progetto del Colle Capitolino e ne aveva trasferito la lezione in quello per la tomba diNapoleone. Qui la supe#icie crma del grmde scudo sospeso delinea sia il coperchio sollevato della tomba, sia la superficie della terra.Come a1 Campidoglio non si E portati a superare la linea creata dal riplice aneilo di gradini che scendono verso 10 spazio cenrale delfocus.Ho gii ricordato" come Louis Kahn fosse solito dire che il Pmtheon
".r rn e&fi"io perfetto, eccetto che per la preseua dellaporta. Cid che intendeva dire era che, nel momento in cui si supera la soglia, si occupa mo spzio interno come se si fosse al centro
139
',%
A sinistra: GrusEppr TERzucN. Monumento a Roberto Sarfaui, Col d'Echele, 1935.A destra: FRd\z METZ\IR, Entuur;f fir einen monumentalen Brunnen (sclizzo per ma fontma mommentale). Da Der Architekt, 7904.
dell'oculus-. gunto da1 quale si riempie ii volme circostmte con il senso spaziale di se stessi. La senszione d'erore, nel progetto, con-sisteva nella necessiti di attraversare la distanza tra Ia pofta e il centro, quando Ia mente pensa gid a.l centro. La proposta di Labrousteper_la t9mb1 di Napoleone agisce in modo simile- Si occupa lo spazio dal centro dello scudo ,erio il bordo estemo delineato dal triplomello di scalini. NIa, a differeua del Pmtheon, non si pud fisicmente occupre il centro, n6 si dowebbe tentare di yiolare la zona cen-trale provmdo ad entrare in essa. In tal caso lo spazio dell'assenza richiede che l'osservatore si unisca ad esso solo attrayerso l'occhioe la mente. Questa d la ragione per la quale dowebbe risultme cosi efficacer3.
Il progetto di La-brouste mostra quanto semplice pud essere creare mo spazio dell'assenza, dal momento che la mera suggestionegenerata dal coperchio di un sepolcro sollevato dal suolo cambia l'aspetto qualitativo dello spazio sotto si esso e lo rimuove dJmondodei vivi. Senza dubbio l'eminente architetto razionalista italiano Giuseppe Teragni era conrio di cid qumdo provd vui schemi per ilmonumento del 1935 deelicato a Roberto Sarfatti. eadrrto nella prima guerra mondiale. In ma vuimte - composizione asimmetrica dipimi verticali e orizzortali- una breye scala porta il visitatore a urr livello pii alto dove due superfici orizzontali sollevate catturanolo spzio sottostante che evoca il reg:ro delia morte. In un altro schema, datato 1934. combina una sca-la posta cenffalmente il ascesaad un pimo verticale su cui sono apposte iscrizioni; segue una duplice discesa sotto m'enome, pesmte copertura a sbalzo che incom-be sul visitatore, con una forza che eccede di gran luga 1a sua massa e che racchiutle sotto di eisa u potente luogo di commione colsoldato morto2'. Il progetto realizzato di Tenagni, comunque, assme m'altra tipologia, nella qua-le si percepisce ;he 10 spidto d statocattuato a-lf interno di ma massa impenetrabile.
La massa impenetrabileNel progetto rea)rzzato del monumento di Roberto Sarfatti, Tenagni ritrovd m potente senso di contegno nella messa in opera cru-
cifome di grandi blocchi di pietra con ma grezza finitma bucciardata. Il centro della composizione E enfatizzato da una rampa cli scaleche porta ad un blocco cubico di coronamento. sulla cui superficie verticale d apposta un'iicrizione. Come se lo spirito del defmto fosseconcentrato nella pietra impenetrabile e, piii specificmente, nel blocco centra.le. Qui incontriamo il paradossale conrilio dello spaziodella morte in foma di tempio: guesto, con il suo mello analogo a quello di Stonehenge, racchiude e consacra il volmre dell'ria checinge.
Col monmento di Terragrri non abbimo alcuno spazio interno, ma solo densa pietra e tena in cui i morri vengono sepolti, subli-mati in rm'inmagine di nobile immutabiliti: il cubo di pietra. Tuttar-ia siamo in preseua di un tempio anche in qriesto ca-so, un tem-pio *finito_dalle braccia dei mui in pietra e trattato con revereua attrayerso la scala che meclia l'approccio.
E singolue che, alf inizio del secolo, lo scultore Frtm Metzner concepisse m prcgetto analogo pubblicato in Der Architektnr 11el1904, l'avalguudistico giomale d'uchitettua della Secessione \riennese. Questo progetto appanle in m articolo scritto da Josef Luxintitolato "Shtine Brumen" (Belle fontane). Sebbene la didascalia rechi la scritta 'Entmr{ fiir einer monmentalen Brunnen,, (Sclizzoper una fontma monumentale) questo progetto era accompagnato da altri analoghi progetti di fontane per mano di Metzner, chiara-mente concepiti in termini di architettre fmerarie. Esempi quali "Bmendenlmal fiir Herrn r L." e '"Entmrf fiir eine Gruft,, sug-geriscono come anche l'idea stessa di "fontana monumentale" debba essere intesa a guisa tli monumento funeruio2s. Decadi prima iiTenagni,_Metzner aveva scoperto il potere dei mmi massicci nel creare lo spazio dell'assenza, cingentlo puzialmente ma zona in pros-simiti della tomba. Egli riconobbe mche la {orza delle poderose masse di pietra dai conci regolari, col centro scavato da una scala. Sianel memoriale di Terragni a Sufatti, sia lella fontana monumenlale di )Ietzner, v"b m forteienso di chiusura ottenuto attrayerso i pir)economici mezzi compositivi. AIlo stesso tempo, le fome concenhate di semplici blocchi prismatici litici delinemo un luogo di sugge-stione tmto quanto quello di qualsiasi spzio in foma di tempio.
Entrambi i monumenti, considerati nel loro pii ampio quadro paesaggistico dalle dimensioni cosmiche. danrro l'impressione d'mapresenza senza tempo fermmente mcorata all'miverso sconfinato. Tutti questi aspetti possono essere ritrovati in m pmgetto non rea-lizzato di Frark Llovd Wright del 1928 per m blue sky sarcophagus o burinl tereice. distinato ad mo dei suoi cliend faioriti: DminD. )Iartin. La predominanza della scala suggerisce l'appartenenza ad un'a1tra tipologia che potrebbe essere definita come scala per ilparadiso.
1,10
Asinistra:FRA\LT,Lo\Dwfilcril blueskl'sarcophagusobuialterrace,perDawiaD.Martin(progetto),792g.A deslra: Cn:rppt TI.RF\c\t. l4emoiale tleila p"rima gr"rra n,ondiol'". L.Lm tr"ino (Como).'tq2'a-td:i -
Lo scalo per il porodisoNel progetto di Fralk Lioyd Vright per "blue skv sarcophagus", ma scala cenhale in marmo sorge tua due ali orgmizzate a guisa
ditenazze a gradoni; ognma dei-esse |coperta da una graade Iastra di marmo con iscrizione. a chiuiua della cameia sepolcrale sot-tostante' Sull'asse e al temine della scala vi d m blocco rettlngolarg Egante che wright denomhd "head stone or cenotafh,,.
In ua varimte a questo schema, compaiono ad entrambi ilau deii.mde blocco"rli pietra muri bassi con cespugli e aiberir6. Nellaversione qui illusffata. al posto di tali mui V'right dispose lastre di pieia orizzonrale ad entrambi il iati della g.i.d'" pi"t u. Le lastrespor8oao olfte i loro supporti 1]"it:.1 1l modo tale da apparire librate nell'aria. Vtight spiegd il progetto a Mr Martin corre segue:oQuesto sepolcro si apre verso il cielo / Una &gnitosa grande pietra comune a tutti. / \r'd * l"t ,i-lotir*o nel terrazzametrto a gra-doni, pre - / Questo schema costituisce lm compromdsso fra la tomba e il mausoleo. / Pud tra.re il meglio da entrambi. / Realuzatocon buoni materiali' con le iserizioni ben incise /O apposte in bronzo - I'insieme non pohebbe fllanctre di un nobile effetto,2?.Il non realizzato "burial te-race" i m ibrido fra il tipo della "scala entro la massa iel monumento", gii tipizzata dal memoriale 4iTerragni per Robeno Sarfattl e il tipo detla "scala verso iI monumento". che pud essere rinvenuto i. i,, uit.o progetto dello stessoTeragni datato 1928-1932: il-monamento-ai caduti delia prima guerra montiiaie ubicato nella piccola citti rli Erba'Incino, non lon-tmo da Como. citti natale dell'achitetto. Senza dubbio qui le diflereme sono sottili, dal mornento che la scala. in tutti e tre i casi. dprre irregrmre deila compo.izione.
, -A Erba Incino, lo spazio in forma di tempio alla somitA dell'irta e lunga salita consisre di due parti: m muro concepito comeschermo concavo cotr apertue quadrate e trcuate che abbraccia.il sac.ario pii basso. il quale - i, *a logi", -*fo.i i* ai contrap-pmto - si proietta all'esterno con uila cuva convessa. Ii sacrmio i creato ia achi opposti di cerchio
"lr'" "."*J*o sfazio inte.nopoco profondo' con soffitto basso e copertua pima; all'interno si trova un crocifisso
"h" .i e.g" dal {rmmento d,un proiettile di cal-
none collocato entro una nicchia centra-le. Ad entrmbi i lati sono collocate due colome incas-sate senza base e capite[o. In entrambigli spazi-templui la piena a grezza e tessuta in corsi iregolari. La croce, con Ia sua corona di filo spinato. lru o, g.iao al rioitua atra-iogo, ia legno appena sbozzato. Siccome il muo a schermo concavo cattua solo frmenti di cielo, it sacrario iitemo ha un caratte-re oppressivo rinforzato da-l basso soffitto- dallo spzio ridotto attomo alla croce collocata in una nicchia assai ristoetta e dall,articola-zione del-mr'rc nel cui spessore le colome senrbrmo intrappolate. Non deve sorprendere che Teragni concepisse qo"r,o ,p-io ,l"ll,ur-sema - dove l'osservatore gumda ma non entra - come m brmkerzt. Ogni asp&o dell'achitettura contribuisce all,effetto desiderato.
". Teragni imagind mche la lunga e ripida scalinata come "ua sclh sairta"rr. [ ,,sacri{icio,,
de]l,ascesa doveva essere una fomadbmaggio a coloro che aver-mo sacrificato le loro stesse vite. L'iscrizione sulla nabeazione del sacrmio in forma di bunker dedica illuogo ai morti, ai vivi, alle futue generazioni: uper quelli che{uono- per quelli che sono- per quelli che saramo,. LaEtessa scala con-sta di tre parfi: una figua semicircolare com'essa di gradini che si allarga i,erso il basso ed d contenuta sui lati da un iuo; rma lmgarmpa centrale con pianerottoli intermedi che approda allaterrazza del sacrario; ma rampa che si incm-a attomo alle Jue parti delsacrario e raggimge la terrzza superiore occupata dal muo pensato come quinta aperta.
Il monumento ai caduti di Jerragnl
a Erba Incino segue direttmente le precedenti impostazioni tratte dall'importarte concorsonaziona-le per un memoriale ai fanti italiani dopola prima guerra mondiale r"i qrrl" *u lrrg, rampa &."aliri c]r" si inerpica sullacollina ierso il sacrario era considerata m tema favorito3o. In tutti guesti schemi v'd un'integLione dell,achitettma col paesaggio icui prototipi sono rapprcsentati-dai monumenti in onore degli esploratori periti nel r-iaggio & La P6rouse, si tratta di progetti che iisal-gono alprit d'4mulation del 1788. voluto dall'Acad6mie Royale d'Architectme"
" q"iiii ul 1830. gumdo pate deiieliii del naufra-
gio fuono ritrovati. Nel progetto vincitore di \/ien e Dumanlet, cosi come nel successivo progetto di L"b.*at", Io spazio dell,assenzad ffeato sia atoaverso l'anliteatro di rocce o di gradini- sia attraverso l'iltemo del cenotafio cie, nell,ultimo progett;, contiene i pochireiitti della navel come reliquie del saoficio degli esploratori.In tutti questi casi l'uchitettua d modellata fuoriter.a in vui gradi dicofrpittezza. che vanno dall'anfiteano di rocce vive al concio levigato che serlra emergere dai quadro naturale.
La materia didene spiritoLuso del veto per suggerire la transustanziazione della materia nello spirito offre un altro tipo di approccio al tema dello spuio
,:
141
rs
Hc*at LlsnousTE, CenotaJio a La p6rouse (progetto), 1g30
deli'assema. In precedenzarl i stato analizzato m progetto per rm 'chmp de repos" che risale all'ultimo decennio del XVlil secolo adopera di Pie,ne Giraud; qui il porticato coperto che definiva il perimetro del crmatorio doveva essere costruito con chime colome clivetro modellate dai relitti mortali trasfomati nelle fornaci nascostelella piramide centrale. Lo schema di Giraud si ispirava aI tratta-to del chimico tedesco Johm Joachim Becker dil ntolo Physica srbterraiea (1,699, 173q,1268) che dirolgd l,idea di salvae i morridall'orrore della pufefzione trasformandoli in bei cristalli, imperitui e lminosi. Anche ur personaggiJdeila grandezza di Jean-Jacques-Roussean,era analogmente affascinato dai proposito diBeckef'?. Fra* Lloyd ff.ight p.og"ttJ-*u
""ppi1" f*".aria nella
quale il tema del cristallo sfaccettato come immagine deila materia transustmlata dimir.rl. Si tratta della ron realizzataRhododendron Chapel, con il suo tetto in rme e vefio. Questo progetto, che risale al 1953, doveva commemorare la moglie di EdgmKaufmm, Lilime, morta po:g p11r. I1 luogo era,la proprietd-deiKaufmana, nei pressi di Fallingwatef3
Il proge&o di \Vright per Rhododendron Chapel i successivo- a quello per Chapei of the Soil del"1 932, la quale impiegava arch,es-sa una massa prismatica per suggerire la trmsustanziuione dalla materia nello spirito. I-lrchitetto concepiva I'edificio lo*" n-oro-mento all'agricoltore che rende la te,m ad immagine del monmento e viceyersa,3i. Bruce Brooks pfeif{er direttore degl[ archivi pres-so_la Frank Lloyd Wright Nlemorial Foudation - il cui lungo legame con Wright risale al 1q49. suo primo
"*" a:Ipp*"ai".,..Tali-min - ci ricorda I'importanza di guesto tema per l'architetto,
"*I p.og"*, .li"qo"rtu cappella, p"o..i, p", il \fiiscon'sir meridiona-
le" fir dasmirrla da Wright "Memorial to the Soil". La particolare a."Ju cri ".a
de.tiratu consisteva in quella parte clello stato nelquale Wright era nato, cresciuto ed in cui aYeYa eretto la sua dimora: Taliesin. Ln paesaggio pastorale, ricco di prodotti della terra enoto per i suoi grandi 635gifi.i. 1...) La $oinezza del signor 'Wright
trascome o"ilu futto.li"dl Juo zio Jmes. [. . .]La madre a"f Srg*.\I'rigJrt, Arma Lloyd Wright.. . . credeva femmente che il rigore, iI dmo lavoro, l'educazione e le richieste che la yita in una fattori"a gliawebbero imposto dovessero ::raiq* una.necessaia contropaftita alle tendenze creative e artistiche presto cosi evidenti nella vita delfiglio'r5. Come ogni lettore dell'autobiografia di Wright ricorderi vivamente, e come la stessa ripetuta hase naccmulre stmchezza sustanchezza" testimonia, egli conosceva perfettmente il duro lavoro e la deteminazione che occoreva agli .agricoltori,36. Questo pro-getto, sotto molti aspetti, pud essere considerato come un montmento alla^madre di \I'right, allo zio Ji f*iiti*i della fattoria, agliantenati rlel clan L1o-vd-Jones, ai contadini di ogli dove; ma i alche rna riaffemzion" dei bi.ogro di sposare l,architettua alla tena,sia letteralmente che meta{oricmente, come se l'architettura dovesse scaturire direttamente dJla tena, m tema costante di tutta Iacariera di Wright, dalleprairie houses in avanti...
. ula Planimetria - spiega Pf"ilj* - d impostata_su m quadrato di base, scelto come simbolo clell'integrid e della solidarieti, mi-citi e-uniti. Lingresso alla cappella awiene da m lato, attrayerso 1m gruppo scu]toreo astratto in
""*..Ir. All,interno, Ie mua dellacappella sono sporgenze di tema battuta appoggiate a1 tereno, dul moiirenio che l'esseua dei progetto era concepita
"o-" -"-o.iut"al suolo. [...] Parte del muo di contenimento si conclude in m giardino fiorito perimetral" rliir."llo deila {inesda. Orttu pu.," ,ppo-sta il mum si estelde alla quota del pavimento con tm mezzo arco di cerchio all''estemo, a contenimento di m velo d,acE a e dimafontarra Cosi, dalf intemo della cappella, ma vista ad altezza d'uomo dalle due parti mostra fiori e vegetuion" pi"ot -Jti sul tene-no di riporto. Il terzo muro, di cristallo. affaccia verso la sede incassata della fontma. Ogni cosa ,"1 dlsegro, dull. fo*u all,aspettosino alla scala umana enlattzza il teneno, il suolo,3.. Vi sono vari morJi t{i consider*" qi"rto edificio che"d pmzialmente sepolto nelteneno. Lo si pud leggere come ma-duplice pirmide capovolta: l'rma di tena che si inliza verso m punto; lialna caporolta, con unascalettatura_in vetro - Spazio cristallino d'rma materia transustanziata che sorge verso l'estemo. Le due fome p;r-riaUi ritrovalo illoro pmto d'incontro al liveilo dei fedeli. Corpo e alima, yita e morte, vita e vii dopo la morte, mateia gtezza ecreazione {inita, terracoltivata e {Tutto dei raecolto - tuttj questi concetti contrapposti sowergoro ul guardure i'imagine di qu-esta duplice piramide. Allora,nuovmente) d possibiie considerme l'edificio come m enome sepolcro la cui pletra tombale di-copertuia si solleva ai ili sopra del ter-reno. librmdosi sullo spazio interiore come 1o scudo sospeso proposto da Labrouste per la tornla di Napoleone. Wright acceniua il pianodel tetto estendendo la lastra di cemento con uno sbalzo drammaticament. ,o.p"ro. Certamente cid che si prova
"r:t o l,
"appella n"llu
meti sepolta al di sotto della copertura sospesa d la sensazione di essere in m-a carema sotterranea o in una tomba- Come nella cap-pella fimermia pirmidale che Boull6e imagini un secolo e mezzo p1lma, il cmattere parzialmente sepolto delle fome e la colloca-zione sotteranea della cappella sono concepite per fm percepire un sentimento di prossimiti con il piri esteso mondo deila natura. Ci6
'fi '" ':
A sinislro: Fnerx Llo'm Wrucrrr. blue sky sarcophagus o buial terrace. per Daruir D. Marrin (progeno). 1928.A destot cn srppe Trnnrc'lt. .Memoiiale deila prina guerra mondiall. Erba lncino (c.-.)l'l-9ig-ldii -
acquisisce ma notevole forza nel disegno dei massicci pilastri i cui motivi omamentali ricordmo lo smottmento di fonnzioni roccio-se awenuto in lmghi periodi di tempo, suggeretrdo al contempo la presenza cristallina della Natra incamata.
Il teuo sospesoLa chapel of the soil di w'right utilizza mche m'alila tipologia che pu6 essere definita come tetto sospeso. Il potenre effetto di spi-rituariti e i] senso d'una dimensione rimossa da una spzialiti *i.*".L ordi.aria che tale tlpologia pud ingenerre i nota grzie aliacappella & pellegrinaggio di Noffe-Dme-du-Haut (1950-195.5].a Rolchmp a l-" co.t r.io. q"r"riu
".pii"-a va rifo.tata ad mmtecedente italimo: il sacrrio dedicato ai cosiddetti martiri deila rivoluioni fascista. Si aatta del progetto dell,architetto razionali-sta Giuseppe Samoni. svolto in occasione del concorso del 1934 per Palazzo Lifto;o;it qurtti", g"rr.rul" del partito fascista, contenen-te il museo della rivoluzione- Il luogo E interamente concepito come m tempio nel tmpio La facciata curva a-ll,esterno e la massa del-l'e&ficio si ritirano dal centro per lasciare libero mo spazio attomo a-l su"r-ario se-icircolre sepolto sotto iI te*eno,e.Il usacrario dei mmtiri e la cappella votiva'. secondo la definizione ai s*. "ni,
a-""""r.o presetrtaf,si come volume austero iI cuisenso mistico doveva essere messo in evideroa dalla sottile striscia dj luce che divideva g1i alti muI'i dal soffitto pi""., qr*rrLi-", i"tal modo,appmiva:ome:ospeso. Si-tratta, natualmente, di ula rie&zione modema E"t1u".o anello di luce che sta alla base dellacupola di Hagia Sophia a Istarbul. All'interno del recinto semicircolmedel progetto di Samonn, u anello d,acciaio ricoperto di plati-l.l" llpJliil *:::H"^:::^t"*"" cilindriche dal mamo piri.bianco, definisce"m pi,i interno sp,io sacrale entro cui so!g" * *oro-hte ch grmito nero dalla sezim guadrata, su ognuna delle cuiJacce d apposta ma gralde croce di platino. I-lanello doveva apparirecome costituito da luce sacra la cui luminositi srebbe stata rafforzata d"i -rt *to""ot grmito rosso del pavimento, col granito nerodella parte pit) bassa del muro perimeaale e cotlaterezza d,ello stesso monolite. QuestI sa".*io
"o-binu fo*a, sp-li materiale.luce, ombra e i sigrrficati associati al cglore P:r-,raggrungere l'effetto desiderato. E .*'rr.t"r. vriazione del sacrario effettiyamente
realizzato in base al progetto dei razionalisti Adalberto Libera e Antonio Valente nel 1932 fer h Mostra della Rivoluzione Fascista checelebrava iI decimo amiversario della mmcia su Roma.
L' arc hitethra delle o mb reIl sarario di Libera e Va]ente, destinato a coloro che vennero poi chiamati "martiri" fascisti, di cui sd gii detto brevemente,,, eram ambiente circolare nel quale la magia della lminositi e l'ombra costituivano i fondamentali eiementi coripositivi. In ma dominan-
te oscuriti" m muo & luce elevato su lucenti pilastri di metallo appariva-attrayerso la ripetuta iterazione viuale della pmola rnEsax-rr! illuminata tia tergo? come se si trattasse dell'iradizione delle'anlme dei cosiddetti ml:iri nell,atto di risponder" rlll,appello. Dooola prima guera mondiale, l'esercito italiano istitui il ritrale di chiamare a voce alta it ro*" a ogni soldato'mort", qqd;;;-;;fi;;isposto spresente', come se il defunto fosso ancora fra i vivi. Nel sacrario, sotto l'anello lminosJsospeso, Libera e ialente collocaro-no i pennoni dei primi Fasci di Combattimento,_dove ogni ba-ndiera recava il nome di m fascista
".doto. Al
""rrt o del grande ambien-te' ma gigante croce metallica sorgeva dalla bme circolare bagnata in cid che, all'epoca, fu descritto come luce ;rosso .aogo",.
All'incrocio dei bracci della croce, m'altua sequeua di caratteri l.-uminosi proclmava cte i iascisti morti onorati io qr"Llorgo ur"ru-no ottetruto l'immortaliti dmdo la vitl Per la loro patria. La regisuziore dell'inno fascista, Cinoinema, si diffonieva fievolmenteathaverso il silenzio di questo spzio*l. Questo sacrario fascista usava la luce allo stesso modo in cui Boull6e utilizzava l,omlra o, piut-tosto, una luce negativa, nella sua architettura fmeraria. Uno dei piri commoventi racconti delle motivazioni dell,mchitetto che stan-no dietro Ia sua volonti di creme non solo ua'architettua funeraria, ma mche rm piri specifico spazio dell,assenza, lo si ritrova nelmarroscritto & Boull6e, Architecture, essai sur /'art: "tovaldomi in campagna, carmjJavo lungo il llmite di un bosco al chiaro &hma' I'a mia immagine prodotta dalla luce attird la mia attenzione i"pp*" olrr.i t rttava cerro diuna novitA per me). A causa di unostato d'animo particolre, l'effetto di tale strano simulacro mi pame di un'estrema tnstezza. Gli alberi dir"gr-ti srl teo"no da-lle loroombre mi imp^ressionarono profondamente. Questo quadro era
-ingigmtito dalla mia immaginazione. Vidi al'iora cid che di pir) cupo lanatua pub offrire. Che cosa vedevo? La^fma degti oggetti che si itagliava o"., ,, di *""lrce d,u1r pallore estremo. La ,i"tura ,"*-
brava mostrarsi in lutto, ai miei occhi. Colpito dai sentimenti che pro'vavo, mi riproposi. in quel momento, di fame ln,appliczione
rl
rl
i
l
743
rs.:i.: ;:r:1,
I'i-.i. .f:r-.:',::t
..te.*i
{It
Fnqrv( LLoYD Warca, Chapel of the Soil (progetto), 1 937.
particolre in mchitetfirra,".Quella notte, nel1a foresta, Boull6e provd una sconosciuta sensazione di se stesso, del silemioso compagno che ogni mortale porta
dentro di s6 e della nulliti seua fine cle t{iventerd dopo la morte. Gli appme nella foma della sua ombra e quindi in quella delle
ombre dell,intera foresta. Si tratta & ma visione di ci3 che i francesi oggi sono soliti chiamare "I-lAutre", l'A}ro; Ia presenza del s6
morto, una nera sagoma senza sostaua, rm essere dallo spazio pmmentl negativo e ombra. Per rendere questa esperienza in forma
uchirettonica, Bouli6e sviluppd i suoi tre principi dell'uchitettura scheletrica, dell'uchitettura sepolta e dell'architettura delle orrbre,
discmsi in precedemai3. In un particolare disegno egli presenta l'immagine di ufl timpano spettrale, sospeso su m colomato altrettm-
to spettrale. Non solo l'asseua di luce ma anche e piuttosto una luce cupa, dotata di ma propria preserua.^Boull6e.
sotto molti aspetti, pud essere considerato come il padre spirituale di tutti progetti qui discussi perch6 il racconto & cid
che egli defini <rm nuovo genere-d'architettrra, ci conduce al pii inti-o signficato dello spazio dell'assenza')|iei suoi proget{ funera-
ri, si [ud sperimentue h fres"*u del dipartito che allo stesso tempo rimare dall'a]tro lato del ruoto' Noi stessi siamo nell'etemo spa-
a" a"l ""1i.,
pur appartenendo ancora ad u ordine pii mpio. Curiosmente, poich6 possiarno occuptre quello spazio e sentire quel-
la condizione comJmodo altemativo alla condizione che ci B propria, non dispersa, qumto piuttostd confinata entro I'immagine nega-
tiva della nostra forma positiva, tale spazio ci offre una possibiliti di speranza e consolazione, o quanto meno. comprensione.
I The Space of Absence d il capitolo conclusivo del libro di ^RtcH*D
A. ET,rl, \mbolic Space. French Enl@htenment Architecture and lts
Leeorv. Thi Universirv of Chicago Press. Chicago and Londoo' I qa4' n d T'*"Xi
;;J"'ifp*,;"rpr."t" iot:rltu,op"*ittelmageof the.City.Nelpmagrafo TheSpaceof Ctaity(pp 73-24),d espostaladistiuionefra
"cuattere espresiivo", "c;attere metaforico" e "crattere simbolico", n'd T'iLa defiiiziose di "mirous space" i) a{froDtata nel secondo capitolo intitolato Reoolutionary Space e dedicato all'rchitettura sia proposta sia
"o.t oitu p"r i""u*are i valori clelli Rivoluzione Frmcese dal 1789 in poi. { pmSglafg-lYaluinous Reuolutionary Spoce si le-gge:.uQumdo lo spa-
zio rivoluiionario espressivo acquisi la capaciti di evocue ua presenza invisibile, lo"spirito"di m nue o ma diviniti, si trasfomd il un'alna atti-
viti sirlolica che potrebbe esseie nominata spazio nminoso rivoluzionmio,, ivi. p. 37. Nell'introdvione (Preface)l'autore awerte che: oNel secon-
ao "upitoto
tratto il concetto di spuio rivoluzionario secondo le tre modaliti di: ipazio nMativo, spuio espressivo, spazio nminoso', iri, p. I'xI,
n.d.T.--" i Dor- Warrnt, Turur.t MELLDicHoFF, Ceman Architectttre and the Classical ldeql (MIT Press, Cambridge, Mass. 1987), p. 72; trad.it.,
Architethra Neoclassica Tedesca, 1710-1840, Electa per Coaduo, Ifilmo 1990, p' 63''" - ; f]i"r".t"-i" /;, io,naryArchitects: Boull6e, Lecloui, Legaea, efibition catalog, University of St. Thomas, Houston, October 19, 1967 - October
19,1968 (University of St. Thomas, Houston 1968), P: 2:3' ^.
6 Uautore si riferisce al terzo capitolo del 1ibro,'ir'titolato Chqracter and Design Method edi dedicato - sebbene non esclusivmente - alla frgu-
ra dell'uchitetto Paul Philippe Cret, n.d.T.-- -;.q1"" 4"" ill"rtr-iori hel p.og"tto in Architectural Archives of the Usiversity of Peusylvmia (AALP), Paul P Cret, n. 160
s Il rilerimento 6 mcora al terzo capitolo, n.d.T., f'nstx Lloro Wnrcwt, An Autobiography (Londoa, ud New York, Longmms, Green md Co , 1932), p. 146; trad. itr,-frark l-Jord Wri^ght,
U"" i;;;;;r;fir, Jaca Book, Milmo (id. tonsultata, 2003)-cm una presentizionltMuia AntoniettaCrippl:^Y3ry Lrfl^Rmdolin, p. 133.,o Illustrizi6ni in STUART WREDE, The Architecture of Erik CunnaiAsphnd (MJ'I Press- Camlridge, Mass. 1980). figg. 173-18011 Illustrzioni in.Erank Ltoyd Wright Archrues. Taliesin West aos J8ll'001, 5811 002'l? Espressione ratra dalla traduione italima. ril ' p 15l. o dT'13 Fru,\x LLoID Watcw, An Auabiography. cit., p 14; trad. it. cit., p. 15-1* Iri, p. 26; trad. it., cit., pp.25-26.,r Sooi suto . Broce Brooti Pfeiffer che, durante la mia visita agli Archivi ili Franl Llovd Wright a Taliesin'lfest nelfAprile del 1991 ha chia-
.i." qrlrto p"""ir, .ori'.o-. t "ilir"*ento
con l'obelisco dei nonni e-il progetto di seppellire i memlri della commiti di Taliesin in ma lunga serie
lineue di tombe.16 Illustrazioni in -Ero nk Lloyd Wight Are hioes, tos ;511 0014, 5877 072'rTl,autore si riferisce ul qoarto e i sesto capitolo rispettivamente irtitolati: The Neoclqssical Interludee Landscapes of Etmity, n.d.T.18 Si veda R. A. ETLL\, The Architecture of O""th. fhe Tiansfomotion of the Cemetery in Eighteenth-Century Pais, (MII Press, Cambridge
r44
,al:-19k:1-:i,.. .
ii${..ri,1rt+:.:"::,.l.i.:ltri.a :-..., ,: ..
ErIEl.}iE-Lot:Is Botl.l.6r-,- Monumento.funerario caratterizzante il. genere d.ell'architettura d.elle ombre, paris. 1?85 circa.
Yass. 1984) p. a7.lq Illustraziorre in JE.'tN-\AxrE PERorlsE DE MoNTCtos. "l'e Prir cle Rome" conceurs de l\caddmie Royale d'Architectu| au XWII siicle. (Berget
Lewault e Ecole -\ltionale Sup6riore des Beau-Arts, Paris 1984). p. 60.20 Su questo corcorso si rreda tr{ICHAEL^PAI]L DRISKEL. By Conpitition or Ad.ninistratioe Decree? The Contest.for the Tbnft ofNapoleon in 1g11.
'Am Jounal" aS (Spring '1989),pp. a6-52.
'r CtsAx Dlrr gaPositio.n des "prcjets
de.Tombeau lnur Napol^on. "Rette G6n6rale de l'ArchiLeeaue" 2 (1841), p. 614.22 Lautore si riferise alla prefazione del libro, n.d.T.!r Per una &scussione circa I'mua proiezioue spziale dal luogo occu1,ato verso un luogo immaginaro. si veda iI saggio L'Ikpace pitn1tif dello
psicanali*aefilosofuDr.EucEln\Tt\-rto\sr.rin_Ibr^suneCosmologle:Fragmentsphilosophiques (A,ilier-Montaigne,fiirfoOliil56]).p;69-78. Si veda inoltrt R. A'. ErLui, Aesthetics orul the Spotial \"r11 r! !"lt -Jimal of ,testler i'"" ard -\rt Cdricismi 56 (\vinra rOO'Sy. pp.'f iil.
'r Illustrazioni in BRIN0 ZEvr, Qt-rye2pe Terragni (Zauchelli. Bologna 198^0), p. 138; Al,r FRANCEscA NfuRCrAxd- Giiseppe Terrogni, ,p"ro
"o^-plea 1925-1913 (Roua 1987),-p. 137; firouts Lisciuacrrsn, &,r/cle "nd
Sjl,a[,s[[;,u*n-iirrogni ora tn" Architeciire of lrafan Rationalisrt(Princeton Architectual Press, Ne*'York 1991). pp. '127-137.
15 Illustrazioni ir JosEr LLr, Sclzone.Branrzen, "Der Architekt,' 10 (1904). p. 83 e tavola 9.!6 Illustrazione in BRUCE BR0oI(S-PFETFFER. Frank Lloyd l{right Monograph'1924-1936 (Tok,y,''o, 1985). pp. 48-49. Si veda inoltre lranA,Llo1,r/
Wrighr 4rchioes rro..2B0l.0U02 " 2801.00J.'7 Il testo d scritto slli disegni pu$licati che_illustrmo laloa va'iante. indicata nella nota precedente.':3 LLTIGI Zuccoll, Qiindici anni di L,ita e di latoro con I'arnico e maeslro Ciuseppe Tbrragii (,Cerure i\-ani. Como 1981), p. 23.'' Tn ira[aro nel tesro. n.d.T.3rl Si veduo i tre diflerenti.progeti di Lirno_ngelli. Baroni, Errico Gril{ini e P4.olo Mezzanotte. in Concorso pe.r il monumento al F4ntu.
"Alchitettrra e Arti Decomtive'" 1 (luglio-agosto 1921), rispclrivmente alle pp. 197.207..204.3r Il riferimento i ancora al primo capitolo; clr. nota 2, n.d.T., R.A. ETLni, The Architecture of Death.. cit., p. 255-3i BRUCE BRooKs Pr;LIFFLR., Drouings, p. 98.3'Nota mmoscritta siglata "FLW" 1uJ d.is9Si9 37.10--001. Frank Lloirl ll/right Fountlation Archiues. Taliesin West, Scottsdale, Arizona.35 BRUCE BRooKS PIEIFFER, "ll[muial to Lhe Soil,"-Chapel for Southem Wiicorcin. 11937. ir Treasures of Taliesin: Seren.ty-Sit Unbuih Designs
(Cali{brnia State Liniversitv Press, Fresno 1985) item 21.16 PFEIFFI:R. "Mem.orin]..." in Treatures.. cit.. item. 21; \lhlcnr. ln,4rtobiography. pp. 16-45. 61: rrad. it.16-45. 61.'rr Qnesto te.raa d trattato in {bma piri estesa in R.A. ETtt:x. Frank Lloyd lliighi and ie Corbusier: Tlte Roruantic Legac1.. Mmchester flrirersirl
Press- Mmchester 1 994-33 PFEIIJFER, "MemorinL,," in Tieasures. item.27.
. J'q Pe-r altre illusf,a,ioni del progetto di Smorn_e per le f-onti dsl tslq .h. reg1e, si veda 1/ na oao stile Littnrb. I prcgetti per il.palazzo Littorio
e. della Mostra della Rholuzinne Fascista.in da deJl'lmperg (Milmo e Roma, 193,"6), pp. 78-84; Concorso per il pati*i'ttttlrX (fascicolo specialecon 43 progetti e 390 illustruioni/. *Architetlura
, n. l3 (1q34). pp. 10-11.'u ll rilerimenro i ancora al rerzo eapirolo: efr. nota b. n.d.T.'1 Si veda RICHARD A.ErrN. Modernism in ltalian Architectare, 1890-1940 (NIIT Press. Cambddge. Mass. 1991)- pp. 413-+15.'! ETIEN\E-L0IIS lloILLEr. Architecture essai sur I'ari, ed. Jem-\{arie P6rouse .[e Montclos (Herinann. pa.is 196bj. pp. 136-132 (fol. 126):
trad. it..Architettura. Saggio sull'arte- a cma di AJbeno Ferlenga. Pircola BiLliotcca Einaudi. Toriro, 2005. Per u1a difierente tr.aduione italianasi veda l'edizione Marsfio. Padova 1967, a cura di AJdo Rossi. p. 123.
Testo otiginale: <Me trouvet i la cmpagne, j'y c6to.'v-ais m bois ar clair de la lune. Mon effigie produite par 1a lmiire excita mon attention(assurtlmelt, cel'6tait pas une nouveaut6 pour moi). Pa- ue disp-osition d'esprit particulidre. l'efI.ei di ce simuiac.e me parut d'une trislesse extr€-ne- Les arbres dessil6s sur la 1en! Pa leus ombres me firent la plus prolbnde irnpression. Ce. tableau s'agrandissait par moi imagimtion. J'apergusafors-tout ce qu'il y a de pl*: sombre dms la natue. Qu y vovais-je 7 Le masse des objets se d6tachmt eir noir su une lumiEre i'me p6leuiextr6-ure. La ralure semblait s'offrir, en deuil, i mes reguds. Frapp6 des senlieents gue j'6prouvais- je m'occupai. dis ce moment, d'en faire une appli-cation particulidre i l'a'chitecturc>.
ai I] riferimento E ucora al sesto capitolo: cfi nota 17, n.d.T.
La traduione italiana del presente saggio a a cura di Nicola Delledorme ed e pubblicata per gertile concessiotre dt The Llnioersiq.of Chicago Press.
115