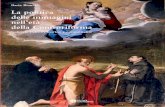Roger Ballen: Immagini dal Sudafrica attraverso l'ambigua lente della Fotografia
Immagini e Testi dello Spazio Geografico nella Mesopotamia del III Millennio
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Immagini e Testi dello Spazio Geografico nella Mesopotamia del III Millennio
Capitolo 1
Introduzione
La storia dell'archeologia altro non è che la storia di un'indagine; negli
ultimi centocinquanta anni gli studiosi hanno cercato di ricostruire la storia
delle civiltà del passato partendo da quel poco che di esse ci resta.
Dopo una prima fase in cui l'archeologia cercò di confutare, attraverso la
ricerca, quei pochi dati che ci erano pervenuti dallo studio dei miti e delle
leggende che di quelle civiltà ancora riecheggiavano nel presente, gli
studiosi tentarono di andare più in profondità. Guardandosi intorno, nel
mondo contemporaneo, era chiaro che la vita umana era fatta di centinaia
di elementi differenti, ognuno particolare ed ognuno importante per il
corretto funzionamento della civiltà. Ben presto si comprese che tale
complessità andava ricostruita anche nell'ambito della teoria se si voleva
che quelle civiltà rivivessero nella loro complessità anche nella mente
degli archeologi e degli storici. Dopo che l'attenzione si era concentrata per
un lungo periodo solo sulle classi dominanti delle varie civiltà e sulle
opulenti opere che esse avevano lasciato, si decise di cercare anche le
poche informazioni che era possibile desumere dalle spesso fragilissime
tracce lasciate dalle classi più umili. Quando si iniziò ad avere un quadro
completo della composizione sociale delle antiche civiltà si aprì allora un
vero e proprio universo per la ricerca e molti altri settori dello scibile
furono esplorati: la religione, l'economia, la politica interna ed esterna e
poi ancora qualsiasi categoria umana esplorabile. Punto di partenza di
questi studi sono sempre stati i reperti ed è incredibile pensare quanto è
stato ricavato da poco, talvolta pochissimo. Lo stesso reperto è stato spesso
sottoposto a più indagini che di volta in volta cercavano di ottenere anche
solo briciole di dati su di un argomento differente: un osso, un frammento
di tavoletta o un coccio di in un vaso sono diventati spesso un tesoro
inestimabile anche grazie alle continue innovazioni della tecnica di ricerca
archeologica e grazie anche alle continue innovazioni nell'ambito
dell'informatica applicata all'archeologia.
In questa sede l'obbiettivo che ci si è prestabilito è quello di continuare il
lavoro nel solco lasciato dagli studi precedenti, di continuare ad esplorare
nuove categorie mentali e sociali per ottenere un quadro ancora più preciso
della civiltà in esame.
In questo caso la cultura che esamineremo è quella mesopotamica del III
millennio a.C. e la categoria mentale che vogliamo esplorare è lo spazio
geografico.
La geografia e lo spazio geografico, intese come un insieme complesso di
idee che definiscono non solo la nostra posizione nel mondo ma anche la
posizione del mondo rispetto a noi, è un compagno insidioso della nostra
società. L'uomo contemporaneo che si rapporta alle antiche
rappresentazioni del cosmo e del mondo spesso è portato a sorridere
beffardamente quando osserva mappe che mostrano la capitale di un
impero immensa rispetto a mari e monti ridotti a semplici accenni sulla
mappa, o quando crede di poter osservare delle marcate imprecisioni in
mappe che sembrano ridurre il mondo ad una semplice combinazione di
elementi geometrici; in realtà l'uomo che fa questo dimentica che anche
nel nostro mondo “l'idea geografica” e la concezione della spazio
geografico influenzano profondamente il nostro modo di rappresentare e
vivere il mondo. Pensiamo in primis alle mappe geografiche per le quali
l'uomo comune non si è mai posto il problema della centralità,
assolutamente arbitraria, dell'Europa; oppure riflettiamo all'influenza
epocale che termini come Occidente e Oriente, di cui l'espressione “mondo
occidentale” è diretta discendente, hanno avuto nella formazione del
pensiero contemporaneo. Ma lo spazio geografico non si limita ad
influenzare il macroscopico, ed anzi è presente, in maniera palese e
nascosta al tempo stesso, nella vita quotidiana: palese per un osservatore
esterno, nascosta per chi come noi condivide quell'idea geografica. Un
esempio piuttosto semplice è dato dalle mappe e le cartine stradali nelle
quali le chiese sono indicate semplicemente con una croce. E' incredibile
pensare a quanti meccanismi logici, per noi oramai completamente
automatizzati, si mettono in modo nel momento in cui, con certezza
dogmatica consideriamo quel semplice poligono sulla mappa come una
chiesa: il nostro cervello considera il simbolo, lo contestualizza, lo associa
all'edificio sia perché lo stesso simbolo è presente sempre ben visibilmente
esposto sul quel tipo particolare di edificio sia perché il simbolo richiama
ad un gruppo di insiemi sociali, culturali e cultuali legati a quel particolare
tipo di edificio. Nessuno di noi è convinto realmente che su ogni chiesa ci
sia incisa una grossa croce, ciò nonostante l'uomo comune che si rapporta
alle mappe e agli strumenti geografici dell'antichità lamenta sempre la
totale assenza di mimesis.
Come però uno studioso del futuro potrà ottenere un bagaglio complesso
di informazioni dal semplice studio di una piantina turistica, allo stesso
modo l'archeologo può, e deve, partire dai reperti e deve quindi
confrontarli con i dati precedenti raccolti da altre branche dello stesso
studio, come i testi e l'architettura, ed infine dovrà decontestualizzare i
dati. Una volta in possesso dei dati essi andranno filtrati e trasformati per
permettere la comunicazione dell'informazione a partire da uno studioso o
un burocrate mesopotamico vissuto cinquemila anni fa, fino ad uno
studioso contemporaneo. Affinché l'informazione possa percorrere questo
lungo viaggio sono ineludibili dalla ricerca tre punti fondamentali: lo
studioso deve ricercare la più completa obbiettività ricordando che, in un
modo o nell'altro, le sue personali categorie mentali lo influenzeranno in
corso d'opera; la quantità dei reperti raccolti deve essere sufficiente al fine
di ottenere un fascio di dati coerenti che escluda il caso eccezionale; i
reperti vanno contestualizzati, tipologicamente, geograficamente e
cronologicamente, poiché le idee nel corso di mille anni mutano
notevolmente e con esse i simboli che vengono trasformati o caricati di
messaggi completamente diversi da quelli originali.
La Storia degli Studi
L'indagine dello spazio geografico nel III millennio a.C., obbiettivo
principale di questo elaborato, può essere compiuta in maniera esaustiva
solo alla luce di uno studio di quei lavori precedenti che hanno creato le
premesse per il presente lavoro e per tale ragione un breve excursus
attraverso la storia degli studi nell’ambito della geografia in Mesopotamia
è d'uopo.
Consideriamo ora non solo gli studi che hanno trattato quei documenti che
hanno permesso la ricostruzione della cosiddetta geografia mesopotamica,
attraverso l’analisi dei toponimi e l’identificazione della posizione di
località antiche note solo da fonti epigrafiche, ma anche, e soprattutto, tutti
quegli studi che si sono rivolti alle opere geografiche prodotte dalle stesse
culture mesopotamiche, nel tentativo di riappropriarsi di quei concetti che
erano sottesi a quei modelli geografici ideali.
La storia degli studi, però, si muoverà attingendo anche da quelle opere
che non nascono in origine come uno studio della geografia mesopotamica
in quanto tale, ma che ad essa apportano nuove ed importanti
considerazioni partendo dall'analisi di uno dei grandi temi che ha
appassionato gli studiosi della Mesopotamia: l’astronomia.
La nostra storia degli studi si apre con il lungo studio relativamente
l'astrologia mesopotamica effettuato da Virolleaud fra il 1907 e il 1912 e
raccolto nella raccolta “L'astrologie chaldéenne”.
Una delle prime opere citate in questa storia degli studi è un testo che
apparentemente non appartiene alla categoria dei lavori che si sono
occupati della geografia nel mondo mesopotamico: si tratta di “Pantheon
Babylonicum. Nomina Deorum e textibus cuneiformibus excerpta” di
Antonius Deimel, edito nel 1914. Quest’opera si caratterizza, come del
resto tutti i primi lavori rivolti al vicino oriente antico, per
un’impostazione spiccatamente teologica e l’impianto del lavoro si iscrive
nel contesto della storia delle religioni. Nonostante ciò è proprio in un
capitolo di tale opera, nel paragrafo denominato De natura deorum, che
osserviamo per la prima volta come l’analisi teologica si confronti con
l’elemento reale, ed in questo caso, con l’elemento naturalistico e
paesaggistico. In un breve elenco troviamo il sole, la luna, le stelle ed altri
elementi del mondo materiale e come essi erano, secondo Deimel, inserite
nel contesto mesopotamico. Di questi elementi viene mostrato come essi si
incastonavano nella mappa mentale complessiva di quegli antichi uomini.
Lo studio di Deimel, pur nella profonda differenza metodologica rispetto ai
lavori successivi, di seguito citati, trattandosi comunque di un testo di tipo
religioso, getta le basi proprio per quegli studiosi che dalla relazione fra lo
spazio mitico e quello naturalistico partiranno all’esplorazione di quello
amministrativo ed infine geografico. Successivo è l’articolo di Thorkild
Jacobsen del 1946 “The cosmos as state” pubblicato nel lavoro di
Frankfort “The Intellectual Adventure of Ancient Man: An Essay on
Speculative Thought in the Ancient Near East”. In tale brano, Jacobsen,
pone in relazione non solo la struttura del cosmo con la struttura sociale,
ma dimostra come buona parte delle decisioni politiche nel mondo
mesopotamico fossero influenzate dall’interpretazione di quegli astri che
altro non erano se non parte integrante del grande meccanismo del mondo;
nel lavoro di Jacobsen l’aspetto geografico, inteso come “Scienza che
studia l'aspetto della superficie terrestre e i fenomeni fisici, biologici e
umani che in essa si verificano ”1, è presente nella sua forma più
totalizzante, con la forma del mondo che è forma dell’uomo, in ogni suo
aspetto, e viceversa. Proseguendo lungo la nostra ricostruzione citiamo
“Ancient Cosmologies” edito nel 1973 da C. Blacker e M. Loewe, frutto
del lavoro dei grandi studiosi dell’università di Cambridge di quegli anni,
ognuno dedicato ad un’area ed ad un popolo dell’antichità. Per l’analisi
della concezione mesopotamica del mondo abbiamo il contributo di W. G.
Lambert il quale, dovendo tracciare un’immagine della “forma” del mondo
Sumero-Accadico e poi Assiro-Babilonese, decide di porre in relazione i
dati relativamente alla superficie terrestre, i corpi celesti, il ruolo degli dei
e quello dei demoni, per creare, infine, un’immagine complessiva, e
conclusiva, coerente. Il nostro viaggio attraverso la storia degli studi
geografici del vicino oriente antico continua toccando il lavoro del 1991 di
Ignace J. Gelb “Earliest Land Tenure System in the Near East: ancient
Kudurrus”, metodologicamente affine a quello di A. George “Babylonian
1- Sabatini 1997
Topographical Texts” del 1992, di seguito citato. Quest’opera è il frutto di
un lungo lavoro iniziato dallo stesso Gelb nel 1952 con “Old Akkadian
Writing and Grammar”, culminato in quest'opera che punta alla
definizione di tutte quelle linee generali che permettono di tracciare degli
insiemi categoriali che possono essere ritrovati nell'analisi delle pietre di
confine (i Kudurru per l’appunto). Gelb ha quindi ricercato quei caratteri
comuni che permettessero di ricostruire l’andamento dell’evoluzione non
solo di tali reperti, ma anche di tutte quelle forme di registrazione scritta,
in special modo testi amministrativi, che vanno dal periodo proto dinastico
a quello di Ur III. Il lavoro di A. George . In comune con il lavoro di Gelb,
quello di George ha una puntuale fedeltà al dato attinto direttamente dai
documenti originali, ma si discosterà dal lavoro di Horowitz, citato di
seguito, per la speculazione di natura interpretativa che tende a preferire
uno studio più mirato su una particolare tipologia di testi. Si tratta della
serie Tintir ben noto agli assiriologi come i “Stadtbeschreibung von
Babylon” (La Topografia di Babilonia), come del resto ben noto anche agli
scribi antichi essendo una delle serie dei testi scolastici più ricopiate nei
periodi tardi. Relativo ad un periodo storico che esula dalla nostra ricerca
ma ugualmente importante per le informazioni che desume, e che possono
celare dati formatisi nel III millennio a.C., è il lavoro di Erica Reiner
“Astral Magic in Babylonia” del 1995.
Un'analisi ugualmente esaustiva, ma invece di tutt’altra natura, è quella
effettuata nell’opera di W. Horowitz, l'opera presa in esame è
Mesopotamian Cosmic Geography del 1998. Horowitz traccia una
definizione esaustiva della concezione cosmologica della Mesopotamia,
analizzando tanto l’aspetto geografico quanto quello astronomico,
prendendo le mosse da quei testi e quei documenti chiave che permettono
una ricostruzione di quegli elementi fondanti che lo compongono. La
geografia, nel lavoro di Horowitz, viene finalmente trattata come la
summa di analisi relativamente allo spazio celeste2; lo spazio politico, con
lo studio della “Mappa Babilonese del Mondo” e la “Geografia di Sargon”,
e lo spazio mitico. Sempre del 1998 e di approccio solo parzialmente
filologico è l'opera di Pettinato “La scrittura Celeste” importante per il
puntuale lavoro sui testi che punta alla ricostruzione della weltanschauung
mesopotamica in ambito celeste. Il lavoro di Hunger, H. e D. Pingree del
1999 “Astral Sciences in Mesopotamia” rappresenta un sunto delle
ricerche effettuate da questi due studiosi nel corso degli anni precedenti, in
special modo relativamente allo sviluppo delle scienze astronomiche in
ambito assiro e babilonese. Come più volte si è ricordato nel corso nel
2- Attraverso lo studio dei documenti KAR 307 e AO 8196
presente lavoro, la nostra ricerca non può fare a meno di giovarsi di tutti
qui testi che, pur non essendo propriamente dei testi di archeologia o di
storiografia , possono contribuire alla formazione di un'idea esaustiva dello
spazio geografico. Per una simile ragione, e ai fini di una ricostruzione
dello spazio mitico in Mesopotamia si ricordano i due lavoro di Abush
“Riches Hidden in Secret Places” del 2002 e “Biblical Accounts of
Prehistory: Their Meaning and Formation” del 2007.
Spazio amministrativo, spazio geografico e spazio mitico nella
Mesopotamia del III Millennio a.C.
Lo spazio geografico è un elemento intrinsecamente legato alla società che
lo produce e lo vive; per questa ragione, è necessario presentare la realtà
mesopotamica del III millennio a.C. così come ci è dato conoscerla
attraverso gli studi archeologici e storici.
Amministrazione e politica
Il III millennio a.C. è un lungo lasso di tempo che vede prima il fissarsi di
quelle realtà sociali ed economiche nate nella seconda metà del IV
millennio, e poi la lenta nascita di quelle peculiarità socio- amministrative
che esploderanno prima con l’impero di Sargon e poi ancora con l’età neo-
sumerica.
Nei primissimi anni del III millennio a.C. osserviamo il consolidarsi delle
realtà amministrative delle città stato sumeriche. In principio si osserva un
travolgente exploit legato alla diffusione della cultura Uruk e dei suoi
modelli organizzativi urbani, per cui qualcuno parla di colonizzazione3:
con il Tardo Uruk, infatti, osserviamo una vera e propria diffusione
espansiva di un modello economico comune che interessa un’area molto
vasta, comprendente i territori che rientreranno poi nelle realtà di Sumer,
Akkad e l’Elam. Le elite locali, stimolate a prendere il controllo delle
risorse primarie dal potere acquisito dalle realtà limitrofe, contribuiranno
alla creazione di un firmamento di città e proto città che costituiranno la
creazione di uno spazio amministrativo composto da varie comunità
urbane che sembrano galleggiare in un vuoto economico ed ideologico.
A questa fase fa seguito un periodo in cui il mondo mesopotamico conosce
una violenta contrazione sociale ed economica: le città stato della
Mesopotamia meridionale si rinchiudono in una realtà tutta regionale e
fortemente conflittuale, legata al controllo dei canali e dei principali
accessi alle fonti d’acqua. Durante questo periodo, noto come
Protodinastico, la realtà amministrativa non subisce sostanziali mutamenti
3 G. Algaze 2002Algaze, G. 2002, The Prehistory of Imperialism, in Uruk, mesopotamia and its neighbors, Santa Fe, School of American Research Press pagg. 27-83
qualitativi rispetto a quanto osservato per la fine del IV millennio, al
contrario è il valore quantitativo a influenzare lo sviluppo
dell’amministrazione: il tempio continua a svolgere una funzione
redistributiva della ricchezza, con la figura del re sacerdote/organizzatore
preminente e legato alla struttura templare; al contempo però tale entità
religiosa/amministrativa è oramai capace di appropriarsi di risorse e
lavoro. E' probabilmente in questa fase che nello spazio amministrativo
percepito dal popolo Sumero e Accadico si è già formata la ben nota diade
concettuale di centro e periferia. Il centro, rappresentato dalla città, è un
polo di attrazione di risorse e lavoro per la periferia, rappresentata dalle
campagne circostanti. Tale distinzione, che ritroveremo nello spazio mitico
specialmente con la nascita dei primi imperi, dopo che essa venne caricata
di significato fondante per la società stessa, nasce in seno ad
un’amministrazione precapitalista che fa della periferia la fonte del surplus
necessario allo sviluppo e al sostentamento della città/centro.
Wallerstein4 osservò come, a differenza delle società capitaliste, il mondo
del vicino oriente antico non fa della produzione di surplus il motore della
propria economia, al contrario, fondamentale è che lo stesso surplus
economico, ma soprattutto produttivo, venga attinto e trasportato nella
4 Wallerstein, I. 1974 The Modern World-System, vol. I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York cap. 1
città.
Ultima e fondamentale unità dello spazio amministrativo della
Mesopotamia del III millennio a.C. è la divisione nord/sud, che, se sul
piano storico assume per noi caratteri maggiormente definiti solo con
l’avvento dell’impero Accadico, è già ravvisata da quelle distinzioni
interne che accompagnano l’avvento della società urbana già nel Medio
Uruk. Quanto poi questa divisione sia coincidente con la realtà etnica, che
vedrà poi distinti Akkad al nord e Sumer al sud, non ci è dato saperlo. Ciò
che è certo è che fin dall’inizio lo studio del dato amministrativo ci mostra
un sud maggiormente legato al potere del tempio, e alla redistribuzione
della ricchezza mediante esso, mentre il nord vede fin da subito l’emergere
di elite legate alla dinastia e alla gens, per quanto comunque
profondamente inquadrate nella struttura redistributiva templare5. Tale
distinzione, che si conferma con i primissimi anni del protodinastico,
diverrà essenziale al momento della formazione dei due grandi imperi che
si faranno garanti ora dell’uno, ora dell’altro sistema economico; difatti
l’impero Accadico risentirà delle influenze delle economie del nord come
l’impero Neosumerico dell’economia templare. Tale differenziazione
porterà ad un mutamento profondo dello spazio amministrativo ed 5 Frangipane, M 2002, Centralization Processes in Greater Mesopotamia in Uruk, mesopotamia and its neighbors School of American Research Press pagg. 307-347
economico, e all’apertura estrema dell’impero sargonico, legato alla
continua ricerca di nuovi nodi da aggiungere alla rete commerciale che
regge l’impero, si contrapporrà la forte chiusura interna dell’impero
Neosumerico che, dopo la crisi del periodo Isin-Larsa, rivolge tutte le sue
attenzioni esclusivamente sulla Mesopotamia.
Lo spazio geografico nel III millennio risente delle oscillazioni di carattere
economico di cui fino adesso abbiamo parlato, anche se lo stadio degli
studi su tale argomento è ancora troppo “in itinere” perché lo si possa
riassumere in questa sede, rinviando quindi tale trattazione al capitolo
specifico ove si affronterà la questione attraverso un confronto diretto con
le fonti.
La religione e il mito
Lo spazio mitico mesopotamico è il frutto di un'operazione complessa
effettuata nel corso dei secoli dalla Weltanschauung dei popoli della
Mesopotamia del III millennio. Esso è il risultato del modo in cui la
religione, e gli elementi che la compongono, vengono collocati nel mondo,
sia fisicamente, con l'edificazione di templi e strutture religiose di varia
natura, sia concettualmente assegnando un valore religioso a certi luoghi
specifici o stabilendo i limiti e i confini del mondo mitico.
Ma il mito e la religione nel mondo mesopotamico non sono un
monolitico blocco sempre uguale a se stesso nel corso dei secoli. Essi,
difatti, non furono mai costanti, ma continuamente soggetti alle
innovazioni apportate da tutti quei popoli, o classi sociali, che si
avvicendarono al potere in Mesopotamia. Nonostante ciò, lo spazio mitico
si identificò grossomodo fin dagli albori come un insieme coerente che si
rifaceva al primigenio passato sumerico.
Lo spazio mitico si componeva di due assi6, uno verticale e l'altro
orizzontale. Il primo rappresentava la connessione fra i cieli, il mondo
terrestre e il regno sotterraneo, il secondo asse, che abbiamo già incontrato
nello spazio amministrativo, divideva invece il centro dalla periferia, gli
spazi interni da quelli esterni. Esso aveva come suo punto di propagazione
ideale la casa, considerata come entità cellulare di base che componeva la
città, la quale a sua volta rappresentava il secondo cerchio di propagazione
dell’asse orizzontale che si allargava dalla città alle terre intorno alle città
ed infine i mari (superiore e inferiore) e le grandi catene montuose
(idealmente comprese fra il Caucaso e gli Zagros). Lungo l'asse verticale
troviamo il mondo suddiviso in sei unità principali. La zona posta
maggiormente in profondità è il Kur per i sumeri o irkallu per gli accadi.
6 Mander, P. 2005, All'origine delle Scienze 1. Medicina ed Esorcistica in "quaderni Napoletani di Assirologia", Napoli, Aracne pagg. 38
Questa regione è ampiamente descritta da vari miti di età successive al III
millennio a.C., ma che in questo periodo si formano o si canonizzano; un
esempio è dato dal mito di Ghilgameš, laddove si parla del defunto
compagno del re di Uruk, Enkiddu, che descrive al protagonista
dell'epopea il triste destino di coloro che albergano nella terra dei defunti;
lo stesso luogo che Inanna raggiunge solo dopo aver superato i sette portali
che la spogliano dei suoi divini poteri7. Ma nella definizione sumerica il
Kur non è solo il punto più profondo della Terra, è anche tutto ciò che
posto oltre le catene montuose che delineavano così un mondo dalla forma
grossomodo di una scodella al cui centro era posto l’alluvio
mesopotamico; il Kur era in sostanza l’ignoto, ciò che si trovava oltre la
Grande Mesopotamia. Risalendo lungo l’asse verticale troviamo l’Abzu
(per gli accadi) detto anche Nammu (per i sumeri) ovverosia l'oceano
sotterrano delle acque dolci, la residenza del grande dio Enki. L’Abzu era a
sua volta sovrastato dalla superficie terrestre, il luogo abitato dagli uomini.
Lo spazio mitico di tale regione non era solo mero scrigno dell’umanità,
ma ospitava una grande quantità di luoghi mistici o sacri, mitici essi stessi,
non localizzati in luoghi distanti e inaccessibili, a parte rari casi, ma
disposti lungo tutto il vicino oriente. Dalla Montagna dei Cedri all’Eabzu
7 Bottèro, J. 1992, Uomini e Dei della mesopotamia, Einaudi, Roma 168-169
di Eridu, erano tutti luoghi ugualmente mitici che non ponevano il dio e la
sua attività in un altrove di fondazione intoccabile e irripetibile; al
contrario ogni sovrano che, come il divino Ghilgameš, attingeva legno
dalla montagna dei cedri rifondava il mito esigendolo per se stesso, così
come ogni qual volta il tempio veniva restaurato, tale attività aveva lo
stesso valore fondante dell’atto di creazione del dio che si era costruito la
sua prima casa al tempo del mito. Lungo l’asse verticale si collocano poi il
cielo inferiore, quello mediano e quello superiore. La loro funzione, il loro
colore e quali dei lo abitassero sono ancora motivo di dibattito presso gli
studiosi.
Horowitz8 raccoglie due distinte tradizioni: la cosiddetta fonte A
(rintracciabile sia nel KAR 307 che nell’AO 8196) e la fonte B
(riconducibile solo al KAR 307), che così descrivono i differenti cieli: nel
cielo inferiore si collocano le stelle e le costellazioni; nel cielo mediano,
per la fonte A, si trova la sede degli dei minori detti Igigi, mentre la per
fonte B la residenza di Bel. Nel cielo superiore invece la Fonte A colloca la
sede di Anu mentre la fonte B colloca qui gli Igigi in numero di 300.
Differente è l’approccio di P. Mander9 che colloca nel cielo inferiore la
8 Horowitz, W. 1998, Mesopotamian Cosmic Geography, Atlanta, Eisenbrauns pagg. 3-19
9 Mander, P. 2005, All'origine delle Scienze 1. Medicina ed Esorcistica in "quaderni Napoletani di Assirologia", Napoli, Aracne pag. 35
volta celeste, in quello mediano il cielo meteorico e la sede degli dei, e nel
cielo superiore la sede di Anu, il luogo delle stelle immobili.
Svolgimento del lavoro e osservazioni sul catalogo.
Il presente lavoro parte quindi dall'esplorazione delle “Immagini, testi e
mappe della rappresentazione spaziale della Mesopotamia del III millennio
a.C.”. Tale operazione verrà effettuata scevrando i suddetti argomenti
seguendo una metodologia che punterà alla progressiva messa in luce delle
differenti categorie secondo una prospettiva amministrativa, poi geografica
ed infine mitica. Solo in un secondo momento verrà compiuta un’analisi
delle categorie concettuali che componevano il mondo speculativo dei
popoli mesopotamici, che venne poi espresso attraverso quelle immagini,
quei testi e quelle mappe. Al termine del lavoro, dalla sovrapposizione dei
dati raccolti verrà proposta un'analisi sperimentale di un documento del I
millennio a.C., frutto dell’elaborazione di quei dati, analizzati in corso
d’opera, prodotti dalle culture del III millennio a.C.
Nel corso della presente introduzione si è tornati di sovente su un ostacolo
fondamentale che ha incontrato l’autore del presente lavoro: la geografia
mesopotamica del III millennio non è mai stata indagata in quanto tale.
Tale tema è sempre stato relegato al ruolo di mero corollario di altri studi,
dando adito implicitamente alla convinzione che fosse possibile desumere
l'ideologia geografica dei popoli mesopotamici partendo dal semplice
studio di altri ambiti; e tale procedimento logico, se non lo si vuole
considerare errato, è sicuramente incompleto. Esistono però studiosi, fra
cui quelli già citati, che hanno comunque contribuito alla creazione di
un'idea complessiva di cosa dovesse significare “geografia” per i popoli
della mezzaluna fertile; ciò nonostante non esiste un unico lavoro specifico
sull'argomento, né sotto forma di libro né di articolo, il che ci spinge ad
operare in maniera complessivamente nuova nel tentativo di creare uno
sguardo di insieme esaustivo. Il punto di partenza è quindi una
metodologia puntuale che continui a giovarsi degli insegnamenti degli
studiosi precedenti, ma che dia la precedenza al dato in sé, in questo caso i
reperti.
Considero importante una piccola digressione relativamente al concetto di
“dato in sé”, e nel fare ciò mi riferisco agli studi di statistica informatica
applicata all'archeologia del prof. D'Andrea10 e le osservazioni, più
prossime all'archeologia in quanto tale, del prof. Ramazzotti11. Il dato in sé,
da un punto strettamente ontologico, si può dire che è una pura costruzione
10 D'Andrea, A. 2006 Documentazione Archeologica, Standard e Trattamento informatico, Budapest, Centro Interdipartimentale di Servizi di Archeologia dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, in collaborazione con il progetto europeo Rete di Eccellenza EPOCH cap. 1
11 Ramazzotti, M. 2010, Archeologia e Semiotica, Settimo Torinese (TO), Bollari Bolinghieri pagg. 33-76
mentale, e come tale non esiste. Difatti, se è vero che il supporto materiale
è reale, al contempo una volta decontestualizzato dai suoi produttori e
fruitori originali e successivamente reinserito in un nuovo contesto di
mediatori e fruitori, rischia di venire completamente travisato, a causa di
una cesura profonda dal dato così come veniva inteso dai suoi produttori.
Volendo fare un esempio pratico prendiamo in esame una tavoletta che
riporti un racconto mitico; scomparsa oramai da tempo la classe di scriba
che l'ha prodotta, si necessita l'intervento di uno specialista che, partendo
da un processo di lenta sedimentazione degli studi, interpreterà la scrittura
della tavoletta. Questo primo passaggio presenta notevoli difficoltà e il
rischio di una propagazione dell'errore è sempre in agguato; ma il vero
problema si presenta solo in un secondo momento, quando il racconto
mitico deve essere interpretato, non più da persone che ascoltandolo lo
inseriscono naturalmente in un complesso logico-culturale familiare, bensì
da studiosi che nonostante tutti gli sforzi possibili saranno sempre intrisi
della loro cultura d'origine, in quanto è stata la loro stessa cultura madre a
spingerli verso lo studio della suddetta tavoletta. Con tale ragionamento
non si vuole sostenere un sofistico principio di indeterminabilità del dato,
ma soltanto ricordare la cautela con la quale bisogna apprestarsi ad ogni
singolo reperto, laddove il puzzle complessivo dell'ambito che si vuole
ricostruire non è composto solo dal reperto in sé, ma anche, e soprattutto,
dalla fitta bibliografia che lo accompagna e che ne garantisce la
contestualizzazione in un quadro che, nonostante ci sia distante nel tempo
e nello spazio, grazie proprio a quella lenta e professionale sedimentazione
degli studi di cui prima accennato, ci è sempre più chiaro. In un'epoca in
cui gli addetti ai lavori devono soffrire quotidianamente la diffusione da
parte dei media di dati palesemente falsi o contraddittori, questa piccola
digressione era più che doverosa. Per non tradire i principi ora esposti si è
preferito quindi stilare ex novo un catalogo dei reperti, che non sarà solo
una risorsa consultabile in appendice al presente lavoro, bensì sarà il punto
di partenza dell'opera stessa. Considerando la grande difformità dei reperti
presi in esame, si è cercato di stabilire delle classi di catalogazione
ugualmente valide per ogni caso per trarre dei dati che, se possono
apparire ad una prima analisi fin troppo vacui, sono in realtà il frutto di
una metodologia che non vuole assolutamente influenzare il dato finale
stabilendo classi troppo specifiche. Una prima distinzione è rintracciabile
già nel titolo: sono infatti le Immagini e i Testi le tipologie di partenza del
nostro lavoro. A queste prime tipologie se ne deve aggiungere una terza
composta dai reperti di natura mista, ovverosia quei reperti che presentano
caratteri sia iconografici e rappresentativi, sia testuali. All'interno di questi
principali insieme si andranno poi definendo altre distinzioni, la prima di
natura propriamente materiale, distinguendo cioè cinque sottoinsiemi che
raggruppano reperti tipologicamente simili. Tale distinzione, se può
sembrare superflua ad un primo sguardo, è in realtà già un modo per
compiere delle osservazioni iniziali fondamentali, in quanto da una parte
tale classificazione ci permette di stabilire delle piccole tabelle che ci
informeranno relativamente al supporto più diffuso, o che semplicemente
si conserva meglio, e in secondo luogo in che modo il supporto influenza il
contenuto. Volendo fare un esempio pratico, e anche piuttosto banale, il
materiale amministrativo sarà sempre grossomodo veicolato dalla
tavoletta, poche volte dalla statuina e talvolta dal sigillo. Fin da adesso si
chiarirà che anche la formazione di questo catalogo ha confermato il trend
caratteristico dell'archeologia mesopotamica, ovverosia la dominanza delle
tavolette e dei sigilli nella casistica di ritrovamento, confermando le une
come la principale fonte di informazioni scritte e gli altri di quelle
rappresentate per mezzo di immagini. Le stesse immagini e testi verranno
sottoposti ad un ulteriore confronto incrociato basato su altri sotto insiemi
categoriali, in questo caso generati dallo studio dei materiali che
componevano il supporto dell'informazione. Tale dato non è assolutamente
da sottovalutare e non può essere grossolanamente né ascrivibile o
sottointendibile alla tipologia precedente, né sottovalutato in quanto
apparentemente non prettamente legato ai fini del presente lavoro. Nella
realtà dei fatti la scelta, da parte dei popoli mesopotamici, di veicolare un
messaggio attraverso l'argilla, la pietra nera (spesso la diorite) o il calcare
definisce un elemento fondamentale del documento: il suo valore.
Sappiamo infatti che l'argilla era relegata al ruolo di supporto povero,
utilizzabile esclusivamente per documenti ritenuti temporanei e che quindi
dovessero essere prodotti o archiviati da parte di un privato o nei grandi
archivi dei palazzi e dei templi. La ragione per cui, proprio questo
particolare sottoinsieme, domini il catalogo, nonostante il valore
assegnatogli dalle popolazioni mesopotamiche, è dovuta ad una semplice
ragione, di natura numerica e pratica: in quanto prodotti di uso quotidiano,
i documenti in argilla venivano prodotti giornalmente ed in grandissima
quantità e sarebbe interessante, per quanto forse impossibile, quantificare
il numero di atti di proprietà, documenti giuridici, vocabolari bilingui,
quaderni di studio di lingua e matematica, attestazioni di transazioni
economiche di variegata natura, appunti di preghiera giornalmente prodotti
in tutta la Mesopotamia. Siamo comunque nell'ordine delle centinaia, se
non forse delle migliaia, e ciò spiega l'abnorme quantità di questi
documenti a noi pervenuta.
Oltre a definire il valore del reperto, il materiale trasmette un'informazione
ulteriore: la relazione fra messaggio e materiale. Tale argomento è stato in
parte già esplorato in special modo nell'ambito dei documenti prodotti ad
uso e consumo della classe dominante. Conosciamo così il legame fra
pietra nera, in special modo la già citata diorite, e la regalità, essendo
questo un materiale piuttosto raro in Mesopotamia e di conseguenza il suo
utilizzo attestava la capacità di dominare quelle reti commerciali che ne
permettevano l'approvvigionamento; tratto distintivo dei regni accadici
prima e neo-sumerici dopo12. In corso d'opera si tenterà di distinguere, nel
caso se ne dovessero intravedere i presupposti, gli ulteriori legami che
possono intercorrere fra il materiale ed un'informazione specifica. Un altro
insieme fondamentale è di natura prettamente geografica, ovverosia i
luoghi in cui sono stati prodotti i reperti. Tale classe è la più semplice da
definire quanto forse la più importante, in quanto osservando la
distribuzione dei luoghi che hanno prodotto i differenti documenti si
possono creare mappe che permettono di isolare le aree più produttive e in
un secondo momento quelle zone che hanno prodotto una specifica
categoria di documenti. Il quadro fino ad ora esposto mostra un gruppo di
reperti, suddivisi in tre tipologie differenti, Immagini, Testi e Testi e
12 Matthie, P. 1997, La Storia dell'Arte dell'Oriente Antico,Roma, Electa pagg. 31-45
Immagini, i quali vengono trasversalmente attraversati da tre sottoinsiemi
principali: materiale, luogo di ritrovamento e tipologia morfologica.
Quello che hanno in comune tutte queste categorie è che sono “suggerite”
dal documento stesso. I vari gruppi tematici vengono via via ampliati dal
dato raccolto, ed in questo modo, se un documento appartiene ad una
tipologia materiale non ancora considerata o è composto da un materiale
non ancora classificato o infine proviene da una zona non ancora presa in
esame dal catalogo, quest'ultimo si aggiorna al fine di includere il nuovo
insieme. I sottoinsiemi trattati di seguito sono, al contrario, il frutto di una
costruzione mentale effettuata a priori: si tratta di caselle nelle quali in vari
documenti vengono di volta in volta inseriti e, per quanto si è diffidato fin
dall'inizio della nostra trattazione di questa forma di preconcetto, tale
veicolazione è purtroppo imprescindibile essendo l'unico strumento a
nostra disposizione. Il paragone con lo scavo archeologico è calzante: per
definizione lo scavo archeologico è un'esperienza distruttiva, ma al
momento delle nostre conoscenze tecniche il piccone e la traul sono tuttora
gli unici strumenti validi a nostra disposizione per raggiungere i reperti
ancora intrappolati nel terreno. Il primo di questi sottoinsiemi “arbitrari” è
forse il più caratteristico di questo genere di cataloghi e si colloca a metà
strada fra una categoria osservabile obbiettivamente nel reperto ed una
completamente arbitraria: si tratta della cronologia. Tale categoria assume i
connotati di un insieme non obbiettivo ma frutto di opinioni condivise,
laddove non è intesa come tabella che assegna ad ogni reperto un valore
numerico in anni calcolato dagli studiosi sulla base di studi epigrafici,
materiali e contestuali, bensì come una catalogazione che, per collocare
cronologicamente un reperto, lo assegna ad un “periodo culturale”. La
divisione della storia della Mesopotamia in periodi culturali si è rivelata
una necessità da parte degli studiosi che, approcciandosi ad una storia
lunga sei millenni, se consideriamo anche le fasi protostoriche, hanno
creato un sistema nominale che mettesse subito in evidenza i principali
mutamenti della storia Mesopotamica. Queste distinzioni non sono celle a
tenuta stagna e la maggior parte dei mutamenti macroscopici sono
avvenuti nel corso di molti secoli, ma è possibile comunque operare delle
distinzioni principali. I periodi del catalogo sono quelli della distinzione
classica, ovvero sia Tardo Uruk, Jemdet Nasr, Protodinastico I,
Protodinastico II, Protodinastico IIIa, Protodinastico IIIb, Età Accadica . Il
lettore attento avrà notato come in realtà il presente lavoro non si occupi
del III millennio da un punto di vista pragmaticamente cronologico, bensì
da un punto di vista culturale. Si è scelto come punto di inizio il Tardo
Uruk e l'Età Accadica come punto di fine (sulla presenza di reperti
appartenenti all'età NeoSumerica-PaleoBabilonese tornerò in un secondo
momento), perché entrambi questi periodi rappresentano una cesura
profonda con il passato, sono la condicio sine qua non per i contesti
socioculturali successivi. Il Tardo Uruk è la fine della grande koinè
culturale che ha di fatto fondato la Grande Mesopotamia e l'impero
Accadico è il punto più alto di un processo statale e culturale parcellizzato
che dopo secoli si riunisce creando qualcosa, però, di mai visto prima. Il
III millennio è l'età dei templi, sia culturalmente che economicamente,
mentre con l'età Accadica si può dire che si entra nell'età dei re. Sulla
presenza nel catalogo di reperti indicati genericamente come NeoSumerici-
paleobabilonesi, va spesa qualche parola di chiarimento in quanto questa
definizione cronologica di periodo è, di per sé, errata. In realtà ciò che è
stato considerato è che il periodo neo-sumerico è stato escluso dal presente
lavoro poiché, nonostante sia cronologicamente compreso nel III
millennio, esso si colloca in un contesto culturale nuovo, e l'analisi
dell'ideologia geografica nell'ambito del rinnovamento e del recupero
ideologico operato dai regnanti di Ur III merita un lavoro dedicato;
ciononostante alcuni reperti provenienti dall'età neosumerica, di Isin-
Larsa, fino ai primi anni dell'età Paleobabilonese, riflettono le ultime
influenze di un'ideologia più antica e in via di estinzione, quella del III
millennio, e per questa ragione sono stati presi in considerazione. Per
questa ragione si è scelto di definire questo ultimo periodo NeoSumerico-
Paleobabilonese che ha ragione di essere solo in relazione al ragionamento
sopra esposto e al fatto che si ricolleghi, culturalmente, al III millennio
a.C. . L'ultimo sottoinsieme del catalogo è probabilmente il più arbitrario,
ma al contempo il più necessario ai fini di una comprensione finale: si
tratta del “soggetto” del reperto (amministrativo, mitico-sacro, geografico-
rappresentativo, geometrico-matematico ed infine politico, dove spesso
questa parola indica, un tempo come oggi, propaganda) , ovverosia la
natura del messaggio che ci proviene dal dato in esame. In altre parole è
quando si compila questo insieme categoriale che si tenta di scomporre
un'ideologia e di ricomporla in categorie familiari al fine di renderla
comprensibile. Le categorie, come si è già detto, sono un male necessario:
se da un lato influenzano il dato, dall'altro sono l'unico strumento a nostra
disposizione e l’unica risorsa realmente attuabile per difendersi sia da un
eccessivo relativismo che da una pedissequa coincidenza fra dati e
categorie. La metodologia più sana è probabilmente quella di utilizzarle
presupponendo un pacato dubbio. Tale dubbio intellettuale si riversa sul
catalogo che, quindi, segnalerà lo stesso reperto in più categorie della
tipologia “soggetto” qualora si fosse poco certi della sua collocazione o nel
Capitolo 2
Spazio amministrativo nella Mesopotamia del III millennio a.C.
La struttura economica della Mesopotamia del III millennio a.C.
Il primo argomento del nostro lavoro che verrà di seguito indagato è quello
relativo all'amministrazione mesopotamica, e come essa abbia prodotto
un'idea geografica non solo originale, ma ascrivibile esclusivamente al
contesto amministrativo stesso. Indubbiamente se lo si osserva dal punto di
vista della produzione burocratica, il mondo Mesopotamico risulta essere
un caso eccezionale per quel che concerne il mondo antico e la produzione
amministrativa risulta essere non solo copiosa ma anche variegata e
specializzata. Tale idea viene indubbiamente suggerita
dal grande numero di documenti ad argomento amministrativo che è
giunto fino a noi, ciò in parte dovuto alle considerazioni già fatte in
precedenza, relativamente alla incredibile resistenza del mezzo argilloso,
ma anche e soprattutto perché è innegabile che la produzione burocratica
in Mesopotamia fu realmente abbondante. Tale ricchezza di dati è lo
specchio di una società economica che fondava le sue stesse basi su una
burocrazia efficiente o per lo meno molto puntuale, e per poter
comprendere tale connessione a maglie strette fra economia e burocrazia è
necessaria una digressione nella storia economica della Mesopotamia. Il
quarto millennio a.C. Fu indubbiamente il momento di formazione delle
realtà economiche che poi si affermeranno nel millennio successivo,
queste ultime saranno il risultato di una fusione fra il modello Tardo
Calcolitico del nord e quello Medio e Tardo Uruk del sud. La prima grande
abbondanza di dati che attestano la registrazione di dati economici è
riscontrabile proprio al nord. Questa informazione potrebbe stupire
considerando che il sud già nel IV millennio presenta uno sviluppo
economico, sociale e demografico, più incisivo, ma la necessità di
registrare, nel caso del nord sotto forma di cretule, il passaggio di proprietà
o l'attestazione di proprietà su di un dato magazzino, nasce dalla struttura
economica delle società in esame. Le elite del Tardo Calcolitico dovettero
fronteggiare la crescita delle loro comunità in relazione ad un modello
economico che è già attestato nel periodo Halaf, ovvero sia quello di
un'economia differenziata e specializzata13. Volendo semplificare al
massimo tale modello, si può dire che esisteva una rete di villaggi ognuno
dei quali specializzato di una data attività (caccia all'onagro, raccolta di
cereali, produzione tessile, etc.) e che provvedeva alla propria sussistenza
dallo scambio continuo di beni. I continui spostamenti di merci e di
persone crearono la necessità di un qualche tipo di garanzia sui magazzini
13 Frangipane, M. 1996, La nascita dello stato nel Vicino Oriente, Laterza pagg. 69-74
che venivano quindi sigillati con l'argilla e sui sigilli veniva inciso un
simbolo personale. Nel sud invece osserviamo un andamento differente.
Fin dalla cultura Samarra si inizia ad osservare la nascita di grandi
strutture abitative, piuttosto isolate rispetto all'abitato e sede di una
famiglia che deteneva da una parte il potere politico e dall'altra qualche
attività di culto (come ad esempio il compito di ospitare l'inumazione dei
bambini all'interno delle mura domestiche). Tale processo subirà
un'accelerazione improvvisa con il periodo Uruk nel quale si osserva come
la casa della famiglia dominante diventi la casa del dio, e infine come il
fenomeno si concretizzi, a livello sociale, con la nascita della casta
sacerdotale. Il modello verrà esportato con l'espansione Uruk verso il nord
e verso l'Elam, adattando i sistemi di gestione dei beni sviluppati altrove,
ad un sistema centrale redistributivo che con l'inizio del III millennio a.C.
sarà perfettamente formato. Per società redistributiva in ambito
mesopotamica si intende indicare un tipo di società dove il tempio svolge
un ruolo centrale di raccolta e gestione della ricchezza per mezzo di un
sistema burocratico che permetta di reindirizzare il prodotto della
comunità verso i settori che ne necessitino. Le terre sono, in questo
contesto, proprietà del dio, e pertanto sono “affidate” al tempio che è
garante del processo di comunicazione fra il divino e l'umano. In un
secondo momento il tempio poteva assegnare le stesse terre ai contadini, i
quali potevano così garantire la propria sopravvivenza e produrre il
surplus che veniva restituito al tempio. Ma il ruolo del tempio non si
esauriva qui: le caste sacerdotali difatti erano anche responsabili della
gestione dei magazzini di cereali, inoltre era loro il compito di vendere o
semplicemente assegnare le sementi, e sempre loro il compito di
distribuire gli attrezzi per la lavorazione dei campi e i mangimi per gli
animali14. Infine, il tempio svolgeva il ruolo chiave di luogo ove venivano
assegnati i compiti di ciascun cittadino, in quanto tecnicamente tutta la
cittadinanza era parte del meccanismo templare che come tale garantiva
che gli uomini svolgessero il loro compito principale: servire gli dei
compiendo il lavoro che essi avevano assegnato all'umanità all'alba dei
tempi. Il sistema prevedeva che, in alternativa a quote dei prodotti del loro
lavoro, i cittadini potessero offrire prestazioni a corvèe intese sia da un
punto di vista civile, quindi la partecipazione alle grandi opere pubbliche,
sia da un punto di vista militare. Dal canto suo, il tempio, oltre a offrire la
gestione dei campi, garantiva lo sviluppo e la cura delle grandi opere
idrauliche, vero motore portante dell'economia mesopotamica, e la difesa
militare della città stessa15.Fatte queste premesse si potrebbe commettere
14 Liverani, M. 1988, Antico Oriente, Roma, Laterza pag. 13615 Liverani, M. 1988, Antico Oriente, Roma, Laterza pag. 176
l'errore di considerare la società mesopotamica simile ad altri sistemi
economici redistributivi come ad esempio l'Egitto dinastico; ma ciò non è
possibile a causa del ruolo peculiarissimo svolto dal commercio e dal
denaro16. In Egitto infatti osserviamo come tutte le attività non solo erano
gestite dal potere centrale ma anche pianificate dallo stesso e l'intero
prodotto veniva integralmente redistribuito dalle strutture templari.
I templi delle città mesopotamiche invece svolgevano un ruolo molto
originale, essi erano infatti anche delle vere e proprie banche che potevano
garantire ai cittadini prestiti di varia natura; tali prestiti non erano soggetti
a interesse se non nella misura in cui si ritardava col pagamento, nel qual
caso si incorreva nel pagamento di una mora17. Fu questa attività a esigere
la creazione di una contabilità puntuale e precisa la quale doveva gestire
l'ingresso e l'uscita di queste risorse, le quali si
presentavano sotto forme variamente differenziate, dalla lana all'orzo, e
proprio tale difformità nel prodotto richiesto richiese l'uso di un artificio,
anch'esso assolutamente originale: la creazione in un sistema di valore
condiviso e che svolgesse il ruolo parametro di riferimento; tale compito
era svolto dal siclo di argento (shekel) e da una misura di grano (il gur) che
erano vere e proprie monete 16 Einzig, P. 1949, Primitive Money, Londra pag. 21117 Davies, G. 1994, A History of Money, From Ancient Rimes to the Present Day, Cardiff,
University of Wales Press pag. 49
scritturali18. Il tempio era il cuore di un economia che possiamo definire
quindi plurale da un punto di vista prettamente economico nominale ma
tuttavia ancora rinchiusa nell'ambito delle economie redistributive a causa
della presenza monopolistica della struttura templare stessa; difatti la casta
sacerdotale era al contempo garante dei cambi nonché il più grande, se non
in qualche caso l'unico, proprietario terriero. Dal punto di vista
internazionale poi la situazione era ancora più inflazionata, essendo tutto il
commercio estero gestito unicamente dal tempio, e non a caso, i mercanti
che animavano tale movimento di merci, erano detti “messageri del re/gran
sacerdote”19. Tale sistema economico, plurale ma monopolistico, unitario
ma diversificato, proprietaristico ma collettivista mostrò la debolezza dei
paradossi insiti in esso a partire dal 2500 a.C. ; da questa data in poi si
osserva un progressivo indebitamento della classe contadina nei confronti
di quella sacerdotale, con un coincidente aumento del numero di schiavi
per debiti rispetto a quello dei contadini liberi. E' molto importante non
commettere l'errore di credere che tale trasformazione del tessuto sociale
fosse in qualche modo incentivata o voluta dalla casta sacerdotale: gli
schiavi infatti sono meno produttivi dei contadini e soprattutto tendono a
scappare. Se quindi ci fu un vantaggio sul breve periodo, sul lungo periodo
18 Crump, C. 1981, The Phenomenon of Money, Londra, Routledge & Kegan Paul pagg. 6-719 Pettinato, G. 1986, Ebla,Nuovi orizzonti della storia, Milano, Rusconi pagg. 177-179
le problematiche di questo sistema divennero palesi. Una conseguenza
naturale alla crisi dei debiti fu l'alienazione completa dalla proprietà
terriera da parte della classe contadina, il che ebbe come unico risultato
quello di accelerare un processo di potenziamento delle famiglie nobiliari,
già in atto da secoli. Tale processo sarà assai più preponderante al nord e
contribuì ad aumentare il divario fra i due sistemi, quello meridionale
ancora di matrice marcatamente templare e quello settentrionale invece di
tipo palazziale, in ogni caso, entrambi ancora redistributivi. La crisi si
trascinerà fino ai decenni successivi alla caduta dell'impero accadico,
quando il fenomeno toccherà il suo acme e costringerà, intorno al 2100
a.C. i regnanti mesopotamici ad emettere gli editti di liberazione, ovvero
sia veniva ordinata la rottura dei contratti e annullata periodicamente la
schiavitù per debito. E' piuttosto interessante osservare come già nel 1800
a.C. iniziarono ad essere prodotti dei documenti nei quali i contraenti si
impegnavano a non rispettare gli editti di liberazione. Questo tipo di
contrattodimostra due aspetti interessanti, motivo per cui ci siamo
permessi di spingerci oltre il limite del III millennio a.C. : da una parte
infatti dimostra che la soluzione ciclica del sintomo non aveva intaccato la
causa del problema, che continuava a colpire l'economia mesopotamica;
dall'altra parte dimostra che il contratto in se aveva una forza superiore
all'editto reale stesso. Tale superiorità del contratto rispetto all'autorità del
governo mi permette di introdurre una tesi proposta da Andrea Zohk20 il
quale pone i contratti stessi come la causa ultima della crisi dei debiti del
2500 a.C.; egli ha infatti osservato come a questo periodo corrisponda la
coincidenza oramai completa fra linguaggio scritto e parlato il che avrebbe
prodotto una maggiore facilità nella creazione di variazioni, aggiunte e
precisazioni al contratto, smantellando, di fatto, il principio del dono,
insito nel debito. In quest'ottica il tempio non aveva più modo di cancellare
i debiti contratti guadagnandone fama e rispetto, essendo stato alienato
dalla burocrazia dal rapporto tempio-contadino. Finisce il potere sociale ed
inizia quello contrattuale economico. “L'oggettività contrattuale, definendo
implicitamente i due contraenti come eguali non si presta ad adattamenti
personalizzati che compensino la realtà di fortune e forze economiche
difformi”. In sostanza dal contratto come mero supporto di un rapporto
personale fra i due soggetti si passa ad un contratto che è esso stesso il
rapporto e quindi inappellabile essendo sufficientemente esaustivo nel
definire i rapporti fra i due contraenti. Quanto questa tesi sia corretta non
ci è dato saperlo, ma indubbiamente essa presenta un approccio
metodologico che è lo stesso che si vorrebbe seguire in questa sede:
20 Zhok, A 2006, Lo spirito del denaro e la liquidazione del mondo, Milano, Jaka Book pagg. 37-38
partendo dal dato, se ne osservano le trasformazioni nel tempo e si cerca di
comprendere i motivi di queste trasformazioni.
Passando ora all'analisi dei documenti amministrativi in quanto tali
bisogna tenere presente quanto osservato da Piotr Steinkeller, secondo cui
il numero di questo tipo particolare di reperti è “virtualmente illimitato”21 e
per tale ragione è bene scegliere con cura le categorie di reperti da porre
sotto analisi. L’amministrazione territoriale è indubbiamente una sezione
importante di questo universo ed anche la più vicina ai fini ultimi di questo
lavoro: i campi rappresenteranno sempre un bene di prima necessità nella
mezza luna fertile e di conseguenza sono spesso al centro di dispute
militari o più semplicemente di transazioni economiche e compravendite;
eppure paradossalmente proprio lo studio di questo aspetto amministrativo
deve essere compiuto con la massima attenzione: anche in questo ambito
bisogna sempre ricordare che non è mai esistita una scissione totale fra
aspetto religioso e aspetto civico il che significa, come ricordato da Piotr
Michalowski22,che se è vero che i nomi di città o semplicemente di
località, nel momento in cui compaiono in documenti ufficiali svolgono la
semplice funzione di termini referenziali, ed è quindi possibile per noi
21 Gelb, I. 1991, Earliest Land Tenure System in the Near Est: Ancient Kudurrus, Chicago, Oriental Institute Pubblications volume 104 pag. 1
22 Michalowski, P. 1986, Mental Maps and Ideology: reflections on Subartu in The origins of cities, Londra pagg. 129-156
anche ricollocarli su una mappa odierna, al contempo essi sono inseriti in
un contesto che li carica di significati aggiunti. Ciò significa che, nel
momento in cui i testi amministrativi sono anche testi politici, essi
travisano completamente la reale natura del toponimo in quanto non lo
considerano più come punto di riferimento di un luogo materiale ma come
punto di una mappa mentale condivisa.
Gli Antichi Kudurru
I documenti dell’amministrazione territoriale nel III millennio sono detti in
assiriologia “antichi kudurru”. Tale definizione è utilizzata in
contrapposizione ai kudurru, le cosiddette pietre di confine, di età Cassita.
A differenza dei Kudurru cassiti e post-cassiti gli “antichi kudurru” non
hanno alcun valore sacro, inoltre non è possibile osservare, nell’evoluzione
degli “antichi kudurru, un momento in cui su di essi sia indicata la dicitura
ina muhhi eqlišu ovvero sia “collocato nel campo (a cui si riferisce)”,
assumendo così il valore di vere e proprie pietre di confine.
Al contrario gli “antichi kudurru”, come del resto anche quelli di età
Cassita nelle fasi iniziali, saranno collocati nel tempio svolgendo in questo
modo una triplice funzione: garantire per essi e per il contratto la
protezione degli dei, rendere possibile a tutti la consultazione del contratto
stesso, ed infine assumere, una volta giunti nel tempio, lo scopo di ius
pubblicitatis l’equivalente dell’odierna pubblicazione ufficiale dell’atto23.
Gli assiriologi distinguono anche fra “antichi kudurru” e semplici contratti
di vendita; a differenza dei primi, quest’ultimi possono contenere anche
informazioni su transazioni relativamente a beni mobili o immobili mentre
la caratteristica principale degli antichi kudurru sembra essere quella di
occuparsi di campi coltivabili.
Inoltre essi si distinguono dai semplici contratti di compra/vendita anche
per un’altra ragione: il materiale che li componeva. Gli“antichi kudurru”
erano, insieme ai sigilli e ai piccoli oggetti votivi, fra i pochi oggetti iscritti
in pietra; essi erano quindi pensati per durare in “eterno” ed essere
“indistruttibili” o, per essere più puntuali, “inviolabili” come sancito dal
termine sumerico Nadua. Gli “antichi kudurru” svolgono una funzione
insostituibile permettendoci di ricostruire la struttura della famiglia/clan e i
sistemi di misurazione dei terreni.
Un kudurru di base riporta le seguenti informazioni: le dimensioni del
campo venduto, il prezzo d’acquisto, il nome del compratore e del
venditore; a queste talvolta se ne aggiungono altre quali la specifica del
pagamento di un dono, la presenza di un venditore secondario, la presenza
23 Cuq, E. 1929 , Etudes sur le droit babylonien, Parigi pagg. 343-346
e i nomi dei testimoni.
Nei documenti dell’amministrazione territoriale il compratore è sempre
uno, al contrario i venditori possono essere vari anche se di solito, specie
nei documenti più antichi, sono pochi se non uno. Un’altra caratteristica
degli “antichi kudurru” è la possibilità che essi non fossero conservati
presso il tempio. Una particolare categoria di questi documenti, come è il
caso del reperto analizzato nella Scheda Testi 8, riporta la dicitura kagbi
egarra bidu ibi zaggi biag cioè “colloca questo cono nel muro e spargi olio
sul lato”. L’operazione descritta era svolta a transazione compiuta e
prendeva il nome di cerimonia del kag, tenuta dal venditore assistito dal
nigiruru, una sorta di araldo dell’autorità cittadina.
Il punto di partenza per uno studio degli antichi kudurru è indubbiamente
l'opera di Ignace J. Gelb “Earliest Land Tenure System”, l'opera infatti,
curata anche da Steinkeller e Robert Whiting Jr., si presenta come la più
accurata raccolta di antichi kudurru. L'opera infatti è il frutto di un lavoro
trentennale iniziato da Gelb nel 1952 con “Old Akkadian Writing and
Grammar” nel quale l'autore, raccogliendo le iscrizioni di età Sargonica e
Pre-Sargonica, iniziò ad identificare ed isolare quei primi documenti che
poi sarebbero entrati nella lunga raccolta degli Antichi Kudurru.
Nella presente raccolta non abbiamo potuto considerare tutti i reperti
dell'opera di Gelb, alcuni poiché esulavano dal periodo in esame, altri
invece poiché non necessari per i fini di questo lavoro. La nostra analisi
procederà dai reperti più antichi fino a quelli più recenti spingendosi da
nord a sud e lasciando per ultimi, periodo per periodo, quei reperti di cui
l'origine è ignota.
Un primissimo esempio di antico kudurru ci è dato dalla cosiddetta
Tavoletta Hoffman (Scheda Testi 1) proveniente da Uruk ed ascrivibile al
Tardo Uruk. In essa ritroviamo in nuce quanto espresso relativamente alla
struttura economica anche se in maniera ribaltata: si attesta infatti
l'acquisto di un terreno da parte dell'autorità templare probabilmente da
venditori privati. La tavoletta è in pietra nera ed incisa solo su una faccia
dimostrando di essere un documento considerato di eccellenza. Tutti gli
altri reperti del Tardo Uruk sono purtroppo di origine ignota.
Il primo documento posto in analisi è la Tavoletta Walters (Scheda Testi 2),
una piccola tavoletta in pietra rossa che attesta ancora una volta un
acquisto da parte dell'autorità templare, indicata questa volta dalla
semplice menzione della divinità come nome del compratore.
Già con i documenti riportati di seguito il quadro cambia completamente a
dimostrazione di come il modello redistributivo non debba essere applicato
pedissequamente immaginando un mondo mesopotamico arcaico privo di
una vera e propria proprietà privata; difatti tutti e tre documenti attestano
compravendite di terreni fra privati, uno spostamento di proprietà tutto
interno ai singoli cittadini.
Il primo esempio è una piccola tavoletta sferica nota, dai testi di Gelb,
come Tavoletta del Louvre (Scheda Testi 3), scritta su tutti i lati che riporta
un acquisto di terreno fra due privati; il secondo esempio è tratto dalla
Tavoletta di Yale II (Scheda Testi 4) ed attesta l'acquisto di 1 bur (circa 14
ettari) da parte di un privato del quale il nome è purtroppo frammentario.
L'ultimo documento posto in esame per quest'epoca presenta una
caratteristica che lo rende unico nel suo genere: si tratta della tavoletta
Leiden (Scheda Testi 5), in essa le misure del campo non sono state
ritrovate, o perché contenute nella parte frammentaria o perché mai
riportate, ma al contempo vengono indicati 10 schiavi come parte
dell'acquisto. Ciò è molto interessante in quanto il documento è un vero e
proprio kudurru, come indicato dalla formula del testo e dal materiale,
utilizzato per la tavoletta, pietra nera, il che indica che il concetto
amministrativo di campo era qualcosa di più ampio di quanto si potesse
pensare. Il fatto che i 10 schiavi siano riportati in questo documento fa
supporre che la loro proprietà sia intrinsecamente legata a quella del
campo e che forse erano dediti ad attività di coltura relative al terreno in
vendita il che farebbe pensare di conseguenza che gli schiavi, in
quest'epoca, siano dei veri e propri “optional” aggiuntivi del campo atti
forse ad alzarne il valore.
Il periodo Jemdet Nasr non ci ha restituito veri e propri kudurru il che è
molto interessante considerando che a questo periodo si ascrive una vera
propria recessione del grande sistema centralizzato del Tardo Uruk che
difatti sfocerà nelle epoche successive nella nascita delle varie città stato
mesopotamiche. Naturalmente tale assenza potrebbe essere spiegata con
l'assenza di ritrovamenti ma resterebbe da capire perché la quantità e la
distribuzione dei kudurru segua, alla luce dei dati disponibili, lo sviluppo
politico della Mesopotamia del III millennio.
Il primo kudurru che ritroviamo, dopo la pausa del periodo Jemdet Nasr, è
anche l'unico rappresentante del Protodinastico I nonché un documento
peculiare in ogni suo aspetto. E' la cosiddetta stele di Ušumgal (Scheda
Immagini e Testi 3) proveniente da Umma: si tratta di una piccola stele in
pietra, alta 22 centimetri, che presenta una sezione iscritta che avvolge il
documento, tralasciando tutte le aree occupate dalle raffigurazioni che
avvolgono anch'esse il documento. Il testo non riporta una compravendita
bensì un passaggio di proprietà da un privato ad un altro privato,
interessante è che beneficiaria del contratto sia una donna la quale risulta
in qualche modo supportata dai suoi parenti, riportati nel testo e nella
rappresentazione dell'immagine. Quale sia stata la ragione di un passaggio
di proprietà di questo tipo non ci è dato saperlo. Gelb24 propone che la
scelta della donna sia stata fatta dal proprietario del terreno in assenza di
eredi maschi. Da interpretare sono anche le immagini rappresentate: in una
di essa si vede il proprietario del terreno che stringe un cono innanzi ad un
edificio. In questa sede possiamo proporre che il donatore abbia voluto
rappresentare se stesso
mentre consegna la stele ad un edificio pubblico garantendo così la
registrazione del documento; possiamo inoltre supporre che per documenti
di questo tipo, in cui si registra il passaggio di proprietà molto vaste, la
registrazione fosse un passaggio inalienabile per garantirne la validità.
Questa tesi potrebbe aprire scenari di studio nuovi in cui si analizzano i
testi in cerca di una qualche
attestazione di un “massimo areale” oltre il quale era richiesto un
procedimento legale differente. Naturalmente è valida anche
l'interpretazione di Gelb che vede nel cono mantenuto dal donatore il
tipico cono di fondazione delle rappresentazioni di quest'epoca.
Con il Protodinastico II torniamo nella categoria più classica dei kudurru
24 Gelb, I. 1991, Earliest Land Tenure System in the Near Est: Ancient Kudurrus, Chicago, Oriental Institute Pubblications volume 104 pag. 44
che tornano ad essere documenti incisi su tavolette di pietra per quanto
attraverso tipologie peculiari. Il primo documento in esame è la “Figura
con Piume” (Scheda Immagini e Testi 4) proveniente da Girsu.
Essa presenta un punto di contatto con il documento dell'epoca precedente,
per la scelta di associare al documento una rappresentazione iconografica.
Essa è assente nei kudurru più antichi ed in quelli delle epoche successive.
Non sappiamo da cosa nasca questa necessità di coadiuvare al documento
una rappresentazione grafica e se essa indichi la natura eccezionale del
contratto o se invece sia una scelta stilistica di questa particolare epoca.
L'iscrizione della “figura con piume” è ancora dibattuta, si considera che
essa sia scritta in sumerico e che descriva l'acquisto di un terreno. Difficile
stabilire se l'acquirente o il proprietario originario sia l'autorità templare.
Fonte di dibattito è anche la relazione che potenzialmente intercorre fra
l'iscrizione e l'immagine rappresentata: in essa infatti osserviamo una
figura, forse femminile, dotata di due piume che le partono dal capo che
regge un'asta dotata di una grossa testa di mazza che sembra stare innanzi
ad altre due aste simili.
Il secondo documento del Protodinastico II è il reperto noto come
“l'uccello di Khafaja” (Scheda Immagini e Testi 2) proveniente da una
località presso Eshnunna; esso si presenta come una statuina di uccello,
secondo Gelb leontocefala, iscritta per ogni suo lato.
L'iscrizione in sumerico riporta l'acquisto di un terreno da parte di un
privato, aspetto peculiarissimo
di questo contratto, sul quale torneremo nell'ambito delle conclusioni finali
del presente lavoro, è la resa del terreno il quale viene presentato non,
come di sovente, attraverso la sua superficie, ma considerandolo come
un'insieme di circonferenze, cinque per l'esattezza, delle quali è indicato il
diametro. Tale scelta risulta anomala nell'ambito dei kudurru, ma
l'interpretazione dello spazio piano non attraverso un sistema di tipo
lineare ma con l'uso di un insieme di circonferenze è ben attestato
nell'ambito della speculazione geometrica, come poi analizzeremo nel
capitolo dedicato allo spazio geografico.
Il baricentro geografico dei nostri documenti si sposta verso nord con il
passaggio al Protodinastico IIIa ed anche in questo caso tale distribuzione
dei reperti deve farci riflettere anche perché il primo dei due documenti
proviene da Nippur (Scheda Immagini e Testi 6)e pur essendo scritto in
accadico sembra riallacciarsi ad una tradizione che ci sembra in questa
sede di poter proporre sia attestata a partire dalla fine del periodo di
Jemdet Nasr in cui il kudurru diviene qualcosa di differente, perdendo il
suo connotato di puro documento e venendo iscritto su statuine o
comunque oggetti dotati di una importante sezione iconografica.
Al contrario il secondo documento, proveniente da Kish (Scheda Testi 6),
sembra riallacciarsi ai kudurru del tardo Uruk, quasi che la tradizione
precedente, che vedeva il kudurru come qualcosa di molto simile ad un
semplice atto notarile, si sia semplicemente spostata in ambito
settentrionale poiché la tipologia dei kudurru meridionali di questo
periodo, sarebbero automaticamente ascrivibili fra le tipiche statuine o
placchette offertorie dell'epoca se non fossero dotate delle iscrizioni di
natura contrattuale che li definiscono come kudurru.
Naturalmente se da una parte queste considerazioni possono essere messe
anche in relazione con i
differenti modelli sociali ed economici presenti al nord e al sud, e quindi
ad esempio un maggiore senso estetico delle opere del sud potrebbe essere
legato ad un loro valore sacrale, va tenuto comunque presente, d'altra
parte, che queste tesi si basano su pochi reperti e possono essere confutate
da nuovi ritrovamenti.
Tornando ai due documenti di questo periodo, definiamoli con maggiore
precisione: il primo, come abbiamo visto proviene da Nippur ed è noto
come Statua di Nippur nella raccolta di Gelb, e si presenta come una tipica
statua di offerente del periodo presargonico, molto curata come è attestato
dai resti di bitume e steatite sulla superficie. Sulla schiena della statuina è
presente una iscrizione che riporta la vendita o il passaggio di venti campi
ad un privato.
Il kudurru proveniente da Kish è noto come “Frammento della Pietra di
Kish II” e riporta in accadico alcuni frammenti di iscrizione relativamente
all'acquisto di un terreno.
Il Protodinastico IIIb vede la progressiva estinzione dei kudurru-offerte al
tempio, come proposto in precedenza, anche nella zona meridionale. A
questo periodo si ascrive il “frammento di Argilla da Adab I” (Scheda Testi
11) il quale pur non essendo in pietra, come tradizionalmente tutti gli
antichi kudurru, presenta la tipica formula dei kuddurru: in questo reperto i
venditori del terreno sono due famiglie a favore di un soggetto il cui nome
è andato perduto nella parte frammentata. La vendita è piuttosto rilevante e
riguarda, oltre che le due famiglie, anche alcuni “venditori secondari” e
ben 22 testimoni.
Della stessa epoca ma proveniente da Sippar è il “DP 2 (ELT)” (Scheda
Testi 12) il quale oltre a riportare la parte relativa al contratto vero e
proprio menziona alcuni particolari del rituale del šadādum è indicato che
a presenziare al rituale e al banchetto successivo all'ufficializzazione del
contratto è presente il governatore a riprova della funzione ufficiale del
documento.
Ultimo reperto di questo periodo è di provenienza ignota e purtroppo al
momento il reperto stesso è smarrito, si tratta del “Disco di Nippur”
(Scheda Testi 10). E’ per l'appunto un disco di pietra il cui diametro
stimato è di 67 cm, e che quindi si presenta come un prodotto eccezionale
per dimensioni ma non per contenuto, in quanto dalla esigua parte
frammentaria rimasta e analizzata risulta essere un normale contratto di
acquisto di un terreno.
Il reperto, proveniente da Sippar, che ci introduce all'età accadica
nell'ambito degli antichi kudurru, è il celeberrimo Obelisco di Manishtushu
(Scheda Immagini e Testi 7). L'obelisco, che si presenta oggi alto 144 cm
ma che in origine era più alto, è il trionfo dell'autorità regia in epoca
accadica: si presenta come un vero e proprio kudurru per quel che
concerne la formulazione dei venditori e dei testimoni ma se ne discosta
per tre ragioni fondamentali: in primis colui che acquista i terreni nominati
non è né l'autorità templare, né un cittadino, bensì il re in persona il che ci
conduce al secondo punto ovvero sia la funzione di questo particolarissimo
kudurru il quale non è localizzato nel tempio per una semplice funzione di
registrazione ma in funzione chiaramente propagandistica. Tale funzione è
testimoniata anche dalla struttura del reperto, un obelisco, quasi
racchiudesse in se le due nature prima osservate del kudurru assolvendone
una terza completamente nuova: il kudurru come semplice contratto
ufficiale incontra il kudurru come “offerta alla divinità” e diviene
celebrazione del sovrano. L'ultimo aspetto particolare di questo documento
è di tipo quantitativo: la quantità di terre acquistate dal re è infatti senza
precedenti, registrando il documento una transazione di 9723 iku pari a
3430 ettari.
L'ultimo kudurru del nostro breve excursus è considerato non tanto per il
suo contenuto o per una sua peculiare caratteristica morfologica,
trattandosi di un minuscolo frammento che attesta una classica
compravendita, ma per il luogo di provenienza. Il reperto infatti (Scheda
Testi 14)
proviene da Assur. Il documento attesta la diffusione anche in piena zona
settentrionale degli antichi kudurru.
Gli Antichi kudurru non esauriscono certamente l'argomento dello spazio
amministrativo in ambito mesopotamico ma sicuramente rappresentano
uno sguardo preferenziale in quanto diretto sulla tematica dello spazio, in
questo caso il territorio. Il territorio mesopotamico che emerge dallo studio
dei kudurru è uno spazio inserito nel concetto di proprietà in maniera
complessa: proprietà nominale e reale. Un paesaggio articolato dove al
fianco delle grandi proprietà terriere quali il tempio e il palazzo si inserisce
una fitta rete di piccole proprietà capaci di relazionarsi fra di loro e con i
grandi proprietari. Per la civiltà cereagricola mesopotamica il territorio è
una proprietà e come tale è alienabile o è possibile appropriarsi di altri
territori, senza che tali mutamenti di proprietà rappresentino un trauma che
vada in qualche modo giustificato, come invece osserveremo nell'ambito
della geografia politica e religiosa.
Il territorio, vissuto da un punto di vista amministrativo, presenta
numerose variabili: il terreno può essere dotato di braccianti inclusi
(Scheda Testi 5), può essere pagato in argento o rame (rispettivamente
Scheda Testi 10 e Scheda Immagini e Testi 6) ma anche in abiti (Scheda
Testi 11), ma soprattutto può essere misurato come la superficie di un
poligono o come il diametro di una circonferenza (Scheda Immagini e
Testi 2).
Il risultato di questa prima analisi dei kudurru sembra dimostrare che il
mondo geografico amministrativo mesopotamico non è soggetto, a
differenza di quello politico e religioso, a particolari regole culturali, ma
piuttosto a stringenti necessità pratiche.
Gli altri documenti dell'amministrazione territoriale.
Naturalmente gli antichi kudurru non esauriscono la grande e variegata
produzione amministrativa mesopotamica del III millennio, anche
rimanendo limitati ai parametri temporali che ci siamo prefissati. Se è vero
infatti che gli antichi kudurru erano, come abbiamo visto, documenti
investiti di una qual certa ufficialità e riportanti sempre transazioni
secondo formule ben definite e standard a riprova della loro importanza, va
anche detto che esisteva un insieme di documenti atto a gestire le
transazioni economiche quotidiane, alcune delle quali riguardavano anche
terreni. Abbiamo già spiegato come l'evoluzione della pratica di
registrazione delle operazioni economiche ed amministrative sia
intrinsecamente legata allo sviluppo dello stato in Mesopotamia e quindi
prima ancora dei miti e delle scene di natura politica, le prime
rappresentazioni delle glittica riguardano proprio attività di natura
economica, di certo investite anche di carattere sacro, ma soprattutto
sociale. Eppure le nostre nozioni riguardo a transazioni di proprietà terriere
e quindi relative alla gestione dello spazio, che è l'argomento che ci
interessa, sembrano dover partire solo dall'avvento della scrittura. Solo con
i testi abbiamo le prove di un'alienazione sostanziale, anche se non ancora
formale, dei terreni da parte dell'autorità templare a favore di quella
privata, o viceversa l'appropriazione di una proprietà privata da parte del
tempio, o infine le tracce di un passaggio di terreni da privato a privato.
Come si è già detto la quantità di documenti a riguardo è virtualmente
illimitata, ed avendo già approfondito l'argomento degli “antichi kudurru”
si è pensato di considerare un'area campione e di osservare il cambiamento
dei documenti amministrativi nel corso del tempo. L'area in questione è la
città di Ur e i tempi presi in considerazione sono il Tardo Uruk, la Prima
dinastia di Ur e la Seconda dinastia di Ur. Il primo reperto preso in
questione è proprio il più antico (Scheda 1 Immagini) e si tratta, come
spesso accade per reperti così antichi, di un'impronta di sigillo. In essa
troviamo la rappresentazione di un uomo seduto fra due strutture
probabilmente templari intento a lavorare vicino ad un vaso e ad un bovino
che fuoriesce da una delle due strutture. Dougherty propone che in questo
sigillo venga riportato lo svolgimento di un qualche tipo di attività lattiera-
casearia. Lo spazio amministrativo qui è solo accennato ed è percepibile
dall'analisi del reperto in sé e dell'immagine che esso riporta. Essendo un
sigillo la sua funzione era naturalmente quella di garantire la paternità
delle azioni svolte dal proprietario dello stesso in ambito economico e
sociale, allo stesso modo l'attività svolta dalla figura rappresentata nel
sigillo ne identifica un ruolo economico legato alla gestione e al possesso
dei bovini. Lo spazio amministrativo inteso come gestione dello spazio in
ambito economico qui non è ancora espresso o se lo è, ciò avviene in
maniera appena accennata di modo che non ci sia possibile comprendere
realmente in che modo l'attività svolta nella rappresentazione di questo
sigillo, come di altri simili, abbia influenzato lo spazio circostante. Con
l'avvento della scrittura la situazione cambia radicalmente e, come
abbiamo già visto per gli antichi kudurru, la gestione dello spazio diviene
una fetta importante dell'amministrazione. Il primo reperto risalente alla I
dinastia di Ur è stato ritrovato nel cimitero reale di Ur e si tratta di una
tavoletta d'argilla piuttosto frammentaria (Scheda 21 Testi). A causa dello
stato del reperto l'interpretazione di Burrows è piuttosto scarna ma è chiaro
che il reperto riporta l'acquista di un terreno, anche se non è chiaro chi sia
l'acquirente e chi il venditore, anche se, considerando la semplicità del
reperto, siamo spinti a credere che si tratti di un documento redatto per una
transazione fra due privati. Va anche osservato però che il reperto presenta
una curiosa anomalia: la parte centrale del reperto è stata intenzionalmente
lasciata vuota il che apre un ventaglio di ipotesi da formulare: potrebbe
darsi che il reperto sia rimasto incompleto ed il contratto non fu mai
terminato, allo stesso modo può darsi che lo scriba non avesse considerato
bene lo spazio sulla tavoletta e semplicemente le righe mancanti sono
“avanzate”, può anche darsi che il documento sia solo un appunto per la
stesura di un documento ufficiale su materiale più resistente (il che lo
collocherebbe nell'ambito degli antichi kudurru). Allo stato delle nostre
attuali conoscenze è comunque prudente formulare l'ipotesi che si tratti di
un documento semplice per una piccola transazione fra privati, similmente
ad un odierno scontrino fiscale. Lo spazio amministrativo assume sempre
più l'aspetto di un puzzle dinamico, sottoposto a numerose sollecitazioni e
trasformazioni, in evidente contrasto con il monolitico mondo dello spazio
mitico e politico, come vedremo nei capitoli successivi. Anche il prossimo
reperto, risalente sempre alla I dinastia Ur (Scheda 19 Testi), è infatti il
frammento di un contratto molto elementare che attesta l'acquisto di un
terreno. Il reperto successivo (Scheda 20 Testi) è ancora un contratto di
acquisto di terreno e proviene anch'esso dal cimitero reale di Ur e risale
alla I dinastia di Ur. In questo caso l'acquisto è sicuramente fra due privati
ed anche in questo caso il materiale del documento è semplice argilla. Va
notata una particolarità. Esattamente come il reperto analizzato in
precedenza (Scheda 21 Testi), anche in questo caso è stata lasciata una
parte della tavoletta intenzionalmente vuota, in questo caso l'ultima riga.
Pur considerando la natura similare contenutistica dei due elementi è
azzardato ipotizzare una relazione fra questa mancanza e quella del reperto
precedente, per quanto tale vuoto preparato va segnalato. Con il prossimo
documento (Scheda 11 Immagini e Testi) ci spostiamo avanti nel tempo, al
tempo della II dinastia di Ur, e osserviamo come il documento di acquisto
e vendita di terreno sia ora complesso ed articolato e intorno alla semplice
transazione si sia sviluppata tutta la struttura economica e sociale ad essa
connessa. Appaiono ora i nomi degli acquirenti e dei venditori, appare il
potere templare che garantisce la transazione per mezzo di un suo
rappresentante (il giudice del re), appare il giuramento innanzi agli dei,
appaiono anche i testimoni, appare un'indicazione temporale ben precisa
che si allaccia alla classificazione degli anni secondo le gesta del re.
Soprattutto appare una definizione più precisa del campo al centro del
contratto. Ne viene indicata con precisione l'estensione e la spesa
necessaria all'acquisto, e quindi implicitamente il suo valore. Inoltre viene
indicata la natura, difatti il campo non è anonimo ma sappiamo che si
trattava di un palmeto. Comprendiamo quindi che, anche fuori dall'ambito
dell'ufficialità degli antichi kudurru, almeno a partire da quest'epoca, anche
le transazioni economiche relative alla gestione dei campi, fra privati, sono
giunti ad un livello di complessità pari a quelle fra istituti pubblici, segno
di una maggiore complessità della gestione dello spazio privato e di
maggiori garanzie richieste dal privato cittadino.
Capitolo 3
Spazio mitico nella Mesopotamia del III millennio a.C.
La Religione e il Mito
Lo studio della percezione dello spazio geografico in ambito mitico si
presenterà come un lavoro trasversale che indagherà diversi ambiti. Come
più volte ricordato nei capitoli precedenti nel mondo mesopotamico non
esisteva una distinzione categoriale marcata fra magia, scienza, politica e
religione. Il tempo del mito presso i popoli della mezzaluna fertile non era
solo, come per la cultura Greca prima e Romana poi, un momento arcaico
di fondazione degli elementi cruciali della realtà, da un punto di vista
ontologico e sociale25. In Mesopotamia il tempo del mito era
continuamente scandito dalla vita quotidiana e le feste pubbliche, i riti e gli
incantesimi rifondavano in continuazione la realtà. Un esempio piuttosto
lampante di questo continuo processo di rinnovamento cultuale era dato
dai confini politici che si consideravano fossero stati stabiliti dagli dei in
persona. Tali delimitazioni erano naturalmente soggette alle continue
fluttuazioni della storia ed il mito si adattava di conseguenza. Bisogna
sempre tenere presente che la religione politeistica mesopotamica non era
25 Eliade M. 1957, The Sacred and The Profane: The Nature of Religion, New York, Harvest/HBJ Publishers pagg. 34-36
una religione “rivelata” e non vi erano testi che dessero un'univoca
interpretazione del mito, e di conseguenza degli spazi del mito. Lo stesso
concetto di “canonizzazione” dei testi è qualcosa di molto tardo e che non
si affermerà prima del II millennio a.C. in ambito babilonese26. Se si vuole
quindi elaborare un approccio scientifico al concetto di Mito, Tradizione e
Religione bisogna tenere presente la loro natura culturale, la loro funzione
sociale, ed anche, si ritiene in questa sede, il loro rapporto con la Storia. In
primis bisogna tener presente che troppo spesso si tende a dimenticare che
la parola Mito è nata nell'ambito dello studio delle religioni del mondo
classico, un mondo che non solo aveva prodotto un termine per designare
con esattezza il mito, ma che ben presto gli aveva contrapposto il concetto
di Storia e di storiografia: istoria. La storia era il frutto di osservazioni
veritiere mentre il mito ben presto venne relegato al ruolo di favole dal
valore sacro 27. Nel mondo mesopotamico tale distinzione non è mai
esistita, l'unico concetto simile, e che riassume quello di mythos e di
istoria è temu šakanu, traducibile con notizia, informazione.
Paradossalmente il termine più vicino a tale concetto è una parola nata
nell'ambito dell'informatica: il dato28. I dati, nelle raccolte mesopotamiche,
26 Mander, P 2005, All'origine delle Scienze 1. Medicina ed Esorcistica in "quaderni Napoletani di Assirologia", Napoli, Aracne pagg. 48-52
27 Luciano di Samostata 2001 Come si deve scrivere la storia, Roma, Liguori Editori pag. 1528 Huehnergard J. 2005, A Grammar of Akkadian, Charlottesville, Eisenbrauns pag. 568
venivano raccolti in fasci per ottenere da essi un insieme coerente.
Naturalmente i dati erano di varia natura e le nostre categorie mentali
attuali li dividono in dati storici e mitici. La Storia, o per meglio dire la
Tradizione, era qualcosa di complesso che non aveva in sé, come abbiamo
già detto, un confine ben preciso rispetto alla sfera del sacro, secondo un
procedimento ben noto anche per la medicina mesopotamica, laddove le
pratiche scientifiche si mischiavano e si integravano con atti di natura
magica e rituale. Solo alla luce di una simile prospettiva quanto anticipato
diviene chiaro e si comprende perché ogni re che abbia lasciato traccia di
se e delle sue gesta, non si limitò a dichiarare solennemente il suo atto di
fondazione o di conquista, bensì collocò quella data azione nella sfera del
sacro, rifondando in continuazione il mito. Allo stesso modo ogni qual
volta un re si riforniva di legname presso la foresta dei cedri egli
ripercorreva l'antica strada già percorsa dal divino Ghilgamesh, ogni qual
volta il tempio veniva restaurato esso era stato rifondato così come quando
il dio, al tempo delle origini, si era costruito la sua prima casa, ed
addirittura abbiamo il caso di un mito, “Viaggio di Nanna a Nippur” che
altro non è che la trasposizione sacra dello spostamento del re UrNammu
alla sacra città di Nippur per ragioni politiche29. La storia quindi era
29 Biga M. G. 2008, Il Politeismo Vicino-Orientale,Roma, pag. 216
sempre legata alla sfera religiosa e collocava quegli avvenimenti sempre
nuovi, in un ambito che se per noi è alieno, favolistico e lontano, era per
l'uomo mesopotamico, quotidiano e sentito. E' probabile, ma non sicuro,
che gli stessi uomini mesopotamici avessero ben presente il significato
simbolico di molte di quelle espressioni e che semplicemente le
contestualizzassero.
Un primo punto obbiettivo di questo lavoro è la messa in luce di quei
simboli ricorrenti nell'ambito dello spazio geografico in ambito mitico.
L'elasticità della religione mesopotamica comporta che il mondo
macroscopico potesse essere visto in più modi. Già nell'introduzione, nel
paragrafo titolato “La Religione e il Mito”, è stata esposta la forma del
mondo mesopotamico secondo i maggiori studiosi. In questa sede si
cercherà di trovare gli elementi ultimi che componevano quella visione del
mondo nei reperti del nostro catalogo partendo dai più antichi fino a quelli
più recenti.
Le Immagini dello spazio mitico in Mesopotamia
Il primo reperto analizzato mostra una scena molto ricorrente
nell'iconografia mesopotamica e che pone in risalto la funzione principale
del tempio come perno della società e centro ideale della città e della sua
articolazione sociale (Scheda 20 Immagini).
Si tratta di una cretula ritrovata ad Uruk ed ascrivibile al 3200 a.C. ca.; su
di essa, fortemente frammentaria e danneggiata riconosciamo un tempio,
rappresentato mediante la raffigurazione della facciata e delle porte,
intorno al quale si collocano alcuni uomini nudi che probabilmente stanno
portando doni presso la struttura sacra.
La scena pone in risalto la funzione economica/sacra del tempio già
presentata nel primo capitolo: la popolazione offre dei doni al dio, che
risiede nella sua casa posta nel cuore del città, e da lì i suoi servitori
redistribuiscono la ricchezza a tutta la comunità. La cretula mostra in
sostanza il cuore dell'asse orizzontale di cui già sia è parlato in precedenza,
e come esso lavori affinché l'opera del dio, attraverso l'azione dei
sacerdoti, si propaghi lungo tutto l'asse orizzontale fino alla periferia della
città.
Similmente al reperto sovra esposto anche quello successivo (Scheda 4
Immagini) mostra una scena che pone in risalto la funzione fondamentale
del tempio come cuore pulsante della società ma in questo caso la funzione
economica sembra espressa con maggiore chiarezza.
Si tratta di un sigillo proveniente da Ur che si colloca fra il 3100 a.C. ed il
2900 a.C. . Su di esso troviamo rappresentati due uomini collocati di
fianco al tempio che lavorano alcuni vasi, dal tempio stesso esce un
bovino.
Troviamo, quindi, riassunti in maniera stilizzata le due principali
operazioni svolte dal tempio: la fissazione dei ruoli dei vari cittadini
nell'ambito della vita in città, rappresentato dai due uomini che lavorano, e
la distribuzione del cibo e della ricchezza, rappresentato invece dal bovino
che esce dal tempio.
Una menzione particolare va al tempio stesso rappresentato in questo caso
come una capanna dotata di due grosse paia di corna che fuoriescono dal
tetto. Sul tempio è possibile distinguere un simbolo che Legrain30 ha
interpretato come un serpente dal valore apotropaico, forse indicante anche
a quale divinità fosse assegnato il tempio e comunque prova del valore
sacro della struttura rappresentato.
La rappresentazione del tempio in associazione ad un simbolo sacro, atta
alla valorizzazione della struttura e ad un riconoscimento immediato dello
stessa nell'ambito cittadino, la ritroviamo nel reperto seguente (Scheda 5
Immagini).
Si tratta di un sigillo proveniente da Ur e contemporaneo a quello
precedente; su di esso vediamo rappresentato il tempio come una capanna
30 Legrain, L. 1936, Archaic Seal-Impressions in Ur Excavations Volume III, Philadelphia The Trustees of the Two Museum pagg. 18-33 Tavola 17
di cui è mostrato anche il soffitto mediante un gioco di prospettiva che
schiaccia il soffitto aprendolo a ventaglio sopra la facciata del tempio.
Sulla destra del tempio intravediamo la parte posteriore di un toro, che
richiama ancora una volta l'attività economica svolta dal tempio. Sulla
sinistra invece osserviamo il simbolo sacro di cui si è parlato prima che in
questo caso è un aquila raggiante le cui dimensioni sono di poco inferiori
al tempio a cui si associa.
Il reperto successivo (Scheda 7 Immagini) è stato scelto per il suo valore
semantico. Si tratta di un altro sigillo proveniente sempre da Ur e sempre
ascrivibile ad un intervallo di tempo che va dal 3100 a.C. al 2900 a.C. . In
esso vediamo rappresentate, in maniera stilizzata, tre città fortificate ed
ecco che possiamo osservare come il valore del tempio, come centro della
città e si potrebbe dire come vera e propria anima della comunità, assuma
in questo caso una funzione di vera e propria identificazione.
L'autore del reperto, infatti, per distinguere le tre città, ha assegnato ad
ognuna di esse un simbolo: un avvoltoio, un simbolo non ancora
identificato che in questa sede proponiamo essere una barca, ed un
serpente. Il simbolo del tempio, e del dio che esso ospita, diviene qui
simbolo della città, che Legrain31 ha interpretato essere Larsa, Adab e Der.
31 Legrain, L. 1936, Archaic Seal-Impressions in Ur Excavations Volume III, Philadelphia The Trustees of the Two Museum pagg. 18-33 Tavola 22
L'ultimo reperto (Scheda 6 Immagini) proveniente da Ur e relativo al
3100-2900 a.C. è un sigillo che mostra una scena dove l'elemento
simbolico ha preso completamente il sopravvento su quello
rappresentativo al punto da indurre Wolley32 a suggerire che si tratti di una
proto-iscrizione o di un insieme di immagini che richiamino dei
logogrammi atti a indicare una frase di senso compiuto.
Al centro della scena osserviamo il tempio, rappresentato oramai solo
come un grande cancello in pannelli di fibbie dove le corna laterali sono
appena accennate. Ai lati di questo troviamo due stelle a rosette a 8 punte.
Una rosetta molto più grande, probabilmente anch'essa ad 8 punte, delle
stesse dimensioni del tempio, è posta alla sua sinistra.
Gli elementi sopra il cancello e alla sua destra sono di difficile
interpretazione. Forse è possibile vedere un sole che sorge fra alcune foglie
e più in là due scimmie accovacciate. I simboli sopra il tempio sono
talmente stilizzati da sembrare aniconici.
Il prossimo sigillo (Scheda 11 Immagini) è probabilmente di un'epoca
successiva, collocandosi non prima del 3000 a.C. e proveniente
probabilmente da Susa.
Il tempio è ancora, in questo reperto, il centro della vita economica della
32 Wolley, L. in Legrain, L. 1936, Archaic Seal-Impressions in Ur Excavations Volume III, Philadelphia The Trustees of the Two Museum Tavola 22
città ma i simboli sacri che lo caratterizzano vengono esternati da esso,
moltiplicati e posti in processione insieme agli elementi relativi alle attività
gestite dal tempio, in questo modo le due realtà sfumano confondendosi e
compenetrandosi l'un con l'altra.
Vediamo così come di fianco ai grandi portoni della facciata del tempio si
collochi un gruppo di elementi quali alcuni caprovini, pentole per le
libagioni al tempio, e poi ancora scorpioni ed un serpente. In particolare
Borowski33 ha interpretato la presenza di questi animali come l'indicazione
della consacrazione del tempio rappresentato alla dea Inanna.
Se il tempio è il centro dell'asse orizzontale è, naturalmente, anche un
punto attraverso il quale passa l'asse verticale di cui già si è parlato nel
primo capitolo, e che connette il mondo degli abissi alla terra degli uomini
e quest'ultima ai cieli abitati dalle divinità. Anzi il tempio è il punto di
partenza preferenziale attraverso cui l'uomo può aspirare di risalire,
spiritualmente parlando, la strada che conduce agli dei.
Nel reperto successivo del nostro catalogo (Scheda 18 Immagini),
proveniente dal Dyala e prodotto intorno al 2900 a.C., tale concetto è
espresso in maniera chiarissima: il tempio è rappresentato canonicamente
attraverso la sua facciata, sopra di esso si distingue la curva della volta 33 Borowski E. 1993, "Introduction" in J G Westenholz Seals and Sealing in the Ancient Near East
- Proceedings of the Symposium held on September 2, Gerusalemme, Bible Lands Museum pag. 21
celeste e sopra di essa tre stelle, di fianco ad esse è rappresentato un
grande volto, espresso mediante gli occhi, le ciglia, il naso e la bocca, che
sembra guardare il tempio. Simile reperto, così esplicativo e al contempo
così enigmatico non ha confronti nell'arte del Dyala.
In precedenza abbiamo spiegato come lo spazio geografico mitico
mesopotamico non investa solo le zone inaccessibili del reale quali la volta
celeste o le profondità abissali. Il mito, il sacro, investivano luoghi
quotidiani.
Oltre alle regioni ben note caricate di un significato mistico come la
foresta dei cedri o le montagne degli Zagros, ce ne sono altre i cui echi ci
giungono attraverso pochi accenni nei testi o, come nel caso seguente, da
rappresentazioni di carattere mitologico collocato però in un ambiente
reale il cui significato ci sfugge e la cui identificazione è ardua.
Il reperto in questione (Scheda 15 Immagini) è un sigillo del 2900 a.C.
proveniente sempre dalla zona del Dyala. In esso troviamo rappresentato
un edificio a cinque piani dotato di tre torri, che sembra richiamare ad un
ambiente cittadino, di fianco ad esso però la scena è chiaramente di stampo
mitico. Su alcuni flutti, rappresentanti probabilmente il fiume, è
rappresentato un uomo dalla testa di leone, o un leone dritto sulle zampe
posteriori, stante fra due alberi attorniati da caprovini e un uccello fra le
sue fronde.
Non ci è dato sapere se questa immagine richiama ad un mito in
particolare o ad un'iconografia sacra condivisa; una difficoltà che
incontriamo in molti altri reperti come un sigillo (Scheda 8 Immagini) del
2600 a.C. ca dove la scena mitologica ha preso il sopravvento
sull'elemento reale e diventa per noi di difficilissima interpretazione.
In altri casi invece la rappresentazione è ugualmente ermetica ma grazie al
confronto con testi noti alcuni studiosi si sono spinti verso
un'interpretazione più precisa, come il sigillo del 2500 a.C. ca proveniente
dalla zona del Dyala, che mostra un uomo barbuto fra gli stipiti di un
portone sotto il quale giace uno scorpione che Frankfort34 ha interpretato
come il guardiano del portale, considerandolo una versione alternativa del
celebre uomo scorpione che nell'epopea di Ghilgamesh è posto a difesa dei
cancelli del sole.
L'uomo scorpione, associato alla figura del sole, lo ritroviamo anche in un
altro sigillo (Scheda 13 Immagini), proveniente da Tell Brak e da
collocarsi intorno al 2400 a.C. ca. , anche se in questo caso è iscritto in una
scena la cui interpretazione è ardua. Difatti esso rappresentato mentre
viene atterrato da un uomo armato di lancio e dotato di coda.
34 Frankfort, H. 1951, Stratified Cylinder Seals from the Diyala Region, Chicago, University of Chicago Oriental Institute Publications Volume LXXII pag. 88
Il reperto ora citato e i due successivi ci permettono di ricordare che
naturalmente, nello studio dell'iconografia mesopotamica, oltre alla
collocazione del mito in ambiti reali ben precisi, ritroviamo anche la
trasposizione del mito in quanto tale, nel quale lo spazio geografico
diviene semplice scenario stilizzato, ovvero sia un richiamo non ad una
specifica montagna o uno specifico bosco bensì al concetto di montagna e
di bosco, con tutte le implicazione cultuali del caso.
Il primo reperto (Scheda 9 Immagini) risale al 2300 a.C. ca. e mostra un
dio, accompagnato da un demone dal volto di leone, mentre uccide un
toro. L'animale è collocato sulla montagna così come essa veniva
canonicamente rappresentata nell'arte mesopotamica, e se ci sfugge il mito
in particolare che l'immagine richiama, conosciamo le implicazioni
concettuali che il simbolo della montagna richiama.
La montagna è infatti il confine fra il il mondo civilizzato e quello
nomade, nonché la principale forma di demarcazione fra il centro e la
periferia, essa è inoltre il luogo attraverso cui l'uomo può incontrare il dio
e le stesse zigurat non sono che un richiamo a questa imponente struttura
naturale35.
Il secondo reperto (Scheda 10 Immagini) , avente come soggetto un
35 Mander, P. 2005, All'origine delle Scienze 1. Medicina ed Esorcistica in "quaderni Napoletani di Assirologia", Napoli, Aracne pag. 32
racconto prettamente mitico, è un sigillo proveniente da Sippar e posto al
limite cronologico del nostro lavoro essendo stato prodotto intorno al 2250
a.C. . In esso vediamo rappresentato il celebre mito di Etana.
Aldilà della rappresentazione del re pastore che si leva in volo a dorso di
aquila, ciò che ci interessa è la presentazione dello spazio intorno ad essa.
Concordemente alle versioni del mito che ci sono pervenute, il sigillo ci
riporta un paesaggio pastorale presentato nei minimi dettagli come se
l'autore del sigillo avesse collocato il mito in una scena a lui familiare: il
pastore che osserva Etana levarsi in volo è posto fra le sue pecore e
accompagnato dal suo cane mentre impugna la frusta e trasporta a spalla
una staffa. Vicino a lui un uomo lavora ad un vaso e sopra di loro,
stilizzati, sono presentati dei formaggi posti ad asciugare al sole.
In chiusura di questo paragrafo dedicato alle immagini dello spazio mitico
in Mesopotamia nel III millennio poniamo un reperto più antico dei
precedenti ma che abbiamo preferito presentare solo ora a causa del suo
significato. Abbiamo infatti mostrato come l'uomo mesopotamico abitasse
lo spazio intorno a sé dei simboli sacri del mito, abbiamo anche visto come
i luoghi della sacralità erano anche il centro di un rapporto inscindibile fra
culto e ordine sociale, ed abbiamo infine osservato il mito riportato nella
sua genuina sostanza. Ma l'uomo mesopotamico era anche impegnato nella
creazione dei luoghi sacri e indubbiamente fra tutti i templi il più sacro nel
corso dei secoli si definì essere la zigurat. La costruzione della zigurat
doveva essere un momento fondante della società mesopotamica: il mito
della fondazione della casa del dio e della città intorno ad essa veniva
rinnovato, lo spazio sacro per eccellenza veniva creato con la stessa
sacralità assegnata al periodo delle origini e assumeva la forma imponente
e sacra della montagna. L'intera comunità si riuniva per questa opera sotto
la guida della casta sacerdotale e si dava per scontato che anche il mondo
divino facesse lo stesso. La centralità della zigurat, la comunità riunita per
la costruzione della stessa e la presenza rassicurante degli dei, è tutto
riassunto in un sigillo del 2500 a.C. ca. proveniente dal Dyala e
commentato da Frankfort36 che mostra proprio questo momento
fondamentale per la società mesopotamica e per la definizione dei suoi
spazi sacri.
La nostra dissertazione sullo spazio mitico in Mesopotamia nel III
millennio a.C. non ha fatto affidamento sui testi ma in larga parte sulle
immagini e la ragione è semplice: se esistono numerosi testi che trattano
della mitologia in quanto tale non ne esistono altrettanti che permettano
riflessioni sullo spazio mitico in Mesopotamia.
36 Frankfort, H. 1951, Stratified Cylinder Seals from the Diyala Region, Chicago, University of Chicago Oriental Institute Publications Volume LXXII pag. 48
Riportare nella nostra ricerca i testi che parlavano specificatamente di miti
sarebbe stato improprio e fuorviante essendo questo elaborato un lavoro di
archeologia e non di storia delle religioni. Inoltre miti che permettano essi
stessi di analizzare come lo spazio era percepito in ambito mitologico per
via dei loro contenuti non verranno prodotti che a partire dall'inizio del II
millennio a.C. ed esulano quindi dal nostro ambito di ricerca.
Ciò nonostante esiste un reperto del nostro catalogo che può essere
ascritto al gruppo dei reperti che trattano dello spazio mitico. Si tratta di
una tavoletta (Scheda 18 Testi) che riporta la descrizione di una
purificazione effettuata su di un terreno contro locuste e bruchi.
Colui che ha effettuato tale operazione è un sacerdote o comunque un
uomo del culto ed infatti alla descrizione delle tecniche usate per purificare
il campo segue una purificazione rituale del terreno. In questo caso è la
gestione pratica di un campo il luogo dove l'aspetto economico, il danno
effettivo provocato dall'infestazione del campo e le contromisure adottate,
e quello religioso, il sacrificio rituale al termine delle operazioni di pulizia,
si mischiano, si compenetrano e si confondono facendo sfumare il reale
confine fra queste due realtà nella percezione dello spazio presso gli
abitanti della Mesopotamia del III millennio a.C.
Capitolo 4Spazio politico nella Mesopotamia del III millennio a.C.
Nel confrontarsi con la percezione dello spazio politico della mesopotamia
del III millennio a.C. non si può fare a meno di di constatare quanto
l'invenzione della scrittura abbia influenzato la nostra conoscenza di
questo particolare settore della società. Se l'archeologia e la storia delle
religioni permettono di indagare numerosi e fondanti aspetti di una società,
molti dei quali non trasparirebbero dal solo dato scrittorio, al contempo il
mondo politico di un popolo si compone di nomi, date precise, e
propaganda, tutti elementi che possono essere trasmessi, alla luce delle
nostre attuali tecniche archeologiche, solo attraverso la scrittura37. Ciò non
significa che il dato archeologico sia irrilevante, ma esso va collocato in
un'impalcatura desunta da dati trasmessici dai testi.
Affinché tale procedimento di sistemazione dei reperti in un quadro
coerente possa essere compiuta nel massimo rispetto di una metodologia
storica e archeologica seria bisogna considerare che il dato testuale è, nella
maggior parte dei casi, propagandistico. Ciò comporta che l'informazione
trasmessa sia deformata e capziosa, ma al contempo dallo studio di queste
deformazioni è possibile desumere altre informazioni, come quali fossero i
37Liverani, M 1988, Antico Oriente, Roma, Laterza pagg. 191-193
veri interessi che la propaganda cercava di soddisfare e chi fosse il
pubblico di riferimento.
Le nostre informazioni sull'assetto politico, più che strettamente
territoriale, non possono essere raccolte per un periodo precedente al
Protodinastico II, almeno nella misura in cui si vogliono seguire le strade
tracciate dalla storiografia. Questo perché, è solo dal Protodinatico II che i
testi iniziano a delineare una situazione politica ben definita.
Dal Protodinastico II al Protodinastico IIIa
Il lungo periodo che va dal 2750 ca. a.C. fino al 2450 a.C. presenta una
serie di caratteristiche comuni dal punto di vista politico per tutti i secoli
presi in considerazione. Con la fine del Protodinastico I osserviamo una
vera e propria esplosione culturale, sociale ed economica che si
caratterizza per un accentuato policentrismo. Il potere politico più che
parcellizzarsi sembra moltiplicarsi con una trasformazione e strutturazione
di tipo complesso di nuovi centri al fianco di Uruk, Ur ed Eridu. Ad oriente
osserviamo emergere centri come Lagash ed Umma, nell'area centrale
Adab, Shurrupak e Nippur e a nord Kish ed Eshnunna38.
Ognuna di queste città è inserita al centro di un sistema radiale la cui
estensione è sempre di circa 30 chilometri, che vede la grande città posta al
38Landsberger, B. 1976, The Conceptual Autonomy of the Babylonian World, Malibu
centro di una maglia di centri intermedi, intorno ai quali si sviluppano i
piccoli villaggi39.
La composizione etnica di queste città è fin dall'inizio mista per quanto
nell'origine dei termini linguistici si intravedono le antiche distinzioni e i
differenti ruoli che sono stati alla base della nascita della grande città
mesopotamica, laddove i termini presumerici ed iranici sembrano connessi
con le funzioni produttive di base, i termini sumerici con quelle
amministrative e burocratiche ed infine quelli semitici con tutte quelle
attività legate alla mobilità ed al trasporto40.
Inoltre una qualche distinzione etnica per area sopravvisse anche in epoca
storica con il gruppo sumerico maggioritario al sud e quello semitico più
diffuso al nord41.
Incarnazione del potere nelle varie grandi città era una figura centrale la
cui titolatura cambiava di città in città e tradiva una differente natura del
potere esercitato.
Ad Uruk troviamo l'En, ovvero sia il gran sacerdote, tale nomenclatura
regale non poteva che segnalare una grande continuità con il potere
templare classico.
A Lagash invece il signore della città era detto Ensi, cioè fattore del dio. 39Gelb I. 1969 in Studi E. Volterra, VI, Milano, pagg. 137-15440Foster B.R. 1982, Orientalia 51, Roma pagg. 297-354 41Diakonoff I. 1969, Ancient Mesopotamia, Mosca
Questa titolatura è già molto differente in quanto il re formalmente era
sottoposto alla figura del dio cittadino ma di fatto si collocava già fuori
dalla struttura templare canonica.
I titoli di En ed Ensi sono già attestati dal periodo Tardo Uruk.
Completamente diverso è il significato politico che traspare dal nome del
re ad Ur e Kish, ovvero sia Lugal, poiché questa parola è l'unica che può
essere realmente tradotta con re, e indica il monarca, uomo fra gli uomini
privo di alcuna investitura sacra42.
Un simile scenario provocò la nascita di numerosi conflitti, la maggior
parte dei quali legati al controllo dei canali, questo per due ragioni.
Da una parte, molto spesso, gli stessi canali approvvigionavano aree
controllate da differenti città o le stesse erano in qualche modo collegate
trovandosi l'una a valle e l'altra a monte dello stesso canale con tutti i
vantaggi e gli svantaggi che la differente posizione provocava e le naturali
influenze dell'una sull'altra.
In secondo luogo il possesso dei canali, e dei relativi territori coltivati, era
l'unico modo per tentare di espandere l'influenza della città.
Come già esposto nell'introduzione, tali conflitti erano inseriti in un
contesto culturale che vedeva tali scontro come un confronto fra le varie
42Cooper J. 1973, Orientalia 42, Roma pagg. 239-242
divinità cittadine laddove gli ensi e gli en altro non erano che semplici
intermediari dell'agire dei loro numi tutelari. La propaganda quindi, in
questo periodo, era tutta tesa a creare un immagine di un re nemico
ingiusto e tracotante che con il suo agire aveva offeso gli dei attirando su
di se la collera degli stessi43. Altra caratteristica del programma
propagandistico era il dimostrare che non si stava attaccando, ma ci si
stava difendendo; per fare ciò, anche laddove era palese che ci si era presi
l'onere dell'attacco, si tendeva a riportare esempi passati che dimostrassero
come, in un primo tempo, si fosse ricevuta l'offesa dell'attacco e che
l'azione che si intraprendeva ora altro non era che un modo di ripagare il
torto subito.
Un esempio caratteristico di questi confronti è il conflitto decennale che
vede contrapposte Umma e Lagasg per il controllo del gu-edinna, un
campo posto in mezzo delle aree di influenza di queste due città44. Lo
svolgersi del conflitto ci è riportato in quello che può essere considerato il
primo grande impianto propagandistico mesopotamico, cioè la grande
Stele degli Avvoltoi, voluta dal vittorioso Eannatum di Lagash. Aldilà dei
fatti in essa narrati, che presentano comunque una Lagash sempre pia e
giusta contrapposta ai re di Umma tracotanti e aggressivi, possiamo da 43Pettinato, G. 1970, Mesopotamia 5, Roma pagg. 281-32044Cooper J. 1983, Reconstructing history from ancient inscriptions : the Lagash-Umma border conflict, Los
Angeles, Source of the Ancient Near Est
essa desumere due informazioni importanti.
In primo luogo essa ci da un'idea di cosa dovessero essere i conflitti
intercittadini protodinastici, che concretizzavano in una serie di
rappresaglie e battaglie campali svoltesi fuori dall'abitato; in secondo
luogo ci trasmettono un dato importante che ci preannuncia il tema del
seguente paragrafo: arbitro della prima fase del conflitto è il Mesilim di
Kish (2550 ca. a.C.) il quale viene chiamato a dirimere i primi contenziosi
sul campo in questione. Il ruolo del quale viene investito il re di Kish ci
lascia intuire che in quel periodo la città dovesse ricoprire un ruolo
predominante nel meridione mesopotamico, preannunciando, in forma
ancora piuttosto superficiale l'anelito delle epoche successive alla
formazione di uno stato unitario che raccogliesse l'intera Mesopotamia o
per lo meno il sud urbanizzato.
Ma i conflitti per il controllo dei canali non esaurivano le azioni di politica
estera delle città mesopotamiche. Oltre ad una fitta rete di commerci che si
estendeva fino ai limiti del mondo mesopotamico e anche oltre, e che
contribuì alla creazione di un'idea di mondo compreso fra il mare superiore
ed inferiore oltre il quale non valeva la pena spingersi, di cui già si è
parlato nell'introduzione, le grandi città del meridione organizzavano di
sovente spedizioni a lungo raggio in Susania e Mesopotamia Centrale. Tali
razzie avevano il compito di raccogliere ingenti quantità di quelle materie
prime difficili da reperire in patria e molto costose da percepire con il
commercio convenzionale45.
Dall'idea di Impero Universale all'Impero Accadico
Con la fine del Protodinastico IIIa si fa sempre più prepotentemente largo
l'idea di un impero universale che raccolga in sè tutto il mondo.
Un altro tipo di unificazione e di accentramento era del resto stato attuato
anche se in un ambito molto diverso.
La città Nippur era infatti unanimamente riconosciuta come la città sacra
per eccellenza, sede del dio supremo Enlil, superiore, in tutto l'alluvio, a
tutte le divinità cittadine. Non c'è da stupirsi quindi se la formazione di
un'ideologia politica di unità universale partì proprio da questo concetto
unificante già presente: il primo dei traguardi ideologici verso l'impero
universale divenne infatti avere l'avallo della santa città di Nippur.
Nel Protodinastico IIIb altri due titoli divengono tappa fondamentale di
questo processo ideologico e politico: il re che aspirasse ad essere il
signore dell'alluvio doveva ricoprire la carica di en di Uruk e lugal di
Kish46.
Osservando il dato storico possiamo dire che la città di Kish già nel
45Lipinski E. 1979, State and Temple Economy in Ancient Near East, Leuven pagg.56546Falkenstein A. 1954, Cahiers d'Histoire Mondiale,Parigi pagg. 784-814
Protodinastico IIIa ricoprì un ruolo di predominanza per quanto esso non si
esercitò mai nelle forme e nei modi dei grandi imperi territoriali delle
epoche successive. Nel Protodinastico IIIb osserviamo già qualcosa di
profondamente differente: Lugalennemundu di Adab si fregia già del titolo
di signore della totalità, per quanto questa sua affermazione vada
profondamente ridimensionata. Difatti è plausibile pensare che egli ebbe
un ruolo egemonico nella fascia meridionale della Mesopotamia ed
esercitò la sua influenza anche sulla Susania, ma il suo potere non si spinse
oltre.
Eppure questo modello ideologico preannuncia il modello reale e ne getta
le basi. Dopo di lui infatti Lugalzaggesi di Umma sottomise Uruk, Larsa,
Umma, Nippur e Lagash intessendo poi rapporti commerciali che
arrivavano fino al Mediterraneo: il confine del mare superiore veniva ora
sfiorato, seppur in maniera ancora prettamente politica e propagandistica.
L'ultimo personaggio della vecchia tradizione politica e che preannuncia le
novità del periodo Accadico è indubbiamente Urukagina di Uruk. Egli,
come sarà per i re accadici, è un usurpatore, ovvero sia non si aggancia alla
antica tradizione dinastica, ed il suo programma propagandistico si rivolge
al popolo. Egli è completamente slacciato dal mondo templare e si propone
come sovrano mortale fra i mortali.
Un uomo nuovo, il cui passato oscuro alimentò leggende e tradizioni molto
successive, è il fondatore della dinastia Accadica, Sargon. Con questo re,
esponente di un nuovo modo di concepire la regalità che vede il palazzo
come unico centro del potere, si apre la stagione dei grandi imperi
territoriali.
Pur essendo originario di quella che sarà la capitale dell'impero, Akkad, la
figura politica di Sargon emerge nel momento in cui egli ricopre la carica
di re di Kish.
Egli, come prima manovra politica e militare, attuerà la completa
sottomissione del sud sconfiggendo Lugalzaggesi arrivando a “lavare le
armi nel mare inferiore”. Sargon si fregia quindi del titolo di signore della
totalità, ma riconosce che il suo controllo reale si estende solo al sud e che
ancora gli si contrappongono l'Elam e Mari.
La seconda fase politica di Sargon è incentrata su di una grande
riorganizzazione economica e territoriale dell'impero. Melukhkha (valle
dell'Indo), Magan (Oman) e Dilmun (Bahrein) vengono collocate in una
rete commerciale che pone al centro dei traffici la capitale Akkad. Le
operazioni militari riprendono e si spingono verso nord attuando la reale
unificazione fino alla città di Tuttul (odierna Ar-Raqqah in Siria) e se pur
le grandi potenze di Ebla e Mari restano indipendenti esse dovranno
dividere le loro risorse territoriali con l'impero sardonico; inoltre il
Mediterraneo e l'Anatolia verranno introiettate nel sistema economico
come già era successo per le estreme regioni meridionali.
Il nipote di Sargon, Naram-Sin, conclude l'opera iniziata dai suoi
predecessori e dopo secoli di gestazione ideologica crea veramente
quell'impero universale che va da mare a mare, riunendo in sè “tutto il
mondo”. Grazie infatti alle precedenti espansioni di Rimush e Manishtutu,
che avevano ampliato l'impero a oriente inglobando anche la parte
occidentale della confederazione elamica, Naram-Sin, in una prima fase
conquisterà la zona del Khabur ed il Medio Eufrate, inoltre imporrà il suo
predominio su tutto l'arco montano dell'Amano, del Tauros e degli Zagros.
La seconda fase espansionistica di Naram-Sin lo spinge alle porte di Ebla e
con la distruzione della grande città siriana il programma di unificazione
dal mare superiore al mare inferiore può dirsi concluso.
Passo decisivo e celebrazione di questo avvenuto sforzo militare e
politico, fu l'autoproclamazione di Naram-Sin come divinità.
L'acquisizione degli elementi divini, seppur osteggiata dal clero Sumerico,
si rivelerà un percorso vincente, caratteristico poi di molti sovrani degli
imperi successivi.
I reperti dello spazio politico
Come si è fatto presente nel corso del presente capitolo, la storia politica
della Mesopotamia del III millennio ha bisogno di essere corroborata da un
corpus di testi tali da ricostruire le vicende caratteristiche di quest'area. Ciò
nonostante, fra i reperti presi in esame in quest'ambito non figurano solo
testi, e se comunque tale categoria fornirà gli esempi più chiarificatori
sulla nozione dello spazio politico, va altresì detto che, alla luce dello
scenario delineato in precedenza anche altri tipi di documenti, talvolta di
contenuto esclusivamente figurativo, possono risultare utili nei termini di
un'analisi più vasta.
Il nostro studio procederà seguendo una direttiva principale di carattere
cronologico, procedendo dal reperto più recente fino a quello più antico.
Tale scelta metodologica è stata effettuata sulla base di considerazioni di
natura tipologica, storica ed infine categoriale. Tipologica in quanto,
essendo i testi i reperti più ricchi di informazioni, si è preferito dare un'idea
di quelle tipologie di reperti storici che hanno permesso di delineare un
quadro preciso della storia politica della Mesopotamia del III millennio e
chiaramente i testi sono i reperti più recenti. Considerazione storica, in
quanto i dati, via via che si procede a ritroso nel tempo, divengono sempre
più nebulosi e diviene necessario formulare ipotesi sempre meno
avvalorate dal riscontro obbiettivo, per questa ragione è bene procedere
tenendo a mente quali siano i reperti che invece portano in sé un bagaglio
sufficiente di informazioni e utilizzarli come linee guida. Infine la
considerazione di carattere categoriale è frutto di semplicemente di una
semplicità di indagine desunta dalle osservazioni sovraesposte e che
diviene comoda ai fini di una comprensione maggiore qual ora si volesse
mettere a confronto il dato esposto con quanto presentato nella prima parte
del capitolo.
Il primo reperto analizzato in questa sede è un frammento di stele in
calcare nota come “Stele di Vittoria” (Scheda 9 Testi). Il reperto, oggi
conservato al Louvre, risale al periodo accadico. La stele è spezzata e
l'iscrizione è frammentaria ma Foster, che ha interpretato il testo, ha
riconosciuto le prove di una confisca di terreni ai danni di Lagash a seguito
di una sconfitta, probabilmente a causa dell'esercito accadico. La stele è un
oggetto particolarissimo per comprendere l'idea dello spazio politico. In
primis essa racchiude in sé stessa il concetto di propaganda, tanto per il
messaggio trasmesso, tanto per il veicolo che trasmetteva il messaggio. La
stele era probabilmente esposta in un tempio affinché i visitatori potessero
osservarla, visitatori che erano cittadini di Lagash e quindi coloro che
avevano subito la sconfitta. In secondo luogo la segnalazione della
confisca di territori su di una stele esposta in un tempio aveva il valore di
registrazione ufficiale: il potere politico si appropiava così ufficialmente, e
religiosamente naturalmente, dello spazio dello città. Tale rivendicazione
si colloca probabilmente nell'ampio progetto di conquista, o controllo di
una città ribellatasi, difficile desumerlo dalla sola osservazione della stele,
effettuato nel sud dall'impero accadico. Altro aspetto interessante, che si
colloca sempre nel progetto di propaganda, è la scelta della lingua della
stele: il sumerico. La stele, esposta a Lagash, era stata formulata e
indirizzata direttamente alla popolazione di Lagash. Lo spazio politico era
stato ufficialmente conquistato.
Proveniente da un'epoca subito precedente, ed ascrivibile in quel
complesso di conflitti che videro impegnate Lagash ed Umma, è il
prossimo reperto del catalogo (Scheda 15 Testi). Anche in questo caso
siamo in presenza di un testo, in questo caso iscritto su di un cono di
argilla. Risale al 2400 a.C. e proviene da Lagash. Nell'ambito di una
visione complessiva del conflitto fra le due città purtroppo il testo non
contribuisce di molto essendo ancora una volta un testo di parte e che non
ci permette di conoscere il vero punto di vista della città di Umma. Se da
una parte il testo non aggiunge nulla alla lunga tradizione di accusa nei
confronti dei sovrani di Umma di aver peccato di tracotanza nei confronti
degli dei e dei sovrani di Lagash, d'altra parte ai fini della nostra ricerca,
questo reperto si rivela fondamentale. Lo spazio politico infatti è il vero
protagonista del racconto e svolge molte funzioni che ora andremo ad
elencare. Il brano si apre proprio con una definizione dello spazio che è
religiosa solo in apparenza: si fa menzione del dio Enlil che in principio ha
fissato il confine fra Ningirsu (divinità tutelare di Lagash) e Shara (sua
controparte di Umma). Si fa menzione dello spazio politico delle due città,
ponendo questo momento come un punto di partenza fondamentale, dando
implicitamente per assunto che esista uno spazio assoluto per ogni città
che sia stato definito ab origine. L'elemento divino e mitico però viene
mitigato e al contempo corroborato da quello umano e politico: Mesalim,
re Kish misura il campo che divide i territori delle due città e ne stabilisce i
confini. Ancora una volta osserviamo la presenza del re di Kish come
arbitro di una disputa, ed in questo caso addirittura come responsabile
della creazione di un confine, a riprova del ruolo egemonico di questa città
in questo momento storico. Lo spazio politico è per il momento una
premessa fondante ma diviene subito il simbolo delle relazioni fra le
diverse entità politiche se, qualche rigo dopo, troviamo indicato che il re di
Umma, nel momento in cui decide di marciare verso Lagash “strappa le
pietre di confine”. Quello che possiamo desumere da una simile
descrizione è che lo spazio politico, come quello mitico, si basa su una
serie di regole interdipendenti: il cambiamento di una di queste regole
richiede uno stato di caos, quindi le pietre che sancivano i confini stabiliti
un tempo, andavano rimosse. Inoltre, proponiamo in questa sede, che l'atto
di strappare le pietre avesse un carattere ufficiale, una vera e propria
consegna dell'atto di dichiarazione di guerra: il re attaccante non
riconoscendo più quei confini strappava la pietra per comunicare questa
sua posizione al suo avversario.
Seguendo il filo del racconto, al termine di questo primo conflitto,
troviamo lo spazio politico in una veste nuova. Fra le due città è stato
infatti posto un terreno di 1290 metri “concepito (come) un campo senza
proprietario”. Una terra di nessuno. E' chiaro che una simile
classificazione esula dall'ambito religioso (che considera ogni territorio
assegnato ad una divinità) ed è completamente immersa in un'utilità
politica la creazione di una zona “cuscinetto” fra due aree calde. Il confine
politico però, anche in questo caso, si dota della sua controparte religiosa
anche se la funzione cultuale è solo apparente. Lungo il confine infatti i re
di Lagash dichiarano di aver costruito dei santuari. In quest'ambito non va
dimenticato che i templi erano poli economici e non deve essere un caso
che il re di Umma, sempre a detta dei re di Lagash riprende le ostilità per
un mancato pagamento di un debito e non a caso il primo bersaglio della
sua attività bellica sono proprio i templi di confine. La collocazione
strategica dei templi coincideva con la creazione di una rete economica sul
territorio e la loro distruzione vuol dire scardinare tale struttura. Infine il
cilindro assolve un'importante funzione propagandistica, tanto nel corpo
centrale del testo, dove Umma presentata sempre come tracotante e mal
guidata, quanto nella conclusione, dove le maledizioni sono tutte rivolte a
chi oserà violare lo spazio politico della città, i campi intorno da essa
controllati. L'appropiazione di un terreno da parte di un sovrano aveva,
abbiamo visto, una triplice natura: personale, in quanto il re si poteva
fregiare dell'acquisizione di un nuovo territorio; religiosa, in quanto il
campo entrava a far parte dei “domini del dio” come il resto della città;
pubblica, in quanto la città allargava i propri territori e le risorse di quel
terreno divenivano un bene fruibile per tutta la popolazione. Abbiamo
anche osservato le forme dell'acquisizione politica di un territorio: la
semplice conquista o la confisca a seguito di vittoria militare. Il reperto
che segue ci permette di analizzare una nuova forma di acquisizione di
terreno da parte del potere centrale. Si tratta di una tavoletta iscritta
(Scheda 7 Testi) proveniente da Lagash e risalente al 2500 a.C. ca. La
struttura di questa tavoletta e la sua morfologia sono quelle di un classico
“antico kudurru”, così come abbiamo esposto nel capitolo relativamente
allo spazio amministrativo. Ciò che rende differente questo reperto è uno
dei due acquirenti del terreno, in questo caso il re di Lagash. Il sovrano
quindi, come strumento di acquisizione politica, poteva sfruttare anche le
norme di transazione economica usate dai singoli cittadini. Purtroppo il
testo non ci da sufficienti informazioni affinché si possa comprendere quali
siano le premesse di questo acquisto. Non sappiamo se la vendita è legata
al pagamento di un debito, ascrivibile a quel processo di progressivo
indebitamento della classe contadina esposto nel capitolo 3, o se invece si
tratti di una sorta di donazione. Quello che è interessante notare è che il re,
aldilà della semplice indicazione del titolo di re, è collocato nel contratto
esattamente con un qualsiasi acquirente su un qualsiasi kudurru, in questo
caso è anche affiancato da un certo Sidu che non è presentato con titoli
particolari. Ciò sta ad indicare, che almeno da un punto di vista formale, e
per questo tipo di acquisizione politica, il re non era diverso da un altro
cittadino. Continuando il nostro percorso a ritroso nel tempo ci lasciamo
alle spalle il mezzo scrittorio ed affrontiamo il primo reperto di
quest'ambito che richiede un'interpretazione più ancorata a quanto desunto
fino ad adesso che non al dato obbiettivo. Si tratta di un sigillo ritrovato
ad Ur e risalente al 2900 a.C. ca. (Scheda 1 Immagini e Testi).
L'immagine in esso rappresentata è piuttosto complessa e racchiude una
serie di rappresentazioni caratteristiche dell'arte glittica: in alto a destra
troviamo le capanne con le corna, segno evidente del santuario, in basso a
destra due uomini, l'uno di fronte all'altro intenti in una qualche attività,
una struttura complessa, forse un portale o un palazzo sormontato da
alcune figure umane, ed infine una grossa capanna alle cui spalle si
intravedono altre strutture. Sotto la capanna, o per meglio dire avvolto da
essa, si trova un simbolo molto particolare. Si tratta di un cerchio diviso in
quattro parti da quattro coni rivolti il centro. Legrain propose nel 1936
un'interpretazione che se non è stata più corroborata da nuove ricerche
d'altra parte non ne è stata neanche smentita. Pose in relazione questo
simbolo, che riferì essere riportato anche su altri reperti nello stesso scavo,
con logogramma sumerico UB, e si riferirebbe ad un potere “che si estende
ai quattro angoli del mondo”. Se tale interpretazione fosse valide si
sarebbe trovata una traccia di quel concetto ideologico-spaziale di
controllo del mondo che si crede originatasi o comunque consolidatosi in
età protodinastica II, in un periodo di molto precedente, addirittura nel
Jemdet Nasr. Considerando poi che tale periodo è un momento di grande
recessione politica ed economica, la tentazione di collocare la
formulazione di tale concetto, sempre considerando corretta
l'interpretazione di Legrain, che comunque andrebbe riconfrontata con le
odierne conoscenze in materia, in età Tardo Uruk, quando cioè la struttura
politica centralizzata era tale da giustificare una simile elucubrazione
politica, è piuttosto forte. Di sicuro il reperto è molto interessante poiché in
ogni caso mostra una rappresentazione dello spazio, fatta di elementi
compositi, completa. La città è rappresentata infatti come un'insieme di
elementi fondanti e fondamentali. Tutte queste parti, che concorrono a
creare il tutto, sono il tempio, il palazzo, le abitazioni, ed è probabile che
nella mente dell'osservatore mesopotamico questo sigillo richiamasse
immediatamente il concetto di città. A ciò si aggiunga che Legrain
interpretò tre segni appena accennati nelle torri rappresentate, ma anche
questa interpretazione andrebbe sottoposta a nuove e approfondite analisi,
come gli ideogrammi DUL, AB e UNU, tutti tre utilizzati di norma, nelle
epoche successive, per indicare nomi di città o di edifici dalle funzioni
abitative o più genericamente sociali.
Il prossimo reperto è di tutt'altra natura per quanto morfologicamente
affine a quello presentato in precedenza. Si tratta ancora di un sigillo in
pietra e risale al 3000 a.C. ca. (Scheda 24 Immagini) In questo manufatto
proveniente da Ur troviamo una tipica rappresentazione di uomini posti di
profilo intenti in un'attività di natura economica, in questo caso la cura di
alcuni bovini. Il disegno è molto schematico e ci si potrebbe chiedere
come mai esso non sia stato trattato nel capitolo relativamente allo spazio
amministrativo o tralasciato essendoci nel catalogo altri pezzi
rappresentativi della categoria. Ciò non è stato fatto perché, pur nella sua
semplicità, il reperto presenta una caratteristica molto importante: mentre
gli uomini sono posti su delle strutture accennate da 3 linee parallele la cui
interpretazione è molto difficile, i bovini sono localizzati sulle montagne, o
per meglio dire sulla canonica rappresentazione mesopotamica delle
montagne, ovvero sia la successione schematica di dunette sovrapposte. Le
osservazioni da fare sono molte. In primis si noti come solo i bovini sono
posti sui monti ma non gli uomini, e alla luce di quanto esposto nei capitoli
precedenti ciò non ci stupisce, in quanto un abitante dell'alluvio
mesopotamico difficilmente avrebbe potuto identificarsi con un abitante
delle montagne. Ciò nonostante la relazione con i bovini è lineare e non
disturbata da tale differenza di base, sottostante. Nel nostro catalogo,
nell'ambito mitologico, abbiamo già incontrato reperti nei quali un dio si
rapportava alla montagna, ma ciò che osserviamo qui è differente, non è un
dio ma il semplice uomo rappresentato in maniera stilizzata, quindi l'uomo
“generico”, che si rapporta ai bovini. Bovini sono che sono rappresentati
volutamente su di una montagna. Sarebbe quindi possibile ipotizzare che il
reperto segnali la volontà, da parte dell'autore, di mostrare come le attività
della comunità, in questo caso la cura dei bovidi, si estendesse fin sopra le
montagne, riallacciandosi al concetto religioso di centro ordinato che
sottomette la periferia caotica. Una simile rappresentazione, se tale ipotesi
è corretta, esula dall'ambito religioso, pur derivandone, divenendo atto
politico comune di rivendicazione di uno spazio, in questo caso, la
montagna.
L'ultimo reperto analizzato in questo capitolo è sempre un'impronta di
sigillo e risale al periodo Tardo Uruk (Scheda 21 Immagini). Proviene da
Jebel Aruda e mostra la facciata di un tempio, rappresentata secondo il
canone della decorazione a sporgenze e rientranze. Sopra di esso si
distingue la figura di un uomo che indossa la tipica gonna sumerica. La
possibilità che tale reperto rappresenti non un luogo dello spazio religioso
ma dello spazio politico è data dal periodo a cui essa risale. In questo
momento storico è il tempio il centro del potere e l'Ensi il sovrano della
città. Altra caratteristica è che, seppur il sigillo è frammentario sembra
chiaro che la figura sia solitaria e quindi non si tratti della tipica
rappresentazione di uomini intenti in attività produttive e potrebbe trattarsi
proprio della rappresentazione dell'ensi (o en) associato al luogo centro del
suo potere. Un'altra caratteristica interessante è il simbolo posto di lato al
tempio. Esso è piuttosto frammentario ed è stato interpretato come uno
stendardo dotato di riccioli laterali da Van Driel. In questa sede però
proponiamo un'interpretazione differente. Gli stendardi a riccioli laterali
infatti, talvolta rappresentati lateralmente a templi o palazzi sono dotati
sempre di riccioli da ambo le parti ed in questo caso invece il ricciolo è
presente solo da un lato (difatti tale parte del sigillo si è conservato ed è
rovinata solo la parte inferiore dello “stendardo”) inoltre esso
rappresentato in solitario senza alcuna associazione con il terreno, quasi
fosse sospeso, un simbolo per la precisione. Confrontando tale immagine
con reperti più recenti, tale simbolo è presente molte volte su molte
rappresentazioni come un dono che gli dei fanno al sovrano, o come
“scettro” retto dal sovrano stesso, in funzione di simbolo del comando
(Stele di Susa con il dio Shamash; Stele di Un-Nammu ricostruzione del
museo di Philadelphia; Codice di Hammurabi ) . L'interpretazione di tale
simbolo è ancora controversa anche se è stato proposto che si tratti proprio
di un mezzo di misurazione il che starebbe ad indicare che la definizione
dello spazio pubblico, e quindi politico, è la caratteristica principale del
sovrano, sia stato esso investito di tale compito dalle divinità o per diritto
di nascita [per questa parte devo consultare ancora il biblico e controllare
bene delle cose aggiungerle] . Se tale interpretazione di questo sigillo
dovesse rilevarsi esatta essa celerebbe la più antica rappresentazione di un
sovrano che rappresenta se stesso con i luoghi del potere (il tempio) ed il
simbolo del potere stesso (lo “scettro”).
Capitolo 5
Spazio geografico nella Mesopotamia del III millennio a.C.
Il presente capitolo chiude questo elaborato, configurandosi come l'ultima
parte di questo progetto di ricerca. Esso però non si tratta di una semplice
chiusura bensì si presenta come la parte più complicata, e probabilmente
interessante, del lavoro. In essa, infatti, dovranno confluire i dati, le teorie,
gli studi, raccolti nei capitoli precedenti e dovranno contribuire alla
formulazione di una amalgama coerente che tenga presente di quanto
esposto e non esuli mai dal dato ma da esso parta e ad esso ritorna. Anche
per questo nel corso del capitolo verranno presentati ancora altri reperti, i
quali, per la loro specifica natura non sono stati ascritti né all'ambito
religioso, né a quello amministrativo, né a quello politico ma
specificatamente all'ambito geografico. Già nei capitoli precedenti
abbiamo affrontato il problema della definizione di spazio geografico e
anche dal confronto con il presente ci siamo resi conto che se non è
impossibile è sicuramente un concetto complesso composto da poliedrici
elementi: geografico è lo studio del territorio e degli elementi antropici che
lo occupano, lo trasformano, lo reinterpretano; geografico è anche lo
studio delle relazioni fra le varie entità sociali (siano esse città, regioni,
stati o continenti) che si distribuiscono sul territorio, così come geografico
è lo studio delle risorse e dei modi sviluppati dalle comunità dell'area per
sfruttarle. Geografica è l'immagine del mondo che ogni uomo ha nel
momento in cui si colloca nello spazio. Se è vero che l'idea geografica è
composta da elementi molto diversificati, va anche detto che essa si
caratterizza da nozioni che producono, pur nella sua complessità,
un'immagine lineare e coerente. Facciamo due esempi in ambito
macroscopico e microscopico con il mondo moderno e cerchiamo di trarre
conclusioni che si rivelino utili per il nostro studio. In ambito
macroscopico si prendano in esame un'immagine tridimensionale della
terra, come può essere quella prodotta da software come google earth, una
piantina politica di un atlante degli anni 80 del secolo scorso e un tabellone
di Risiko. Un osservatore moderno non solo riconosce tutte le regioni su
tutte le mappe, ma riesce ad individuare numerose corrispondenze. Eppure
le tre mappe pur rappresentando la stessa cosa sono molto differenti tra
loro sia per la loro funzione, che per il supporto che, naturalmente per la
tecnica di riproduzione usata: la mappa in 3d ricerca una fedele
rappresentazione della Terra, inseguendo un effetto di mimesis che però
non la esula da modifiche di carattere culturale e pratico: la Terra è
rappresentata come una sfera e non come un geoide per motivi di carattere
pratico legati alla gestione del software e i territori risultano quindi
leggermente modificati di conseguenza inoltre i programmatori non hanno
resistito alla tentazione, questa volta di carattere culturale, di porre sempre
al centro, al momento dell'accensione il Nord America. Può sembrare una
banalità ma nel momento in cui ci spostiamo alla cartina degli anni 80 ci
rendiamo conto di come, un punto di vista formale stabilito, influenzi
notevolmente la rappresentazione laddove il supporto non possa garantire
la stessa “elasticità” del supporto informatico. Essendo la cartina centrata
sull'Europa osserviamo come, per ottenere una rappresentazione veritiera
di questa regione, si attui una necessaria deformazione dei territori
all'estremità della mappa risultato non di un'ignoranza in materia, ma dello
schiacciamento del geoide su di una superficie piana. Il risultato è quindi è
un'Oceania ed un Sud America che sembrano vorticare verso un
supercontinente creato da questa deformazione: l'Antartide. Anche la
Groellandia risulta risulta innaturalmente grande e schiacciata. E
naturalmente ci sono i colori, che occupano un ruolo fondamentale in una
piantina politica: il blocco sovietico è rappresentato sempre in tonalità
simili mentre i paesi della Nato e quelli dei Non Allineati con altri colori,
spesso di tonalità opposte (la soluzione più adottata è rosso l'uno e azzurro
l'altro). A colpo d'occhio, ignorando deformazioni e imprecisioni, un uomo
moderno raccoglie tutti i segnali politici, geografici e culturali della
cartina. Ci spostiamo ora al tabellone di Risiko il quale è il forse il vero
trionfo della mentalità geografica: la mimesis infatti qui non è ricercata, in
quanto non è questa la funzione del tabellone, quindi l'idea geografica è
conservata in nuce, ovvero sia, per i suoi elementi fondanti. Osserviamo
allora che nonostante in questo caso non sia necessaria una reale
corrispondenza con l'estensione dei territori la Groellandia è comunque
immensa e schiacciata segno che l'idea Geografica si è oramai radicata e
anche quando lo scopo della rappresentazione muta essa risente comunque
del suo sostrato. Anche se questa digressione può sembrare prolissa
proprio la scelta del tabellone del Risiko non è casuale e ci torneremo
quando analizzeremo una tavola da gioco di età neosumerica. Dal
macroscopico al microscopico. Consideriamo un cartello, il disegno di un
bambino e una possibile foto scattata ad una casa in una delle nostre città.
E' interessante osservare come l'idea dello spazio, specialmente quello
nucleare come può esserlo una casa, perduri nel tempo e resista a
variazioni di carattere storico anche per molto tempo prima di venirne
modificato. Se osserviamo una tipica abitazione urbana o rurale moderna
essa non rassomiglia per niente, se non in taluni casi specifici, alle tipiche
case europee con tetto spiovente, a un piano. Ciò nonostante la
rappresentazione tipica di una casa da parte di un bambino è proprio quella
della casetta con tetto, di solito rosso, che richiama le tegole, un piano o al
massimo due, segnalato dalle finestre appena accennate e intorno un
elemento che caratterizzi lo spazio circostante, che dia il senso del fuori:
che sia un prato o un albero o un fiore, difficilmente la casa fluttua nel
vuoto del foglio, essa è sempre collocata nello spazio. Come una forma
può persistere per ragioni culturali, allo stesso modo può essere scelta per
la sua capacità intrinseca di richiamare, nell'occhio dell'osservatore, un
simbolo. In questo modo se in un bosco troviamo un cartello che
rappresenta, stilizzata in poche linee nere, la sagoma di un quadrato
sormontato da un triangolo e con qualche piccolo rettangolo inscritto nel
quadrato, sappiamo per certo che siamo in prossimità di un rifugio: non
importa che esso abbia realmente quella forma, né l'osservatore lo
pretende, quel che conta che il simbolo della “casetta” ha richiamato
automaticamente alla mente il modello di casa/riparo/rifugio/ostello. Oggi
come nel III millennio a.C. lo spazio geografico è il frutto di un'insieme di
elementi che come abbiamo visto compongono ancora oggi questo vasto
ambito della cultura umana. Considerando questi esempi sarà ora forse più
chiara la scelta di presentare prima separatamente le relazioni fra lo spazio
e il mito, la politica e l'amministrazione, per poi analizzare solo ora lo
spazio nel suo insieme. Prima di fare ciò verranno presi in esame i reperti a
carattere strettamente geografico che concluderanno la nostra raccolta.
Quindi seguirà una scomposizione dello spazio in termini modulari e
concatenati, cercando di ricostruire l'immagine mentale che avevano
presente i mesopotamici del III millennio nel rapportarsi ai concetti di
mondo, regione, città, casa.
Lo Spazio Geografico e i suoi documenti
Nel corso del presente lavoro abbiamo analizzato numerosi reperti raccolti
nel nostro catalogo e tale analisi va tenuta presente ora che ci si spinge
verso quei documenti considerati utili esclusivamente per la ricostruzione
dello “spazio” in quanto tale. Senza tale considerazione i reperti di seguito
esposti apparirebbero incompleti e non esaustivi. Nel presente paragrafo
essi verranno esposti dal più antico al più recente e dal più semplice al più
complesso. Pur considerando che questi reperti sono dei campioni di
categorie assai più ampie, è forte la tentazione di immaginare uno
sviluppo della rappresentazione dello spazio che vada dal semplice al
complesso. Tale procedimento è, alla luce delle nostre attuali conoscenze,
azzardato, e probabilmente conviene non sbilanciarsi nell'interpretazione
della caratterizzazione del fenomeno analizzato. Simili errori sono stati
fatti nell'interpretazione dell'arte preistorica e medievale ed è bene fare
tesoro degli errori passati.
Il primo reperto che analizziamo è un'impronta di sigillo (Scheda 2
Immagini) proveniente da Ur e risalente al 3100-2900 a.C.. In essa è
rappresentata una capanna. La capanna è il nucleo centrale dello spazio, in
essa si trova la famiglia, il nucleo centrale della società, e rappresenta
anche il primo nodo della rete economica che converge poi al tempio. In
questa immagine la capanna è rappresentata di faccia, ed è disegnata la
sagoma curva delle canne che ne compongono la struttura. Al centro della
facciata si nota una struttura che si potrebbe interpretare molto
semplicemente come la porta della capanna. Legrain propose però
un'ipotesi più suggestiva, del resto mai smentita da studi successivi.
Basandosi sull'osservazione delle capanne di canne che sorgevano ancora
in Iraq nei pressi dello scavo archeologico da lui svolto, dedusse che
quello rappresentato non era la porta della capanna ma il tetto a cassettoni.
Come se gli elementi prospettici fossero stati osservati entrambi di faccia,
smontati dal loro contesto e rimontati insieme. Se tale teoria fosse vera, ma
purtroppo ricordiamo non sono stati fatti nuovi studi a riguardo, in quel
piccolo sigillo si celerebbe un'intuizione “picassiana”.
Cilindro invece che probabilmente mostra il portale della capanna/tempio
nella facciata della stessa, è quello considerato di seguito ( Scheda 3
Immagini). Nel reperto, ascrivibile allo stesso periodo di quello
precedente, osserviamo, di fianco alla struttura, accovacciato, un uomo
probabilmente intento in una qualche attività lavorativa. Come è facile
osservare tale reperto non è molto dissimile da altri che abbiamo già
analizzato in precedenza e viene preso in considerazione proprio per
questa ragione. Esso infatti è qui a modello di una categoria, quale è quella
dei sigilli che mostrano un'attività lavorativa in rapporto all'edificio
templare (in questo caso segnalato dalla presenza delle due volute sul
soffitto della capanna), che vuole essere qui osservata in un'ottica
prettamente semantica e geografica. Abbiamo già esposto nel capitolo 1 il
concetto di centro e periferia e di asse orizzontale, quel principio cioè, che
in un gioco di cerchi concentrici, mette in relazione il tempio con la città,
la città con la campagna, la campagna con la periferia, la periferia con le
lontane terre ignote. Il tempio è il centro di tale asse, nonché punto di
congiunzione fra l'asse orizzontale e quello verticale. Se mai si dovesse
avere un dubbio sulla tesi di asse orizzontale non bisognerebbe fare altro
che osservare la categoria di reperti a cui il sigillo, ora esaminato,
appartiene: in queste rappresentazioni il tempio è sempre il centro della
scena e da esso, mai contrapposto ad esso o verso di esso, partono uomini
e animali quasi come se il reale stesso venisse propagato dal tempio. Certo,
una volta “fuoriusciti” dal tempio uomini e animali possono disporsi
liberamente ma il momento dell'uscita o comunque della relazione di
dipendenza è sempre reso in maniera chiara: come in quest'immagine, essi
danno le spalle al tempio, in quanto se lo sono appena lasciato alle spalle.
Passando a reperti più recenti (e quindi ascrivibili al periodo Jemdet Nasr)
il concetto non perde la sua forza propulsiva ma anzi viene rafforzato in
reperti come i due sigilli del nostro catalogo (Schede 22 e 25 Immagini)
che se differiscono per un aspetto sono uniti al contempo dalla resa del
rapporto con lo spazio del tempio. In essi ci vengono mostrati due templi
molto diversi, sia nella struttura architettonica che nella resa stilistica.
Eppure entrambi i sigilli mostrano una teoria di bovini che riempono la
scena su due fasce. I bovini marciano ordinatamente in una direzione
slegata da qualsiasi elemento geografico, eppure, nella fascia inferiore si
vede chiaramente il tempio (nella scheda 22) o i templi (nella scheda 25)
dai quali i bovini escono; concetto reso con molta forza e semplicità con la
rappresentazione dei mezzi busti dei bovini seduti che si affacciano dalla
struttura templare.
Rimanendo ascritti al periodo subito precedente all'inizio del cosiddetto
protodinastico osserviamo ora ora un reperto proveniente dal cimitero
reale di Ur (Scheda 19 Immagini). Si tratta di un manufatto molto piccolo
(2,9 cm) e destinato ad un pubblico di elitte: è una placchetta in conchiglia
sulla quale sono state tracciate delle dunette disposte su tre file. Per meglio
esaltare la forma stessa di queste piccole curve e, come noi crediamo, per
meglio definire cosa esse indicassero, la fila centrale è stata colorata di
nero ed il bordo di rosso. Quando Wolley lo trovò all'inizio del secolo
scorso, interpretò il disegno come una rappresentazione schematica di una
scala. Alla luce invece degli studi attuali, non puntuali sul reperto che
come molti altri reperti del nostro catalogo sembrano essere stati ignorati
dalle grandi pubblicazioni, e dall'osservazione di tutti gli altri reperti del
nostro catalogo siamo spinti a credere invece che siano rappresentate le
montagne. Le stesse montagne così fondamentali nell'ambito religioso e
politico, e così schematiche e canoniche nella rappresentazione, non solo
nel III millennio ma per tutta la storia della cultura Mesopotamica,
un'immagine così' ricorrente e standardizzata che anche noi, dopo aver
preso visione di molti reperti riconosciamo immediatamente le montagne.
Ecco un caso di riuscitissima formazione e sopravvivenza di un'idea
semantica geografica.
Il prossimo reperto è un'anomalia dal punto di vista della ricerca
archeologica di periodi storici in quanto appartiene ad una categoria spesso
non considerata o comunque sottovalutata nell'ambito della ricerca per
questi periodi. Si tratta infatti di un vaso (Scheda 23 Immagini) risalente
sempre al periodo Jemdet Nasr, e il fatto che esso sia l'unico reperto di
questa categoria della nostra raccolta è dovuto non ad una scelta
intenzionale o ad un appiattimento su metodologie pregresse ma è
piuttosto la dimostrazione di quanto povera sia la storia degli studi a
riguardo. Non sono infatti stati rintracciati studi che mettano in relazione la
pittura vascolare con la produzione artistica della glittica o l'architettura
dell'epoca a cui il vaso si riferisce, quasi come se due civiltà differenti
producessero i grandi monumenti, la documentazione scritta da una parte,
e i vasi dall'altra. Per questo reperto è stato quindi adottato un metodo
sperimentale che tende a trattare la pittura vascolare e le sue forme come
quelle degli altri reperti. Lungo la parte superiore del reperto si dispone
una fascia dipinta, in essa troviamo varie fasce con motivo intrecciato
intervallate da punti vuoti o in alcuni casi con linee ondulate. In uno degli
spazi vuoti troviamo rappresentato un animale, forse un uccello, in un altro
un segno che sembra il risultato di un triangolo posto su di un altro
triangolo sormontato da un rettangolo, sempre di un motivo intrecciato.
Proprio questa immagine potrebbe essere interpretata, anche secondo
Lloyd, come un portale. Alla sua considerazione in questa sede ne
vogliamo aggiungere un'altra nata dal confronto con gli altri reperti: la
rappresentazione a intrecciata sembra richiamare l'incannucciato delle
capanne rappresentato di sovente nella glittica. Se questa considerazione
fosse esatta, nella parte alta di questo vaso avremmo una rappresentazione
di una capanna con le pareti ed il portale. A questo punto resta comunque
difficile l'interpretazione delle linee ondulate o degli animali rappresentati
in alcuni spazi vuoti, anche se essi potrebbero assumere un senso se si
considerasse che la capanna sia rappresentata dall'interno e quindi gli
animali sono collocati all'esterno e visti dall'interno e le linee ondulate
siano una qualche forma di decorazione. Naturalmente, allo stato attuale
delle nostre conoscenze, questa è solo una congettura.
Con il reperto successivo abbandoniamo il periodo Jemdet Nasr
spingendoci al 2600 a.C. Abbandoniamo anche l'accidentato ambito delle
immagini e della loro interpretazione con il seguente reperto che si ascrive
ad una categoria della rappresentazione dello spazio più puntuale e più
pratica. Si tratta (Scheda 23 Testi) della prima tavola metrologica nota. La
tavoletta si compone di un lungo elenco di unità di misura tenendo conto
dei vari rapporti di uguaglianza, naturalmente sempre secondo il sistema
sessagesimale tipico delle unità di misura mesopotamiche. Questo
documento è fondamentale in quanto svolge, nello studio e nella
percezione dello spazio, lo stesso ruolo svolto in ambito linguistico dai ben
noti dizionari bilingui. In questo caso i rapporti di uguaglianza e
similitudine sono considerati con le varie unità di misura lineari. Lo stesso
reperto ci permette di introdurre un piccolo sunto delle unità di misura in
uso in Mesopotamia così come sono state riassunte nel lavoro di Robson47.
Naturalmente in 3 millenni di storia mesopotamica queste misure non
coincidono sempre con gli stessi valori e quelle riportate sono quelle più
antiche:
1 grosso dito: 3,1 cm
1 cubito-arà, equivalente a 24 “grosse dita”: 75 cm.
1 asta, equivalente a 12 cubiti: 9 m
1 asta moltiplicata per un'asta equivale a 1 sar: 81mq
1 ubu equivale a 50 sar: 0,4 ettari
1 iku equivale a 2 ubu: 0,81 ettari
1 eše equivale a 6 iku: 4,86 ettari
1 bur equivale a 3 eše o 18 iku: 14,6 ettari
1 šar equivale a 60 bur: 875 ettari
1 qŭ: 270mq
1 sŭtu equivale a 10 qŭ: 0.27 ettari
47 Eleonor Robson Matematics in ancient Iraq, 2008, Princenton pagg. 295-296
1 pànu equivale a 6 sŭtu o 2 iku: 1,62 ettari
1 kurru equivale a 5 pànu o 10 iku: 8,1 ettari.
Lo spazio che si desume da questo documenti, e dagli studi di Robson, è
uno spazio standard, puntuale, uno spazio che sia fruibile da tutti nella
stessa maniera e archiviabile in maniera certa. L'importanza di simili
documenti può essere percepita solo considerando l'impatto che ha avuto
sul mondo contemporaneo l'introduzione del sistema metrologico decimale
standard.
L'ultimo reperto analizzato in questa categoria è forse il più importante
dell'intero catalogo poiché in esso lo spazio geografico viene riassunto,
reinterpretato e reso sotto forma di mappa producendo un documento che
si colloca a metà strada fra la mimesis spaziale e l'ideologia geografia: si
tratta della cosiddetta mappa di Nuzi (Scheda 9 Immagini e Testi). Questo
fondamentale reperto venne ritrovato nel 1930 a Gar-Sur vicino Harran a
200 miglia a nord di Babilonia. Si tratta di una piccola tavoletta di argilla
quadrangolare di 7cm nella quale è riportata una raffigurazione schematica
di un territorio. Di esso si riconosce la sagoma di un fiume che dal bordo
in alto a destra della tavoletta discende diagonalmente dividendosi in due
rami, il primo prosegue quasi parallelo al bordo destro, il secondo invece
procede orizzontalmente diramandosi infine sul limite del bordo sinistro in
altri tre rami. Sia in alto a sinistra che in basso a sinistra il territorio
rappresentato è delimitato da due catene montuose. Tutta la
rappresentazione è arricchita da didascalie indicative che ci permettono di
assegnare dei significati precisi alla zona rappresentata, fra cui i 3 punti
cardinali indicati ai margini della tavoletta. Lungi dall'essere la prima
mappa vera e propria con rappresentazioni grossomodo veritiere degli
elementi geografici, si pensi all'antichissima mappa di Catal Hoyuk
risalente al 6400 a.C.48, è sicuramente un reperto unico per la Mesopotamia
del III millennio che precede le ben note mappe del I millennio prodotte in
ambienti Assiri e Babilonesi. Le didascalie ci informano che l'area al
centro della mappa si estende per 354 iku ed è di proprietà di un certo
Azalan49, difficile dire se si tratti di una persona o di un dio poliade.
L'angolo in alto a sinistra riporta una didascalia, l'unica che riporta un
toponimo che sia stato riconosciuto: Mashken-dur Ibla50; le altre iscrizioni
simili sono quasi tutte illeggibili ma quelle inscritte nei cerchi sembrano
possano essere riferite a delle città51. Il fiume mostrato è probabilmente
l'Eufrate rappresentato mentre confluisce in un mare/lago nell'area nord
48 Mellaart, J, 1998 Çatal Hüyük: the 1960’s seasons, in Ancient Anatolia: fifty years work by the British Institute of Archaeology at Ankara (ed R Matthews), 35–41 (London: British Institute at Ankara).
49Bogrow, L. 2009, The History of Cartography, Harward, pag. 3150Freedman, N. 1977, The Nuzi Ebla in Archeology of Moab Biblical Archeologist n°72 pagg. 104-110
51Brown, L. 1979 The Story of Maps, Dover, pagg. 33-37
della Mesopotamia con un delta trilobato; in alternativa esso potrebbe
essere associato al Wadi Harran, un tributario dell'Eufrate52. Questo reperto
è fondamentale per due ragioni. La prima è che rappresenta un'importante
documento storico che può contribuire alla localizzazione di toponimi
geografici antichi in una realtà cartografica attuale. La seconda è che ci
mostra come, parallelamente ad una gestione ed una rappresentazione
dello spazio soggetta a dettami prettamente ideologici e simbolici, esisteva
una produzione geografica per noi, ad un livello di lettura più semplice si
intende, più comprensibile, una rappresentazione dello spazio che per la
lunga tradizione antecedente (la già citata mappa di Catal Hoyuk) fino alle
odierne rappresentazioni, sembra essere iscritta nella naturale percezione
dello spazio di ogni uomo.
Geometria e Spazio
La geometria, nell'accezione moderna del termine, direttamente
discendente da quella greca, indica la “misurazione della Terra”, quella
scienza cioè che riconduce lo spazio fisico ad elementi matematici e
trasformandole in forme astratte permettendo poi di trasferire le stesse
forme astratte nella realtà fisica. Oggi si è soliti considerare che la
52Harley, J.B. 1992 The History of Cartography, Volume I, Chicago, pagg. 113-115
geometria sia stata inventata proprio in ambito sumerico in relazione alla
gestione dei campi arati53 anche se in questa sede ci sembra lecito proporre
cautela a riguardo e probabilmente scoperte successive dimostreranno
come la formalizzazione di una geometria se non canonizzata sicuramente
condivisa va fatta risalire agli albori della civiltà neolitica, quando cioè la
relazione con lo spazio, e la gestione dello stesso, cambia radicalmente. La
nascita della geometria in Mesopotamia e della resa dello spazio in
maniera geometrica è probabilmente legata alla nascita della matematica o
per lo meno alla sua formalizzazione in età Tardo Uruk. A riguardo ci
sembra doveroso fare una piccola digressione sulla matematica
mesopotamica. I numeri sono sempre stati facilmente riconoscibili nelle
tavolette del III millennio poiché sono scritti in maniera radicalmente
diversa; difatti essi venivano incisi con uno stilo ricurvo inoltre essi
mantengono le stesse forme, a differenza della scrittura vera e propria, per
secoli. Assai più difficoltosa è stata per molti anni la loro interpretazione in
quanto essi non sembrano avere gli stessi valori in tutti testi: per spiegare
tale apparente irregolarità sono state proposte differenti teorie fino ad
un'incapacità cronica dei matematici del III millennio a gestire calcoli
complessi. In realtà il lavoro di Nissen, Damerow ed Englund ha spiegato
53 Boyer, C. B. A History of Mathematics, 2nd ed. rev. by Uta C. Merzbach.1991 New York
che tali differenti sostanziali e non formali sono spiegabili se si considera
che gli stessi simboli venivano utilizzati per differenti sistemi matematici54.
Nella Mesopotamia del III millennio infatti sono stati identificati diversi
sistemi matematici, sessagesimali, decimali e misti, utilizzati in diversi
ambiti. I cosiddetti sistemi S1 ed S2, sessagesimali, utilizzati per il
conteggio delle pecore, degli animali e per tutte le merci di natura animale.
Il sistema bisessagesimale B per il calcolo dei cereali e il sistema
bisessagesimali B2 per il calcolo delle merci ittiche. Il sistema DUG per il
calcolo delle quantità di latte e i quattro sistemi ŠE per il calcolo delle
quantità di grano. Esistono infine altri tre sistemi matematici, il primo, il
sistema EN rintracciabile solo nel Tardo Uruk la cui funzione ci sfugge, il
secondo, il sistema U4 usato per il calcolo del tempo ed in ambito
calendariale ed infine il sistema GAN, in parte sessagesimale in parte
decimale, usato per il calcolo delle distanze. Lo spazio quindi, la sua
gestione e la sua fruizione, era affidato ad uno specifico sistema
matematico. In realtà il legame di questo sistema con la realtà geografica
potrebbe essere ancora più stringente. Secondo infatti taluni studiosi, fra
cui Robson55 , la matematica in Mesopotamia sarebbe nata proprio dallo
studio della geometria. Sembra infatti dimostrato che la puntualizzazione
54Nissen, J. H., Damerow, P., Englund, R. K. 1993 Archaic Bookkeeping, Chicago pagg. 25-3255 Robson 2008 pagg. 45-50
delle quantità, e le relative regole per gestirle in maniera ottimale,
deriverebbe dallo studio delle distanze e delle aree e solo in un secondo
momento questi valori, questi numeri, abbiano assunto un livello di
astrazione indipendente dalla forma geometrica. Le regole geometriche e
matematiche prodotte in Mesopotamia nel III millennio sono tante e tali e
gli studi a riguardo sono così abbondanti che una digressione su di essi
rischia di essere superficiale in quanto sarebbe necessaria una monografia
sull'argomento. In questa sede consideriamo i reperti del catalogo
ascrivibili alla cultura geometrica e che ci permettono di avere un ulteriore
punto di vista sulla percezione dello spazio geografico e rimandiamo, per
ulteriori approfondimenti ai lavori di Friberg56 e Dauben57.
Prima dell'età sargonica, pur esistendo tavolette metrologiche e
matematiche, già analizzate nei precedenti paragrafi, non abbiamo prove
riguardo alla produzione di vere e proprie tavolette geometriche, ovvero
sia di documenti dove il dato matematico è riferito ad una figura nello
spazio. Tutt'al più abbiamo tavolette di varia natura (matematiche,
letterarie, amministrative) in cui, negli spazi vuoti, vengono incisi dei
segni che sembrerebbero astratti ma che qualcuno ha voluto vedere come i
56 Friberg, J. (1982). A survey of publications on Sumero-Akkadian mathematics, metrology and related matters (1854--1982). Preprint 82-17, Chalmers University of Technology.
57 Dauben, J.W. (1985). The History of Mathematics from Antiquity to the Present. A Selective Bibliography. Garland Publishing, Inc., New York.
primi segni geometrici58. In questa sede non abbiamo voluto considerare
tali documenti in quanto si è considerata l'associazione di queste immagini
alla sfera degli studi geometrici, troppo arbitraria per quanto suggestiva.
Il primo reperto del nostro catalogo è una tavoletta in argilla iscritta
(Scheda 22 Testi) che pur non rappresentando lo spazio geometrico lo
descrive in maniera esaustiva. In essa infatti troviamo descritto, in
maniera piuttosto chiara, un problema di matematica. Ciò che rende tale
reperto così interessante è che la soluzione del problema è suggerita per
mezzo di un ragionamento che sfrutta concetti di geometria, difatti
attraverso una spiegazione metrica, avendo dato il lato lungo di un
rettangolo e la sua area viene chiesto di ottenere il lato corto. Tale reperto,
riportato e analizzato nel lavoro di Foster e Robson59 e posto al centro della
tesi, esposta da Frieberg60 che riprende le teorie di Powel61 e Whiting62,
secondo cui per cui in una prima fase il pensiero logico matematico in
Mesopotamia fosse espresso solo in relazione ad una rappresentazione
58Deimel, A. 1923, Die Inschriften von Fara in Deutshe Orient-Gesellschaft, Berlino Tav. 75-77Biggs, R. D. 1974 Inscription from Tell Abu Salabik, Chicago pag. 42
59Foster B. R. , Robson E. 2004, A New Look at the Sargonic Mathematical Corpus in Zeitschrift für Assyriologie n°94 pagg. 56-7660Friberg J. 2005, Mathematical Cuneiform Texts (Pictographic and Cuneiform Tablets in the Schøyen Collection 1), Oslo, Hermes Academic Publishing cap.A6
61Powell M. A. 1976, The Antecedents of Old Babylonian Place Notation and the Early History of Babylonian Mathematics Historia Mathematica n°3 pagg. 417-43962Whiting, R. 1984, More Evidence for Sexagesimal Calculations in the Third Millennium B.C. in Zeitschrift für Assyriologie n°74 pagg. 59-66
geometrica senza una reale presenza di numeri astratti indipendenti che si
relazionassero fra di loro secondo una logica esclusivamente matematica.
Secondo tale teoria solo dal periodo neosumerico in poi si svilupperà una
matematica sciolta dal ragionamento geometrico. Corretta o meno che sia
tale tesi indubbiamente, con il periodo accadico, assistiamo alla grande
produzione dei tipici documenti di natura geometrica a cui appartiene il
prossimo reperto (Scheda 10 Immagini e Testi). Si tratta del più classico
problema di geometria in ambito mesopotamico, atto alla esposizione di
tutte le informazioni desumibili da un trapezio isoscele suddiviso in due
trapezi isosceli. In questo caso le didascalie sono fortemente danneggiate e
non potremmo conoscere tutte le informazioni necessarie se non grazie al
confronto con altri reperti giunti a noi in condizioni migliori come ad
esempio il prossimo reperto (Scheda 8 Immagini e Testi) risalente sempre
al periodo accadico. Si tratta anche in questo caso di una piccola tavoletta
ed è facile immaginare come questi documenti fossero utilizzati dagli
studenti delle scuole per scribi per lo studio delle forme geometriche e
delle regole matematiche desumibili da esse.
In chiusura del presente paragrafo si è voluto riportare un reperto che è
cronologicamente allogeno alla presente ricerca ma che ci permette di
creare un punto di collegamento con i primi studi di geometria del III
millennio con la copiosa produzione nello stesso ambito delle epoche
successive. Si tratta di una tavoletta d'argilla (Scheda 14 Immagini)
proveniente da Kisurra prodotta nel periodo paleo-babilonese. In essa non
sono riportate didascalie ma è chiaro che rappresenta un problema di
geometria, in questo caso reso attraverso l'iscrizione di quattro cerchi in un
quadrato. Tale documento poggia le sue basi negli studi delle superfici
delle epoche precedenti e si colloca come antesignano di quegli studi di
geometria del periodo babilonese e assiro le cui risoluzioni troveranno
applicazioni nell'arte e nell'architettura: lo spazio geometrico, desunto
dallo spazio geografico, ritorna infine nello spazio geografico reale.
Sistemi Alternativi di Misurazione dello Spazio
Che cosa si intende per sistemi di misurazione alternativi? Come abbiamo
visto, sia il calcolo delle distanze e delle superfici nello spazio reale,
quanto la loro trasposizione nell'astrazione geometrica, erano parametri
perfettamente canonizzati e standardizzati nel III millennio a.C. I campi e i
territori, sia che ci si riferisse ad essi in ambito amministrativo e storico
con il toponimo di riferimento, sia che essi venissero resi in maniera
geometrica attraverso l'indicazione delle misure dell'appezzamento di terra
in questione, erano rapportabili a categorie mentali ben precise ed
impostate. Tali sistemi però non esauriscono le possibilità della resa dello
spazio geografico e, parallelamente a quelli esposti, ne esistettero altri, la
cui natura ci è possibile intravedere laddove siano sopravvissuti documenti
che attestano l'uso di questi principi spaziali minoritari. Nel nostro caso
sono stati presi in considerazione due reperti presenti nel nostro catalogo
che presentano simili sistemi alternativi di misurazione dello spazio. Il
primo è una stele in calcare grigio proveniente da Lagash e risalente al
periodo Protodinastico I-II (Scheda 5 Immagini e Testi). Purtroppo tale
reperto è oggi smarrito ma dagli studi di Gelb63 sappiamo che la stele
descrive tre terreni. Tali terreni sono resi come delle circonferenze e come
tali trattate. Ciò che rende ancora più interessante tale reperto è che,
trattandosi di una stele di pietra in origine piuttosto grande, esso va ascritto
alla categoria degli antichi kudurru, ed in questo caso diviene piuttosto
chiaro che tali sistemi non classici di rappresentazione dei terreni, pur non
essendo molto diffusi, dovevano comunque appartenere ad un bagaglio di
conoscenze condivise tali da permettere, all'autore del kudurru, di
utilizzare tale sistema su di un documento ufficiale. Proprio tale ufficialità,
e l'antichità del documento, potrebbe spingerci a mettere in relazione tale
reperto con i succitati esempi di documenti Protodinastici o Tardo Uruk
63Gelb I. 1991, Earliest Land Tenure System in the Near Est: Ancient Kudurrus, Chicago, Oriental Institute Pubblications volume 104
che presentano delle rappresentazioni astratte, di difficile interpretazione,
negli spazi lasciati vuoti dal testo. Ancora una volta è difficile dire se tale
direzione di indagine sia corretta, ma indubbiamente uno studio mirato
effettuato su tali documenti e sulle poche informazioni in nostro possesso
sulla stele di Lagash potrebbero risultare illuminanti da questo punto di
vista, ma fino a quel momento è bene non sbilanciarsi troppo e tenere solo
considerazione dei dati in nostro possesso. Il secondo reperto che presenta
una misurazione dello spazio non convenzionale è una tavoletta di età
accadica oggi conservata al British Museum (Scheda 5 Testi). Il
documento è stato analizzato commentato da Archi64 il quale per primo ha
notato l'eccezionalità del reperto. Il testo tratta di acquisti di prodotti e
trasporto degli stessi, effettuati da privati, da e attraverso un dato terreno.
Data la natura del documento e il suo utilizzo, l'autore utilizza i costi di
trasporto come unità del campo stesso coniando l'espressione “da x a y
misura X litri di grano”. In questo caso lo spazio geografico non viene più
ricondotto quindi a valori metrici assoluti bensì a concetti di spesa legati al
campo stesso. Per comprendere meglio questo procedimento mentale si
pensi oggi all'espressione utilizzata per alcuni autoveicoli per cui, per
indicarne la capacità di serbatoio, non si dice la quantità effettiva del
64Archi, A. 2003, Cuneiform Digital Library Initiative , Los Angeles/Berlino, Sommerfeld pag.121
serbatoio, che comunque sarebbe relativa in base al consumo stesso del
veicolo ma la perifrasi “x chilometri con un pieno”. Tale documento,
ritrovato a Nagar, ha anche una grande rilevanza in quanto si lega alle
indagini relativa all'occupazione accadica nella piana dell'Habur e viene
considerato dallo stesso Archi come uno dei documenti che fonda la
presenza accadica sul territorio talvolta messa in discussione. Cosa sia
incluso e a quale spesa in particolare si riferisca l'autore della tavoletta nel
momento in cui definisce che il campo “misura 40000 litri di grano” è
difficile dirlo. Probabilmente, pur trattandosi di un documento di privati ad
uso privato, e non quindi legato alla produzione burocratica regia, si
riferisce anche alla tassazione accadica che grava sul terreno. Weiss65 ha
anche proposto che il documento, nel momento in cui descrive la quantità
di grano che “delinea” qualitativamente e quantitativamente il campo,
tenga presente al costo del grano trasportato fino alla capitale Akkad.
Il Gioco
Nel corso del presente lavoro si è utilizzato di sovente il mondo
contemporaneo come confronto o come esempio nell'esposizione di un
dato o una teoria relativamente alla Mesopotamia del III millennio. Ciò è
65Weiss, H. Rova, E. 2003 The origins of north Mesopotamian civilization: Ninevite 5 chronology, Subartu, Vol. 9, cap. 3
stato fatto in parte per rendere più comprensibili alcuni esempi, ma anche
perché si considera che esistano aspetti della vita, come ad esempio il
gioco e la sua relazione con lo spazio mentale e reale, universali e comuni
a tutti gli uomini di tutte le epoche pur considerando i dovuti distinguo
dettati dal contesto culturale e sociale. Se questa affermazione può
sembrare azzardata si consideri che, secondo Derrida66, il gioco in quanto
tale, estrapolato dal suo tempo e dal suo contesto, reinterpreta la realtà,
indagando tutti i mondi possibili senza contrapporsi ad essa. Inoltre il
gioco diviene strumento preferenziale per l'analisi dello spazio e di come
esso viene percepito da coloro che producono il gioco, come anche
riportato da Frobenius67, secondo cui il gioco deve essere analizzato come
portatore e summa dei valori di spazio e tempo della società che “gioca”.
Tali considerazioni assumono un valore sottilmente, quanto potentemente,
esplicativo qualora le si osservino relativamente ad un gioco moderno,
come il Risiko, o un gioco del III millennio come il reperto analizzato nel
presente paragrafo (Scheda 12 Immagini). Il gioco si compone di una
tavola da gioco in legno suddivisa in 20 caselle, divisa in due zone, una di
12 caselle collegata all’altra, con due caselle, di 6 caselle. Le 20 caselle
66 Derrida, J. 1967 La structure,le signe, le joeur dans le discours des sciences humaines in L'écriture et la différence, Parigi pag. 360
67 Frobenius, L. 1933 Kulturgeschichte Afrikas orischen Gestaltlehre, Berlino cap.4
sono variamente intarsiate con placche di conchiglia quadrate; i bordi sono
composti da piccole placche e strisce. Alcune caselle riportano la
rappresentazione di un occhio, altre invece con rosette; sul retro è
possibile osservare tre linee di conchiglia triangolari e intarsi ornamentali.
Le regole del gioco sono state parzialmente desunte da una tavoletta
d'argilla risalente al 177-176 a.C. ora conservata al British Museum68 (la
quale attesta anche la incredibile longevità di questo gioco) e sembrano
essere simili a quelle del ben noto Senet o all'odierno Backgammon69. Una
versione graffita della tavola da gioco è stata anche ritrovata nel palazzo di
Korsabad (721-705 a.C.)70. Le regole precise del gioco sono ancora fonte
di dibattito ma gli studiosi sembrano concordare, aldilà della precisa
funzione dei 2 dadi piramidali e delle 7 pedine a giocatore e delle 4
bacchette comprese nella scatola, che scopo del gioco fosse far percorrere
a tutte le proprie pedine tutto un bordo della plancia di gioco partendo da
un angolo in basso del rettangolo lungo, arrivando all'altra estremità di
quello piccolo, per poi tornare indietro passando per i tasselli centrali e far
“uscire” le pedine, proprio come nel backgammon, dalla casella centrale in
basso del rettangolo di partenza, di fianco al punto di partenza; sembra
68 Weidner, E. 1956 Ein Losbusch in Keilschrift aus der Seleudikenzeit, Syria 33, Berlino69 Becker, A. 2008 The Royal Game of Ur, Londra pag. 11-1570 Finkel, I. 2008 Ancient Board Games in Persective: Papers from 1990 British Museum Colloquium with additional
contributions, Londra
inoltre ugualmente condiviso che le caselle con il simbolo della rosetta
avessero un ruolo di “caselle sicure” dove le proprie pedine non potessero
venire mangiate71. Alla luce di quanto esposto diviene chiaro quale
universo di considerazioni possano essere fatte se collochiamo questo
gioco, e tutte le tesi su di esso profuso, nell'ambito della percezione dello
spazio geografico. Ma allora, se il gioco è, come sostiene Gargano72
citando e commentando Eraclito, un simbolo cosmico, il tabellone del
gioco reale di Ur, come è soprannominato questo gioco, non può
rappresentare simbolicamente uno spazio geografico noto e condiviso, né
più né meno dell'odierno Risiko? La suggestione di leggere, nel
movimento delle pedine, e nella forma del tabellone, la rappresentazione
del mondo Mesopotamico, disegnato e racchiuso dai due fiumi e dai mari
inferiore e superiore, che definiscono i due alluvi, quello meridionale e
quello settentrionale, seguendo le reali sporgenze e rientranze dei fiumi, è
molto forte, forse azzardata. Eppure, considerando l'importanza di questo
gioco, tale da sopravvivere nei secoli e di renderlo degno di essere
seppellito nelle tombe reali, viene in mente la definizione che Wittengtein
da degli scacchi nel momento in cui dice che essi sono una struttura
idealmente costruita che, attraverso una rete di parole (le regole) e
71 Lhote, J. M. 1994 Histoire des jeux de sociéte, Parigi pag. 36-4972 Gargano, M. 1991 Il gioco e il tragico, Napoli pagg. 81-85
significati simbolici decostruisce un lembo di realtà dandogli,
arbitrariamente, una fine ed un inizio. Se tali considerazioni fossero esatte,
prima ancora dei trattati politici, questo gioco può aver rappresentato
l'antico sogno, realizzato solo in Età Accadica e poi sempre inseguito nella
storia Mesopotamica, della riunificazione delle 4 parti del mondo.
Ricostruzione dell'idea di spazio in Mesopotamia dal Tardo Uruk al
periodo Accadico.
Ricostruire l'idea dello spazio geografico per un millennio di storia
mesopotamica non deve essere inteso, in questa sede, come il punto di
arrivo di questo elaborato. E' più un aspirazione, e le seguenti conclusioni
sono soltanto un primo passo in questa direzione. Al fine di non risultare
ridondanti non verranno ora ripetute le considerazioni riportate nei capitoli
precedenti ma si tenterà di aggiungere qualche considerazione di carattere
generale. I popoli mesopotamici intorno alla metà del IV millennio a.C.
fino alla fine del III millennio a.C. danno vita ad una serie di
trasformazioni radicali della loro società che cambieranno per sempre il
volto del pianeta. Concetti come lo stato, la religione, la scrittura, la
burocrazia, il lavoro, assumono in questo periodo quei connotati che
ancora oggi, nelle loro forme basilari, caratterizzano il nostro mondo. Con
il mutare della società, che si lascia per sempre alle spalle la tradizione
neolitica, rielaborandola e trasformandola in qualcosa di assolutamente
nuovo, muta anche la percezione dello spazio. Il rapporto e la dicotomia
fra uomo e ambiente, già caratterizzatesi con la rivoluzione neolitica,
conoscono ora una rafforzamento ontologico che diviene irreversibile. La
definizione dello spazio come centro e periferia poi spoglia il mondo della
sua natura selvaggia e autonoma e nell'attimo in cui l'uomo popola il
mondo di toponimi e lo abita con la sede dei suoi dei se ne appropria,
anche nel momento in cui definisce dei luoghi distanti e periferici. Lo
spazio del caos e dell'ignoto si ritrae sempre di più ad ogni decade di
questo millennio di storia e la periferia storica, mitica e sociale va
sostituendo questo topos non definito che viene infine confinato nello
spazio irraggiungibile immaginario del sottosuolo e degli spazi aerei.
Anche questi luoghi però non vengono a lungo risparmiati dall'opera
organizzatrice delle società mesopotamiche. Divinità e demoni e miti
abitano i luoghi irraggiungibili, e pur rappresentando essi stessi tal volta il
caos e il disordine, essi sono canonizzati ed inseriti in un complesso
cultuale, e sociale, ben definito. Nel momento in cui i sovrani accadici si
autodefiniscono divinità tutelari del loro stesso impero l'ultima barriera
viene valicata e formalmente anche gli spazi irraggiungibili sono
sottomessi. La riunificazione amministrativa e politica delle 4 parti del
mondo vede la totale riunificazione di ogni spazio geografico, reale e non,
un'opera di controllo del reale totale e totalizzante di un compendio di
società coscienti di essere il frutto di un'alchimia storica eccezionale e
irripetibile. Queste le considerazioni di natura cultuale e filosofica, ma se
volessimo indagare le implicazioni di natura più prettamente geopolitica?
In questo caso, l'autore di questo elaborato, ha ritenuto ricercare
un'interpretazione esauriente non fra le già citate opere archeologiche e di
assiriologia ma nell'opera di una grande esperto di diritto internazionale
del calibro di Carl Schmitt73. Nella sua opera Il nomos della terra, Schmitt
analizza il concetto di proprietà in relazione allo spazio, e l'influenza di
tale concetto semantico e ontologico sulla realtà che lo circonda. Partendo
dalla definizione giuridica che vede la terra, intesa come territorio ma
anche come suolo, come la madre del diritto, Schmitt cerca di corroborare
tale definizione scevrando i tre elementi fondamentali che la caratterizzano
come unità computabile, facendo desumere dalla misurabilità il concetto
stesso di diritto e organizzazione sociale complessa74. In primo luogo la
terra costringe l'uomo, fin dalla rivoluzione neolitica, ad un rapporto di
lavoro/retribuzione dove ad uno sforzo fisico ben preciso corrisponde la 73Schmitt, C. 1974 Il nomos della terra, Milano, Adelphi Editore (ed. 1991) pagg. 20-6374 Argomento che abbiamo già trattato nel presente capitolo come in quello relativo allo spazio politico a riprova della
convergenza del nostro elaborato con le considerazioni di Schmitt.
nascita, anch'essa piuttosto precisa, di prodotti e quindi di ricchezze. Il
secondo aspetto analizzato da Schmitt è sempre relativo all'ambito della
coltivazione: sulla terra infatti, nel momento in cui l'attività agraria traccia
le sue linee, vengono altresì tracciati dei limiti e delle delimitazioni che
sono palesi a tutti i soggetti della società. Infine la terra è la tavolozza su
cui l'uomo sedentario disegna la mappa dei suoi rapporti sociali e culturali,
lascia la sua tradizione e organizza il suo futuro: le case, le mura, i templi e
i palazzi del potere sono i segni di questa opera. L'opera di analisi della
terra come base del diritto però non si ferma a queste considerazioni. Egli
infatti osserva come, al momento dell'occupazione di un territorio da parte
di un popolo, si creino immediatamente due tipi di relazioni. La prima
interna, con riguardo all'ordinamento del suolo e della proprietà entro un
territorio, la seconda esterna, nei confronti di altri popoli. Questo è,
secondo Schmitt, il vero archetipo di un processo giuridico costitutivo. Ed
infine il nomos, argomento centrale dell'opera del filosofo e parola, che pur
nascendo in un ambito greco, quindi ben distante dalla Mesopotamia del
III millennio, cela in sé concetti che abbiamo già incontrato nella nostra
opera: il nomos è ordinamento della terra, divisione, gestione dello spazio,
ma col tempo, e non per caso, nomos diviene semplicemente norma, legge.
Prima ancora di Schmitt, sempre nell'ambito dello spazio amministrativo, è
importante, o quanto meno deve spingere a considerazioni di natura
generale sull'argomento, un passo del Decretum Gratiani75 nel momento in
cui definisce il concetto di diritto: “Jus gentium est sedium occupatio,
aedificatio, munitio, bella, captivitates, servitutes, postliminia, foedera
pacis, induciae, legatorum non violandorum religio, conubia inter
alienigenas prohibita. “. Come si può osservare il diritto si compone in
primo luogo da elementi relativi allo spazio fisico: l'occupazione di terra
(sedium occupatio), fondazione di città (aedificatio), fortificazione
(munitio). Così come una considerazione non dissimile è rintracciabile
nella definizione di Locke76 “Government has a direct jurisdiction only
over the Land”.
Tutte le osservazioni ora riportate sono ben distanti non solo dall'ambiente
storico che stiamo analizzando, ma anche dall'ambiente degli studi a cui
sovente ci si riferisce. Eppure questa scelta è stata effettuata sulla spinta di
una considerazione di fondo. Le similitudini fra quanto desunto in questo
lavoro, dallo studio dei reperti archeologici, puntualmente contestualizzati
e storicizzati, e gli studi di geopolitica dal medioevo a oggi, devono essere
interpretate non come un tentativo di forzare il concetto dello spazio
mesopotamico del III millennio con quello odierno, ma come la prova di 75 Graziano 1080 ca. Decretum Gratiani in Papa Gregorio 1591 Decretales D. Gregorii Papae IX, Roma Cpitolo I, paragrafo I, capoverso 976 Locke, J. 1689 Civil Government II, Rockville (ed. 2008 Wildside Press) paragrafo 12
come le innovazioni prodotte dalle società mesopotamiche del III
millennio a.C. siano state radicali e profonde e che anche in questo ambito,
vivano ancora oggi nel mondo che viviamo.
Bibliografia
Abush, T. 2002, Riches Hidden in Secret Places: Ancient Near Eastern Studies in Memory of Thorkild Jacobsen. Ann Arbor (Michigan), Eisenbrauns for the American Oriental Society
Abush, T. 2007, Biblical Accounts of Prehistory: Their Meaning and Formation in " Bringing the Hidden to Light: The Process of Interpretation. Studies in Honor of Stephen A. Geller. Ed. K. Kravitz and D. M. Sharon. Winona lake (Indiana), Eisenbrauns
Algaze, G. 2002, The Prehistory of Imperialism, in Uruk, mesopotamia and its neighbors, Santa Fe, School of American Research Press
Amiet, P. 1961, La Glyptique Mesopotamienne archaique (2 ed.), Parigi, Editions du Centre national de la recherche scientifique
André, B. 1982, Naissance de l'écriture : cunéiformes et hiéroglyphes, exposition du Grand Palais, 7 mai - 9 août 1982, Parigi, Éditions de la Réunion des musées nationaux.
Archi, A. 2003, Cuneiform Digital Library Initiative , Los Angeles/Berlino, Sommerfeld
Aruz J. , Wallenfels R. 2003, Art of the First Cities: The Third Millennium B.C. from the Mediterranean to the Indus, New York, Metropolitan Museum of Art
Banks E. J. 1912, Bismaya, New York, Oriental Institute of the University of Chicago
Ball C.J. 1898, Proceedings n°20, Londra, Society of Biblical ArcheologyBall C.J. 1899, Light from the East, Londra, HD Baker
Barton G.A. 1901, Kugler’s Criterion for Determining the Order of the Months in the Earliest Babylonian Calendar in Journal of the American Oriental Society n°22 pagg. 283-295Barton G.A. 1902, Tammuz and Osiris in Journal of the American Oriental Society n°23 pagg. 9-13 Barton G.A. 1902, A Scketch of Semitic Origins, New York, The Macmillan Company Barton G.A. 1913, The Tablet of Enkhegal, Philadelphia, The museum Journal n°4 pagg. 4-9 e 23 e 79Barton G.A. 1913, The Origine and Development of Babylonian Writing (= Beitrage zur Assyriologie und semitischen Sprachwissenschaft)in American Journal of Archeology n°9, Leipzig, JC HinrichsBarton G.A. 1913, The Origin and development of Babylonian writing in AJA (American Journal of Archeology) n°17 pag. 295Barton G.A. 1915, Publication of the Babylonian Section, Philadelphia, Philadelphia Museum of Art
Bauer T. 1971,Ein viertes altbabylonisches Fragment des Gilgamesch-Epos in Zeitschrift fur Assyriologie und vorder-asiatische Archaologie n°61, Berlino, pagg. 193-207
Becker, A. 2008 The Royal Game of Ur, Londra pag. 11-15
Biga M. G. 2008, Il Politeismo Vicino-Orientale,Roma, pag. 216
Biggs, R. D. 1974 Inscription from Tell Abu Salabik, Chicago
Bogrow, L. 2009, The History of Cartography, Harward, pag. 31
Borowski E. 1993, "Introduction" in J G Westenholz Seals and Sealing in the Ancient Near East - Proceedings of the Symposium held on September 2, Gerusalemme, Bible Lands Museum
Bottèro, J. 1992, Uomini e Dei della mesopotamia, Einaudi, Roma
Brown, L. 1979 The Story of Maps, Dover, pagg. 33-37
Budge, E. A. W. , King L. 1896, Cuneiform Texts from Babylonian Tablets in the British Museum, Londra, The Trustees of The British Museum,
Buren E. D. Van 1940, The Cylinder Seals of the Pontifical Biblical Institute in Analecta Orientalia XXI n°7, Roma, pagg. Xxii,51, tavola 12
Burrows E. 1935, Ur Excavations Texts II: Archaic Texts , Philadelphia, The British Museum and the University Museum/University of Pennsylvania
Chavalas M. W. 2006, The Ancient Near East: Historical Sources in Translation, Melbourn, Blackwell
Chevalier N. 2002, La recherche archéologique française au moyen-orient 1842-1947, Parigi, Editions Recherche sur les Civilisations
Cooper J. 1973, Orientalia 42, Roma pagg. 239-242Cooper J. 1983, Reconstructing history from ancient inscriptions : the Lagash-Umma border conflict, Los Angeles, Source of the Ancient Near Est Cooper J. 1985, Medium and message : inscribed clay cones and vessels from presargonic Sumer, Parigi, Revue d'Assyriologie n°79 pagg. 92-114
Collon W. 1980, Tell ed-Der III: Sounding at Abu Habbah (Sippar) , Louvain, Gasche & R. Paepe eds. Collon W. 1982, Catalogue of the Western Asiatic Seals in the British Museum: Cylinder Seals II: Akkadian, Post Akkadian, Ur III Periods Volume II, Londra, British Museum Publication
Crawford T. 1960, Hassanlu in Bulletin of the Metropolitan Museum of Art, New York, pag. 85-94
Crump, C. 1981, The Phenomenon of Money, Londra, Routledge & Kegan Paul Cuq, E. 1929 , Etudes sur le droit babylonien, Parigi
D'Andrea, A. 2006 Documentazione Archeologica, Standard e Trattamento informatico, Budapest, Centro Interdipartimentale di Servizi di Archeologia dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, in collaborazione con il progetto europeo Rete di Eccellenza EPOCH, Davies, G. 1994, A History of Money, From Ancient Rimes to the Present Day, Cardiff, University of Wales Press
Dangin T. F. 1884-1912, Decouvertes en Chaldee, Parigi Dangin T. F. 1897 Le cône historique d'Entemena, in Revue d'Assyriologie n° 4, Parigi, Leroux pagg. 592-599Dangin T. F. 1905, Les Inscriptions de Sumer et d'Akkad, Parigi,Leroux
Dangin T. F. 1907, Die sumerischen und akkadischen Konigsinschriften, Lipzia, Vorderasiatische Bibliothek Dangin T. F. 1927, Distances entre étoiles fixes d’après une tablette de l’époque des Séleucides in Revue d’assyrologie et d’archeologie orientale n°24, Parigi pagg.215-225
Diakonoff I. 1954, Sale of Land In Pre-Sargonic Sumer, Mosca, Paper presented by the Soviet Delegation at the XXIII International Congress of Orientalists Diakonoff I. 1954, Vestnik drevnej istorii vol 4., Mosca Diakonoff I. 1959, Obscestvenny I gosudarstvenny story Drevnego Dvurecya Sumer, MoscaDiakonoff I. 1969, Ancient Mesopotamia, Mosca
Deimel, A. 1923, Die Inschriften von Fara in Deutshe Orient-Gesellschaft, Berlino Deimel, A. 1924, Wirtschaftstexte aus Fara in Orientalia n°9, Roma, pag. 320Deimel, A. 1924, Die Inschriften von Fara 1-3, Leipzig, Wissenschaftliche Veroffent-liuchungen der Deutschen Orient-Gesellschaft Volume 1
Deliztsch F. 1907, Mehr Licht:die bedeutsamsten Ergebnisse der babylonisch-assyrischen Grabungen für Geschichte Kultur und Religion in Vortrag Atla monograph preservation program, Leipzig
Delougaz P. , Lloyd, S. 1942, Pre-Sargonid Temples in the Diyala Region Oriental Institute Publications, n°58, Chicago, The University of Chicago Press, pagg. xxvii-320
Derrida, J. 1967 La structure,le signe, le joeur dans le discours des sciences humaines in L'écriture et la différence, Parigi pag. 360
Dougherty R. P. 1925-6, Searching for Ancient Remains in Lower Iraq, in Annual of the American Schools of Oriental Research) Volume VII, parte IDougherty R. P. 1927, Searching for Ancient Remains in Lower Iraq, in Annual of the American Schools of Oriental Research, Volume VII parte II
Driel, H. Van 1983, Seals and sealing from Jebel Aruda (1974-1978), in Akkadica n°33 pagg. 34-62
Du Ry, C. J. 1969, Art of the Ancient Near and Middle East, New York, Harry N Abrams Inc,
Edzard, D. O. 1924, Die Mythologie der Sumerer und Akkader in Orientalia n°9 pag. 112Edzard, D. O. 1968 Sumerische Rechtsur-kunden des III, Dynastie von Ur. , Monaco, Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften philosophisch-historische Klasse Eliade M. 1957, The Sacred and The Profane: The Nature of Religion, New York, Harvest/HBJ Publishers
Einzig, P. 1949, Primitive Money, Londra
Falkenstein A. 1954, Cahiers d'Histoire Mondiale,Parigi pagg. 784-814
Finkel I. 1995, Board games and fortune telling: a case from antiquity, Leiden, University of Leiden/International Institute for Asian StudiesFinkel, I. 2008 Ancient Board Games in Persective: Papers from 1990 British Museum Colloquium
with additional contributions, Londra
Forest J. D. 1996, Mesopotamia. L'invenzione dello Stato nel VII-III millennio,Milano,
Giappicchelli,
Foster, B.R. 1982, Orientalia 51, Roma pagg. 297-354Foster, B.R. 1985, Uruk pottery from Tell Brak in Iraq n°47 pagg. 175-186
Foster, B. R. , Robson E. 2004, A New Look at the Sargonic Mathematical Corpus in Zeitschrift für Assyriologie n°94 pagg. 56-76
Frangipane, M. 1996, La nascita dello stato nel Vicino Oriente, Laterza Frangipane, M. 2002, Centralization Processes in Greater Mesopotamia in Uruk, mesopotamia and its neighbors School of American Research Press pagg. 307-347
Frankfort, H. 1936, Progress of the Work of the Oriental Institute in Iraq, 1934/35: Fifth Preliminary Report of the Iraq Expedition Oriental Institute Communications 20, Chicago, The University of Chicago Press. Pagg. 157-165Frankfort, H. 1951, Stratified Cylinder Seals from the Diyala Region, Chicago, University of Chicago Oriental Institute Publications Volume LXXII
Friberg, J. 1990, Mathematik in Reallexikon der Assyriologie (und Vorderasiatischen Archäologie) n°7, pagg. 531-585
Friberg, J. 2005, Mathematical Cuneiform Texts (Pictographic and Cuneiform Tablets in the Schøyen Collection 1), Oslo, Hermes Academic Publishing
Freedman, N. 1977, The Nuzi Ebla in Archeology of Moab Biblical Archeologist n°72 pagg. 104-110
Frobenius, L. 1933 Kulturgeschichte Afrikas orischen Gestaltlehre, Berlino cap.4
De la Fuye, F. M. A. 1908-12, Documents presargoniques, Parigi
Gargano, M. 1991 Il gioco e il tragico, Napoli pagg. 81-85
Gelb, I. 1969 in Studi E. Volterra, VI, Milano, pagg. 137-154Gelb, I. 1991, Earliest Land Tenure System in the Near Est: Ancient Kudurrus, Chicago, Oriental Institute Pubblications volume 104
Gordon H. 1939, Western Asiatic seals in the Walters art Gallery in Iraq VI pagg. 3-34
Graziano 1080 ca. Decretum Gratiani in Papa Gregorio 1591 Decretales D. Gregorii Papae IX, Roma
Gregoire J. P. 1978, Inscriptions et archives administratives Cunéiformes in Moorey Kish Excavations 1928-1933, Oxford, Clarendon Press (ristampa) 1990 in Unione Accademica Nazionale Materiali per il vocabolario neo-sumerico n°10 pag. 214, Roma
Grunfeld E. 1968, The mystery game of Ur , Horizon X n°2 (Numero di Autunno) pagg. 32-81
Hackman G. G. 1937, Babylonian Inscriptions in the Collection of J. B. Nies, New Heaven, Bibliotheca Orientalis
Harley, J.B. 1992 The History of Cartography, Volume I, Chicago, pagg. 113-115
Heinrich, E. 1956, Erster vorlaufiger Bericht uber deutschen Wissenscahft in Uruk-Warka
internommen Ausgrabungen, volume I-II (1929-40), in Abhandlungen der Pressichen Akademie der Wissenscahften philos.-hist. Klane; volume 12 in Abhandlunghen der Deutschen Orient-
Gesellschaft 1993, Berlino pagg. 10-21
Heuzey L. 1896, Statues espagnoles de style gréco-phénicien (question d'autenticité) in Revue d’assyrologie et d’archeologie orientale n°3 pagg. 96-112Heuzey L.1900, Une ville royale chaldeenne, ParigiHeuzey L.1902, Catalogue des antiquites chaldeennes, Parigi, Musee National du Louvre, Heuzey L.1903, A la Memoire de Jules Opper in Revue d’assyrologie et d’archeologie orientale n°5, Parigi Heuzey L.1904, Une statue complète de Goudéa in Revue d’assyrologie et d’archeologie orientale n°6 pagg. 18-22, Parigi
Hilprecht H. V. 1896, Zeitschrift fur Assyriologie und vorder-asiatische Archaologie n°11 pag. 165-203Hilprecht H. V. 1910, The Babylonian Expedition of University of Pensylvania Series A: Cuneiform Texts, Department of Archeology , Philadelphia, University of Pensylvania
Horowitz, W. 1998, Mesopotamian Cosmic Geography, Atlanta, Eisenbrauns
Hronzny F. 1907, Der Obelisk Manistusu in Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes n°21 pagg. 21-24Hronzny F. 1909, das Problem der altbabylonischen Dynastien von Akkad un Kish in Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes n°23 pagg. 17-30
Huehnergard J. 2005, A Grammar of Akkadian, Charlottesville, Eisenbrauns pag. 568
Hunger, H. e Pingree, D. 1999, Astral Sciences in Mesopotamia, Leiden
Jacobsen T. 1942, Pre-Sargonid Temples in the Diyala Region, Oriental Institute Publications n° 58 pag. 58, Chicago, The University of Chicago Press
Jeremias A. 1906, Das Alte Testament im Lichte des Alten Orients Handbuch zur biblisch-orientalischen Altertumskunde, Leipzig, J C Hinrichs
Jestin R. 1937, Tablettes sumériennes de Shuruppak conservées au Musée de Stamboul, Parigi, Ed. Boccard
Kramer S. N. 1975, L'Histoire commence à Sumer, Parigi, Arthaud (V Edizione)
Lambert W. G. 1955, Man and His God: A Sumerian Variation on the "Job" Motif in Archive Orientalni n°23 , Praga, Academy of Sciences of the Czech Republic pag. 289
Landsberger, B. 1976, The Conceptual Autonomy of the Babylonian World, Malibu
Langdon S. 1923, Oxford Editions of Cuneiform Text Volume II, Oxford pag. 258
Legrain L. 1936, Archaic Seal-Impressions in Ur Excavations Volume III, Philadelphia The Trustees of the Two Museum pagg. 18-33
Lhote, J. M. 1994 Histoire des jeux de sociéte, Parigi pag. 36-49Lhôte J. M. 2005, Hypothése concernant le tablier du jeu royal d'Ur in Orient-Express 2005/3 Novembre, Parigi, Institut d'Art et d'Archéologie pagg. 67-72
Lipinski E. 1979, State and Temple Economy in Ancient Near East, Leuven
Liverani, M. 1988, Antico Oriente, Roma, Laterza
Lloyd, S. 1943, Tell Uqair: Excavations by the Iraq Government Directorate General of Antiquities in 1940 and 1941 in Journal of Near Estern Studies vol. 2 pagg. 131-58
Locke, J. 1689 Civil Government II, Rockville (ed. 2008 Wildside Press)
Luciano di Samostata 2001 Come si deve scrivere la storia, Roma, Liguori Editori
Luckenbill D. D., 1930, Inscription from Adab in Oriental Institute Pubblications n° 14 Chicago pagg. 121
Mander, P. 2005, All'origine delle Scienze 1. Medicina ed Esorcistica in "quaderni Napoletani di Assirologia", Napoli, AracneMander, P. 2007, I Sumeri, Roma, Carocci editore,
Matthews R. 2003, Excavation at Tell Brak Vol. 4 Exploring an Upper Mesopotamian regional centre, Londra, British School of Archeology in Iraq 1994-1996 pagg. 321-362
Matthie, P. 1997, La Storia dell'Arte dell'Oriente Antico,Roma, Electa
McCown E. 1952, The Training and Education of the Professional Physical Anthropologist in Archeology. A magazine dealing with the Antiquity of the world 5/2, Cambridge, pagg. 75-88
McCown, Haines, Biggs e E. F. Carter 1978, Nippur, Volume 2. The North Temple and Sounding E: Excavations of the Joint Expedition to Nippur of the American Schools of Oriental Research and the Oriental Institute of the University of Chicago. n° 97 Chicago
Meek T. J. 1935, Old Akkadian, Sumerian and Cappodocian Texts from Nuzi, Excavations at Nuzi, Vol. 3 in Harward Semitic Series, Volume 10, Cambridge, Harward University Press, pagg. 713-715
Meissner B. 1913, Die Keilscrift, Berlino e Leipzig Meissner B. 1927, Dye Babylonie Assyrische Literatur , Wildpark-Postdam
Mellaart, J, 1998 Çatal Hüyük: the 1960’s seasons, in Ancient Anatolia: fifty years work by the British Institute of Archaeology at Ankara (ed R Matthews), 35–41 (London: British Institute at Ankara).
Michalowski, P. 1986, Mental Maps and Ideology: reflections on Subartu in The origins of cities, Londra pagg. 129-156
Moortgat A. 1967 Die Kunst des alten Mesopotamien Wissenschaftliche Buchges, Colonia,
De Morgan J. , Jequier G., e Lampre G. 1902, Delegation en Perse , Memoire 1, Parigi
Neugebauer O. 1936-37, Mathematische Keilschrifttexte, Berlino, Springer
Nissen, J. H., Damerow, P., Englund, R. K. 1993 Archaic Bookkeeping, Chicago pagg. 25-32
Ogden E.S. 1902 A Conjectural Interpretation of Cuneiform Texts . Journal of the American
Oriental Society n°23 Pag. 103
Parrot A. 1937-39, in una recensione di un articolo di Mallowan menzionata nella nota 16 in Archiv fur Orientforschung 12 pag. 151Parrot A. 1948, Tello, Vingt campagnes de fouilles, Parigi Parrot A. 1960, Sumer le Moyen-Orient antique, ParigiParrot A. 1961, Sumer, The Dawn of art, New York, Parrot A. 1961, Syria n°38 pagg. 319-320
Pettinato, G. 1970, Mesopotamia 5, Roma pagg. 281-320Pettinato, G. 1986, Ebla,Nuovi orizzonti della storia, Milano, RusconiPettinato, G. 1998, La scrittura celeste. Milano.
Porada, E. 1948, The Collection of the Pierpont Library, Corpus of Ancient Near Estern Seals in north America, Collection I, Bollinger Series n° 14, Pantheon Books pagg. 118-119
Powell M. A. 1976, The Antecedents of Old Babylonian Place Notation and the Early History of Babylonian Mathematics Historia Mathematica n°3 pagg. 417-439
Ramazzotti, M. 2010, Archeologia e Semiotica, Settimo Torinese (TO), Bollari Bolinghieri
Reade J. 1993, Hormuzd Rassam and his Discoveries Iraq n°55 pagg.39-62
Reiner, E. 1995, Astral Magic in Babylonia, Philadelphia.
Robson E. 2007, The Mathematics of Mesopotamia,China, India, and Islam, Princeton, Princeton University Press Robson E. 2008, Mathematics in Ancient Iraq, A social History, Princeton, Princeton University Press
Sabatini F. 1997, Dizionario italiano, Firenze, Giunti
Sarzec E. de 1884-1912, Decouvertes en Chaldee , vol. 1 e vol 2 Parigi
Scheil V. 1900, Recueil de travaux relatifs à la philologie et à l’archeologie egyptiennes et assyriennes , n° 22 Parigi pag. 206Scheil V. 1907, Delegation en Perse , Memoire 2, Parigi
Schmitt, C. 1974 Il nomos della terra, Milano, Adelphi Editore (ed. 1991)
Smith W. S. 1938, 3 Cylinder seals and scarabs in Geographical Journal, Londra, British Museum Quarterly pagg. 62-63
Sollberger E. 1956, Corpus des Inscriptions royales présargoniques de Lagash, Parigi, Droz Sollberger E. 1971, Les Inscriptions royales sumériennes et akkadiennes, Parigi, Littératures anciennes du Proche-Orient n°3
Stol M. 1973, Van beitel tot pensen , Leiden
Vigneau A. 1935, Encyclopedie photographique de l’art, Volume 1 Parigi
Virolleaud, C. 1907, L'astrologie chaldéenne. Fasc. 2 Texte cunéiforme, Shamash. Paris
Virolleaud, C. 1907, L'astrologie chaldéenne. Fasc. 4 Texte cunéiforme, Adad. ParisVirolleaud, C. 1908, L'astrologie chaldéenne. Fasc. 1 Texte cunéiforme, Sin. ParisVirolleaud, C. 1908, L'astrologie chaldéenne. Fasc. 3 Texte cunéiforme, Ishtar. ParisVirolleaud, C. 1910, L'astrologie chaldéenne. Fasc. 9 Supplément, texte. ParisVirolleaud, C. 1912, L'astrologie chaldéenne. Fasc. 11-12 Second supplément, texte cunéiforme
Wallerstein, I. 1974 The Modern World-System, vol. I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York
Wareham, N. 1866-69, Sold a number of Mesopotamian antiquities, including cuneiform tablets, cylinder seals, terracotta figurines and pottery, to The British Museum between 1866 and 1869 in A Guide to the Exhibition Galleries of the British Museum 1895, Londra
Weidner, E. 1956 Ein Losbusch in Keilschrift aus der Seleudikenzeit, Syria 33, Berlino
Weiss, H. Rova, E. 2003 The origins of north Mesopotamian civilization: Ninevite 5 chronology, Subartu, Vol. 9, cap. 3
Whiting, R. 1984, More Evidence for Sexagesimal Calculations in the Third Millennium B.C. in Zeitschrift für Assyriologie n°74 pagg. 59-66
Winstone, H. V. F. 1990, Woolley of Ur: the life of Sir Leonard Woolley, Londra, Secker & Warburg
Wiseman, D. J. 1960, Fifty masterpieces of Ancient Near Eastern Art, Londra, British Museum Publication Wiseman D. J. 1962, Cylinder Seals I: Uruk -Early Dynastic Periods in Catalogue of the Western Asiatic Seals in the British Museum:, Londra, British Museum Publication pag. 153
Woolley L. 1934, The Royal Cemetery, II, Londra, British Museum Publication Woolley L.1935, Ur Excavations, Volume IV, The early Periods, Londra, British Museum Publication Woolley L. 1953, Spadework: adventures in archaeology, Londra, Lutterworth Press Woolley L. 1962, As I seem to remember, Londra, Allen & Unwin
Young N. 1912, Dictionary of National Biography (Second Supplement) vol. III, Londra, Smith Elder & Co
Zervos C. 1935, L’art de la Mesopotamie, Parigi, Chaiers ed.
Zhok, A 2006, Lo spirito del denaro e la liquidazione del mondo, Milano, Jaka Book