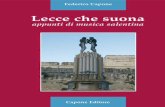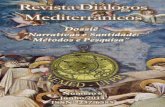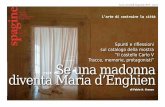Lecce che suona. Appunti di musica salentina (Capone Editore, 2003)
L’ORIZZONTE CULTURALE DEL III MILLENNIO A.C.: IL TUMULO 7 DI SALVE (LECCE)
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of L’ORIZZONTE CULTURALE DEL III MILLENNIO A.C.: IL TUMULO 7 DI SALVE (LECCE)
XXXII, Nuova Serie IV, 2010: 203-258
IL TUMULO 7 (SALVE, LECCE)
Il tumulo 7 è il più imponente dei tumuli finora scavati nel territorio di Salve (fig.1).
Negli anni scorsi, di sei tumuli indagati, due si erano rivelati privi di interesse ar-cheologico, due sono stati interpretati come monumenti cultuali, due erano monu-menti funerari che documentavano il rito incineratorio (Ingravallo et alii 2007). Latipologia era molto semplice: consisteva in cumuli, di forma ovale o subcircolare, diterra e pietre che coprivano una piattaforma basale di grandi massi sistemata sulla roc-cia di base: due di essi contenevano solo frammenti ceramici, su due (tumuli 1 e 6)erano stati deposti vasi con resti incinerati. Una datazione su osso proveniente dal tu-mulo 6 era compresa tra 2600 e 2300 a.C.
Ad essi ne vanno aggiunti altri due, di cui uno (n.8) è risultato un accumulo ca-suale di pietre, l’altro (n. 9) un’ulteriore testimonianza funeraria: di forma ellittica,anch’esso con una piattaforma basale di lastre e pietre, subito sotto lo strato superfi-ciale presentava al centro ossa umane frammentarie e disposte senza ordine. Nel riem-
203
ORIGINI
L’ORIZZONTE CULTURALE DEL III MILLENNIO A.C.: IL TUMULO 7DI SALVE (LECCE)
Elettra Ingravallo* - LecceIda Tiberi* - Lecce
Norma Lonoce* - Lecce
RIASSUNTOIl tumulo 7 di Salve ha pochi confronti nell’e-neolitico italiano per quanto riguarda archi-tettura e ritualità. I materiali, invece, sono difacies Laterza e Gaudo, i primi con precisi ri-mandi a Grotta Cappuccini di Galatone, i se-condi al sito campano di Taurasi.Uno sguardo al III millennio europeo con-sente di inserire i tumuli di Salve in un feno-meno più vasto che coinvolge l’intera Euro-pa attraverso processi di interazione tra cul-ture diverse e geograficamente lontane, dallaYamnaya al Campaniforme fino all’AnticoElladico.
PAroLE ChIAvE: Tumuli funerari, Eneolitico.
ABSTRACTThe tumulus 7 in Salve has few comparisons in theItalian Eneolithic concerning architecture and rit-uality. The materials, instead, can be ascribed tothe Laterza andGaudo facies, the former with pre-cise references to Grotta Cappuccini in Galatoneand the latter to the Taurasi site in Campania.An overview of the European III millennium al-lows to insert the tumulus in Salve into a widerphenomenon which involves the whole Europethrough the interaction processes between differ-ent and geographically far cultures, from Yam-naya Culture to the Bell Beaker Phenomenon tillthe Early Helladic.
KEYwordS: Burial Mounds, Eneolithic.
204
Ingravallo et alii
Fig. 1 – Localizzazione del sito di Salve.
pimento, fatto di terra e pietre, era sparsa una grande quantità di frammenti cerami-ci rotti intenzionalmente.
Il tumulo 7, a circa 100 m in direzione Nord dal tumulo 6, si presentava anch’es-so come un cumulo di pietre esteso su una superficie di circa 200 mq: asportato il li-vello superficiale, mostrava una pianta trapezoidale visibilmente tagliata da una stra-da comunale (fig. 2).
Sul margine orientale era una cista litica di forma rettangolare (160x135 cm spa-zio interno; 230x200 cm ingombro esterno; prof. 150 cm), fatta da lastroni media-mente alti un metro e larghi 1,70 cm, tranne sul lato orientale dove tre massi di me-dia grandezza facilmente rimuovibili segnavano presumibilmente l’ingresso (fig. 3).
Al suo interno, poggiati sulla roccia di base e separati tra loro da due pietre postedi taglio, erano tre vasi con incinerati (fig. 4) dai quali non è stato possibile ricavarealcuna datazione: essi, in ogni caso, hanno inaugurato l’uso sepolcrale della cista. Unpacco di terra, spesso circa 60 cm, li copriva e li separava dalle successive sepolture a
205
L’orizzonte culturale del III millennio a.C.: il tumulo 7 di Salve (Lecce)
inumazione (numero minimo 50 individui): da una di esse proviene la datazioneLTL2464B: 3905±35 BP, 2480-2280 a.C. cal. 2σ, coincidente con quelle disponibi-li per la Grotta Cappuccini di Galatone (Ingravallo 2002).
Gli elementi di corredo erano costituiti da forme ceramiche di tipo Laterza e Gau-do e da oggetti di ornamento quali pendagli e vaghi di collana in osso e conchiglia.
Nell’area prospiciente la cista litica un livello di concotto con intonaco e pietre bru-
Fig. 2 – Salve (Lecce). Tumulo 7 (Foto di S. Pellegrino).
Fig. 3 – Salve (Lecce). Tumulo 7. Cista litica (Foto di A. Potenza).
206
Ingravallo et alii
ciate farebbe pensare alla presenza di una struttura, una sorta di altare, in cui era sta-to acceso il fuoco a scopo rituale nel corso di probabili cerimonie.
Sul margine settentrionale del tumulo erano state deposte tra le pietre due asce-mar-tello del tipo a ferro da stiro e, poco lontano, una piccola ascia.
Il monumento sembra delimitato sul versante meridionale da una sorta di murocostituito da una fila obliqua di grandi massi lunga circa 14 m e interrotta dalla stra-da. Al di qua del muro e, anch’essa interrotta dalla strada, è una superficie con pietredi circa 50 mq al cui interno si trova una buca cultuale di forma circolare delimitatada otto lastre (diam. esterno 150x140 cm; diam. interno 70 cm; prof. 45 cm): con-teneva terra bruciata e una saliera tipo Gaudo intenzionalmente rotta quasi a metà.A circa 1 m da questa e addossata al muro in asse con la cista, una struttura qua-drangolare è marginata da cinque massi, tanto da sembrare anch’essa una cista: si trat-ta, in realtà, di una fossa (110x170 cm; prof. 45 cm) il cui riempimento, costituitoda pietre e terra, rossastra alla base con zone di bruciato, ha restituito un frammentodi femore e alcuni denti umani. da un campione di carbone proviene la datazione:LTL3736A: 4265±40 BP, 2930-2750 a.C. cal. 2σ.
Un saggio (2x2 m) al centro del tumulo sulla sua sommità, in corrispondenza diun lastrone posto quasi come segnacolo, ha rivelato la seguente situazione: rimosso illastrone, era un primo livello con pietre di medie dimensioni e terra di colore grigia-stro con carboni. Asportato questo livello, si è scoperta una buca circolare delimita-ta da pietre piatte sovrapposte su quattro filari e foderata all’interno da altre pietre(diam. 54 cm; prof. 40 cm).
Si trattava di una struttura di combustione, piena di terra e ossa bruciate, servitaprobabilmente per incinerare gli individui, cui potrebbero appartenere i resti raccol-ti nei tre vasi posti alla base della cista.
Fig. 4 – Salve (Lecce). Tumulo 7. Base della cista con vasi contenenti resti incinerati (Foto di A. Potenza).
207
L’orizzonte culturale del III millennio a.C.: il tumulo 7 di Salve (Lecce)
Al fondo della buca era deposta un’olla frammentaria, secondo un rituale - quellodella frammentazione - già presente nell’altra buca con la saliera Gaudo.
L’intero monumento ha il perimetro segnato da massi che dovevano isolarlo dalpaesaggio circostante, salvo il lato che confina con la strada, inevitabilmente di-strutto.
Nonostante la sua incompletezza, si tratta di una costruzione complessa costituitada più elementi separati da un muro: da una parte la cista litica con la retrostante strut-tura di combustione, dall’altra la fossa quadrangolare e la buca cultuale (fig. 5).
Come sempre, nel caso di strutture complesse, si tratta di ricostruire i rapporti trai vari elementi che le compongono.
Anche se con differenti destinazioni d’uso, le due sezioni da cui risulta compostoil tumulo dovevano interagire tra loro, caratterizzandosi l’una come destinata al trat-tamento dei corpi, l’altra come probabile zona di rispetto dalla valenza cultuale, im-piantata – a giudicare dalla datazione proveniente dalla fossa – in un momento pre-cedente. Se ne deduce che il monumento funerario, rappresentato dalla cista e dallaretrostante struttura di combustione, è stato aggiunto, in un secondo momento, dan-do continuità all’uso cultuale di un’area che doveva essere già nota per la sua voca-
Fig. 5 – Salve (Lecce). Tumulo 7. a: buca cultuale; b: fossa; c: struttura di combustione (Foto di S. Pellegrino;elaborazione grafica A. Potenza).
zione sacrale. A questo proposito, non è da escludere che il femore e i denti della fos-sa siano i resti di precedenti sepolture, poi rimosse e trasferite altrove.
di estremo interesse risulta la coesistenza dei due riti, inumazione e incinerazione,che rimanda alla complessità delle pratiche funerarie del III millennio, anche se restada accertare la loro contemporaneità dal momento che - come si è detto - non è sta-to possibile datare gli incinerati.
da sottolineare è anche l’esposizione della cista, rivolta a est, con il mare di fron-te e in posizione dominante sul paesaggio circostante.
L’intero tumulo va, inoltre, contestualizzato rispetto alla presenza sparsa, nel rag-gio di pochi km, di altri tumuli di cui si è detto, molto meno elaborati, alcuni dei qua-li interpretabili come monumenti cultuali, altri, invece, come monumenti funerari:tutti probabilmente appartenenti al medesimo arco cronologico, come si deduce dal-le tipologie ceramiche rinvenute in quelli finora scavati e dalla datazione del tumulo6, poco difforme da quella proveniente dalla cista del tumulo 7.
Il tumulo 6, in particolare, è quello più vicino al 7, distante appena un centinaiodi metri, ha restituito resti combusti di 5 individui (numero minimo) di cui 3 adul-ti, uno di età giovanile e un bambino di 4 anni circa e vasi in ceramica come corre-do. Il tumulo 1 dista, invece, circa 800 m in direzione sud e in esso erano custoditi iresti, sempre combusti, di 2 individui, una donna adulta e un bambino, anch’essi concorredo ceramico. Il tumulo 9, a circa 500 m a sud dal 7, conteneva i resti frammentaridi due individui, di cui uno combusto.
rimane irrisolto il quesito relativo al diverso trattamento dei defunti, al perché adalcuni venisse riservata l’inumazione e ad altri l’incinerazione. Sembrerebbe da accan-tonare una distinzione per classi di età o per sesso dal momento che adulti, bambini edonne sono egualmente presenti tra gli incinerati e gli inumati. Le ragioni sono forseda ricercare in differenze legate allo status, a gerarchie sociali o a linee di discendenza.
resta il fatto che, a differenza delle coeve grotte naturali o artificiali adoperate co-me sepolture collettive, i tumuli rappresentano un modo diverso di celebrare i defunti,con un’architettura aerea che, rispetto alle tombe ipogeiche, aveva un impatto im-mediato sul paesaggio a testimonianza non solo dei morti che vi erano stati sepoltima anche dei vivi che continuavano ad abitarvi.
IL TUMULO 7 DI SALVE E L’ENEOLITICO ITALIANO
Il tumulo 7 di Salve non trova molti confronti nell’eneolitico italiano se non perun richiamo generico alla tipologia (Ingravallo et alii 2007).
Gli esempi più pertinenti sono i tumuli di Sovizzo, ritenuti di ispirazione campa-niforme, i monumenti dell’area megalitica di velturno, i tumuli cultuali di ossimo-Pat e di Sesto Fiorentino.
Come nel caso di Salve, anche il complesso monumentale di S. daniele di Soviz-zo – viale degli Alpini (vicenza), doveva essere ben visibile da lontano: fu eretto, in-fatti, nel punto più elevato della località.
Costruito al di sopra di una piattaforma delimitata da un piccolo fossato, era ca-ratterizzato da un corridoio sacro a tre filari paralleli di pietre e ciottoli - lungo circa
208
Ingravallo et alii
209
L’orizzonte culturale del III millennio a.C.: il tumulo 7 di Salve (Lecce)
20 m - che immetteva in un’area centrale con destinazione funeraria: qui erano tretumuli di forma e dimensioni leggermente diverse; costruiti con pietre e ciottoli, dueavevano forma ellissoidale e uno, il medio, forma quadrangolare; le dimensioni era-no comprese tra i 3 e i 6 m di lunghezza, i 2 e 5,5 m di larghezza con altezza massi-ma di 90 cm. Tutti e tre coprivano una fossa rettangolare centrale in cui erano le se-polture singole di un adulto nel tumulo più grande, un giovane in quello medio, uninfante nel più piccolo. A poca distanza erano altri tumuli funerari purtroppo ma-nomessi.
da una buca da palo scavata nei pressi della fossa sepolcrale del tumulo più gran-de proviene una datazione compresa tra la seconda metà del Iv e la prima metà delIII millennio a.C.
Tra Iv e III millennio a.C. (4430±60 BP, 3349-2905 a.C.) si colloca anche un al-tro tumulo, quello di via Alfieri, rinvenuto a poca distanza dal complesso di vialedegli Alpini: esso era fatto di terra e copriva la sepoltura a inumazione di un indivi-duo giovane con corredo costituito da due punte di freccia peduncolate (Bianchin Cit-ton 2004, 2006; Balista, Bianchin Citton in stampa).
Il complesso di Sovizzo è stato attribuito alla cultura campaniforme per affinitàstrutturali e funzionali col sito di velturno, datato tra il 2500 e il 2250 a.C.
A velturno - Tanzgasse (Bolzano) vi era un’area megalitica caratterizzata da diver-se strutture di carattere cultuale e funerario come tumuli e piattaforme recintate: aldi sotto del tumulo principale erano le ossa cremate di almeno quattro individui: sitrattava di due giovani – di sesso maschile l’uno, femminile l’altro - un bambino e unindividuo di sesso e età non determinabile (Tecchiati 2006).
Aveva invece funzione cultuale il santuario megalitico di ossimo-Pat, in valle Ca-monica, caratterizzato da un’area con allineamenti di stele posta al centro di due areecon tumuli: dal tumulo A provenivano esclusivamente oggetti interpretabili, forse, co-me offerte: si trattava di un vaso e una collana in osso (Poggiani Keller 2006). Ancheil tumulo campaniforme di via Bruschi a Sesto Fiorentino, fatto di piccole pietre ecircondato da un fossato, era privo di resti ossei al suo interno: la sua destinazione fu-neraria è stata ipotizzata sulla base di affinità con strutture della fine del III millen-nio a.C. dell’Europa nord-occidentale (Sarti 1987-88).
Sul piano architettonico, dunque, il tumulo 7 non trova confronti stringenti, fi-nora, nella penisola; i monumenti coevi, infatti, hanno una forma grosso modo cir-colare o ellissoidale e dimensioni più modeste. Quanto al rito funerario – quando èaccertato -, esso consiste in inumazioni singole o in pochi resti cremati. Il tumulo 7ha, invece, - per quanto incompleta - una forma trapezoidale e grandi dimensioni (cir-ca 200 mq) e, sul piano funerario, documenta entrambi i riti.
Il rito incineratorio entro vasi è documentato, dal canto suo, in pochi contesti del-l’eneolitico italiano e mai – finora – sotto tumulo: si tratta di esempi campani, comequelli di Succivo (Marzocchella 1998), Sala Consilina e Taurasi (Talamo 2008) e diun unico caso laziale, quello di Maccarese (Manfredini et alii 2009) in cui i resti diun giovane, datato tra 3500-3000 a.C., erano però deposti in una fossa all’interno,forse, di un contenitore in materiale deperibile.
Nel sito di Capo la Piazza a Sala Consilina (Talamo 2008), sono state riconosciu-
te due fasi relative all’eneolitico: nella prima fase erano, nei pressi di due strutture conbasamento in pietra a secco, alcune incinerazioni entro vasi con corredo composto dapiù oggetti. Nella fase successiva le sepolture consistono in inumazioni in fossa conscarso corredo.
A Succivo le incinerazioni erano contenute in due vasi integri.A Taurasi, in contrada S. Martino, furono rinvenute cinque strutture delimitate da
pali con intelaiatura di frasche e rivestimento di argilla, utilizzate a scopo cultuale efunerario. Alcune avevano pianta absidata e zoccolo di pietra, una era a pianta trape-zoidale e aveva un pavimento lastricato, le altre avevano una pianta non ricostruibi-le. I resti degli individui cremati – si tratta di sepolture singole o bisome cui erano as-sociati resti animali o oggetti di corredo anch’essi bruciati - erano raccolti in vasi, pro-tetti o coperti da un altro vaso capovolto o dal fondo di un vaso rotto, e deposti infosse scavate all’interno delle strutture o nelle immediate vicinanze. In alcuni casi ivasi erano poggiati sul piano di calpestio, in altri i resti umani erano collocati diret-tamente nelle fosse. I pochi oggetti di corredo consistevano in un trapezio, un vasoin ceramica, un pugnale o una fusaiola, solo in un caso in uno spillone in rame. I va-si non utilizzati come cinerari furono in molti casi rotti in posto.
Se i rimandi ad altri contesti dell’eneolitico italiano sono piuttosto generici perquanto riguarda architettura funeraria e tipo di rituale, diverso è il discorso relativoai materiali restituiti dal tumulo 7: le forme ceramiche rimandano, infatti, diretta-mente a Laterza e Gaudo e, in molti casi, trovano esemplari identici in Grotta Cap-puccini di Galatone.
I materiali
I manufatti provenienti dal tumulo 7 sono numerosi e piuttosto diversificati: si trat-ta di recipienti in ceramica, oggetti di ornamento in pietra, osso e conchiglia, stru-menti in calcare, selce e ossidiana, un manufatto in corallo.
dalla buca cultuale proveniva un vaso gemino rotto quasi a metà e costituito dadue ciotole globulari - di cui una frammentaria – raccordate sul corpo da diaframmacon manico traforato e decorate con file sovrapposte di rettangoli alternativamentepunteggiati (fig. 6).
Alla base della struttura di combustione vi erano un’olla globulare, anch’essa rottaintenzionalmente, con quattro anse ad anello verticale impostate sul corpo (fig. 7) euna lama in selce.
Sul lato nord del tumulo furono recuperate due asce martello a ferro da stiro contallone piatto e foro biconico, entrambe in calcare (fig. 8, a, b) e un’ascia in pietra le-vigata di forma trapezoidale (fig. 8, c).
I restanti manufatti provengono dall’interno della cista litica: è assai probabile chemolti di essi fungessero da oggetti di corredo ma in nessun caso - data l’alta fram-mentarietà di forme vascolari e ossa - è stata possibile la loro attribuzione alle singo-le sepolture.
Forse si possono attribuire all’unico individuo in parziale connessione anatomica- che si trovava al di sopra dei vasi contenenti i resti cremati e con il quale iniziava il
210
Ingravallo et alii
211
L’orizzonte culturale del III millennio a.C.: il tumulo 7 di Salve (Lecce)
Fig. 6 – Salve. Tumulo 7. Vaso gemino (dis. A. Guercia).
ciclo delle inumazioni - una punta di freccia peduncolata in selce combusta (fig. 14,h) e alcuni pendagli - uno trapezoidale su conchiglia (fig. 14, b) e un altro losangicosu osso (fig. 14, i).
I recipienti ceramici (figg. 10-13), piuttosto frammentari ma in gran parte rico-struibili, erano mescolati alle ossa e agli oggetti di ornamento: si tratta in prevalenzadi forme per bere – come tazze, boccali e bicchieri - e di recipienti molto bassi e aper-
ti – come le scodelle - usati forse per il consumo di cibi. Non è escluso che tali vasifossero utilizzati in occasione di pratiche cerimoniali che comportavano il consumodi pasti rituali: la loro alta frammentarietà e il fatto che non si ricompongono mai in-tegralmente fanno pensare a pratiche di frantumazione intenzionale e successiva de-posizione degli oggetti in frammenti nella struttura funeraria, secondo una pratica do-cumentata anche negli altri tumuli di Salve e ampiamente attestata in Italia centro-meridionale in tutta l’età del rame (Ingravallo et alii 2007).
oltre ai recipienti ceramici, nella cista erano oggetti di ornamento di materiali eforme diverse: consistevano in un frammento di corallo (fig. 14, k), in vaghi di col-lana cilindrici su conchiglia (fig. 14, c-d) e pendagli su osso (fig. 14, g, j), su dente(fig. 14, f) e uno in calcare (fig. 14, a). Particolare una placchetta in osso decorata conmotivo trapezoidale realizzato con puntini incisi con tre fori passanti a una estremitàe un gancio spezzato su quella opposta (fig. 14, e). Nella cista erano anche un pun-teruolo in osso (fig. 14, l) e alcune lame di ossidiana.
In tre vasi integri erano contenute, infine, le incinerazioni rinvenute alla base del-la cista: si tratta di una brocca con collo troncoconico e corpo globulare decorata asolcature sul collo e sulla spalla (fig. 9, b), una probabile brocca con colletto cilindri-co decorata anch’essa con solcature sul collo e sulla spalla (fig. 9, c) e un’olla globula-re con impressioni a tacche sull’orlo e due anse a rocchetto decorate a solcature obli-que (fig. 9, a).
Numerosi sono i rimandi a Gaudo e Laterza, interessanti le analogie con GrottaCappuccini di Galatone: boccaletti, tazze, scodelle rientrano, ad esempio, nel reper-torio vascolare Laterza presente in diversi contesti funerari e d’abitato dell’Italia cen-
212
Ingravallo et alii
Fig. 7 – Salve. Tumulo 7. Olla (dis. A. Guercia).
213
L’orizzonte culturale del III millennio a.C.: il tumulo 7 di Salve (Lecce)
Fig. 8 – Salve. Tumulo 7. Asce (dis. A. Guercia).
tro-meridionale. Si tratta di forme standardizzate che si ripetono, pur con piccole va-rianti, in molte grotte salentine e in siti Laterza campani e laziali: le scodelle con or-lo sopraelevato (fig. 10) sono attestate, ad esempio, a Cappuccini (Ingravallo 2002:n. 46) e in numerosi siti tirrenici di facies Laterza (Cocchi 2007: fig. 3, 1-9); le taz-ze con manico trapezoidale sopraelevato (fig. 11) sono documentate a Cappuccini (In-gravallo 2002: nn. 63-65), Trinità (Cremonesi 1978: fig. 1, 10) e sono ampiamentediffuse, ad esempio, nel territorio di roma (Anzidei et alii 2007: fig. 10, 2; fig. 12,1, 20); i boccaletti che richiamano il profilo del classico boccale Cellino S. Marco (fig.12, a, b, d) sono presenti, oltre che nella tomba omonima (Lo Porto 1962-63: fig. 6),a Cappuccini (Ingravallo 2002: n. 112) e al Fico (Palma di Cesnola, Minellono 1961:fig. 2, 6).
Sembrano rientrare in una produzione seriale anche la tazza troncoconica con pic-colo tacco (fig. 13, b) e quella carenata con ansa a nastro sopraelevato (fig. 12, c): en-trambe si ritrovano a Grotta Cappuccini (Ingravallo 2002: nn. 57, 69, 72).
Anche tra gli ornamenti vi sono manufatti molto simili per forma, dimensioni, de-corazione e forse anche funzione a quelli di Cappuccini: è il caso della placchetta suosso con traccia di gancio a una estremità (fig. 14, e) che trova un confronto analo-go, appunto, a Galatone (Ingravallo 2002: n. 156).
Quelle finora descritte sono forme vascolari che rientrano in una tradizione loca-le fortemente sedimentata, come testimoniato da altre grotte salentine come Cap-puccini, Trinità, Fico.
hanno invece pochi confronti, finora, in Puglia, i recipienti ceramici riferibili al-la facies del Gaudo: si tratta della saliera (fig. 6), delle brocche (fig. 9, b, c) e del vasoa collo (fig. 9, d) del tumulo 7 che trovano confronti in molti contesti campani tracui Pontecagnano, Acerra, Caivano e, soprattutto, Taurasi. Nel caso della saliera, va-le la pena notare il suo carattere ibrido: nella forma rimanda a Gaudo ma nella de-corazione il riferimento è a Laterza e in particolare a Grotta Cappuccini dove una cio-tola globulare (Ingravallo 2002: n. 39) e un’olla (Ingravallo 2002: n. 15) sono deco-rate con medesima tecnica e motivo. è un esempio significativo della circolazione diforme e motivi che spesso finiscono con il contaminarsi, realizzando varianti locali.Il vaso gemino di Salve, infatti, pur trovando confronti con analoghi esemplari qua-li quello della T 112 di Acerra (Bailo Modesti, Salerno 1998: figg. 39-40 e Tav. 65,3) e della T10 di Caivano (Laforgia et alii 2007: fig. 2; Laforgia, Boenzi 2009: fig.12, 3) differisce da questi per forma e disposizione della piastra.
diverso, invece, il discorso per il vaso a collo che ricorre, uguale, in contesti Gau-do quali la tomba 112 di Acerra (Bailo Modesti, Salerno 1998: fig. 38 e Tav. 65, 2),la T10 di Caivano (Laforgia et alii 2007: fig. 2; Laforgia, Boenzi 2009: fig. 12, 5), letombe 6589 e 6513 A di Pontecagnano (Bailo Modesti, Salerno 1998: fig. 29, 4; fig.17, 11); esso è presente, inoltre, nel Lazio, nella T23 di osteria del Curato -via Cin-quefrondi (Anzidei et alii 2007: fig.9, F), dove era associato a una scodella biansatadi facies Laterza e a una ciotola rinaldone, quasi a conferma della mancanza di con-fini geo-culturali.
Anche le brocche che contenevano le incinerazioni alla base della cista richiamano
215
L’orizzonte culturale del III millennio a.C.: il tumulo 7 di Salve (Lecce)
217
L’orizzonte culturale del III millennio a.C.: il tumulo 7 di Salve (Lecce)
Fig. 11 – Salve. Tumulo 7. Ceramica di facies Laterza (dis. A. Guercia).
tipologie Gaudo: in particolare ricordano molto, per il profilo e la decorazione a solca-ture sul collo e sul corpo, forme analoghe rinvenute a Taurasi. Confronti con questo si-to erano già stati messi in evidenza per alcune brocchette rinvenute nel tumulo 1 di Sal-ve (Ingravallo et alii 2007: fig. 5, 4-5): il tumulo 7 ne offre altri, altrettanto significati-vi. Si vedano, in dettaglio, le due brocche di cui una con alto collo troncoconico, cor-po globulare e ansa a nastro verticale impostata tra collo e spalla che presenta un deco-ro a solcature orizzontali sul collo e a fasci di linee convergenti che formano triangolisulla spalla (fig. 9, b), molto simile a una brocca, anch’essa contenente resti umani bru-ciati, rinvenuta nella struttura 1 di Taurasi (Talamo 2008: fig. 3, ½, fig. 13, 1), e l’altraprobabile brocca (fig. 9, c), molto simile alla precedente per forma e decorazione, conrimandi a contenitori analoghi, anch’essi contenenti incinerazioni, rinvenuti nelle strut-ture 2 e 5 di Taurasi (Talamo 2008: fig. 4, 2/4; fig. 7, 5/4, fig. 13, 6).
Tra gli altri manufatti del tumulo 7, particolari sono le asce-martello del tipo a fer-ro da stiro (fig. 8, a, b). Si tratta di strumenti che hanno ampia diffusione in tuttal’Europa centro-orientale e anche nella penisola sono ben attestati - sia in contesti fu-nerari che d’abitato - a partire dall’eneolitico come, ad esempio, a Conelle di Arcevia(Carrisi 2003) e Maddalena di Muccia (Manfredini et alii 2005). Pochi gli esempla-ri provenienti dall’Italia meridionale: si tratta, in prevalenza, di manufatti recuperati
218
Ingravallo et alii
Fig. 12 – Salve. Tumulo 7. Ceramica di facies Laterza (dis. A. Guercia).
durante ricognizioni di superficie come, ad esempio, l’ascia in pietra dura provenientedai dintorni di Galatone (Cremonesi 1985: Tav. 4, 1).
Per i materiali provenienti dal tumulo 7 di Salve il confronto ravvicinato è, dun-que, con Grotta Cappuccini ma gli ambiti di riferimento sono Gaudo e Laterza, ilcui stile caratterizza buona parte della produzione dell’Italia centro-meridionale. Sitratta di forme che – al pari di quelle di rinaldone – annoverano numerose variantiin virtù delle quali si è ritenuto di dover procedere a ulteriori suddivisioni in gruppie facies in aggiunta a quelli già noti.
Alla facies di rinaldone si è aggiunta la facies di Camerano - Fontenoce (Cocchi2009), a Laterza quella di Torrespaccata - Gricignano (Cocchi 2009); pertinente a Gau-do è stata coniata la facies di Taurasi (Talamo 2008). Numerosi gruppi, inoltre, sonostati individuati in rinaldone (Cocchi 2009), mentre 4 fasi sono state distinte nell’e-neolitico più strettamente meridionale e precisamente calabrese (Pacciarelli 2008).
Grazie al procedere della ricerca si dispone, effettivamente, di una maggiore quan-tità di dati che hanno rivelato aspetti finora inediti dell’eneolitico centro-meridiona-le come ad esempio, la scoperta dell’aspetto abitativo della facies Laterza venuto inluce in siti come Gricignano. La rarità di siti d’abitato - a dire il vero - riguarda unpo’ tutto l’eneolitico italiano e da ciò deriva la difficoltà di ricostruire modi di vita eorganizzazione sociale e territoriale del III millennio.
Ma, mentre per rinaldone e Gaudo si disponeva di esempi significativi (si pensi a
219
L’orizzonte culturale del III millennio a.C.: il tumulo 7 di Salve (Lecce)
Fig. 13 – Salve. Tumulo 7. Ceramica di facies Laterza (dis. A. Guercia).
siti noti come Cerquete – Fianello e Toppo daguzzo), per Laterza se ne doveva regi-strare la totale assenza. Aver ritrovato anche per essa la dimensione abitativa confer-ma una vecchia certezza, anche se mai del tutto provata, e cioè che le facies dell’e-neolitico italiano non potevano esaurirsi nell’aspetto meramente funerario ma che, an-zi, questo andava considerato come una parte per di più lontana dal restituire l’im-magine di un’intera società.
risulta, dunque, pleonastica una facies come quella di Torrespaccata - Gricignanocreata solo per sottolineare – rispetto alla classica Laterza – l’aspetto insediativo.
Non c’è bisogno, in altre parole, di esplicitare ciò che è implicito e ovvio nella stes-sa nozione di facies: la possibilità, cioè, di comprendervi non solo i modi di morirema anche i modi di operare e di vivere.
oltre all’aspetto insediativo di Laterza, un altro importante tassello dell’eneolitico me-ridionale è venuto in luce con le strutture a incinerazione di Taurasi, da cui la facies omo-nima. Essa, con forme vascolari molto simili a quelle del Gaudo, viene tuttavia ritenu-ta facies a sé stante e giustificata da due ordini di fattori: il primo di carattere cronolo-gico dal momento che l’arco di tempo entro il quale rientra Taurasi (dai 3900 ai 3000a.C.) è considerato troppo antico per il Gaudo, il secondo di carattere tipologico rela-tivo a singoli dettagli nella fattura e nel decoro dei vasi che segnerebbero una differen-za con la tipologia Gaudo, come – per esempio – l’attacco delle anse sulle brocche: ne-gli esemplari di Taurasi l’attacco superiore dell’ansa è sul collo e non sulla spalla comeavviene in Gaudo. o nella decorazione a solcature che avrebbe molta più familiarità conPiano Conte, soprattutto dei contesti calabresi, che non con Gaudo (Talamo 2008).
Ad avvalorare l’accostamento Piano Conte - Taurasi sono le fasi eneolitiche indi-viduate nell’altopiano del Poro (vibo valentia), la più antica delle quali (Foculìo) pre-senta somiglianze con Taurasi nelle scodelle ornate sull’orlo con solcature (simili alletacche di Taurasi) o nei vasi a collo cilindrico basso con fasci di solcature sottili. Sidelineerebbe, in altre parole, una progressiva evoluzione tra gli stili di Piano Conte eGaudo, e Taurasi ne sarebbe la conferma (Pacciarelli 2008).
In attesa che gli elementi costitutivi della facies di Taurasi vengano maggiormen-te approfonditi, sia lecito avanzare dubbi sugli attuali fondamenti che la giustifiche-rebbero, uno cronologico e l’altro – come si è detto – tipologico.
La cronologia di Taurasi che mal si concilierebbe con Gaudo, in realtà è meno in-congrua di quanto si pensi: essa sposterebbe l’inizio del Gaudo nel Iv millennio, co-me in qualche modo si è sempre ipotizzato e come lasciava immaginare la datazionedi Toppo daguzzo (3690-3340 a.C.), per quanto isolata.
è opinione comune, d’altra parte, che gli aspetti dell’eneolitico italiano inizino nelIv millennio come confermato da rinaldone; il fatto che la maggior parte delle da-tazioni attualmente disponibili per il Gaudo e tutte quelle relative a Laterza ricadanonel III millennio non vuol dire che l’uno e l’altra non risalgano entrambi al Iv mil-lennio, in analogia con rinaldone.
occorre, per questo, attendere successive verifiche. In ogni caso, per tornare allafacies Taurasi, il fattore cronologico perde la sua validità nel momento in cui Taura-si viene considerato culturalmente affine a Salve (Talamo 2008): c’è da dire, infatti,che Salve ha datazioni vicine a quelle di Gaudo, e questo rende difficile accettare la
220
Ingravallo et alii
221
L’orizzonte culturale del III millennio a.C.: il tumulo 7 di Salve (Lecce)
Fig. 14 – Salve. Tumulo 7. a-g, i-k: oggetti di ornamento; h: cuspide di freccia; l: punteruolo (dis. A. Guercia).
parentela con Salve e escludere quella con Gaudo. Quanto alla tipologia, le difformitàtra Taurasi e Gaudo appaiono attualmente di lieve entità: sono piccole varianti chedi norma si osservano all’interno di una stessa facies nell’ambito di siti ad essa attri-buibili. Si vedano, per esempio, le differenze nella produzione Laterza tra un sito co-me Grotta Cappuccini e altri come Salve.
Il che equivale a dire che non ci si può attendere uniformità seriale da una produ-zione che, per quanto ispirata a canoni comuni, è di per sé soggetta a variazioni le-gate a gusti, preferenze, tradizioni quando non addirittura a motivi casuali. Per nonparlare delle rielaborazioni che uno stile è destinato a subire nel corso della sua – spes-so lunga – durata.
Quanto alle affinità Piano Conte – Taurasi, le analogie riscontrate tra i due si ri-ducono, di fatto, a elementi decorativi quali tacche sull’orlo o solcature sul collo divasi che nella loro diffusione in contesti eneolitici di Iv e III millennio finiscono conl’essere tanto generici – soprattutto quando si tratta di frammenti isolati - da perde-re qualsiasi riferimento a specifiche facies. Le solcature, infatti, sottili o profonde ap-partengono al bagaglio di motivi comuni dell’eneolitico e solo in pochi casi acqui-stano valore diagnostico, come accade con le scodelle Piano Conte del sito eponimoo con le brocche del Gaudo.
Al momento appare, dunque, prematuro parlare di facies per Taurasi che potreb-be, al contrario, rappresentare l’inizio di Gaudo, da porsi – al pari di quello di ri-naldone – nel Iv millennio.
Ma, al di là delle questioni relative alla parentela o meno con Piano Conte o conGaudo, ciò che fa di Taurasi un caso finora unico nell’eneolitico centro-meridionale èl’aver svelato l’antichità del rito incineratorio. Se ne deduce che esso si afferma fin dalIv millennio, affiancando il più documentato rito inumatorio. è difficile, infatti, pen-sare a Taurasi come a un episodio isolato: l’esempio di Succivo – per quanto episodi-co – e quello più consistente di Sala Consilina (Talamo 2008) ne sono un indizio.
Alla luce di quanto appena detto, niente esclude che anche nel Salento il rito inci-neratorio possa risalire a una fase più arcaica di quella documentata a Salve. Le data-zioni del sito lo collocano nel III millennio ma va anche sottolineato che né dalla strut-tura di combustione né dai vasi con gli incinerati del tumulo 7 è stato possibile rica-vare alcuna datazione per mancanza di collagene nelle ossa. Al momento, quindi, Sal-ve rappresenta l’esempio più antico di incinerazione nell’eneolitico del sud-est italia-no culturalmente compatibile sia con Taurasi che con Gaudo.
i.t.
L’EUROPA TRA IV E III MILLENNIO A.C.. IL FENOMENO DEI TUMULI
Quello dei tumuli non è un fenomeno omogeneo sia che lo si consideri sul pianocronologico che su quello tipologico, oltre che dal punto di vista della loro funzionenon sempre univoca.
Essi, infatti, possono essere monumenti funerari o, in alcuni casi per l’assenza di
222
Ingravallo et alii
223
L’orizzonte culturale del III millennio a.C.: il tumulo 7 di Salve (Lecce)
deposizioni, essere interpretati come monumenti cultuali e, come tali, possono ave-re svolto ruoli differenti all’interno di un territorio; hanno differenti dimensioni, strut-ture e tipi di tombe al loro interno; occupano segmenti anche distanti di un lungoarco cronologico.
Uno sguardo all’Europa tra Iv e III millennio esteso all’area egea può, forse, aiu-tare a comprenderne meglio la portata e l’incidenza, una volta inseriti nelle rispetti-ve culture di riferimento e messi in rapporto con gli altri aspetti che le hanno carat-terizzate. Come dire, una breve rassegna dalla cultura Yamnaya all’antico elladico, pas-sando per la ceramica cordata e il campaniforme.
La cultura Yamnaya
La comparsa dei tumuli in Europa tra Iv e III millennio a.C. è stata una questio-ne a lungo dibattuta, sulla quale influì notevolmente la teoria migrazionista di Gim-butas (1981), che attribuiva all’invasione del popolo dei Kurgan (tumuli) l’introdu-zione dei tumuli nell’area egeo-balcanica attorno al III millennio a.C. Più esattamente,attribuiva alla cultura dei Kurgan la comparsa delle tombe a fossa e delle successivetombe a catacomba, comprendendovi però molte altre culture di fine neolitico e delprimo bronzo dell’Europa orientale, sicché della cultura dei Kurgan entrarono a fareparte tutte le culture con tumuli o perfino senza (Anthony 2007).
Con il procedere della ricerca è emerso, tuttavia, che più che di migrazioni siste-matiche si trattò di un processo probabilmente a ondate, che portò i gruppi Yamnaya(tombe a fossa in russo) verso occidente nelle pianure del basso danubio e nella zo-na centrale del bacino carpatico. In quest’area (romania, Bulgaria, Serbia, Ungheria)i tumuli si affermano in concomitanza con l’espandersi della cultura di Baden (metàIv- primi secoli del III millennio) accompagnata, a sua volta, da un’accentuata re-gionalizzazione nei costumi funerari che esclude l’uso dei tumuli come tipologia pri-vilegiata. Nella pianura pannonica, per esempio, continua l’uso del primo Baden disepolture coperte da pietre o di stele usate come segnacoli di tombe o di intere ne-cropoli. rari i tumuli nel bacino carpatico occidentale, mentre una presenza cospi-cua si segnala per il Baden tardo nelle zone periferiche orientali, in particolare nel sud-est con la chiara influenza dei Kurgan (Sachsse in stampa).
La migrazione Yamnaya nella valle del danubio iniziò attorno al 3100 a.C. com-pletandosi nel giro di circa 300 anni (Anthony 2007), mentre l’intera durata della cul-tura dovrebbe ricadere in un arco di tempo compreso tra 3100 e 2500-2400 a.C. (Kai-ser in stampa).
In realtà, spostamenti di popolazioni dalle regioni nord- pontiche si erano già avu-ti dalla metà del v millennio; ciò che cambia rispetto a prima è, evidentemente, unimpatto più visibile sulle culture locali, come testimoniato dai tumuli.
Questi si presentano spesso come monumenti imponenti, misurando dai 15 ai 60 mdi diametro (heyd in stampa). Nelle tombe a fossa rettangolare a volte sono tracce distuoie, di elementi lignei e di ocra sparsa sui resti ossei; le tombe centrali sono per lo piùmonosome con un adulto sepolto supino o in posizione rannicchiata. Spesso ci sono tom-be aggiunte successivamente con ulteriori sovrapposizioni, sicché i tumuli possono rag-
giungere anche i 3-4 m di altezza. Ciò rende a volte difficile una chiara distinzione tratombe Yamnaya e quelle di altri gruppi. Ugualmente complessa è la situazione in cui al-cuni tumuli vengono eretti su precedenti insediamenti, tipo Boleràz e Baden in Unghe-ria e Serbia o Cernavoda in romania, dove non è dato sapere quanto di intenzionale ocasuale ci sia stato in questa scelta. rari i corredi e ciò distingue gli Yamnaya occidenta-li del Mar Nero dai loro affini nord-pontici, le cui tombe sono mediamente più ricche.La ceramica, quando c’è, appartiene di solito alle culture locali con le quali si trovano aconvivere i gruppi Yamnaya; più di rado ha caratteristiche che sembrano rinviare a lorotradizioni, come impressioni a corda o motivi a triangoli (heyd in stampa).
Poco si sa sull’organizzazione sociale, dal momento che si dispone esclusivamentedi testimonianze funerarie e anche queste poco dicono sul loro significato: chi avevail diritto di essere seppellito nei kurgan, quanto tempo durava il loro uso prima del-l’abbandono, quale era il rapporto con il territorio.
Nonostante tali lacune, la Yamnaya rappresenta, a parere di alcuni studiosi(Anthony 2007), la prima cultura europea più o meno unificata nel rituale funera-rio, nell’economia e nella cultura materiale, anche se mai completamente omogenea,molte essendo le varianti regionali e per le quali viene anche definita “comunità sto-rico-culturale”. definizione non condivisa da tutti per l’implicito richiamo a una co-mune identità culturale o etnica, per cui si suggerisce di usare al suo posto il terminemeno impegnativo di “orizzonte”(Anthony 2007). E, tuttavia, secondo alcuni auto-ri (harrison, heyd 2007) l’influenza sull’ideologia, il costume, l’economia delle areeda essa raggiunte sarebbe stata tale da configurarsi come vero e proprio “pacchettoYamnaya” in cui, oltre alla decorazione cordata e alle stele antropomorfe, rientrano itumuli. Non si ignora il fatto che i tumuli Yamnaya non furono i primi a comparirenella loro area di distribuzione, ma il dato saliente che viene sottolineato è la loro pro-liferazione all’inizio del III millennio in un vasto areale che arriva, come estrema pro-paggine, fino alla Puglia meridionale (heyd in stampa).
Quanto al loro stile di vita, si è parlato di una società pastorale di stampo patriar-cale, legata a un nomadismo stagionale, che viveva in tende con carri trascinati da ani-mali e il cavallo come efficiente mezzo di trasporto (Anthony 2007).
Tutto ciò viene, tuttavia, desunto da prove indirette quali sono la mancanza di in-sediamenti, il ritrovamento di ossa di cavallo e di carri nelle tombe.
In effetti, alla fine del Iv millennio, nell’area pontica settentrionale, con la cultu-ra Yamnaya, si diffonde l’usanza di seppellire il defunto insieme al carro. La maggiorparte delle “tombe a carro” si ha nella I metà del III millennio soprattutto nella rus-sia meridionale, mentre la presenza del carro diventa rara nella successiva fase dellecatacombe (2500-2000 a.C.). Le tombe sono sotto tumulo, spesso con più sepoltu-re. La presenza del carro nelle tombe, peraltro non molto frequente, è associata in ge-nere a individui maschili e doveva costituire un elemento di distinzione. A giudicaredal numero delle ruote, sembra si trattasse di carri a due ruote, anche se non è da esclu-dere l’esistenza di diverse tipologie (Kaiser 2007).
La cultura Yamnaya evoca inevitabilmente la questione della ruota e del cavallo conle relative controversie circa l’origine e la loro diffusione.
Per quanto riguarda la ruota, alla tradizionale dicotomia tra il modello monocen-
224
Ingravallo et alii
trico che ne vuole la comparsa in Mesopotamia alla metà del Iv millennio e il mo-dello policentrico che ne vede uno sviluppo parallelo e indipendente in base alla pre-senza di modellini in contesti dell’Europa centro-occidentale (Pétrequin et alii 2006),si aggiunge la posizione di chi ne attribuisce l’invenzione alla fase antica della cultu-ra di Tripolje (fine v- inizi Iv millennio): da qui si sarebbe diffusa in Europa e in Me-sopotomia (Matuschik 2006).
Per questa, come per altre simili controversie, è sempre difficile arrivare a un pun-to fermo e, quand’anche vi si arrivi, ha poca importanza sapere il luogo d’origine diqualsiasi innovazione se non se ne comprendono i presupposti che in quel luogo han-no consentito la sua adozione.
Quanto al cavallo, la discussione verte sul suo addomesticamento e sull’uso comecavalcatura.
Tralasciando anche qui il problema dell’area nucleare, nella quale molti studiosi ve-dono il centro propulsore delle lingue indoeuropee, è indubbio che le steppe euroa-siatiche abbiano costituito l’habitat ideale per la vita del cavallo. Non sorprende, per-ciò, che la sua prima domesticazione sia avvenuta – presumibilmente nel III millen-nio - in quei luoghi dove era cacciato fin dal neolitico.
Ma, come tutti i processi di addomesticamento, avrà comportato fasi sperimenta-li sicché da risorsa di cibo il cavallo sarà stato usato come cavalcatura, simbolo di po-tere, animale da traino con tempi e modi differenti da luogo a luogo.
Sulla questione, poi, se l’uso del cavallo come trazione animale abbia preceduto ilsuo impiego come cavalcatura o viceversa, al momento non esistono dati certi e i pa-reri sono discordi (Cattani 2007).
Certo, cavalcare non richiedeva attrezzature complesse quali quelle necessarie allatrazione di un carro. Nondimeno, secondo alcuni autori, il cavallo come mezzo di tra-sporto veloce si prestava bene in un’economia di caccia o di incursioni predatorie, me-no in un’economia pastorale dove non c’era la necessità di movimenti rapidi. Secon-do altri (Anthony 2007), invece, il suo uso era polifunzionale e, accoppiato al carrotrascinato da buoi, avrebbe fatto del modo di vivere dei gruppi Yamnaya un model-lo di “successo”.
Allo stato attuale è difficile dire quanto abbia pesato l’urto dei gruppi Yamnaya sul-le culture da essi raggiunte.
Il modello “di successo”, in realtà, ha ancora bisogno di prove documentarie, nonessendoci testimonianze di un uso generalizzato del carro nella vita quotidiana o del-l’impiego abituale del cavallo come cavalcatura o animale da traino.
Analoga cautela occorre nel parlare di “pacchetto”, dal momento che esso presup-pone un’origine comune per elementi che spesso devono la loro apparente omogeneitàa contatti e influssi di provenienza diversa o anche a fenomeni di convergenza.
è un po’ arduo, per esempio, immaginare che le statue stele dell’Italia settentrio-nale siano nate sotto la spinta della cultura Yamnaya, e così anche i tumuli del sud-est italiano. Più facile attribuire le une e gli altri all’azione concomitante di più fat-tori in cui entrano in gioco diffusione, interazione tra culture o anche autonoma ela-borazione.
La cultura Yamnaya viene, dunque, chiamata in causa nella spiegazione dei muta-
225
L’orizzonte culturale del III millennio a.C.: il tumulo 7 di Salve (Lecce)
menti dell’Europa a partire dalla metà del Iv millennio per l’introduzione del carro,del cavallo e dei tumuli funerari i quali ne sono effettivamente un tratto distintivo adifferenza di quanto si può constatare per altre culture.
Uguale importanza ai fini del cambiamento viene data, indipendentemente dallaYamnaya, a un più intenso sfruttamento dei prodotti secondari dell’allevamento, al-la trazione animale per fini agricoli, alla metallurgia.
Si tratta, in realtà, di elementi non tutti apparsi contemporaneamente né per ope-ra di un unico agente promotore e, soprattutto, con una storia diversa da regione aregione che non consente facili omologazioni neppure sul terreno dei costumi fune-rari, non rappresentando i tumuli un modello unanimemente adottato. L’Europa traIv e III millennio presenta, infatti, un quadro più frastagliato e disomogeneo di quan-to si possa pensare, anche se è probabile che le innovazioni tecnologiche – sommatea un peggioramento climatico (Barfield 2003) – abbiano contribuito alla fine del mon-do neolitico e alla nascita di nuove culture, non solo nei luoghi raggiunti dai popolidelle steppe, ma anche nel resto d’Europa.
La ceramica cordata
dal 2900 al 2700 a.C. la ceramica cordata si diffonde in Europa centrale dall’U-craina al Belgio, introducendo una nuova produzione ceramica e le sepolture sottotumulo che convivono con altri rituali quali le tombe singole o raggruppate in ne-cropoli.
dietro la presenza di armi nei corredi maschili, alcuni studiosi hanno intravisto unasocietà regolata da un’élite guerriera (heyd 2004) formatasi in seguito allo sviluppodella metallurgia e alla gestione delle relative reti di traffico e di comunicazione.
Può darsi, anche se c’è da considerare che il mondo restituito dalle testimonianzefunerarie quasi mai coincide con la realtà sociale e che anzi, il più delle volte, ne è laproiezione ideale costruita a beneficio dei morti e, per loro tramite, delle rispettivecomunità.
Poco altro si sa delle società della ceramica cordata, la cui importanza è forse do-vuta al solo fatto di aver anticipato forme e decori del campaniforme che di lì a po-co le si sovrappone in buona parte d’Europa (dal Portogallo alla Polonia, dalla Siciliaalle isole britanniche).
I suoi oggetti, simili in parte a quelli della ceramica cordata, definiscono il classi-co set (Strahm 2004a): punte di freccia con peduncolo e alette o a base concava tipi-che dell’ Europa centrale, punte di Palmela, pugnale con codolo, bracciale da arcie-re, bottoni con perforazioni a v. Il loro insieme si sarebbe strutturato nel corso deltempo in vero e proprio “pacchetto”, che viene considerato espressione di societàorientate al riconoscimento di status symbol al proprio interno.
Il bicchiere, in particolare, diventa simbolo di riconoscimento ma anche, per al-cuni autori, contenitore di bevande alcoliche, secondo una ritualità socialmente co-dificata che prevedeva precise modalità funerarie: sepolture singole in posizione ran-nicchiata con tutto o parte del set e probabile svolgimento di cerimonie con libagio-ni in onore del defunto.
226
Ingravallo et alii
Il campaniforme
Si continua ancora oggi a discutere sull’origine del campaniforme, tentando di rin-tracciare in alcuni sostrati autoctoni i precedenti tipologici e decorativi dai quali si sa-rebbe generato il classico stile.
Tramontata la teoria tradizionale che ne vedeva il centro nella valle del Guadalquivirsulla base della “cultura de las cuevas” (Bosch Gimpera 1926), sono note le ipotesiavanzate successivamente: il Portogallo (harrison 1977), i Paesi Bassi (Lanting, vander waals 1966), l’Europa centrale (hajek 1966), l’Europa meridionale dal Portogalloalla Sicilia occidentale (Guilaine et alii 2009) sono stati di volta in volta indicati co-me probabili luoghi di nascita del fenomeno.
Considerata la presenza campaniforme nella sua vastità geografica, numerosi pro-blemi tuttavia sussistono su una visione monocentrica della sua genesi proprio alla lu-ce dell’eterogeneità delle manifestazioni ad essa legate e della molteplicità dei sostra-ti preesistenti.
L’unificazione europea di cui il campaniforme sarebbe stato artefice, a un’analisi ap-profondita, si rivela in realtà più apparente che reale, rendendo difficile una sintesirelativa ai vari aspetti che lo caratterizzano, a cominciare dalle tipologie insediative.
Qui, come in altri campi, c’è una grande variabilità di situazioni che include con-tinuità d’uso di siti preesistenti oppure piccoli nuclei sparsi o, ancora, in presenza ditombe, assenza di strutture abitative. A regioni con discreta densità di popolazionecome la Spagna centro-settentrionale (harrison, Martin 2001) fanno da contrappuntoaltre, quale l’Estremadura portoghese (Cardoso 2001), che registrano un popolamentosparso fatto di semplici capanne. rarità di abitati si riscontra nel Midi (Guilaine etalii 2001), dove pure sono censite alcune centinaia di insediamenti dislocati in pia-nura, su terrazzi o anche in grotta.
In Italia, per ora, le attestazioni campaniformi si fermano al confine Lazio setten-trionale-Toscana meridionale sul versante Tirrenico, mentre su quello Adriatico si han-no solo ritrovamenti isolati (Leonini, Sarti 2008). E anche nelle situazioni in cui èmaggiormente documentato come in Italia settentrionale (Bermond Montanari2001; Nicolis 2004; Baioni, Poggiani Keller 2008) o in area fiorentina (Leonini et alii2008), i dati sono troppo frammentari per ricavarne orientamenti generali su scelteinsediative o organizzazione degli spazi abitati.
Analoga difformità di situazioni si riscontra nei rituali funerari che non sembranorisentire di grandi novità rispetto alle tradizioni preesistenti. In regioni come Spagna,Francia mediterranea, Portogallo vengono riutilizzati monumenti megalitici anterio-ri al campaniforme o antiche necropoli collettive; continua l’uso degli insediamentifortificati in Portogallo e Zambujal (Kunst 2001) ne è un esempio. In Italia, l’unicatestimonianza di carattere rituale in area fiorentina attribuita al campaniforme è il tu-mulo in via Bruschi di Sesto Fiorentino (Leonini et alii 2008), mentre più numero-si sono i dati della Lombardia con strutture complesse quali piattaforme, tumuli, al-lineamenti di stele (Baioni, Poggiani Keller 2008), del Trentino e valle d’Aosta conle aree megalitiche di velturno (Tecchiati 1998, 2006) e Saint Martin de Corléans(Mezzena 1998), probabilmente del veneto con la scoperta a Sovizzo di tre tumuli
227
L’orizzonte culturale del III millennio a.C.: il tumulo 7 di Salve (Lecce)
funerari considerati campaniformi (Balista, Citton in stampa). Al campaniforme, an-cora, rinvia il complesso cultuale di Fosso Conicchio (Fugazzola delpino, Pellegrini1999).
Uno sguardo sommario al versante centro-orientale europeo restituisce anch’essoun panorama in gran parte lacunoso con una preponderanza delle testimonianze fu-nerarie rispetto a quelle abitative.
Nei Paesi Bassi il bicchiere viene visto come la naturale continuazione della cera-mica cordata (PFB), di cui conserva l’usanza delle sepolture in fossa coperte da tu-mulo accanto ad altre tipologie come semplici tombe o riuso di monumenti megali-tici del vaso imbutiforme (drenth, hogestijn 2001). Alcuni siti hanno restituito pian-te rettangolari di capanne ma non è un dato generalizzabile per la sua irrilevanza quan-titativa.
Il maggior numero di testimonianze sul campaniforme dell’area centro-orientaleviene dalla Boemia e dalla Moravia, dove già la ceramica cordata aveva introdotto letombe sotto tumulo.
Anche qui sono pochi i dati sugli insediamenti se confrontati con quelli funerarianche se, a giudicare dall’estesa rete di piccole necropoli, è possibile che queste cor-rispondessero ad altrettanti nuclei abitativi.
Migliaia di sepolture documentano, nel campaniforme, inumazioni per lo più infossa, raramente in casse di legno, ciste litiche o sotto tumulo. Prevale il rito inuma-torio ma è presente anche quello incineratorio, in Moravia soprattutto, dove le duemodalità convivono a volte nella stessa necropoli.
Le cremazioni, durante il campaniforme, hanno svariate tipologie di contenitori(Turek 2008): possono essere in fosse circolari poco profonde oppure sparse sulla som-mità di tombe a fossa, simili a quelle usate per le inumazioni. In Boemia sono atte-stati pochi casi di incinerazioni poste in ciste litiche secondo una modalità comunenella Germania orientale. Sono, altresì, documentate urne cinerarie. In pochi casi so-no state scoperte fosse con incinerati la cui cremazione era avvenuta in situ.
Sebbene la maggior parte dei tumuli sia stata distrutta dall’intensa attività agrico-la e dall’erosione, Turek (Turek 2006, Peska et alii in stampa) ritiene che sia egual-mente possibile individuarne le tracce.
I dati raccolti nel XIX e XX secolo sulle necropoli con tumuli della Moravia sug-geriscono che i tumuli erano fatti di terra con poche pietre, che alcuni coprivano piùtombe e che essi furono riutilizzati introducendo altre tombe.
Sia nelle necropoli della ceramica cordata sia in quelle campaniformi compaionotombe che definiscono il rango dell’inumato. La maggior parte dell’inumazione è infossa, forse coperta da tumulo. Ma ci sono costruzioni elaborate come camere fune-rarie rivestite di legno e circondate da fossati circolari. I fossati sono molto comunisia nella ceramica cordata che nel campaniforme: di norma sono poco profondi e han-no al centro una tomba a fossa (Turek 2006).
Ugualmente rari nella bassa Austria gli insediamenti: come in Moravia, anche inAustria sembra essere stato forte il nesso tra ceramica cordata e campaniforme con ri-ti funerari che includevano sia cremazione che inumazione.
La regione di Budapest segna il limite orientale della diffusione del campaniforme
228
Ingravallo et alii
con il gruppo di Csepel (il maggior numero di ritrovamenti proviene dall’isola di Cse-pel nel danubio). Qui è molto forte il ruolo della cultura locale di Nagyrév che avreb-be inglobato il campaniforme in seguito a contatti e scambi con l’area di diffusionecentro-europea (Endrodi et alii 2008).
Significativa, in questa cultura, è la grande quantità di resti di cavallo, tanto da fa-re ipotizzare che il suo territorio sia stato un centro specializzato di domesticazione:da lì potrebbe essere partita la sua diffusione in Europa nella metà del III millennioattraverso la rete degli insediamenti campaniformi.
Il rito funerario prevede sia l’incinerazione che l’inumazione.Il limite occidentale della diffusione del “gruppo orientale” del campaniforme è co-
stituito dal sito del Petit Chasseur a Sion nel vallese, reso famoso dalle numerose ste-le antropomorfe: luogo di culto pluristratificato vede, durante il campaniforme, la co-struzione di dolmen a entrata laterale con la riutilizzazione di stele antropomorfe diperiodi precedenti reimpiegate anche per tombe a cista litica (Gallay 1995).
Quello restituito dalla documentazione archeologica è, dunque, un quadro poli-morfo in cui i tumuli sono una delle tante facce che nel III millennio assume la cul-tura del morire. Essi non soppiantano usi tradizionali, semplicemente ne arricchisconola gamma con nuove pratiche relative al trattamento dei defunti.
A ulteriore conferma della molteplicità delle scelte si aggiunge la cosiddetta “com-plementary ware”(Strahm 2004b), definizione sostitutiva del termine tradizionale “Be-gleitkeramik” storicamente coniato per l’area orientale del campaniforme. Accade, inaltre parole, che gli elementi campaniformi siano molto spesso associati a una pro-duzione ceramica (chiamata in vari modi: comune, domestica, d’accompagno) distintada essi, nel senso di avere caratteristiche proprie in virtù delle quali potrebbe rappre-sentare specifiche entità culturali.
A lungo si è discusso sulla sua formazione nel tentativo di discernere quanto in es-sa sia dovuto a sostrati autoctoni e quanto ad apporti esterni.
L’individuazione nell’Europa continentale di tre grandi insiemi (orientale, setten-trionale, meridionale) evidenzia una parcellizzazione culturale in cui il rinnovamen-to delle tipologie legato al campaniforme si osserverebbe solo nell’area meridionale,segnatamente nella Francia mediterranea (Besse 2004).
Senza nulla togliere all’utilità di simili ricerche, converrebbe evitare di enfatizzareil problema della ceramica comune, dal momento che – come lascia intendere la do-cumentazione archeologica – ogni regione ha sottoposto il campaniforme al vaglio dipropri codici, continuando a produrre ceramica quotidiana in gran parte ispirata atradizioni locali. è quanto avviene, per esempio, in Italia, dove il campaniforme si ac-compagna a ceramiche che, per decorazioni e forme, attingono alla tradizione localead esso antecedente, nel caso specifico agli aspetti classici dell’eneolitico italiano (Leo-nini, Sarti 2008).
L’esempio italiano aiuta, forse, a comprendere che l’acquisizione del campanifor-me in alcune regioni europee altro non è stato che un episodio della normale dina-mica di prestiti e scambi che da sempre caratterizza il rapporto tra culture nel mo-mento in cui appaiono nuovi stili decorativi o nuove fogge vascolari, la cui ricezionepuò essere stata a volte favorita anche da modificazioni nella sfera dell’immaginario.
229
L’orizzonte culturale del III millennio a.C.: il tumulo 7 di Salve (Lecce)
Nella maggior parte dei casi il campaniforme si è integrato nei contesti locali, di cuinon sembra averne modificato gli assetti, come dimostra – in aggiunta ai comporta-menti funerari che rimangono sostanzialmente immutati - proprio la “ceramica com-plementare”: tolte poche eccezioni, infatti, essa è una produzione che in ciascuna re-gione obbedisce a canoni maturati localmente che già alla metà del Iv millennio han-no accolto, in misura diversa, nuove tipologie nelle forme e nelle decorazioni.
decorazioni a punti impressi, a pettine trascinato, a cordoni, sono ben documen-tate, per esempio, nell’eneolitico italiano prima dell’arrivo del campaniforme, il cuiruolo principale fu, forse, quello di promuovere una più estesa rete di scambi, con l’a-bituale trasmigrazione di modelli e di fogge da un areale all’altro.
Anche la definizione cronologica, un tempo basata sulla successione degli stili, ri-vela una maggiore articolazione che non sempre coincide con il modello tipologico (Ni-colis 2001) e molto spesso evidenzia cronologie regionali non sovrapponibili tra loro.
Lo stesso set campaniforme è un insieme di oggetti che ricorrono in maniera spar-sa e senza un legame sistematico tra loro al punto che diviene improprio parlare di“pacchetto” campaniforme se non limitatamente ad aree circoscritte.
Per tentare di mettere ordine in questa intricata vicenda che vede oggetti campa-niformi in contesti lontanissimi dal loro areale d’origine, dall’alamaro nel sud-est ita-liano (Grotte Cappuccini e Trinità) al frammento decorato di Lerna IIIb, è stato ela-borato un modello (heyd 2007) centrato sulla dialettica nucleo/periferia/margini, si-mile a quello a suo tempo adoperato da Sherratt (1993) per spiegare i cambiamentinell’Europa dell’età del Bronzo in cui il nucleo era rappresentato dal Medio oriente.Qui il nucleo è rappresentato dal campaniforme orientale e da quello italiano set-tentrionale; la periferia, dalle culture “sincretiche” che, dalla Polonia alla dalmazia(Proto-Cetina/Cetina) alla Puglia (Laterza-Cellino San Marco), hanno assorbito ele-menti campaniformi dando vita a nuove espressioni culturali proprie della prima etàdel Bronzo; i margini, da zone come il Peloponneso, in cui ricorrono singoli elementiprivi, però, della forza necessaria per innescare ulteriori sviluppi. Procedendo da norda sud verso il Mediterraneo centrale prende forma una mappa dei ritrovamenti cam-paniformi che mette in risalto la dimensione internazionale del fenomeno e il prota-gonismo di culture che alla sua propagazione hanno contribuito, in particolare Ceti-na e, comprimaria sull’opposta sponda, Laterza (heyd 2007).
I rapporti tra i due versanti adriatici sono noti fin dal neolitico e non stupisce ri-trovarli nel III millennio, come si vide già dalle due brocche Cetina nella tomba 3 diLaterza. Ad esse, con il tempo, si sono aggiunti altri rinvenimenti che, nel decoro enella forma, rinviano alla cultura dalmata: in particolare si è soliti citare le sepolturedi Altamura (Casal Sabini-tomba 1 e Pisciulo-ipogeo 2), i siti le rene di rutiglianoe rodi Garganico, questi ultimi quasi avamposti di Cetina in terra straniera (Maran1998, 2007), Fontanarosa sempre dalla Puglia settentrionale (Quoiani 1983) Zungridalla Calabria, ognina e Castelluccio dalla Sicilia (Cazzella 1999, 2002).
Grazie ai parallelismi Laterza-Cetina basati su una parziale condivisione di motivie forme, è stato inoltre ricostruito il quadro cronologico della prima età del bronzoin Puglia (Peroni 1996).
riconosciuta l’evidenza dei contatti tra le due sponde, non si deve tuttavia igno-
230
Ingravallo et alii
rare che la comparazione e relativa discussione si fonda su frammenti sporadici o og-getti provenienti da contesti funerari in parte manomessi, i quali – al di là di analo-gie formali – poco dicono sull’incidenza e la natura del rapporto di Cetina con La-terza e a poco servono per una distinzione cronologica in due momenti della ceramicaCetina in Italia (Cazzella 1999).
Accantonate dunque le coincidenze tipologiche, rimane aperto il problema – pertornare al modello di heyd - se il campaniforme sia giunto a Grotta Cappuccini esclu-sivamente attraverso la mediazione di Cetina o se non abbia seguito altre vie. vieneda chiedersi, in altre parole, se non sia stato enfatizzato il ruolo di Cetina quale cata-lizzatore dei fermenti che in quel momento agitavano il bacino mediterraneo, a sca-pito di uno scenario più intricato e meno prevedibile.
Sempre in relazione alla distribuzione geografica del fenomeno campaniforme in Eu-ropa, un’interpretazione differente viene proposta da vander Linden (2007). osservatala discontinuità territoriale dei relativi ritrovamenti, vengono tratte le seguenti con-clusioni: 1) che il fenomeno campaniforme non è stata l’ineluttabile onda di avanza-mento sociale e culturale quale è stata spesso descritta; 2) che il fenomeno è consisti-to nella nascita di una serie di comunità legate da una rete di scambi a corto raggio: inessa un ruolo decisivo hanno avuto la trasmissione culturale e la mobilità umana nelpromuovere anche regole di scambi matrimoniali, come insegna il Lévi-Strauss de “Lestrutture elementari della parentela”. da qui la spiegazione del fenomeno campa-niforme non come un movimento organico di diffusione culturale, ma come l’esito fi-nale di una serie di reti locali, dotate di una notevole capacità di interazione.
Come per la ceramica cordata, anche per il campaniforme si è parlato di un’ideo-logia guerriera in base ai corredi maschili (heyd 2004). In molti di essi, infatti, sonoattestati pugnali, asce, alabarde in rame accanto a pugnali in selce: tutti oggetti chesembrano alludere a una struttura sociale nella quale emergono figure dall’elevato sta-to sociale, dotate di ricchezza e prestigio.
Si delinea, in altre parole, una società organizzata in lignaggi a capo dei quali si im-pongono “guerrieri” detentori del potere e della funzione di rappresentanza dei varigruppi familiari.
Ciò è probabilmente vero ma, per evitare conclusioni definitive, è bene ricordare cheil modo di morire non è certamente lo specchio del modo di vivere; che le testimo-nianze funerarie vanno sempre lette attraverso il filtro dell’autorappresentazione, ne-cessariamente enfatizzata e idealizzata; che gli oggetti deposti nelle tombe obbedisco-no a esigenze del rituale che hanno codici di comportamento difformi da quelli dellavita ordinaria; che gli stessi elementi di corredo, infine, possono aver fatto riferimen-to ad ambiti diversi della vita associata: per esempio, il pugnale può avere alluso al rag-giungimento dell’età adulta da parte dell’inumato e così via; come è anche presumi-bile che ogni regione abbia avuto un’ideologia fondata sulle proprie tradizioni.
Un’ulteriore conferma dell’esistenza di un’élite guerriera si crede di poterla trovarenelle statue stele (Pedrotti 2007), su cui vengono raffigurati in prevalenza personag-gi maschili abbigliati sontuosamente con armi e ornamenti, in misura minore figurefemminili riconoscibili dai seni.
Anche qui si tratta di decodificare un linguaggio che in parte può essere la traspo-
231
L’orizzonte culturale del III millennio a.C.: il tumulo 7 di Salve (Lecce)
sizione su pietra di un ordine sociale costituito, in parte può rispondere al bisogno digenealogia attraverso la creazione di personaggi mitici sentiti come antenati, da ritrarrecon i simboli del prestigio a loro dovuto.
Per concludere, non si può escludere che il campaniforme abbia contribuito al-l’affermazione su scala europea di modelli ideologici basati sulla differenziazione so-ciale, con il riconoscimento di capi, ma c’è anche da considerare che, tolte le testi-monianze funerarie, rimane ancora molto da scoprire sulle società del III millennio.Senza dire che sono le stesse testimonianze funerarie con la loro pluralità di rituali asconsigliare una lettura univoca circa la presunta stratificazione sociale.
L’ Antico Elladico
L’Antico Elladico (Eh) rimane ancora un periodo poco noto nelle sue dinamicheformative con numerose lacune sia sugli aspetti della vita quotidiana che sulle prati-che cultuali e funerarie.
rispetto all’EhI, maggiore documentazione esiste sull’EhII grazie anche a vecchiscavi quali quelli di Lerna, nell’Argolide, che misero in luce il primo esempio di “ca-sa delle tegole” (Lerna III) (Caskey 1960), edifici a più ambienti comunemente in-terpretati come luoghi di pubbliche attività.
dette anche “case a corridoio”, sono diventate il simbolo dell’Eh in generale e del-l’Eh II in particolare. Presenti in varie regioni, da Tebe in Beozia a Akovitika in Mes-senia, hanno in comune la caratteristica di essere su due piani, con il pianoterra com-posto da una serie di stanze quadrate o rettangolari, fiancheggiate sul lato lungo dacorridoi spesso adibiti a vano scala per l’accesso al piano superiore.
Poco si sa sulla loro effettiva funzione, anche se la loro edificazione viene conside-rata l’indizio di una maggiore complessità sociale nell’EhII, quando probabilmentesi affermano élite sotto forma di chiefdom.
Le case a corridoio rappresenterebbero, dunque, la sede di immagazzinamento dibeni e di traffici con l’Est gestiti dalle élite (Maran 1998). o, ancora, sarebbero resi-denze di autorità che controllavano e gratificavano le rispettive comunità con l’esibi-zione del proprio prestigio, in un gioco di emulazione e competizione con analoghicentri sparsi nel territorio. La comparsa di forme particolari come le salsiere suggeri-sce, inoltre, che poteva essersi diffusa la pratica di cerimonie che le richiedevano peril versamento e il consumo di bevande, probabilmente anche fermentate (wiencke1989). Un’altra variante le vedrebbe metafora del potere rappresentata dalla loro mo-numentalità, a metà tra spazio privato a uso delle leadership e centro di iniziative po-litiche e religiose (o’Neil 2008).
Alcuni autori ritengono, altresì, che la presenza delle case a corridoio in un sito nesegnali l’importanza nella gerarchia insediamentale di una regione (Pullen 1985). Al-tri, invece, pur sottolineandone la centralità pubblica all’interno di un insediamen-to, non ne vedono il ruolo gerarchico, bensì il perno di azioni collettive (weiberg2007).
Le tipologie funerarie dell’Eh sono varie, essendo attestate tombe a fossa, a cista,a camera (Canavagh, Mee 1998).
232
Ingravallo et alii
In confronto a quelli dei periodi successivi, sono pochi i tumuli tradizionalmente at-tribuiti all’Eh: sono noti i casi di olimpia (Elide), Tebe (Ampheion e Museo archeo-logico, Beozia) e Lerna (Argolide), sulla cui definizione di “tumuli rituali” si è molto di-scusso (Forsén 1992). definizione che viene contestata da chi la ritiene poco rispondentealle differenti funzioni e tipologie dei monumenti in questione (weiberg 2007).
due di essi, infatti (quello di Lerna e quello presso il Museo di Tebe), furono eret-ti su rovine di strutture preesistenti.
A Lerna, un tumulo fu costruito sui livelli di incendio che aveva distrutto la “casadelle tegole” ed è datato tra EhII e Eh III.
dietro il Museo archeologico di Tebe fu scoperto un edificio absidato e, in rela-zione con esso, un muro di pietre e mattoni crudi databile al tardo EhII. Il muro fuabbattuto e i resti coprirono il pavimento dell’edificio. Nel livello di distruzione fu-rono sepolti quattro adulti e un bambino. Il tutto (sepolture, edificio e muro) fu ul-teriormente coperto da un tumulo di mattoni crudi, sempre nell’EhII.
due furono, invece, creati ex novo.La collina Ampheion di Tebe fu terrazzata in tre piani sovrapposti: su quello su-
periore fu eretto un tumulo di mattoni crudi con, all’interno, una tomba a cista de-predata e, presso di questa, furono trovate ossa umane, due vasi datati EhII e quat-tro pendagli d’oro (Spyropoulos in stampa).
A olimpia un tumulo fu eretto in cima alla collina Altis databile a EhII. Al mede-simo periodo si deve la presenza di frammenti ceramici e resti di pasto sparsi nei pres-si. Nel tardo EhIII ai suoi piedi furono eretti edifici absidati e, sul suo lato orientale,fu impiantata un’area cultuale. Nel Mh il tumulo fu sfruttato come cava di argilla.
Le loro modalità di costruzione potrebbero rivelare significati differenti. I primi duepotrebbero essere stati edificati per conservare la memoria di ciò che preesisteva op-pure per perpetuare il ricordo di un evento quale la distruzione e/o la costruzione deltumulo stesso.
Gli altri due, invece, potrebbero aver risposto al bisogno degli abitanti del luogodi lasciare un segno tangibile della propria esistenza nel territorio, dando origine a unanuova storia (weiberg 2007).
Comunque la si pensi in proposito, è innegabile che si tratta di costruzioni pocoaccomunabili tra loro.
La maggior parte delle evidenze sui tumuli del III millennio viene, in ogni caso,dalla necropoli r di Lefkas, scavata nel primo Novecento (dörpfeld 1927), dove fu-rono messi in luce tumuli di dimensioni variabili, alcuni dei quali coprivano incine-razioni entro pithoi. Il periodo d’uso viene attribuito alla transizione EhII-EhIII(Müller 1989).
Un’analisi del ruolo e della reale incidenza dei tumuli sulle pratiche funerarie del-l’Eh è resa difficile dalla documentazione lacunosa sia sulle testimonianze funerarie,sia sul rapporto con eventuali siti d’abitato a loro contemporanei. La maggior partedelle evidenze relative ai comportamenti funerari dell’Eh manca, inoltre, di una cro-nologia precisa (Pullen 1994).
La comparsa dei tumuli in Grecia viene comunemente ritenuta di origine esternae si pensa che la diffusione sia avvenuta attraverso la costa orientale adriatica (Müller
233
L’orizzonte culturale del III millennio a.C.: il tumulo 7 di Salve (Lecce)
1989) o direttamente dall’Albania (Forsén 1992), i cui tumuli potrebbero avere ispi-rato quelli della necropoli r di Lefkas.
Per affrontare la questione conviene risalire la costa passando per Albania, Monte-negro, dalmazia con una breve digressione sui rapporti tra penisola balcanica e mon-do egeo nel III millennio.
è noto come nell’antico elladico la seconda fase sia considerata il momento aureoin cui si afferma l’architettura monumentale come espressione di leadership radicatenel territorio, si definiscono gerarchie insediamentali, si intensifica – rispetto all’EhI– la circolazione di beni di lusso quali oggetto di scambi tra le varie élite.
Lungo la costa adriatica orientale nel corso del III millennio – in concomitanza conl’Antico Elladico – si susseguono, intrecciandosi a volte, vari aspetti, in particolare ilgruppo Adriatico con le culture di vučedol e di Lubiana e il gruppo Cetina datato a2500-2200 a.C. e posto in parallelo con EhIII e il campaniforme (della Casa 1996).
Come si è visto a proposito del campaniforme, si assiste nel III millennio a un in-treccio di rapporti tra le diverse regioni del Mediterraneo in cui un ruolo centrale vie-ne assegnato alle culture balcaniche nelle vicende che hanno interessato in particola-re l’Egeo.
Nel ricostruire le cause della cesura tra EhII e EhIII, il passaggio cioè da un pe-riodo di grande complessità sociale a un altro in cui tutto ciò sembra perdersi, Ma-ran (1998, 2007) sottolinea il protagonismo delle aree ionico-adriatica e centro-me-diterranea nelle vie di traffico legate ai metalli, soprattutto allo stagno. Agli inizi delIII millennio – egli sostiene - punto di riferimento diviene la cultura di vučedol laquale, nei tumuli del Montenegro, esibisce una ricchezza di corredi senza eguali nel-la Grecia contemporanea, dove verranno importati elementi di pregio, quali gli anel-li d’oro nella necropoli r di Lefkas simili a quelli di velika Gruda.
Si instaura, seguendo l’analisi di Maran, un sistema di scambi intrecciati lungo lerotte marittime controllate dai centri del Peloponneso in cui i Balcani e il Bacino car-patico diventano i luoghi della distribuzione.
Al passaggio tra EhII e EhIII i ruoli si invertono: le popolazioni dell’Adriaticoorientale, approfittando della crisi dei centri elladici, si impadroniscono delle loro rot-te commerciali giungendo fino alle coste del Peloponneso e occupando l’arcipelagomaltese. La conferma viene dall’egemonia di Cetina sulle coste adriatiche e ionichecome attesta la comunanza di forme e di ornati ravvisabile a Malta (Tarxien ceme-tery), nei siti pugliesi (Altamura, le rene di rutigliano), a Lipari (Capo Graziano),ad Altis di olimpia e in Albania (necropoli di Shkrel). L’espansionismo di Cetina sisalda, a sua volta, con la rete transnazionale del campaniforme (Maran 1998, 2007).
Sospendendo il giudizio sulla profondità della crisi al passaggio tra EhII e EhIII,su quanto cioè esso sia stato realmente traumatico o non piuttosto un cambiamentosegnato dalla consueta dialettica tra continuità e rotture, occorre fare delle distinzio-ni: se è indubbia la dominanza della cultura di Cetina nel suo areale d’origine com-prese le zone confinanti, altrettanto non si può dire per il resto del Mediterraneo do-ve la presenza di elementi Cetina - per quanto copiosa - andrebbe meglio attribuitaalla normale circolazione di motivi e di fogge che - rispetto al neolitico – nel III mil-lennio diviene più accentuata e visibile, grazie anche all’aumentata domanda di ma-
234
Ingravallo et alii
terie prime pregiate come i metalli. Che ciò in alcune situazioni abbia comportato lospostamento di piccoli gruppi è probabile, anche se è difficile credere a un processodi colonizzazione tout court.
La documentazione archeologica farebbe piuttosto pensare che, di fronte al diffon-dersi di nuove tipologie, ci sia stato da parte delle diverse culture un processo di se-lezione ispirato al principio dell’ “innovare quanto basta e conservare quanto serve”.
Un esempio: i tumuli del Salento potrebbero essere un fatto intrusivo ma la pro-duzione ceramica è del tutto conforme alla tradizione locale: Laterza e Gaudo. I mo-tivi tipo Cetina, diffusi anche nelle grotte salentine come la Grotta delle veneri o laGrotta dei Cervi, sono decori al pari di altri nel senso che si amalgamano al resto del-la produzione senza alterarla più di tanto, comportandosi allo stesso modo degli ele-menti campaniformi nei confronti dei contesti locali. Quello che, in altre parole, sem-bra emergere alla distanza è il dinamismo delle culture e la loro capacità di influen-zarsi e rimodellarsi dietro la spinta di impulsi esterni, senza per questo rinunciare al-la propria autonomia.
Ma, per tornare alla costa orientale adriatica, meglio uno sguardo da vicino.
Costa orientale adriatica
In Albania la cultura più rappresentativa del Bronzo antico è quella di Maliq IIIaseguita da Maliq IIIb (Prendi 2002).
Anche in Albania, come in Grecia, i primi tumuli compaiono nel III millennio e so-no anch’essi in numero infinitamente inferiore rispetto a quelli dei periodi successivi.
Allo stato attuale si conoscono le necropoli di Shkrel e di Shtoj (nord-ovest del-l’Albania) e il tumulo 1 di Barç nella regione di Korçe (sud-est dell’Albania).
Nella necropoli di Shkrel (Jubani 1995) dei circa 40 tumuli attualmente esistenti,i 10 scavati sono attribuibili al Bronzo antico. Alcuni di essi contenevano incinera-zioni, altri inumazioni. In due casi è documentata la sepoltura in cista, l’una incine-rata e l’altra inumata. In tutti sono stati rinvenuti solo vasi in frammenti, nessuno in-tero. Le forme e le decorazioni sono quelle di Cetina.
A Shtoj furono scoperti in totale 160 tumuli (Korkuti, Petruso 1993). di specia-le interesse per il III millennio è il tumulo 6, riusato nel corso del tempo con vari ti-pi di tombe al suo interno. Il primo impianto risale all’antico Bronzo con una tom-ba a fossa centrale. Interessante del corredo è un vaso confrontabile, per la decorazioneincisa, con esemplari della cultura di Kotorac-Cetina e il ritrovamento di sei statuinea forma di “violino”, paragonabili, secondo Prendi (2002) a un esemplare trovato aLerna Iv, mentre secondo Korkuti gli antecedenti sono da cercare nei livelli eneoliti-ci di Maliq. Si tratta di una forma considerata tipica della prima fase dell’Antico Ci-cladico (EC I- Grotta Pelos 3200-2800 a.C.) ma ricorre egualmente nelle culture diGumelnita e Cernavoda I (Comsa 1993), oltre che in quella di Cucuteni-Tripolje pri-ma fase (Marinescu-Bilcu 1993). In Sicilia due statuine dello stesso tipo sono staterinvenute a Camaro (Bacci, Martinelli 2001) in un contesto Piano Conte datato inun arco di tempo compreso tra 4080 e 2900 a.C.; alla fase Zebbug sono attribuibilidue esemplari maltesi (Malone et alii 1995).
235
L’orizzonte culturale del III millennio a.C.: il tumulo 7 di Salve (Lecce)
Anche per questo tipo di statuine si è posto il problema della loro origine: coeren-temente con la sua analisi che sposta dall’Egeo ai Balcani il centro della circolazionedei beni di prestigio, Maran (1998, 2007) le ritiene originarie dell’area balcanica oc-cidentale, dalla quale sarebbero arrivate in un secondo momento in Grecia. In ag-giunta, sostiene Maran, l’esemplare di Lerna Iv ha una decorazione che rinvierebbeall’antico elladico III e, perciò, non può essere attribuito a influenza cicladica i cui pro-totipi erano già scomparsi molti secoli prima.
oltre al 6, anche il tumulo 10 potrebbe risalire all’antico Bronzo in base a pochiframmenti simili a quelli della cultura di Lubiana.
A Barç dei due tumuli scavati (Andrea 1975, 1983-84), il n.1 conteneva, oltre anumerose tombe del Bronzo finale e del Ferro, alcuni frammenti attribuibili al Bron-zo antico.
In Montenegro, colpisce la straordinaria ricchezza dei corredi rinvenuti in molti tu-muli. Nella baia di Kotor, sono noti i tumuli di Mala e velika Gruda (della Casa 1996;Primas 1996), quest’ultimo in particolare per la ricaduta che le sue datazioni ebberosulla cultura di Laterza (Ingravallo 2002).
Il tumulo di Mala Gruda copriva una tomba centrale a cista con un individuo eun corredo costituito, tra le altre cose, da un pugnale d’oro di foggia anatolica, un’a-scia d’argento e da cinque anelli d’oro aperti, del tipo detto di Mala Gruda.
Il tumulo di velika Gruda è pluristratificato con tre fasi di utilizzo, la prima risa-lente all’Eneolitico, la seconda all’età del Bronzo, la terza all’età del Ferro.
La seconda fase è quella che ha restituito il maggior numero di sepolture con ti-pologie diverse come ciste con inumazioni collettive, cremazioni, ossari, inumazioniin pithoi. da essa proviene la ceramica tipo Cetina-Kotorac datata tra 2500-2200 a.C.(della Casa 1996).
Nel tumulo della prima fase vi era un’unica tomba a cista con un individuo e unricco corredo che, tra gli altri oggetti, comprendeva un piatto decorato del tipo “fryingpan” egeo e otto anelli d’oro (in realtà cinque spirali e tre anelli aperti del tipo MalaGruda).
Le spirali d’oro, simili a esemplari della tomba r 15b di Lefkas, sarebbero, secon-do Primas, di influenza egea contrariamente alla tesi di Maran; alle Cicladi rimandail piatto decorato e, precisamente, al gruppo Kampos, una cultura tradizionalmenteconsiderata di transizione (2800-2700 a.C.) tra l’EC I (Grotta Pelos 3200-2800 a.C.)e l’EC II (Keros-Syros 2700-2200 a.C.) (Fitton 1989), ma che potrebbe aver rap-presentato solo una produzione specializzata di oggetti per tombe di personaggi emi-nenti (davis 1992), come i caratteristici fiaschi a motivi curvilinei incisi e le “fryingpans” con decorazioni molto elaborate sul fondo.
L’età della sepoltura di velika Gruda è posta tra 2800-2700 a.C. ed è quindi pa-rallelizzabile con il primo vučedol (3000-2700 a.C.); entrambi i tumuli (Mala e ve-lika Gruda), inoltre, sono da considerarsi coevi alla prima fase della necropoli di Lefkasda porre nell’EhIIA, a sua volta sincronizzabile con l’Antico Cicladico II (Primas1996).
I due tumuli, quindi, dovevano essere espressione di un territorio saldamente in-serito in una delle molteplici zone di interazione che in quel periodo attraversavano
236
Ingravallo et alii
il Mediterraneo, creando una rete di traffici tra aree anche lontane tra loro. In questarete le isole dell’Egeo divennero un importante centro di innovazione legata alla po-limetallurgia, probabilmente in contatto con l’area levantina. Lefkas, a sua volta, sipose come punto di riferimento marittimo, quale avamposto occidentale delle Cicladi(Primas 1996).
Come si vede, ricomporre il puzzle dei flussi, degli scambi, delle reciproche in-fluenze non è matassa facile da sbrogliare e le opinioni divergenti in materia lo di-mostrano. è, tuttavia, un dibattito destinato a durare, come tale assai lontano da con-clusioni definitive, almeno finche avrà a che fare con un quadro complessivamentepovero di datazioni radiometriche confrontabili tra loro e con uno stato della ricercaancora territorialmente diseguale e lacunoso. da qui la perplessità verso grandi qua-dri d’insieme in cui tutto torna e si spiega a dispetto della provvisorietà dei dati.
Altri tumuli sono stati in seguito scoperti in Montenegro (Bulatovic, Lutovac 2003)attribuibili a vari periodi, oltre che all’Eneolitico, come quelli – circa una ventina qua-si tutti distrutti – in località Kuca rakica (Podgorica), da uno dei quali provengonofigurine del tipo “a violino” paragonabili alle figurine del tumulo 6 di Shtoj in Alba-nia, o il tumulo, anch’esso in parte smantellato, di Boljevica Gruda (Podgorica) de-finito “principesco” per la ricchezza del corredo. Esso era stato eretto su una tomba afossa centrale con uno scheletro in posizione flessa. Tra gli oggetti, particolarmentesignificativi per la cronologia sono due anelli aperti del tipo di Mala Gruda e un piat-to simile a quello di velika Gruda (Bakovic in stampa).
Nella dalmazia la presenza di tumuli, già nota fin dal secolo scorso, è stata ulte-riormente confermata dalle ricerche successive, soprattutto nella regione del fiume Ce-tina con numerosi ritrovamenti relativi all’omonima cultura e ai suoi rapporti con l’a-spetto adriatico di Lubiana.
Considerata un elemento chiave dell’Europa del III millennio, alla cultura di Ce-tina viene riconosciuta una vasta zona nucleare che va dall’Adriatico centrale con lerelative isole (hvar, Korčula, Palagruža) all’Adriatico meridionale con la costa delMontenegro e l’Albania settentrionale.
La sua sfera d’influenza si estende, altresì, ai Balcani occidentali come risulta daimateriali di vecchi scavi, la cui spiccata tipologia Cetina indica l’esistenza di rappor-ti tra le due aree, anche se è difficile – allo stato attuale – precisarne la natura (Go-devarica 2006).
Si tratta di vasi o frammenti provenienti dall’insediamento di Kotorac (Sarajevo),da alcuni tumuli nell’area di Glasinac (Bosnia) e dalla necropoli di Anište (Serbia oc-cidentale): le evidenti affinità tipologiche con Cetina non bastano da sole a ricostruirele vicende storiche del periodo e il ruolo in esse avuto da Cetina, molte essendo le la-cune sulla prima età del Bronzo in quelle regioni oltre che sulla stessa Cetina di cui ènoto l’aspetto funerario ma molto meno quello insediamentale (Godevarica 2006).
Come si vede, anche nei Balcani esiste il problema che si pone in Italia quando sitratta di definire la consistenza dei rapporti con Cetina che vadano al di là dei sem-plici richiami tipologici.
Sul piano interno, la suddivisione in tre fasi crono-tipologiche la vedono in un pri-mo momento (Cetina 1) legata alle tipologie Lubiana; nel momento intermedio (Ce-
237
L’orizzonte culturale del III millennio a.C.: il tumulo 7 di Salve (Lecce)
tina 2) raggiunge l’aspetto classico con motivi impressi e incisi; nella fase finale (Ce-tina 3) assume le caratteristiche del Bronzo tardo.
Le prime due fasi sarebbero comprese tra 2500 e 1800 a.C., grazie anche ai datiprovenienti da Grapceva Spilja (Kaiser, Forenbaher 1999), con una durata quindi digran lunga maggiore di quella ipotizzata da della Casa (1996).
Un importante trampolino verso l’esterno fu l’occupazione di Palagruža (Kaiser, Fo-renbaher 1999) che dovette servire da ponte verso occidente, istituendo una rete dirapporti con le coste italiane e le isole tirreniche finalizzati allo scambio di materie pri-me e beni di prestigio. Scambio probabilmente gestito da élite la cui presenza vienededotta dalle differenze nella composizione dei corredi funerari.
Circa i riti funerari, sono attestate sia l’incinerazione che l’inumazione sotto tumulo.Su tale bi-ritualità dati interessanti vengono da due tumuli: Prosika a dicmo e Polja-nice a Bisko, entrambi nei pressi di Sinj (dalmazia centrale) (Milosevic in stampa).
CONSIDERAZIONI
A conclusione di quanto appena visto, si può affermare che l’Europa del III mil-lennio presenta un’evidente regionalizzazione in cui elementi unificanti come tipo-logie vascolari o consuetudini funerarie coesistono con un largo ventaglio di varian-ti e articolazioni locali. I tumuli rientrano in questa pluralità di soluzioni.
Essi costituiscono una presenza importante ma non uniformemente diffusa né ge-neralmente preponderante rispetto ad altre tipologie funerarie. Essi stessi spesso han-no poco in comune, obbedendo le loro architetture a canoni diversi sia per dimen-sioni e tecniche costruttive sia per strutture contenute all’interno, quali tombe a fos-sa, ciste, urne.
Alcuni sono pluristratificati con aggiunte e ingrandimenti successivi, altri docu-mentano singoli episodi. Non tutti, infine, hanno una chiara destinazione funeraria,dal momento che alcuni sembrerebbero rispondere più a un ruolo di “sentinelle” ter-ritoriali che a una funzione sepolcrale.
Ciò impedisce confronti ravvicinati, ostacolati anche da differenti contesti cultu-rali, della maggior parte dei quali la componente funeraria – sopravanzando quellaquotidiana – restituisce una versione potenzialmente fuorviante.
A ciò si aggiunga uno stato della ricerca spesso disomogeneo da regione a regionee un’insufficienza di datazioni radiometriche tra loro confrontabili.
Tre sono i grandi fenomeni culturali che nel III millennio percorrono l’Europa: lacultura Yamnaya, la ceramica cordata e il campaniforme con l’antico elladico da com-primario nell’area egea.
Nell’arco di tre secoli la cultura Yamnaya si espande nella valle del danubio, ve-nendo a contatto con culture locali già attraversate da cambiamenti profondi, di fron-te ai quali si ridimensiona il suo impatto dirompente.
Nel bacino carpatico, infatti, la cultura di Baden, che ha i suoi precedenti negliaspetti del Iv millennio, ha già provveduto a darsi una identità multipla in cui nonstupisce di trovare assorbiti e amalgamati anche gli elementi Yamnaya.
La ceramica cordata e il campaniforme, a loro volta, contribuiscono con la diffu-
238
Ingravallo et alii
sione di nuove fogge a innovare il repertorio tradizionale, senza tuttavia omologarloné tantomeno sottrarlo al peso delle culture locali.
L’impatto delle nuove tecnologie sull’organizzazione socio-economica delle singo-le comunità nel corso del III millennio è in genere poco visibile sul piano archeolo-gico e, in ogni caso, deve essersi distribuito con diverse gradazioni e intensità. Si pen-si, per esempio, alla rarità di resti di cavallo nella penisola italiana in confronto ad al-tre regioni come l’Ungheria dove invece il suo impiego sembrerebbe consolidato.
Probabilmente una maggiore precocità nella nascita di società gerarchizzate va in-dividuata nell’area balcanica se si considera l’affermazione di vecchia data di una raf-finata metallurgia, favorita anche dalla vicinanza alle fonti di approvvigionamento.
Non diversamente il mondo egeo registra anch’esso, nella comparsa di architettu-re complesse, l’affacciarsi di attività politico-amministrative probabilmente gestite daélite nei territori di loro pertinenza.
è possibile che le élite delle diverse regioni comunicassero a distanza attraverso gliscambi, come si evince dalla circolazione di materiali e beni di prestigio in cui un ruo-lo centrale acquista il Mediterraneo quale via di trasmissione di idee e di modelli.
Senza escludere che le sue rotte possano essere state oggetto di contese tra gruppidiversi, in particolare tra balcanici ed egei, allo stato attuale è azzardato ipotizzare unoscenario dai contorni precisi che vedrebbe – nella seconda metà del III millennio – ilpassaggio di egemonia dal mondo greco a quello balcanico.
La presenza pressoché ubiquitaria di oggetti e motivi “esotici” nel corso del III mil-lennio starebbe piuttosto a indicare una trama di interazioni in cui a risaltare non ètanto la forza di presumibili centri di irradiazione quanto l’autonoma determinazio-ne delle differenti culture a farsene permeare senza soccombere.
Un esempio può essere offerto dalla penisola italiana esposta com’è, nel III millen-nio, a influssi di varia provenienza che, tuttavia, non ne alterano la specificità di fondo.Gli aspetti dell’eneolitico italiano, infatti, mantengono la loro originaria fisionomia puradottando tipologie largamente condivise e aprendosi ad apporti transadriatici.
La diffusione di elementi Cetina, come quella di elementi campaniformi, rientrain questa dinamica di rapporti che non saranno stati sempre simmetrici ma neppureprevaricatori se osservati oggi con lo sguardo lungo della storia.
In questo panorama si colloca l’adozione più o meno generalizzata dei tumuli: èuna tipologia funeraria che si aggiunge ad altre già presenti e che prevede una moda-lità diversa di onorare i morti.
Ben visibili nel paesaggio, ne marcano il profilo ponendosi come punti di riferi-mento “topografico” dalla valenza accentuatamente simbolica: monumenti per imorti ma fatti dai vivi per ricavarne senso di appartenenza fondato sul legame con ilterritorio e con una propria genealogia.
Inumazione e cremazione sono entrambe adoperate e non sembrano in opposizionesottintendendo piuttosto una scelta di singoli gruppi dovuta probabilmente a credenzediverse circa la maniera migliore di congedarsi dalla vita terrena. Nei casi di bi-ritua-lità, invece, in un medesimo monumento talora come a Salve o in dalmazia, dovevaesserci una distinzione tra singoli individui, alcuni meritevoli di combustione, altridi semplice seppellimento in base a criteri che oggi si rivelano imperscrutabili.
239
L’orizzonte culturale del III millennio a.C.: il tumulo 7 di Salve (Lecce)
Mentre dai corredi di alcuni tumuli transadriatici (Montenegro soprattutto) è pos-sibile arguire l’esistenza di differenze sociali, non è così per i tumuli salentini o, al-meno, per quelli finora noti.
Gli elementi di corredo non sono attribuibili e, quand’anche lo fossero, hanno unaspetto tutto sommato quotidiano, tranne gli oggetti di ornamento peraltro assai si-mili a quelli in uso presso gli altri gruppi che nello stesso periodo nel Salento, al po-sto dei tumuli, preferivano le grotte naturali o artificiali.
Si pone, a questo proposito, la questione delle differenti ritualità praticate da gen-ti che condividevano la medesima cultura materiale e che, certamente, non doveva-no ignorarsi.
La questione – in altre parole – se i tumuli siano dovuti o no ad apporti esterni,considerata anche la loro diffusione sull’opposta sponda adriatica.
Premesso che la coesistenza di diverse tipologie funerarie non è un fatto inusualecome risulta da molte testimonianze in Italia e fuori, va sottolineato tuttavia che i tu-muli costituiscono una presenza insolita nel sud-est italiano del III millennio.
Quanto realmente insolita spetterà alle future ricerche chiarirlo, per ora convieneprenderne atto non diversamente da come si fa con altri elementi “stranieri” quali imotivi campaniformi o Cetina.
Per questi ultimi non si fa difficoltà a considerarli un portato della circolazione avasto raggio di modelli e fogge che nel III millennio conquistano il gusto dell’epoca.
Per i tumuli il problema è più complesso perché non si sa, al momento, se essi com-paiano nel sud-est effettivamente nella seconda metà del III millennio o se la loro in-sorgenza sia più antica, parallela all’affermazione di altre tipologie funerarie, quali lesepolture in grotte, in fossa o in cista.
In un caso o nell’altro – che si tratti di antica o recente istituzione – resta la do-manda sull’area di provenienza.
Senza escludere un’origine transadriatica, in attesa di più puntuali riscontri è for-se opportuno trattare i tumuli alla stregua di un altro fenomeno che nel corso dellapreistoria ha avuto la stessa capacità di propagazione, e cioè il megalitismo.
Entrambi – sia il megalitismo sia i tumuli – condividono una lunga esistenza cheaffonda le sue origini nel v millennio e una diffusione che, con il tempo, si espandein tutte le direzioni.
A entrambi è accaduto di vedersi attribuire una quantità di monumenti poco omo-logabili tra loro e tuttavia ritenuti tali per via di una generica tipologia. Sia il mega-litismo che i tumuli annoverano, in realtà, costruzioni di vario tipo con funzioni e si-gnificati mai univoci perché in relazione con contesti diversificati nel tempo e nellospazio.
Come per il megalitismo anche per i tumuli perde importanza l’ipotetico centrod’origine di fronte alla molteplicità di realizzazioni e di pratiche ad esse connesse: chesia stata la facciata atlantica per l’uno o la cultura Yamnaya per gli altri, resta il fattoche, una volta adottati dalle diverse comunità, essi (tumuli o megaliti) sono stati larisposta a esigenze e bisogni del tutto particolari. è questa la ragione per la quale i tu-muli del Salento sono altra cosa dai tumuli Yamnaya, come anche i megaliti rispettoai loro prototipi atlantici.
240
Ingravallo et alii
Alla luce della vicinanza cronologica e geografica non si può escludere – come det-to – un’influenza balcanica sui tumuli salentini.
Anche in questo caso, tuttavia, per procedere a un confronto tra le due situazioni,manca un elemento fondamentale: la conoscenza delle rispettive società e delle mo-tivazioni alla base di un comportamento rituale apparentemente uguale.
Ancora una volta si ha a che fare, nel sud-est italiano, con testimonianze esclusi-vamente funerarie che, se raccontano come si moriva, poco dicono su come si vive-va. Mancano i siti d’abitato e, con essi, la possibilità di ricostruire la configurazionegeo-politica del territorio.
Allargando lo sguardo all’Italia centro-meridionale, il quadro è più articolato conuna maggiore documentazione relativa non solo a insediamenti ma anche a necropolicon importanti evidenze di tombe particolarmente ricche.
Alcune di esse, di facies rinaldone e Gaudo, con corredi caratterizzati dalla pre-senza di armi, hanno offerto lo spunto per individuare nella figura del guerriero o, al-ternativamente, del cacciatore (a seconda dell’interpretazione delle cuspidi di frecciase armi o strumenti venatori) il perno di una società strutturata attorno al riconosci-mento di ruoli (Cocchi Genick 2009: 230, 257).
La questione è sempre la stessa: se cioè i corredi funerari possano o no prestarsi aun’interpretazione per sineddoche, intendendoli come la parte per il tutto.
è un procedimento – come si è detto – rischioso con la conseguenza, tra le altre,di generalizzazioni poco suffragate dai fatti. Nei corredi del sud-est italiano, per esem-pio, la presenza di armi è abbastanza rara: nella cista del tumulo 7 – per citare un ca-so - tra i tanti elementi di corredo figura una sola cuspide di freccia.
detto questo, è probabile che le società del III millennio riconoscessero differen-ze al proprio interno dal momento che è innegabile una disparità di trattamento deidefunti in molte testimonianze. In quale misura tale disparità rispecchiasse realmen-te l’assetto della società e con quale ordine gerarchico rimane un problema aperto.
e.i.
I RESTI SCHELETRICI UMANI
I resti ossei inumati e combusti rinvenuti sono molto frammentari e rotti in antico.ogni singolo osso è stato determinato con l’intento di risalire al numero minimo
di individui (NMI).Si è cercato di stabilire il sesso, l’età di morte ove possibile e l’eventuale presenza
di caratteri discreti e patologie.La determinazione del sesso e dell’età di morte è stata possibile per pochi indivi-
dui considerando i caratteri morfologici del coxale: l’altezza della grande incisuraischiatica (Letterman 1941) e la presenza del solco preauricolare (houghton 1978)per il sesso, i cambiamenti morfologici della superficie della sinfisi pubica per l’età(Meindl et alii 1985).
Per determinare l’età negli individui immaturi è stato preso in considerazione lostato di maturazione ed eruzione dentaria (Ubelaker 1978).
241
L’orizzonte culturale del III millennio a.C.: il tumulo 7 di Salve (Lecce)
Si è cercato inoltre, di determinare la statura (Trotter, Gleser 1958; Sjǿvold 1990)e il peso (ruff et alii 1991) degli individui. Le misure seguono la numerazione e lametodologia di Martin e Saller.
è stata effettuata l’analisi dell’apparato stomatognatico, rilevando il grado di usura deidenti (Molnar 1978), la presenza di carie, tartaro e delle linee di ipoplasia dello smalto.
Per quanto riguarda l’analisi dei resti scheletrici umani combusti si è cercato di ri-salire al tipo di cremazione e all’intensità della deformazione dei resti, osservando latipologia delle fratture visibili superficialmente (Mayne Correia 1997) valutando latemperatura e il tempo di esposizione al calore dei cadaveri, sulla base del colore do-minante dei resti ossei (Mays 1998).
TUMULO 7
Nel tumulo 7 i resti umani sono stati rinvenuti all’interno di una cista litica e inquelle che sono state denominate “fossa” e struttura di combustione.
La cista litica
Nella cista litica i reperti inumati sono molto numerosi, rotti in antico e distribuitiin diversi livelli.
Molti sono stati gli attacchi e le coppie rinvenute all’interno dello stesso livello, po-chi quelli rinvenuti tra differenti livelli. Si è deciso comunque di considerare global-mente i resti ossei rinvenuti all’interno della cista per il calcolo del NMI. In base airesti rinvenuti il numero minimo di individui è 50, di cui 35 adulti, maschi e fem-mine, e 15 immaturi (0-19 anni).
I reperti scheletrici umani sono posti senza ordine e ciò fa supporre una manipola-zione in antico anche se in alcuni casi si poteva osservare la presenza di alcune ossa nel-la giusta posizione anatomica. Nel primo livello con cui iniziano le inumazioni è statorinvenuto, infatti, un individuo in decubito laterale destro, con orientamento oE, inparziale connessione anatomica (bacino, arti inferiori e piedi), mentre il cranio, gli artisuperiori e il torace appaiono sconvolti. Sopra questo individuo, denominato T7A, sirileva parte di un rachide nella giusta posizione anatomica, con lo stesso orientamento.
è possibile formulare in proposito diverse ipotesi:si tratta di sepolture primarie che dopo la deposizione e la scheletrizzazione dei ca-
daveri sono state sconvolte;si tratta di sepolture secondarie e riduzioni la cui deposizione e scheletrizzazione
dei resti è cominciata e/o avvenuta in un altro luogo;le deposizioni rinvenute in parziale connessione anatomica deposte e scheletrizza-
tesi all’interno della cista (primarie) sono state sconvolte nel momento in cui sono sta-ti aggiunti, in differenti periodi, i resti pertinenti ad altri individui seppelliti in altroluogo.
Il numero minimo di individui adulti rinvenuto all’interno della cista è 35, poichéerano presenti 35 M2 inferiori destri. Un’indicazione sul sesso ed età di morte, altez-za e peso è stata possibile per pochi individui. L’analisi dei caratteri sessuali sull’osso
242
Ingravallo et alii
dell’anca e sul cranio e il dimorfismo sessuale, evidente nelle dimensioni delle ossa lun-ghe, indica la presenza di individui maschili e femminili anche se risulta difficile sta-bilirlo quantitativamente a causa della frammentarietà dei resti e del modello di de-posizione, mentre nella maggior parte dei casi si è potuto dare soltanto una determi-nazione qualitativa di età adulta considerando la completa maturazione dentale. Traquesti individui vi è l’individuo adulto T7A, di sesso maschile, alto circa m 1,73. Ilsesso è stato determinato inoltre, per due individui maschili adulti, osservando i ca-ratteri morfologici dell’osso dell’anca, mentre per un solo individuo è stata stimatal’età basandosi sull’analisi della superficie della sinfisi pubica (45-50 anni). L’altezzaè stata calcolata per due individui (162,932±4,49 cm e 163,745±4,49 cm), il peso pertre (59,3 Kg - 63,2 Kg - 67,1 Kg –63,2 Kg).
Sono stati rinvenuti 907 denti di cui 807 (88,98%) riferibili a individui adulti e100 (11,02%) agli immaturi. Lo studio odontologico interessa i denti dei soli indi-vidui adulti.
I denti caduti post mortem sono 728 (90,21%), in maggioranza superiori (quasi il51%), mentre solo 79 (9,79%) sono negli alveoli e sono in maggioranza inferiori(62%). Più specificatamente la distribuzione dei diversi denti suddivisi in superioried inferiori sono meglio illustrati nella figura 15. I denti maggiormente rappresenta-ti sono in generale i molari inferiori (23,17%), quelli meno rappresentati i canini in-feriori (6,92%).
L’usura dentale varia da 1 a 8 ma pochissimi (2%) sono i denti che hanno usuradentale di grado alto (6-7-8): 11 (68,75%) sono superiori, e più interessati 9 dentianteriori (56,25%).
243
L’orizzonte culturale del III millennio a.C.: il tumulo 7 di Salve (Lecce)
Fig. 15 – Distribuzione dei denti suddivisi in superiori ed inferiori.
Su 20 denti (2,47%) è stata rilevata carie: in generale è più presente sui denti su-periori (70%), più in particolare sui molari (85%). L’insorgenza e la frequenza di ca-rie all’interno di una popolazione possono essere dovute a diversi fattori. General-mente riveste primaria importanza il consumo di cibi cariogeni, raffinati e ricchi disostanze zuccherine, ma possono concorrere alla sua formazione anche altri fattori,come un’imperfetta amelogenesi, che determina una scarsa resistenza dello smalto den-tario (Mallegni et alii 1999).
244
Ingravallo et alii
Fig. 16 – a, osteomielite su femore destro. Vista posteriore; b, parte superiore di omero destro combusto. Sono os-servabili la riduzione volumetrica e le fratture ad andamento conoide. Vista anteriore.
Il tartaro è presente su 309 denti (38,28%): è presente in maggior misura sui den-ti inferiori (52%), in particolare sui molari (20,40%). Il tartaro può essere definitocome un insieme di depositi minerali fortemente adesi ai denti e colonizzati da bat-teri. La causa è da ricercare in una cattiva igiene orale e nel ph della saliva, il cui gra-do di acidità e basicità può condizionare la quantità, la velocità di formazione e la suacomposizione e, pur dipendendo dal metabolismo generale, è particolarmente con-seguente al tipo di alimentazione (Canci, Minozzi 2005).
Le linee di ipoplasia dello smalto sono state rilevate solo sui canini (122). Questeerano visibili su 53 canini (43,44%): il 71,70% sono canini superiori, il restante28,30% canini inferiori. L’ipoplasia dello smalto si manifesta sotto forma di linee opozzetti sulla superficie dei denti ed è causata da interruzioni o rallentamenti nel-l’apposizione dello smalto durante lo sviluppo dello smalto dentale (amelogenesi).Queste interruzioni sono causate da episodi di stress aspecifici come malnutrizioni omalattie, avvenute durante l’infanzia. Poiché i denti non subiscono variazioni nel cor-so della vita, queste alterazioni sono permanenti e possono essere osservate nei dentia qualsiasi età (Canci, Minozzi 2005).
Un caso di patologia è stato rilevato su un femore destro: probabilmente si trattadi osteomielite (fig. 16). L’osteomielite è un infezione non specifica in cui i micror-ganismi, mediante il flusso sanguigno, coinvolgono nell’infezione il midollo osseo sti-molando una deposizione di osso neoformato molto massiccia fino ad alterare lamorfologia del distretto scheletrico colpito. Si osserva soprattutto negli arti inferiorie spesso è associata a produzione di materiale purulento e a fori di drenaggio. L’o-steomielite può causare anche la morte dell’individuo poiché l’infezione può esten-dersi ad organi vitali attraverso il sistema circolatorio e linfatico (Canci, Minozzi2005).
Non sono stati rinvenuti caratteri discreti, probabilmente a causa della frammen-tarietà dei reperti.
diversi sono i resti ossei pertinenti ad individui immaturi. Per immaturi si inten-dono gli individui di età compresa tra 0 e 19 anni. I denti riferibili ad individui im-maturi sono 100, tutti caduti post mortem, di cui 38 deciduali e 62 permanenti in viadi maturazione, rispetto ai quali pochi sono i resti dello scheletro postcraniale. Il NMIimmaturi è 15 dato dalla differente distribuzione dell’età (Tab. 1).
245
L’orizzonte culturale del III millennio a.C.: il tumulo 7 di Salve (Lecce)
Età N. Individui9m.±3m. 118m.±6m. 13a.±12m. 14a.±12m. 15a.±16m. 28a.±24m. 19a.±24m. 212a.±30m. 415a.±36m. 2
1155 Tab. 1 – Distribuzione dell’età negli individui immaturi.
Le incinerazioni
Per incinerazione (o cremazione) si intende il trattamento del cadavere col fuoco.Si possono distinguere due tipi di incinerazioni: l’incinerazione primaria e l’incine-razione secondaria.
Nell’incinerazione primaria il cadavere viene combusto in una struttura (“tomba arogo” o “fossa a rogo”) e ricoperto di terra.
Nell’incinerazione secondaria i momenti funerari sono due: dopo la cremazione del-l’individuo, i resti combusti vengono recuperati e deposti in un contenitore, che saràinfine posto nella tomba definitiva (duday 2005).
I resti umani combusti, rinvenuti all’interno di due brocche e di un’olla poste allabase della cista, presentano un tipo di cremazione incompleta in cui sono sopravvis-suti frammenti di osso. I resti hanno subito un’alterazione morfologica, una riduzio-ne volumetrica e presentano fessurazioni trasversali e ad andamento conoide (fig.16,b). La colorazione è in alcuni frammenti blu, ma in prevalenza bianca: in questocaso la combustione è avvenuta ad una temperatura maggiore di 650° (Mays 1998).
L’analisi della posizione dei resti ha indicato come non ci sia stato alcun ordine nel-la distribuzione dei reperti combusti all’interno dei tre vasi.
All’interno di una brocca sono stati rinvenuti resti pertinenti ad un unico indi-viduo di sesso ed età non determinabile (g 157,84). Nella seconda brocca i repertiumani combusti sono riferibili ad un individuo di sesso non determinabile e di etàcompresa tra 16 e 20 anni per la presenza delle tracce di fusione sull’estremità di-stale dell’ulna (g 156,72). All’interno dell’olla sono stati rinvenuti resti pertinentiad un individuo di sesso indeterminabile e di circa 18 anni (g 956,68) poiché la sin-fisi pubica presenta la superficie ondulata, ben delineata ed evidente, tipica degliindividui giovanili (Meindl et alii 1985): la colorazione blu su alcuni frammenti dicranio, nel caso specifico l’emimandibola e parte dell’arcata superiore destre, indi-cativa di una temperatura minore, rispetto alla colorazione bianca delle corrispet-tive parti sinistre, potrebbe indicare che al momento della cremazione alcune par-ti del corpo erano meno soggette di altre all’azione del calore. oltre al cranio in-fatti, anche frammenti di femore e fibula, purtroppo non lateralizzabili, presenta-vano tracce di blu.
Si è partiti dal presupposto che in ogni vaso vi fossero resti pertinenti a un soloindividuo; in realtà non si può essere certi poiché, se considerassimo nella sua glo-balità il materiale combusto conservato nei tre vasi, il numero minimo di individuisarebbe due: un’arcata superiore e una mandibola sono state rinvenute sia nella se-conda brocca sia nell’olla. Nella tabella seguente sono riportati i pesi dei diversi di-stretti scheletrici, considerando nel peso totale anche i frammenti non determina-bili, suddivisi nei tre vasi (Tab. 2). Tra quelli riconoscibili, solo i frammenti di cal-vario e degli arti inferiori erano presenti in tutti i vasi, mentre mancano le ossa del-le mani.
Più in dettaglio segue l’analisi del contenuto di ciascun vaso. Nella prima brocca sono riconoscibili frammenti di calvario, femore, tibia, fibula
e il sustentaculu tali del calcagno sinistro.
246
Ingravallo et alii
Nella seconda brocca sono stati determinati frammenti di calvario (14 denti, partedell’emiarcata superiore destra e sinistra), mandibola (emimandibola sinistra fram-mentaria, processo condiloideo destro), corpo dell’epistrofeo, metà corpi di due verte-bre cervicali, parte di spina e cavità glenoidea di scapola destra, teste omerali, frammentodi estremità distale ulna, frammento di ileo sinistro, frammenti di diafisi femorali.
Nell’olla sono presenti frammenti di calvario e mandibola, 5 denti, corpi di 6 ver-tebre toraciche, corpi delle 5 vertebre lombari, frammenti di coste, parte margine la-terale di scapola destra, cavità glenoidea di scapola sinistra, metà diafisi di entrambigli omeri, capitello di radio, frammento diafisi di ulna sinistra, sinfisi pubica destra,parte della superficie auricolare e ischio sinistri, frammento della prima vertebra sa-crale, estremità prossimale femore destro, tibia, fibula, frammento troclea di astraga-lo sinistro, frammento di calcagno, frammenti testa di entrambi i primi metatarsi, cor-po di metatarso.
La fossa
I resti rinvenuti sono pochi e frammentari: il rinvenimento di due secondi molarisuperiori sinistri riferibili a due individui adulti e di un primo incisivo superiore de-stro con la radice non completamente obliterata, non assegnabile agli altri due per-ché immaturo, indica la presenza di tre individui. Il confronto dell’incisivo con lo sche-ma dello sviluppo e della maturazione dentaria indica che l’individuo immaturo haun’età di 9a.±24m. (Ubelaker 1978).
Tra i resti recuperati vi sono 11 denti, corpo di una 1ª falange della mano, frammentodi acromion scapolare destro, frammento di 1ª costa, 1/3 diafisi femore sinistro, fram-mento diafisi fibula. L’usura dentale va dal grado 1 al grado 7 (Molnar 1978). Tra que-sti è stata rilevata carie sulla superficie occlusale del M3 destro. La presenza dei pochireperti umani riferibili a diversi individui all’interno della fossa potrebbe indicare l’uso
247
L’orizzonte culturale del III millennio a.C.: il tumulo 7 di Salve (Lecce)
Brocca Brocca olla(g) (g) (g)
Cranio 9,46 57,89 102,47vertebre - 3,8 65,83Coste - - 5,14Cinto scapolare - 4,66 11,51Arti superiori - 5,75 74,89Mani - - -Bacino - 2,6 63,93Arti inferiori 56,64 13,33 121,04Piede 3,26 - 11,14diafisi non determinabili 53,12 18,97 189,22Frammenti non determinabili 35,36 49,72 311,51Totale 157,84 156,72 956,68
Tab. 2 – Peso dei resti combusti rinvenuti nei tre vasi suddivisi per diversi distretti scheletrici.
della stessa come luogo utilizzato per la deposizione e scheletrizzazione degli individui,i cui resti, in un secondo momento, sono stati asportati e deposti in altro luogo.
La struttura di combustione
Nella struttura di combustione sono stati rinvenuti pochi frammenti combustiumani (radice di un dente, frammenti di coste e diafisi non determinabili) di colora-zione prevalentemente bianca, tipica della combustione ad alta temperatura (maggioredi 650°), con fessurazioni trasverse e ad andamento conoide (17,09 g). I frammentiumani combusti e il terreno misto a cenere potrebbero indicare l’uso della strutturacome luogo usato per la cremazione.
TUMULO 9
All’interno del tumulo 9 sono stati messi in luce resti scheletrici umani riferibili adue individui adulti di cui uno combusto. I reperti non sono in connessione anato-mica e risultano rotti in antico ma sono concentrati in un’area ben circoscritta. Al-cuni di questi resti presentano tracce di combustione più o meno evidenti.
La presenza della diafisi di una tibia sinistra non combusta e di un frammento del-la faccia posteriore di tibia dello stesso lato (dove è presente il forame nutritizio) contracce di combustione, ha sottolineato la presenza con sicurezza di almeno due indi-vidui. oltre alla tibia, è stato rinvenuto un frammento dell’estremità inferiore di ul-na destra con tracce di combustione, che non poteva essere assegnata alla diafisi del-l’ulna dello stesso lato non combusta per le differenti dimensioni, pur essendo fram-mentaria proprio quell’estremità. Gli individui sono stati denominati T9A e T9B.
T9A è rappresentato da tutti i reperti non combusti: frammenti di calvario, man-dibola frammentaria, 17 denti, frammenti di vertebre e coste, clavicola e spina sca-polare sinistre, diafisi dell’omero destro, metà diafisi inferiore dell’omero sinistro, dia-fisi delle ulne e dei radii, tre corpi di metacarpi non determinabili, quattro prime fa-langi e due seconde falangi della mano, diafisi dei femori, diafisi della tibia sinistra eframmenti della tibia destra, un frammento di navicolare sinistro e il corpo di un me-tatarso non determinabile.
Si tratta di un individuo di sesso ed età non determinabile. L’usura dentale va dalgrado 2 al grado 6 di Molnar (1978) ed è più marcata sugli incisivi presenti (gradi 5e 6) rispetto ai molari (gradi 2 e 3). Tra questi sono stati rilevati carie al colletto sullato distale del M1 destro, tartaro sul lato linguale del P2 sinistro e le linee di ipo-plasia dello smalto sul C, sinistro.
T9B è rappresentato da pochissimi resti frammentari combusti (43,78 g). Alcunidi questi (frammenti di calvario, ulna, tibia, fibula e diafisi non determinabili) pre-sentano solo tracce di combustione (25,04 g) con una colorazione che varia dal na-turale, al nero, al blu, al bianco; altri (frammenti di diafisi non determinabili) sonodi colorazione bianca (18,74 g), con fratture trasverse e ad andamento conoide e han-no subito un alterazione morfologica. Non è possibile determinare il sesso e l’età dimorte dell’individuo.
248
Ingravallo et alii
CONSIDERAZIONI
Nel tumulo 7, i resti scheletrici umani sono stati rinvenuti in tre differenti con-testi:
– cista litica– fossa– struttura di combustione.Nella cista litica sono stati rinvenuti reperti riferibili ad un numero minimo di 50
individui: 35 adulti, sia di sesso maschile sia femminile, e 15 immaturi (0-19 anni).
249
L’orizzonte culturale del III millennio a.C.: il tumulo 7 di Salve (Lecce)
CLAvICoLA M6ds 38ds 37
oMEro M3sn 50sn 31ds 49sn 60sn 62ds 63sn 59ds 49ds 61ds 62ds 52sn 53sn 63ds 63
rAdIo M1 M2 M3 Indice robustezzaM3/M2
ds 38sn 36sn 34ds 33sn 36sn 37sn 35sn 40ds 35sn 239 229 39 17,03ds 34,5ds 37sn 261 251 45ds 38
ULNA M1 M2 M3 M6 M13 M14 Indice robustezza Indice olenicoM3/M2 M13/M14
sn 16 18 88,89sn 29ds 18 19 94,74sn 16 19 84,21ds 32sn 18 20 90ds 35sn 19 22,5 84,44ds 23 20 20 100sn 36sn 35sn 284 251 37 29 21 27 14,74 77,78ds 27 21 26 80,77sn 36
Tab. 3 – Perimetri minimidelle clavicole rinvenute nellacista litica.
Tab. 4 – Perimetri minimi de-gli omeri rinvenuti nella cistalitica.
Tab. 5 – Misure dei radii rin-venuti nella cista litica.
Tab. 6 – Misure delle ulne rinvenute nella cista litica.
Alla base della cista litica sono stati messi in luce tre vasi contenenti resti ossei com-busti. Nella prima brocca (157,84 g) sono stati rinvenuti resti pertinenti ad un indi-viduo di sesso ed età non determinabile; nella seconda brocca (156,72 g) vi erano re-sti di un individuo di sesso non determinabile e di età compresa tra i 16 e i 20 anni;nell’olla (956,68 g) i resti sono riferibili ad un individuo di sesso non determinabilee di circa 18 anni. Presumibilmente si tratta di tre individui, ciascuno raccolto in unvaso, ma poiché uno stesso tipo d’osso non si ripete nei tre vasi, nulla vieta di pensa-re che i resti siano di due individui.
Nella fossa sono stati rinvenuti pochi resti umani riferibili a tre individui: due adul-ti e un immaturo (9a.±24m.).
Nella struttura di combustione sono stati recuperati pochi resti combusti (17,09g).
Nel tumulo 9 sono stati rinvenuti resti pertinenti ad almeno due individui: il pri-mo non combusto è un individuo adulto di sesso ed età non determinabile; al secondosono riferibili pochi frammenti combusti (28,62 g).
In totale quindi i resti rinvenuti in entrambi i tumuli sono pertinenti ad almeno58 individui (se consideriamo tre individui nei vasi), di cui quattro combusti. Si trat-ta di 38 individui adulti, 18 individui immaturi (compresi gli individui cremati al-l’interno dei vasi) e 2 individui combusti di età non determinabile, rinvenuti uno nel-la brocca, l’altro nel tumulo 9.
Le misure delle ossa degli inumati rinvenuti nella cista e nel tumulo 9 sono ripor-tate nelle tabelle 3-10.
I dati qui ottenuti, considerando il campione per intero, sono stati confrontati conquelli di siti più o meno coevi in Italia.
L’unica altezza confrontabile con altri campioni, poiché è stato utilizzato lo stessometodo, è quella dell’individuo denominato T7A (173,358±5,01 cm), che risulta piùalto degli individui maschili del gruppo eneolitico di Colle val d’Elsa (Siena) (Cen-cetti, Pacciani 1994).
Sul 2,72% della totalità dei denti rinvenuti nel tumulo 7 è stata rilevata carie, per-centuale vicina a quella del campione eneolitico di Grotta San Giuseppe (LI) (Bedi-ni et alii 1999), ma più bassa di quella ottenuta per il sito di Maredolce San Ciro (PA)(16,41%) (Moreci et alii 2006). Nei casi di confronto i denti più colpiti sono i mo-lari inferiori, al contrario nel campione di Salve sono i molari superiori (85%). In tut-ti i casi studiati sugli incisivi non è stata rilevata carie.
La bassissima incidenza di carie nel gruppo eneolitico di Salve, come nel casodel gruppo umano di Grotta San Giuseppe, farebbe ipotizzare quindi un’alimen-tazione basata su cibi “duri” e ricchi di fibre, povera di sostanze zuccherine e raf-finate.
Nel campione di Salve il tartaro è presente su 38,41% dei denti, percentuale piùbassa del campione di Maredolce San Ciro (PA) (55,22%), ma in entrambi i cam-pioni sono più colpiti i denti inferiori: 52,58% per Salve, 50,74% per il campione diconfronto.
Le linee di ipoplasia dello smalto sono state rilevate solo sui canini (6,56%), per-centuale superiore rispetto a quella di Grotta San Giuseppe (1,5%). Nel caso di Sal-
250
Ingravallo et alii
ve il 70,37% sono canini superiori, il 29,63% canini inferiori. A Grotta San Giuseppele proporzioni si invertono: il 14,28% è superiore, l’ 85,78% è inferiore.
Per quanto riguarda i resti umani combusti il confronto più immediato è con l’in-cinerazione rinvenuta nel tumulo 1 di Salve (Ingravallo et alii 2007).
Il peso dei reperti combusti del tumulo 1 è di 1432,54 grammi, più alto di quellodelle incinerazioni del tumulo 7 (nella prima brocca 157,84 g) (nella seconda broc-ca 156,72 g) (nell’olla 956,68 g) ma i resti presentano le medesime caratteristiche neltipo di combustione (colorazione, tipologia di frattura, esposizione al calore e tem-peratura). In cremazioni moderne il peso totale dei reperti ossei di un individuo cre-mato adulto è compreso tra i 1000 e i 2400 grammi, con una media di circa 1625grammi (McKinley 1993). In altri casi si è trovato un peso medio di 2700 grammiper i soggetti maschili adulti e un peso medio di 1840 grammi per quelli femminili(holck 1997). Nel campione di Salve i pesi sono evidentemente inferiori a quelli ot-tenuti nei moderni studi.
251
L’orizzonte culturale del III millennio a.C.: il tumulo 7 di Salve (Lecce)
TIBIA M8a M9a M10b Indice merico M9a/M8a
sn 30 21 67 70ds 33 19 57,58sn 76sn 80
FIBULA M1 M4a Indice robustezza M4a/M1
ds 378 39 10,317
FEMorE M1 M2 M5 M6 M7 M9 M10 M18 M19 Indice Indicepilastrico merico M6/M7 M10/M9
sn 32 25 78,13sn 27 26 96,30sn 33 22 66,67sn 28 20 71,43sn 31 27 87,10sn 27,5 24 82,27ds 42sn 432 330 26 23 26 27 113,04 103,85sn 31 27 87,10sn 27 19 70,37ds 32,5 21 64,62sn 46 45sn 435 432 330 27 24 29 24 44 43 112,50 82,76ds 31 27 87,10ds 29 24 82,76ds 44 44
Tab. 7 – Misure dei femori rinvenuti nella cista litica.
Tabb. 8-9 – Misure delle tibie rinvenute nella cista litica; misure delle fibule rinvenute nella cista litica.
Una situazione sicuramente simile a quella rinvenuta nel tumulo 9 è quella che siera già analizzata per il tumulo 6, dove resti umani non combusti sono stati rinvenutiinsieme a resti umani con tracce di combustione. Nel caso del tumulo 6 il peso deiresti ossei combusti era di 421,85 grammi, mentre nel tumulo 9 i resti sono moltopochi (45,71 g).
n. l.
* Facoltà di Beni Culturali -Università del Salento
252
Ingravallo et alii
CLAvICoLA N° Martin ds snPerimetro minimo 6 34oMEroPerimetro minimo 7 60rAdIoPerimetro minimo 3 38,5 39ULNAdiametro trasversale superiore 13 18,5diametro antero-posteriore superiore 14 20Indice olenico 13/14 92,50FEMorEdiametro antero-posteriore nel mezzo 6 26 26diametro medio-laterale nel mezzo 7 25 26,5diametro sotto trocanterico trasversale 9 29 30,5diametro sotto trocanterico sagittale 10 24 25Indice pilastrico 6/7 104,00 98,11Indice merico 10/9 82,76 81,97TIBIAdiametro sagittale al forame nutritizio 8a 33diametro trasversale al forame nutritizio 9a 23Perimetro minimo 10b 71Indice merico 9a/8a 69,70
Tab. 10 – Misure delle ossa dello scheletro postcraniale dell’individuo T9A.
253
L’orizzonte culturale del III millennio a.C.: il tumulo 7 di Salve (Lecce)
ANdrEA Z. 1975 - Barç (Korçe), Iliria III:415-420.
- - : 1983-84 - Archaeology in Albania, Ar-chaeological Reports: 102-119.
ANThoNY d. w. 2007 - The horse, the wheeland language, Princeton University Press.
ANZIdEI A. P., CArBoNI G., CASTAGNA M. A.,CELANT A., CIANCA M., EGIdI r., FAvo-rITo S., FUNICIELLo r., GIordANo G.,MALvoNE M., TAGLIACoZZo A. 2007 -L’abitato eneolitico di osteria del Curato -via Cinquefrondi: nuovi dati sulle facies ar-cheologiche di Laterza e ortucchio nel ter-ritorio di roma, Atti XL riun. Sc. I.I.P.P.:477-508.
BACCI G. M. , MArTINELLI M. C. 2001 - L’in-sediamento neo- eneolitico di Camaro, inDa Zancle a Messina, a cura di Bacci G. M.,Tigano G., Catalogo della Mostra, Messi-na: 169-181.
BAILo ModESTI G., SALErNo A. 1998 - Pon-tecagnano II.5. La necropoli eneolitica.L’età del rame in Campania nei villaggi deimorti, AIoN, Quad. 11, Napoli.
BAIoNI M. PoGGIANI KELLEr r. 2008 - BellBeakers in Lombardy: sites and settlementstrategies, in Bell Beaker in everyday life, acura di Baioni M., Leonini v., Lo vetro d.,Martini F., Poggiani Keller r., Sarti L., Fi-renze: 151-170.
BAKovIC M. (in stampa) - The Princely Tu-mulus “Gruda Boljevica”, Podgorica, Mon-tenegro, in Ancestral Landscapes. BurialMounds in the Copper and Bronze Ages (Cen-tral and Eastern Europe - Balkans - Adriatic- Aegean, 4 - 2 millennium BC), a cura diBorgna E., Atti del Convegno, Udine 2008.
BALISTA C., BIANChIN CITToN E. (in stampa)- I tumuli funerari dell’età del rame di So-vizzo (vicenza). Aspetti costruttivi e cultu-rali, in Ancestral Landscapes. Burial Moundsin the Copper and Bronze Ages (Central andEastern Europe – Balkans - Adriatic –Aegean, 4 – 2 millennium BC), a cura di
Borgna E., Atti del Convegno, Udine 2008.BArFIELd L. h. 2003 - L’Europa nel 3500 a.
C.: una congiuntura tra diffusione e crisiambientale?, in Il declino del mondo neoliti-co. Ricerche in Italia centro-settentrionale fraaspetti peninsulari, occidentali e nord-alpini,a cura di Ferrari A., visentini P., Atti delConvegno, Pordenone 2002: 11-18.
BEdINI E., dUCCI S., MALLEGNI F., USAI L.,BArToLI F., rUBINI M. 1999 - Una rinno-vata visione della paleobiologia del gruppoumano eneolitico di Grotta San Giuseppe(rio nell’Elba, Livorno), in Archivio perl’Antropologia e la Etnologia, 129: 83-121.
BErMoNd MoNTANArI G. 2001 - Forme inse-diative e aspetti sepolcrali nel Campaniformedell’Italia settentrionale, in Bell Beakers today.Pottery, People, culture, symbols in prehistoricEurope, a cura di Nicolis F., Proceedings ofthe International Colloquium, riva del Gar-da (Trento, Italy): 199-206.
BESSE M. 2004 - des Campaniformes eu-ropéens au Campaniforme méditerranéen,in Les Campaniformes aujourd’hui, a curadi Guilaine J., Besse M., Lemercier o., Sa-lanova L., Strahm C., vander Linden M.,Bulletin de la Société Préhistorique Françai-se, 101: 215-222.
BIANChIN CITToN E. 2004 (a cura di) - L’a-rea funeraria e cultuale dell’età del rame diSovizzo nel contesto archeologico dell’Ita-lia settentrionale, Quaderni di ArcheologiaVicentina, Museo Naturalistico Archeolo-gico, 1: vicenza.
- - : 2006 - Il complesso funerario e cultuale ditipo monumentale di S. daniele di Sovizzo(vicenza), in La cultura del morire nelle so-cietà preistoriche e protostoriche italiane, a cu-ra di Martini F., Collana origines I.I.P.P.:164-168.
BoSCh GIMPErA B. 1926 - Glockenbe-cherkultur, in Reallexikon der Vorgeschichte,ed. Ebert M.: 344-352.
BULATovIC L. S., LUTovAC P. 2003 - The
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Golden Age of Montenegro, JU Muzeji i Ga-lerije Podgorice: Podgorica.
CANAvAGh w., MEE C. 1998 - A privateplace: death in Prehistoric Greece, Studiesin Mediterranean Archaeology, vol. CXXv,Paul Åströms Förlag, Jonsered.
CANCI A., MINoZZI S. 2005 - Archeologia deiresti umani, Carocci: roma.
CArdoSo J. L. 2001 - Le phénomène campa-niforme dans les basses vallées du Tage etdu Sado (Portugal), in Bell Beakers today.Pottery, People, culture, symbols in prehisto-ric Europe, ed. Nicolis F., Proceedings ofthe International Colloquium riva del Gar-da (Trento, Italy): 139-154.
CArrISI E. 2003 - I manufatti in pietra leviga-ta, in Conelle di Arcevia II. I manufatti inpietra scheggiata e levigata, in materia duradi origine animale, in ceramica non vascola-ri; il concotto, a cura di Cazzella A., Mosco-loni M., recchia G., Università di roma“La Sapienza”: 355-404.
CASKEY J. L. 1960 - The Early helladic Peri-od in the Argolid, Hesperia, 29: 285-303.
CATTANI M. 2007 - L’impiego del cavallo nel-le steppe euroasiatiche, in Ori dei cavalieridelle steppe: collezioni dai Musei dell’Ucrai-na, a cura di Bonora G. L., Marzatico F.,Cinisello Balsamo: 84-89.
CAZZELLA A. 1999 - L’Egeo e il Mediterraneocentrale tra III e II millennio: una riconsi-derazione, in ΕΠΙ ΠΟΝΤΟΝ ΠΛΑΖΟΜΕΝΟΙ,Simposio italiano di studi egei dedicato a L.Bernabò Brea e G. Pugliese Carratelli, a cu-ra di La rosa v., Palermo d., vagnetti L.,Scuola archeologica italiana di Atene: 397-404.
- - : 2002 - Malta nel contesto del Mediterra-neo centro-orientale durante la secondametà del III millennio, in Da Pyrgi a Mo-zia. Studi sull’archeologia del Mediterraneoin memoria di Angela Ciasca, a cura di Ama-dasi Guzzo M. G., Liverani M., MatthiaeP., vicino oriente, Quaderno 3/1, roma:139-152.
CENCETTI S., PACCIANI E. 1994 - resti uma-ni di età eneolitica a Colle val d’Elsa (Sie-na), Bullettino di Paletnologia Italiana, 85:287-306.
CoCChI GENICK d. 2007 - Considerazioni
sulle presenze Laterza nei siti tirrenici, AttiXL riun. Sc. I.I.P.P., vol II: 437-459.
- - : 2009 - Preistoria, QuiEdit: verona.CoMSA E. 1993 - La romanie meridionale,
Atlas du Néolithique Européen. L’Europeorientale, E.r.A.U.L.: 151-189.
CrEMoNESI G. 1978 - Gli scavi nella Grottadella Trinità (ruffano, Lecce), QuaderniRicerca Scientifica, 100, CNr: 131-148.
- - : 1985 - La Grotta Cappuccini di Galatone,Congedo editore: Galatina.
dAvIS J. L. 1992 - review of Aegean Prehis-tory I: The Islands of the Aegean, AmericanJournal of Archaeology, 96: 699-756.
dELLA CASA P. 1996 - velika Gruda II. dieBronzezeitliche Nekropole velika Gruda(opš. Kotor, Montenegro), Universitäts-forschungen zur prähistorischen Archäeolo-gie, 33: Bonn.
dörPFELd w. 1927 - Alt-Ithaka. Ein Beitragzur Homer-Frage 1, r. Uhde: München.
dUdAY h. 2005 - Lezioni di archeotanatologia.Archeologia funeraria e antropologia di cam-po, Istituto Arti Grafiche Mengarelli: roma.
drENTh E., hoGESTIJN w. J. h. 2001 - TheBell Beakers Culture in the Netherlands:the state of research in 1998, in Bell Beakerstoday. Pottery, People, culture, symbols in pre-historic Europe, ed. Nicolis F., Proceedingsof the International Colloquium riva delGarda (Trento, Italy): 309-332.
ENdrodI A., GYULAI F., rEMéNYI L. 2008 -The roles of the environmental and cultur-al factors in the everyday life of Bell BeakerCsepel Group, in Bell Beaker in everydaylife, eds. Baioni M., Leonini v., Lo vetrod., Martini F., Poggiani Keller r., Sarti L.,Firenze: 235-256.
FITToN J. L. 1989 - Cycladic Art, British Mu-seum: London.
ForSéN J. 1992 - The Twilight of the Early Hel-ladic: a Study of Disturbances in East-Centraland Southern Greece towards the End of theEarly Bronze Age, Jonsered.
FUGAZZoLA dELPINo M.A., PELLEGrINI E.1999 - Il complesso cultuale campaniformedi Fosso Conicchio, Bullettino di Paletnolo-gia Italiana, 90: 61-159.
GALLAY A. 1995 - La nécropole du Petit-Chasseur à Sion et ses steles: idéologie et
254
Ingravallo et alii
contexte social, in Dans les Alpes à l’aube duMétal: archéologie et bande dessinée, ed. Gal-lay A., Sion: 103-112.
GIMBUTAS M. 1981 - The three waves of theKurgan people into old Europe, 4500-2500 BC, in Anthropologie et Archeologie: lecas des premiers âges des Metaux, eds. Menkr., Gallay A., Actes du Symposium de SilsMaria: 113-137.
GodEvArICA B. 2006 - Finds of the Cetina typein the western Balkan hinterland and the is-sue of culture-historical interpretation in theprehistoric archaeology, Journal of Dalmat-ian Archaeology and History, 1, 99: 27-41.
GUILAINE J., CLAUSTrE F., LEMErCIEr o., SA-BATIEr P. 2001 – Campaniformes et envi-ronnement culturel en France Méditerra-néenne, in Bell Beakers today. Pottery, Peo-ple, culture, symbols in prehistoric Europe, ed.Nicolis F., Proceedings of the InternationalColloquium riva del Garda (Trento, Italy):229-276.
GUILAINE J., TUSA S., vENEroSo P. 2009 - LaSicile et l’Europe campaniforme, Archivesd’écologie préhistorique, Toulouse.
hAJEK L. 1966 - die älteste Phase derGlockenbecherkultur in Böhmen undMahren, Pamatky archeologicke, 57: 210-241.
hArrISoN r. J. 1977 - The Bell Beaker Cul-tures of Spain and Portugal, Peabody Muse-um, n. 35, harvard University: Cam-bridge,.
hArrISoN r. J., MArTIN A. M. 2001 - BellBeakers and Social complexity in CentralSpain, in Bell Beakers today. Pottery, People,culture, symbols in prehistoric Europe, ed.Nicolis F., Proceedings of the Internation-al Colloquium riva del Garda (Trento,Italy): 111-124.
hArrISoN r. J., hEYd v. 2007 - The Trans-formation of Europe in the Third Millen-nium BC: the Example of “Le petit Chas-seur I+III, Präehistorische Zeitschrift 82/2:129-214.
hEYd v. 2004 - Nuova individualizzazione einternazionalizzazione. I gruppi della Cul-tura della Ceramica Cordata e del Bicchie-re Campaniforme lungo il corso superioredel danubio, in Guerrieri, principi ed eroi
fra il Danubio e il Po dalla preistoria all’al-to Medioevo, a cura di Marzatico F., Gleir-scher P., Trento: 125-134.
- - : 2007 - when the west meets the East:The Eastern Periphery of the Bell BeakerPhenomenon and its relation with theAegean Early Bronze Age, in Between theAegean and Baltic Seas: Prehistory across Bor-ders, eds. Galanaki I., Thomas h.,Galanakis Y., Laffineur r., Proceedings ofthe International Conference, AEGAEUM27: 91-107.
- - : (in stampa) - Yamnaya groups and tumuliwest of the Black Sea, in Ancestral Land-scapes. Burial Mounds in the Copper andBronze Ages (Central and Eastern Europe -Balkans - Adriatic - Aegean, 4 - 2 millenni-um BC, ed. Borgna E., Atti del Convegno,Udine 2008.
hoUGhToN P. 1974 - The relationship of thepre-auricular groove of the ilium to preg-nancy, American Journal of Phisical Anthro-pology, 41: 381-390.
INGrAvALLo E. 2002 - Grotta Cappuccini (Ga-latone) tra eneolitico e primo bronzo, Con-gedo: Galatina.
INGrAvALLo E., TIBErI I., LoNoCE N., FABBrIP. F. 2007 - Testimonianze culturali e fu-nerarie nel territorio di Salve (Lecce), Ori-gini, XXIX: 7-31.
JUBANI B. 1995 - Kultura ë bronzit të hershëmnë tumat e Shkrelit, Iliria, 25: 53-90.
KAISEr E. 2007 - Sul carro verso l’eternità. Letombe a carro del III millennio a. C. rinve-nute nelle steppe dell’Europa orientale, inOri dei cavalieri delle steppe: collezioni daiMusei dell’Ucraina, a cura di Bonora G. L.,Marzatico F., Cinisello Balsamo: 78-79.
- - : (in stampa) - New investigations on Yam-naya (Pitgraves) Culture in the NorthernPontic region, in Ancestral Landscapes.Burial Mounds in the Copper and BronzeAges (Central and Eastern Europe - Balkans- Adriatic – Aegean, 4 - 2 millennium BC),ed. Borgna E., Atti del Convegno, Udine2008.
KAISEr T., ForENBAhEr S. 1999 - Adriaticsailors and stone knappers: Palagruža in the3rd millennium BC, Antiquity, 73: 313-324.
KorKUTI M, PETrUSo K. M. 1993 - Archae-
255
L’orizzonte culturale del III millennio a.C.: il tumulo 7 di Salve (Lecce)
ology in Albania, American Journal of Ar-chaeology, 97, 4: 703-743.
KUNST M. 2001 - Invasion? Fashion? Socialrank? Consideration concerning the BellBeaker phenomenon in Copper Age fortifi-cations of the Iberian Peninsula, in BellBeakers today. Pottery, People, culture, symbolsin prehistoric Europe, ed. Nicolis F., Procee-dings of the International Colloquium ri-va del Garda (Trento, Italy): 81-90.
LAForGIA E., BoENZI G., SIGNorELLI C. 2007- Caivano (Napoli). Nuovi dati sull’eneoli-tico dagli scavi A.v. La necropoli del Gau-do, Atti XL riun. Sc. I.I.P.P.: 615-618.
LAForGIA E., BoENZI G. 2009 - La necropolieneolitica di Caivano (Napoli), Rivista diScienze Preistoriche, LIX: 181-218.
LANTING J. N., vAN dEr wAALS J. 1976 -Beaker Culture Relations in the Lower RhineBasin, Glockenbecher Symposion, ober-ried: 1-80.
LEoNINI v., SArTI L. 2008 - Bell Beaker pot-tery in Central Italy, in Bell Beaker in every-day life, eds. Baioni M., Leonini v., Lo ve-tro d., Martini F., Poggiani Keller r., Sar-ti L., Firenze: 119-128.
LEoNINI v., MArTINI F., PIZZIoLo G., SArTIL. 2008 - Bell Beaker in the Florentinearea: comments, problems and hypotheses,in Bell Beaker in everyday life, eds. BaioniM., Leonini v., Lo vetro d., Martini F.,Poggiani Keller r., Sarti L., Firenze: 129-137.
LETTErMAN G.S. 1941 – The greater sciaticnotch in American whites and Negroes,American Journal of Phisical Anthropology,28: 99-116.
Lo PorTo F. G. 1962-63 - La tomba di Cel-lino San Marco e l’inizio della civiltà delBronzo in Puglia, Bullettino di PaletnologiaItaliana, 71-72: 192-225.
MAYNE CorrEIA P. M. 1997 - Fire Modifica-tion of Bone: A review of Literature,Forensic Taphonomy, in The postmortemfate of human remains, CrC Press, Boca ra-ton: 275-293.
MAYS S. 1998 - Cremated Bone, in The Arche-ology of human bones, routledge, NewYork: 207-224.
MALoNE C., SToddArT S., BoNANNo A.,
GoULdEr T., TrUMP d. 1995 - Mortuaryritual of 4th millennium BC Malta: theZebbug period chambered tomb from theBrochtorff Circle at Xaghra (Gozo), Pro-ceedings of the Prehistoric Society, 61: 303-345.
MANFrEdINI A., CArBoNI G., CoNATI BAr-BAro C., SILvESTrINI M., FIorENTINo G.,CorrIdI G. 2005 - La frequentazione eneo-litica di Maddalena di Muccia (Macerata),Atti XXXvIII riun. Sc. I.I.P.P.: 433-444.
MANFrEdINI A., FUGAZZoLA dELPINo M. A.,SArTI L., SILvESTrINI M., MArTINI F., Co-NATI BArBAro C., MUNToNI I. M., PIZ-ZIoLo G., voLANTE N. 2009 - Adriatico eTirreno a confronto: analisi dell’occupa-zione territoriale tra il Neolitico finale el’età del rame in alcune aree campione del-l’Italia centrale, Rivista di Scienze Preistori-che, LIX: 115-179.
MArAN J. 1998 - Kulturalwandel auf dem grie-chischen Festland und den Kykladen im spä-ten 3. Jahrtausend v. Cr., I-II, habelt: Bonn
- - : 2007 - Seaborne Contacts between theAegean, the Balkans and the CentralMediterranean in the 3rd millennium BC:The Unfolding of the Mediterraneanworld, in Between the Aegean and BalticSeas: Prehistory across Borders, eds. Galana-ki I., Thomas h., Galanakis Y., Laffineurr., Proceedings of the International Con-ference , AEGAEUM 27: 3-24.
MArINESCU-BILCU S. 1993 - Les Carpatesorientales et la Moldavie, Atlas du Néoli-thique Européen. L’Europe orientale,E.r.A.U.L.: 191-241.
MArTIN r., SALLEr r. 1957-1966 - Lehrbuchder Antropologie, Fischer verlag: Stuggart.
MArZoCChELLA A.1998 - Tutela archeologi-ca e preistoria nella Pianura Campana, inArcheologia e Vulcanologia in Campania, acura di Guzzo P.G., Peroni r., Atti delConvegno, Napoli: 97-133.
MATUSChIK I. 2006 - Invention et diffusion dela roue dans l’Ancient Monde: l’apport del’iconographie, in Premiers chariots, premiersaraires. La diffusion de la traction animale enEurope pendant les IV et III millénaires avantnotre ère, eds. di Pétrequin P., Arbogast r.M., Pétrequin A. M., van willigen S., Billy
256
Ingravallo et alii
M., monogr. du CrA, 29, CNrS, Paris:279-297.
MCKINLEY J.I. 1993 - Bone Fragment Sizeand weights of Bone from Modern BritishCremations and the Implications for theInterpretation of Archaeological Crema-tions, International Journal of Osteoarchae-ology, 3: 283-287.
MEINdL r.S., LovEJoY C.o., MENSForThr.P., wALKEr r.A. 1985 - A revisedmethod of age determination using the ospubis, with a review and tests of accuracy ofother current methods of pubic symphysealaging, American Journal of Phisical Anthro-pology, 68: 29-45.
MEZZENA F. 1998 - Le stele antropomorfenell’area megalitica di Aosta, in Dei di Pie-tra, Skira, Milano: 90-121.
MILoSEvIC A. (in stampa) - New data on Bur-ial Mounds of Cetina Culture. Examplesfrom Central dalmatia, in Ancestral Land-scapes. Burial Mounds in the Copper andBronze Ages (Central and Eastern Europe -Balkans - Adriatic - Aegean, 4 - 2 millenni-um BC), ed. Borgna E., Atti del Convegno,Udine 2008.
MoLNAr S. 1978 - human tooth wear. Toothfunction and cultural variability, AmericanJournal of Phisical Anthropology, 34: 175-190.
MorECI r., MESSINA A., SINEo L. 2006 - Stu-dio su alcuni resti umani eneolitici prove-nienti dal sito di Maredolce San Ciro (Pa-lermo), Archivio per l’Antropologia e la Et-nologia, 136: 133-149.
MüLLEr S. 1989 - Les Tumuli helladiques:où? Quand? Comment?, Bulletin de Corris-pondance Hellénique 113: 1-42.
NICoLIS F. 2001 - Some observations on thecultural setting of the Bell Beakers ofNorthern Italy, in Bell Beakers today. Pot-tery, People, culture, symbols in prehistoricEurope, ed. Nicolis F., Proceedings of theInternational Colloquium riva del Garda(Trento, Italy): 207-229.
- - : 2004 - Il Campaniforme nel territorio po-sto a sud dello spartiacque alpino, in Guer-rieri, principi ed eroi fra il Danubio e il Podalla preistoria all’alto Medioevo, a cura diMarzatico F., Gleirscher P., Trento: 135-138.
o’NEIL J. 2008 - Utility and metaphor: thedesign of the house of Tiles at Lerna, inDais. The Aegean Feast, eds. hitchcock A.,Laffineur r., Crowley J., AEGAEUM, 29:217-220.
PEdroTTI A. L. 2007 - Guerrieri di pietra dalMar Nero all’Atlantico. La diffusione dellastatuaria antropomorfa nel III millennio a.C. in Ori dei cavalieri delle steppe: collezionidai Musei dell’Ucraina, a cura di Bonora G.L., Marzatico F, Cinisello Balsamo: 80-83.
PEroNI r. 1996 - L’Italia alle soglie della sto-ria, Laterza: roma-Bari.
PESKA J. TUrEK J., MATEJICKovA A. (in stam-pa) - visible and invisible Barrows. LateEneolithic Burial Mounds in Forested Ar-eas of Central Moravia, in Ancestral Land-scapes. Burial Mounds in the Copper andBronze Ages (Central and Eastern Europe -Balkans - Adriatic - Aegean, 4 - 2 millenni-um BC), ed. Borgna E., Atti del Convegno,Udine.
PéTrEQUIN P., ArBoGAST r. M., PéTrEQUINA. M., vAN wILLIGEN S., BILLY M. 2006 -Premiers chariots, premiers araires. La diffu-sion de la traction animale en Europe pendantles IV et III millénaires avant notre ère, mo-nogr. du CrA, 29, CNrS: Paris.
PoGGIANI KELLEr r. 2006 - Santuari megali-tici nelle valli lombarde, Preistoria dell’Ita-lia Settentrionale. Studi in ricordo di Ber-nardo Bagolini, Atti del Convegno, Udine2005: 243-266.
PrENdI F. 2002 - Les relations entre l’Albanieet l’Egée à travers la préhistoire, Bulletin deCorrispondence Hellénique, supplement 42:85-96.
PrIMAS M. 1996 - velika Gruda I. hügelgrä-ber des früen 3. Jahrtausends v. Cr. im Ad-riagebiet- velika Gruda, Mala Gruda undihr Kontext, Universitätsforschungen zurprähistorischen Archäeologie, 32, habelt:Bonn.
PULLEN d. J. 1985 - Social organization in Ear-ly Bronze Age Greece. A multidimensional ap-proach, Indiana University, Ann Arbor, Mi-chigan.
- - : 1994 - Modeling mortuary behavior on aregional scale: a case study from mainlandGreece in the Early Bronze Age, in Beyond
257
L’orizzonte culturale del III millennio a.C.: il tumulo 7 di Salve (Lecce)
the site. Regional studies in the Aegean area,ed. Kardulias P. N., Lanham: 113-136.
QUoJANI F. 1983, rinvenimenti eneolitici edell’età del Bronzo, in Studi sul neolitico delTavoliere della Puglia, a cura di Cassano S.M., Manfredini A., BAr - IS 160, oxford:269-292.
rUFF C.B., SCoTT w. w., LIU A.Y.C. 1991 -Articular and diaphyseal remodeling of theproximal femur with changes in body massin adults, American Journal of Phisical An-thropology, 86: 397-413.
SAChSSE C. (in stampa) - Burial Mounds in theBaden Culture. Aspects of Local develop-ment and outer impacts, in Ancestral Land-scapes. Burial Mounds in the Copper andBronze Ages (Central and Eastern Europe -Balkans - Adriatic - Aegean, 4 - 2 millenni-um BC), ed. Borgna E., Atti del Convegno,Udine 2008.
SArTI L., BIrToLo r., CorrIdI C., FoGGI B.,MAGI M., MArTINI F. 1987-88 - Il tumu-lo eneolitico di via Bruschi a Sesto Fioren-tino, Rivista di Scienze Preistoriche, XLI, 1-2: 139-198.
ShErrATT A. G. 1993 - Core, periphery andmargin: perspectives on the Bronze Age, inDevelopment and Decline in the Mediter-ranean Bronze Age, eds. Mathers C., Stod-dart S., Sheffield University Press, Sheffield:335-345.
SJǾvoLd T. 1990 - Estimation of stature fromlong bones utilizing the line of organic cor-relation, Human Evolution, 5: 431-447.
SPYroPoULoS T. (in stampa) - Ampheion atBeotian Thebes: Burial Practices and ritu-al Performances in Early helladic Greece,in Ancestral Landscapes. Burial Mounds inthe Copper and Bronze Ages (Central andEastern Europe - Balkans - Adriatic - Aegean,4 - 2 millennium BC, ed. Borgna E., Atti delConvegno, Udine 2008.
STrAhM C. 2004a - Le phenomene campani-forme et les composantes autochtones noncampaniformes, in Les Campaniformes au-jourd’hui, eds. Guilaine J., Besse M., Le-mercier o., Salanova L., Strahm C., van-der Linden M., Bulletin de la Société Pré-historique Française, 101: 201-206.
- - : 2004b - das Glockenbecher-Phänomen
aus der Sicht der Komplementar-Keramik,in Similar but different, Bell Beaker in Eu-rope, ed. Czebreszuk J., UAM, Poznan:101-125.
TALAMo P. 2008 - dinamiche culturali nellearee interne della Campania centro-setten-trionale durante le prime fasi dell’Eneoliti-co, Rivista di Scienze Preistoriche, LvIII:125-164.
TECChIATI U. 1998 - velturno, localitàTanzgasse: un’area megalitica di età cam-paniforme in val d’Isarco (Bolzano) inSimbolo ed enigma. Il bicchiere campa-niforme e l’Italia nella preistoria europeadel III millennio a.C., a cura di Nicolis F.,Mottes E., Catalogo della mostra, Trento:69-72.
- - : 2006 - Il luogo di culto della tarda età delrame di velturno - Tanzgasse (Bolzano).Aspetti sepolcrali e affermazione territoria-le alle soglie della protostoria in Alto Adi-ge, in La cultura del morire nelle società prei-storiche e protostoriche italiane, a cura diMartini F., origines: 161-163.
TroTTEr M., GLESEr G.C. 1958 - A re-evalu-ation of estimation of stature based on mea-surements of stature taken, American Journalof Phisical Anthropology, 16: 79-123.
TUrEK J. 2006 - Beaker barrows and the houseof dead, in Archaeology of Burial Mounds,ed. Smejda L., University of west-Bohe-mia, Plzen: 170-179.
- - : 2008 - Significance of cremation in the fu-nerary practices of the Bell Beaker EasternProvince, in Bell Beaker in everyday life, eds.Baioni M., Leonini v., Lo vetro d., Mar-tini F., Poggiani Keller r., Sarti L., EdI-FIr- Edizioni Firenze: 271-279.
UBELAKEr d.h. 1978 - Human skeletal re-mains. Excavations, analysis, interpretation,Taraxacum, washington.
vANdEr LINdEN M. 2007 - what linked theBell Beaker in third millennium BC Eu-rope?, Antiquity 81: 343-352.
wEIBErG E. 2007 - Thinking The Bronze Age:Life and Death in Early Helladic Greece,Uppsala Universitet.
wIENCKE M. h. 1989 - Change in Early hel-ladic II, American Journal of Archeology, 93:495-509.
258
Ingravallo et alii