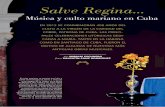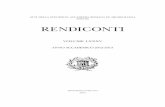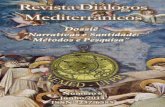Recenti datazioni dalla necropoli di Salve (Lecce)
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Recenti datazioni dalla necropoli di Salve (Lecce)
PREISTORIA E PROTOSTORIA
Volume primo
a cura diDaniela Cocchi Genick
CRONOLOGIA ASSOLUTA E RELATIVA DELL’ETÀ DEL RAME IN ITALIA
Atti dell’Incontro di StudiUniversità di Verona, 25 giugno 2013
a cura diDaniela Cocchi Genick
CRONOLOGIA ASSOLUTA E RELATIVA DELL’ETÀ DEL RAME IN ITALIA
Atti dell’Incontro di StudiUniversità di Verona, 25 giugno 2013
PREISTORIA E PROTOSTORIA
Volume primo
PREISTORIA E PROTOSTORIA
DIRETTORE
Daniela Cocchi Genick
COmITATO SCIEnTIfICO
Diego Angelucci, Alessandra Aspes, Paolo Bellintani, Maria Bernabò Brea, Paola Cassola Guida, Maurizio Cattani, Angiolo Del Lucchese, Raffaele C. de Marinis, Filippo M. Gambari, Stefano Grimaldi, Alessandro Guidi, Giovanni Leonardi, Roberto Maggi, Franco Marzatico, Emanuela Montagnari, Fabio Negrino, Nuccia Negroni Catacchio, Franco Nicolis, Annaluisa Pedrotti, Marco Peresani, Andrea Pessina, Luciano Salzani, Elisabetta Starnini, Giuliana Steffè, Maurizio Tosi, Marica Venturino
Copyright© by QuiEdit s.n.c.Via S. Francesco, 7 – 37129 Verona, Italywww.quiedit.ite-mail: [email protected] I – Anno 2013ISBN: 978-88-6464-248-2Finito di stampare nel mese di dicembre 2013
La riproduzione per uso personale, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, è con-sentita esclusivamente nei limiti del 15%.
149
GIORGIA APRIlE(1) - ElETTRA InGRAvAllO(2) - IDA TIbERI(3)
Recenti datazioni dalla necropoli di Salve (Lecce)
RIASSunTO
Le nuove datazioni al C14 e mediante termoluminescenza provenienti dalla necropoli a tumu-li di Salve hanno permesso di datare non solo il suo impianto tra la fine del IV e gli inizi del III millennio a.C. ma anche la sua lunga durata fino alle soglie dell’età del Bronzo. Si confer-ma, inoltre, che anche nel Salento l’inizio dell’eneolitico risale al IV millennio, come docu-mentato in altre regioni.
AbSTRACT
New radiocarbon and thermoluminescence dating obtained from Salve burial mounds al-lowed to date the building of the necropolis between the end of the IV millennium and the beginning of III millennium BC and to establish its long duration until the Bronze Age. It is also confirmed the beginning of the Copper Age in the Salento peninsula in the IV millenni-um BC, as already documented in other regions.
Parole chiave: Puglia meridionale, tumuli, III millennio a.C., Gaudo, Laterza. Keywords: Southern Apulia, burial mounds, III millennium BC, Gaudo, Laterza.
Nel Salento le datazioni disponibili fino a pochi anni fa riguardavano esclusiva-mente l’aspetto di Laterza e rinviavano ai secoli centrali del III millennio a.C.
Le tre datazioni di Grotta Cappuccini di Galatone si riferivano a un periodo com-preso tra il 2500 e il 2300 a.C.: 3937±29 BP (2500-2300 cal BC 2σ); 3936±28 BP (2500-2330 cal BC 2σ); 3955±28 BP (2500-2390 cal BC 2σ) (Ingravallo 2002); ad esse si aggiungeva la datazione, coeva, proveniente dalla Grotta della Campana d’Oro (Poggiardo) in cui sepolture plurime erano accompagnate da vasi in stile Laterza - Cellino S. Marco: 3937±50 BP (2580-2280 BC) (Aprile e Orlandi Barbano 2011).
La scoperta della necropoli a tumuli di Salve ha modificato il quadro esistente for-nendo nuovi dati sull’eneolitico salentino e, in particolare, sul III millennio a.C. (fig. 1).
L’importanza di Salve risiede in primo luogo nell’aver documentato la presenza di Gaudo nel Salento e la sua convivenza con Laterza; nell’aver dimostrato, in secondo luogo, che accanto all’inumazione collettiva in grotta nel Salento del III millennio a.C. veniva praticato anche il rituale dell’incinerazione entro vasi deposti all’interno di tu-muli (Ingravallo et alii 2007, 2010; Ingravallo e Tiberi 2011).
Anche a Salve le prime datazioni si riferivano alla metà del III millennio in accor-do con quelle disponibili di altri siti. Trattandosi però di una necropoli molto estesa (una settantina di tumuli distribuiti in un’area di circa 100 ettari), si è sentita la neces-sità di avere a disposizione ulteriori datazioni: era presumibile, infatti, che il suo im-
(1) Università degli Studi di Foggia, Via Arpi 176, 71122 Foggia; [email protected](2) Dipartimento di Beni Culturali - Università del Salento, Via D. Birago 64, 73100 Lecce; tel. 0832/295541; e-mail: [email protected](3) Dipartimento di Beni Culturali - Università del Salento, Via D. Birago 64, 73100 Lecce; [email protected]
150
Fig. 1 - Localizzazione dei siti citati nel testo.
pianto potesse risalire a un periodo più antico della metà del III millennio a.C.Una verifica in questo senso è venuta dai tumuli nn. 7, 9 e 10, oggetto delle più
recenti ricerche.Il tumulo 10 articolato in più ambienti ha restituito, nella camera principale, tre
vasi impilati che conservavano al loro interno i resti di un individuo incinerato datato al 3020-2680 cal BC 2σ (LTLT10: 4261 ± 45 BP) (fig. 2). I resti di un altro individuo erano in un altro contenitore deposto a breve distanza. In un ambiente attiguo alla camera principale erano, ridotte in frantumi, brocchette in stile Gaudo (Ingravallo et alii cds a-b).
Il tumulo 7 ha rivelato una situazione più complessa: il monumento è suddiviso in due comparti con diversa destinazione, cultuale l’una e funeraria l’altra, separati da un muro di grandi massi. L’area cultuale era caratterizzata da un piano pavimentale su cui
151
si aprivano due strutture: una buca delimitata da lastre e contenente un vaso gemino tipo Gaudo con decorazione Laterza rotto intenzionalmente a metà e una fossa cul-tuale con tracce di fuoco; il comparto funerario era caratterizzato da una cista litica in cui erano i resti di 50 individui inumati accompagnati da corredi in stile Laterza e Gaudo e, alla base, un’olla e due brocche di facies Gaudo con resti umani combusti; alle sue spalle, una struttura di combustione, oltre a terra mista a ceneri e ossa umane bruciate, aveva alla base un’olla anch’essa rotta a metà.
Quanto alla cronologia, si disponeva finora di due datazioni, una proveniente dal-la cista litica e ricavata da uno dei 50 individui inumati (LTL2464B: 3905±35 BP: 2480-2280 cal BC 2σ), l’altra su carbone di rhamnus/phillyrea, più antica, proveniente dalla fossa cultuale: LTL3736A: 4265±40 BP, 2930-2700 cal BC 2σ.
Una recente campagna di datazioni radiocarboniche e mediante termolumine-scenza effettuate in collaborazione col CEDAD-Università del Salento e il Diparti-mento di Scienza dei materiali dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha forni-to nuovi dati per la ricostruzione delle vicende della necropoli e in particolare del tu-mulo 7.
La datazione su carbone proveniente dalla fossa cultuale (LTL3736A: 4265±40 BP, 2930-2700 cal BC 2σ) è risultata statisticamente compatibile con quelle ricavate dai due individui incinerati deposti alla base della cista litica: l’uno (di età compresa tra 16 e 20 anni) contenuto in una delle brocche Gaudo, l’altro (di circa 18 anni) de-posto all’interno dell’olla, datati entrambi al 2910-2630 cal BC 2σ: LTL4456A (4212 ± 45 BP) e LTL4458A (4209±45 BP) (Ingravallo et alii cds).
Datazioni simili tra loro sono anche quelle restituite da due carboni contenuti nell’olla deposta alla base della struttura di combustione retrostante la cista litica. Si tratta di due campioni di rhamnus/phillyrea datati rispettivamente al 3033-2892 cal BC
Fig. 2 - Salve: tumulo 10.
152
2σ (G2: 4348±42 BP) e al 3116-2903 cal BC 2σ (G3: 4392±45 BP). Interessante sot-tolineare come esse siano statisticamente sovrapponibili a quelle ricavate tramite ter-moluminescenza da due frammenti ceramici riferibili al vaso in questione: D2435B: 3327 ±300 BC e D2435C: 3134 ±300 BC.
Alla luce di questi dati è possibile affermare che l’impianto del tumulo 7 è avvenu-to tra la fine del IV e gli inizi del III millennio BC. Sin dal primo momento il monu-mento si affermò come luogo di importanti attività cultuali e rituali: fu creata la strut-tura di combustione e, dopo l’uso, alla sua base fu deposta l’olla rotta a metà; alla base della cista litica furono sistemati i vasi con gli incinerati; nella fossa cultuale fu com-piuto un atto rituale che comportò l’uso del fuoco. Più tardi la cista fu destinata ad accogliere le ossa di individui inumati dei quali uno soltanto ha restituito una datazio-ne che cade nella metà del III millennio a.C. (fig. 3). Nello stesso periodo veniva co-struito il tumulo 6, che ha restituito le ossa di cinque individui cremati e da cui pro-viene la seguente datazione: LTL1687A: 3941±50 BP, 2580-2290 cal BC 2σ.
Datazioni parzialmente sovrapponibili a quelle del tumulo 6 sono quelle prove-nienti dal tumulo 9 (fig. 4), molto simile al 6 dal punto di vista architettonico: anche qui, un ammasso di terra e pietre copriva una piattaforma basale di grandi massi in cui erano state deposte le ossa di due individui, uno combusto e l’altro inumato.
Un frammento ceramico rinvenuto nel tumulo 9, dopo essere stato sezionato in due porzioni, è stato sottoposto a due tecniche di datazione: termoluminescenza e radiocarbonio. La parte più interna del frammento, che conteneva inclusi di natura organica, ha restituito la seguente datazione: D2435D: 2702-2474 cal BC 2σ (4063±47 BP). La frazione più esterna, di natura inorganica, è stata datata invece con la tecnica della termoluminescenza e ha restituito la datazione di 2570±300 BC (fig. 4).
Per concludere, i tumuli 7 e 10 risultano, finora, i più antichi monumenti della ne-cropoli: il loro impianto risale a un periodo compreso tra la fine del IV e gli inizi del III millennio a.C. Si tratta delle uniche due strutture con architettura complessa co-struite per ospitare vasi di stile Gaudo con incinerati.
La costruzione dei tumuli 6 e 9, simili per architettura e trattamento dei defunti avvenne più tardi, intorno alla metà del III millennio: privi di articolazione interna, hanno restituito le ossa di più individui sparsi senz’ordine al centro della struttura. Allo stesso periodo si riferisce l’inumato deposto nella cista del tumulo 7 (fig. 5).
Le nuove datazioni, per concludere, hanno consentito di retrodatare gli aspetti ini-ziali dell’eneolitico salentino tra la fine del IV e gli inizi del III millennio a.C. e, in par-ticolare, di avere a disposizione datazioni relative al Gaudo nella Puglia meridionale. A questo proposito va sottolineato come alcune incinerazioni deposte nella necropo-li a tumuli di Salve e datate ai primi secoli del III millennio a.C. (comprese tra il 3000-2600 a.C.) erano contenute all’interno di vasi simili ad alcuni esemplari provenienti da Taurasi (si tratta di una brocca deposta alla base del tumulo 7 di Salve che trova con-fronti in Talamo 2008, figg. 3.1,2; 13.1 e di una ciotola proveniente dal tumulo 10 di Salve simile a quella in Talamo 2008, fig. 10.1). Fino a poco tempo fa le datazioni di Taurasi, comprese tra il 3500 e il 3100 a.C. (Talamo et alii 2011), risultavano troppo alte rispetto a quelle di Salve ma al momento tale distanza si è ridotta e niente esclude che - con il proseguimento della ricerca - anche Salve restituisca analoghe datazioni.
153
Fig. 3 - Salve: tumulo 7.
Fig. 4 - Salve: tumulo 9.
Allo stato attuale, Taurasi potrebbe rappresentare, quindi, uno dei siti più antichi della facies Gaudo. Toppo Daguzzo, d’altra parte, aveva restituito alcune datazioni perfet-tamente sovrapponibili a quelle di Taurasi (LJ-4545: 4710±80 BP: 3660-3340 a.C.; LJ-4544: 4680±60 BP: 3640-3350 a.C.; LJ-4546: 4580±80 BP: 3650-3000 a.C.) (Talamo
154
Fig. 5 - Datazioni provenienti dalla necropoli di Salve.
Fig. 6 - Datazioni relative alle fasi iniziali del Gaudo.
et alii 2011). A queste si aggiunge la datazione al 3360-3010 BC (LTL3338A 4478±45 BP) proveniente dalla tomba IX di Paestum (Aurino, in questo volume) (fig. 6).
Se ne può dedurre che Gaudo, al pari di altri aspetti dell’eneolitico italiano, come ad esempio Rinaldone, risale al IV millennio a.C.
155
RIfERImEnTI bIblIOGRAfICI
APRIlE G., ORlAnDI bARbAnO f. 2011, La Grotta Campana d’Oro di Poggiardo (Lecce), AttiIIPP XLIII, pp. 767-769.
InGRAvAllO E. 2002, Grotta Cappuccini (Galatone) tra eneolitico e primo bronzo, Galatina.InGRAvAllO E., TIbERI I., lOnOCE n., fAbbRI P.f. 2007, Testimonianze culturali e funerarie nel
territorio di Salve (Lecce), Origini XXIX, n.s. IV, pp. 7-30.InGRAvAllO E., TIbERI I., lOnOCE n. 2010, L’orizzonte culturale del III millennio a.C.: il tumulo 7
di Salve (Lecce), Origini XXXII, n.s. IV, pp. 203-258.InGRAvAllO E., TIbERI I. 2011, Il tumulo 7 nel territorio di Salve (Lecce), Masseria Profichi, Atti IIPP
XLIII, pp. 343-348.InGRAvAllO E., TIbERI I., APRIlE G., ChIRIACò G., lOnOCE n. cds a, La ritualità funeraria in
località Macchie Don Cesare (Salve-Le): Il tumulo 10, in Tra le rocce nascoste agli Dei, Atti del Convegno, Napoli 2011.
InGRAvAllO E., TIbERI I., APRIlE G., ChIRIACò G. cds b, La necropoli a tumuli di Salve (Le): aspetti topografici e cronologici, AttiIIPP XLVII, Ostuni 2012.
TAlAmO P. 2008, Dinamiche culturali nelle aree interne della Campania centro-settentrionale durante le prime fasi dell’Eneolitico, RSP LVIII, pp. 125-164.
TAlAmO P., PASSARIEllO I., lubRITTO C., TERRASI f. 2011, Evoluzione culturale in Campania: indagine cronologica sistematica tramite datazioni radiocarboniche, AttiIIPP XLIII, pp. 39-48.