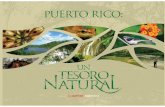Il grande tesoro monetale di Suk El Kedim (Misurata). Recenti studi e ricerche *
Transcript of Il grande tesoro monetale di Suk El Kedim (Misurata). Recenti studi e ricerche *
Il grande tesoro monetale di Suk El Kedim (Misurata).
Recenti studi e ricerche *
Salvatore Garraffo
CNR - ITABC
ABSTRACT
KEYWORDS: Misurata, Suk_El_Kedim, Hoards, Nummus, Follis.
The Treasure of Roman nummi (folles) discovered on 17 February 1981 at Suk El Kedim, near Misurata (Libya),
is one of the biggest finds of silvered bronze coins struck in the Late Roman Empire (108.000 items dating from 294 to
ca. 333 A.D.). In the present paper Salvatore Garraffo, Director of CNR Institute of Technologies applied to the Cultural
Heritage, charged by Libyan Authorities with the study of the Treasure, gives the latest research’s outcomes, by discussing
in detail the remains of the ancient building found in the same archaeological area, the mapping of the different clusters
of coins and their precise chronology. A special attention is addressed to characterize the ancient site, to identify the
owner(s) of the treasure and to explain why the jars full of coins, earthed because of a sudden threat at the end of 333
or at the very beginnings of 334, were not retrieved later: a deadly raid of Austuriani (barbarian tribes of inner
Tripolitania) is assumed.
* La presente relazione riprende, in versione aggiornata e arricchita, quella presentata (attualmente inedita) al Con-vegno Internazionale di Studi su Il grande tesoro monetale di Misurata (Libia). Stato degli studi e prospettive future,tenutosi al CNR (Roma) il 7 luglio 2009, dal titolo Il tesoro di Misurata: un progetto di ricerca interdisciplinare
coordinato dal CNR.Nella nostra dimensione temporale sempre più priva di ‘memoria’, ci si dimentica spesso di coloro che ci hanno,
seppur momentaneamente, lasciato. Viceversa, vorrei dedicare questa relazione a tre Studiosi senza la cui opera la nostraattività non sarebbe stata possibile:
- al fondatore dell’ITABC, Prof. Giuseppe Donato, che tra i primi in Italia sostenne il ruolo della scienze ‘dure’ perla conoscenza e la valorizzazione del Patrimonio Culturale;
- ad Omar El Mahjub, Soprintendente di Leptis Magna, che concesse la Sua fiducia ad un allor giovane studioso,affidandogli lo studio del Tesoro di Misurata;
- al Prof. Antonino di Vita, da poco scomparso, che mi ha sempre appoggiato e aiutato nella ricerca dei fondi.
231
Fig. 1.
Carta stradale
Zliten-Misurata
(da Bognetti 1929)
Fig. 2.
Foto satellitare
dell’area tra
Tripoli e Misurata
(da Google Earth)
Salvatore Garraffo
232
Fig. 3.
Foto satellitare
dell’area tra
Saniyat bu Dar e
Misurata
(da Google Earth)
Fig. 4.
Foto satellitare
dell’area di
scoperta del tesoro,
con l’impianto
della serra
(da Google Earth)
Il grande tesoro monetale di Suk el Kedim (Misurata). Recenti studi e ricerche
233
Fig. 5.
Pianta dello scavo
di Suk el Kedim,
Giardini del 7 Aprile
(a cura della Sopr.
Arch. di Leptis
Magna)
234
Salvatore Garraffo
La scoperta del Tesoro in località Suk el Kedim (Mercato Vecchio), in linead’aria a ca. 10 chilometri ad Est di Dafnia (Villaggio Garibaldi), a 18 chilometri adOvest del centro della odierna città di Misurata, a 700 metri a N-O di Tariq al-Sahili,nonché a ca. 4 chilometri dalla costa, avvenne casualmente il 17 febbraio 1981, aseguito dei lavori di sistemazione di un terreno per la realizzazione di una serra(Giardini del 7 Aprile), con impiego di macchine di movimento terra (Figg. 1-4).
Purtroppo, il personale della Soprintendenza Archeologica di Leptis Magna,allora diretta da Omar El Mahjub, fu in grado di intervenire solo dopo qualchetempo, allorquando la ditta incaricata dei lavori aveva già proceduto in parte allospianamento del terreno e gli operai della società elettrica avevano scavato pro-fonde buche per la messa in opera di pali, con il parziale sconvolgimento di partedell’area archeologica.
Dalla documentazione grafica (Fig. 5) e fotografica (Fig. 6) realizzata a curadella Soprintendenza, e dalla succinta relazione di scavo1, si deduce che, a pocaprofondità dall’attuale piano di campagna, si rinvennero le fondazioni e una pic-cola parte dell’elevato di due (?) blocchi di costruzione a pianta rettangolaredisposti quasi ad angolo retto, in muratura grossolana di pietre e calce: il piùgrande dei due era partito all’interno da muri divisori, delimitanti una serie dipiccoli ambienti alcuni dei quali mostravano vistose tracce di bruciato. In unodi questi ambienti fu ritrovata una grossa anfora tripolitana con cenere all’in-terno, probabilmente residuo della combustione di granaglie. Tra le due strut-ture fu rinvenuta una vasca di metri 1,50 x 1 ca.
La funzione delle costruzioni non risulta tuttora chiara. All’interno di unodegli ambienti si trovarono, tra l’altro, un capitello in pietra tenera scolpito
1 La relazione, in due versioni, è depositata, insieme ad una parziale documentazione fotograficadello scavo e delle emergenze, presso l’archivio della Soprintendenza Archeologica di LeptisMagna (El Khoms).
235
Il grande tesoro monetale di Suk el Kedim (Misurata). Recenti studi e ricerche
Fig. 6.
Parte dei resti
rinvenuti nel
corso dello scavo
(foto Sopr. Arch.
di Leptis Magna)
236
Salvatore Garraffo
Fig. 7.
Il Limes Tripolitanus(da Di Vita 1964)
Fig. 8.
Tabula Peutingeriana,
Sezione VI
(da Talbert 2010)
grossolanamente e abbondanti frammentidi anfore e di ceramica non decorata.
Indagini successive, volte ad ac-certare se le costruzioni scoperte fos-sero isolate o se invece facessero partedi un’area nella quale erano presentialtri edifici, ebbero esito negativo.Ulteriori indagini sarebbero tuttaviadi grande aiuto, soprattutto perchiarire il motivo della presenza diuna enorme quantità di monete.
Il sito si trova a circa 400 metri aNord dalla odierna autostrada Zliten-Misurata, la quale dovrebbe, plus-
minus, seguire il percorso della stradaantica, che da Alessandria portava aCartagine: da tenere presente, peraltro,che tutta la zona, tra Dafnia e Misuratarisulta, dalle indagini archeologichepianificate e non, densamente popolatain antico, con tracce di ville e fattorie2.Se l’antica Thubactis (Fig.7) – ad Estdi Suk el Kedim - è da identificare,grosso modo, con Misurata Marina3,il nostro sito risulterebbe distante daessa, in linea d’aria, circa 30chilometri. Pur non conoscendo qualefosse l’esatto percorso della stradacostiera antica, in relazione al tracciatodella moderna via di comunicazioneZliten-Misurata, si potrebbe avanzarel’ipotesi che Suk el Kedim possa es-sere prossimo, se non addirittura iden-tificarsi con essa, alla Simnana (unastatio o una mutatio ?) ricordata nell’Itinerarium Antonini4 e, più tardi, nellaTabula Peutingeriana5 (Fig. 8), che la colloca a 22 m.p. ad Ovest di Thubactis6.
Riprendendo la descrizione delle emergenze di Suk el Kedim, risulta cheall’esterno dei due blocchi scoperti, e più precisamente nella zona intermedia tradi essi, fu rinvenuto, in parte già nel corso dello spianamento operato dalla dittaesecutrice dei lavori, in parte a seguito degli scavi successivamente eseguiti dallaSoprintendenza, un numero rilevante di grossi vasi (olle, brocche, anfore etc.)ripieni di monete, interrati poco al di sotto del piano antico di campagna (Fig. 9).
Il grande tesoro monetale di Suk el Kedim (Misurata). Recenti studi e ricerche
237
Fig. 9.
Vaso con monete
in situ(foto Sopr. Arch.
di Leptis Magna)
Fig. 10.
I contenitori
restaurati delle
monete del tesoro
esposti nella sala
numismatica del
Museo di Leptis
Magna
(foto S. Garraffo)
2 Mattingly 1997; Di Vita 2009, pp. 6-7.3 Mattingly 1994, pp.132-133; Talbert 2000, p.535.4 Miller 1916, coll. 894-895 e fig. 283.5 Talbert 2010, Section VI.6 Per la localizzazione di Simnana nell’area di Zawiat el-Mahjub vedi Talbert 2000, map 35, grid
G2. Tuttavia l’ipotesi va accolta con estrema cautela in quanto la sua localizzazione è incerta: sulpunto vedi Miller 1916, l.c.
Tali vasi furono ritrovati disposti in due cluster: il primo (A), tra il lato ovestdell’edificio più grande e la vasca di cui sopra, con i vasi (6) quasi a semicer-chio; il secondo (B), a circa 13 metri ad Ovest della vasca stessa, con un maggiornumero di vasi (9), più vicini tra loro, ma disposti in maniera irregolare (Fig. 5).Alcuni vasi erano più o meno integri, altri si rinvennero con la parte superiorespezzata; altri ancora con le pareti frantumate (Fig. 10).
Già nel corso dello scavo, l’ottimo stato della maggior parte delle monete rin-venute, in molti casi leggibili anche prima del restauro, permise al personale dellaSoprintendenza di datare, grosso modo, i vari gruppi di esemplari via via chevenivano alla luce.
A parte qualche diecina di antoniniani residuali del III secolo, tutti i vasi con-tenevano monete in bronzo con patina superficiale in argento in buono e, non dirado, ottimo stato di conservazione, che si rivelarono pressoché esclusivamente- con l’eccezione di un numero proporzionalmente esiguo di frazioni - nummi
(folles) battuti a seguito della riforma monetaria di Diocleziano del 294, pesantiin media, nella fase più antica, circa 10 g. I nummi più tardi del tesoro, dal pesomedio di circa 2,50 g., parvero databili non oltre la fine del 333, in quanto giàdalla prima ricognizione non si rilevarono monete battute per Costante, il più gio-vane dei figli di Costantino, proclamato Cesare la notte di Natale di quell’anno.
I vasi del cluster A restituirono complessivamente circa 20.000 pezzi; quellidel cluster B, circa 74.500.
Gruppi isolati di monete, per un totale di circa 13.500 nominali, apparente-mente senza traccia di contenitore o con quest’ultimo completamente ridottoin frantumi, furono ritrovati a varia distanza dai due cluster. Tale circostanza sispiega, con ogni evidenza, con l’azione del caterpillar e con il trascinamentodei reperti, in qualche caso a rilevante distanza dalla posizione originaria.Tutta l’area fu comunque successivamente indagata tramite un metal detector.
I lavori di scavo e di ricerca durarono una ventina di giorni. Alla fine, tutto il mate-riale ritrovato, circa 108.000 monete – dal peso complessivo di oltre 500 kg - e abbon-
Fig. 11.
I nummi del
tesoro prima del
restauro
(foto S. Garraffo)
238
Salvatore Garraffo
dante ceramica, fu trasportato presso i magazzini della Soprintendenza di Leptis Magna.Qualche centinaio di nummi fu dato, quale premio di rinvenimento7, agli operai delladitta che svolgeva i lavori di realizzazione della serra e al proprietario del terreno.
Dopo qualche tempo, l’allora Soprintendente di Leptis Magna, Omar ElMahjub mostrò alcune monete del tesoro allo scrivente, che si trovava in locoper lo studio dei materiali provenienti dagli scavi del Teatro. In un primo mo-mento, il Soprintendente si mostrò cauto e avaro di dettagli sulle circostanzedel ritrovamento. Tuttavia, nei giorni seguenti, la riserva iniziale venne meno.Ben conscio della eccezionalità del ritrovamento, Omar El Mahjub mi affidò l’in-carico dello studio e della pubblicazione del tesoro, lasciandomi libero dicooptare nella ricerca altri studiosi di mia fiducia. Un ruolo decisivo in questascelta ebbe la sponsorizzazione da parte di Antonino di Vita e Nicola Bonacasa -quest’ultimo direttore della missione della quale facevo parte - decani dellaricerca archeologica italiana in Libia, che si fecero garanti della affidabilità edella competenza del giovane studioso, allora poco più che trentenne.
Povero di mezzi, ma sostenuto da grande entusiasmo, nel corso delle missionieffettuate tra il 1981 e il 1990 riuscii a restaurare da solo oltre 10.000 monete,procedendo inoltre ad una prima ricognizione di tutto il materiale del tesoro.
Il restauro delle monete conobbe nei primi anni ‘90 una sostanziale discon-tinuità, a seguito della mancanza di fondi. Lo studio degli esemplari restauratiin effetti non fu mai interrotto, e qualche anno dopo pubblicai una breve notizia8.
La svolta si ebbe nella seconda metà degli anni ’90. Usufruendo dei fondiCNR del Progetto Finalizzato Beni Culturali, e successivamente del MIUR edel MAE, divenne possibile costituire una Missione archeologica composta dauna diecina di studiosi, restauratori e tecnici, operanti in loco almeno per unmese l’anno, e talvolta due. Le operazioni di restauro, con la partecipazione diprofessionisti del settore, progredirono velocemente; parallelamente, furono por-tati avanti la catalogazione e lo studio delle monete. L’originario progetto diricerca venne ampliato con la programmazione, attraverso innovative strumen-tazioni analitiche portatili non distruttive progettate ad hoc, dello studio degliaspetti composizionali e tecnologici dei nummi, per la valutazione, su ampiascala, del loro progressivo svilimento, nonché per la ricostruzione del processodi fabbricazione dei tondelli e dell’ arricchimento superficiale in argento, ai finidi una storicizzazione integrale dei manufatti.
Elemento centrale del progetto di studio del Tesoro di Misurata sono state laprogettazione, la sperimentazione e l’implementazione di un apposito sistema in-formativo atto a gestire l’immensa mole dei dati relativi alle monete, non solostorico-numismatici e documentali (foto digitali), ma anche di quelli derivanti dalleanalisi composizionali fisico-chimiche. Il sistema, contraddistinto da un alto gradodi innovazione, è stato sin dall’inizio orientato non solo alla gestione, ma anchealla pubblicazione dei materiali, prevedendo l’output di schede dei nummi redattesecondo le attuali regole internazionali di catalogazione e pubblicazione, per zec-che di produzione, in sequenza topografica e cronologica: il sistema si deve al dr.Angelo Nicolosi, informatico dell’IBAM-CNR, sede di Catania. Lo stesso dr. Ni-colosi ha curato recentemente la realizzazione del sito sulle monete catalogate.
Il restauro delle monete è stato ultimato nel 2008. Circa un migliaio di nummi,
239
Il grande tesoro monetale di Suk el Kedim (Misurata). Recenti studi e ricerche
7 Devo questa indicazione al compianto prof. André Laronde.8 Garraffo 1996, pp.179-181.
Fig. 12.
Galerio,
Roma, 303-305,
nummus(Sutherland 1973,
p.363, n.112b:
foto G. Fragalà,
IBAM-CNR)
Fig. 13.
Massimiano
Erculio,
Alessandria,
304-305,
nummus(Sutherland 1973,
p.666. n.38:
foto G. Fragalà,
IBAM-CNR)
Fig. 14.
Massimino Daza,
Ticinum, 305,
nummus(Sutherland 1973,
p.289, n.58b:
foto G. Fragalà,
IBAM-CNR)
Fig. 15.
Galerio,
Ticinum, 306,
nummus(Sutherland 1973,
p.289, n.59b:
foto G. Fragalà,
IBAM-CNR)
Salvatore Garraffo
240
peraltro pienamente leggibili, sono stati lasciati nel loro stato originario, qualitestimoni per studi futuri (Fig. 11). Nel sistema informativo sono attualmentepresenti oltre 70.000 record, ai quali se ne aggiungono circa 13.000 in formatocartaceo, in corso di computerizzazione.
Ritornando ora al contenuto del nostro tesoro, notiamo innanzitutto che i ter-mini cronologici inizialmente proposti sembrano attualmente confermati: perquanto riguarda gli esemplari più tardi, nessuno degli esemplari sinora studiatirisulta battuto per Costante Cesare.
Il ritrovamento, sin dalle prime indagini, si è rivelato una fonte inesauribileper lo studio delle emissioni del nummus nei primi quarant’anni della sua storia,progressivamente ridotto nel contenuto in fino, nel diametro e nel peso, sino acirca 1/5 di quello originario: documentando i prodotti di tutte le zecche delmondo romano attive nel periodo di riferimento, il complesso monetale costituisceuna testimonianza privilegiata delle emissioni in bronzo arricchito di argento, etout court della storia politica ed economica dell’Impero tra la fine del III e iprimi decenni del IV secolo (Figg. 12-31).
Le monete sono state catalogate per contenitore, e comunque per gruppi dirinvenimento, al fine di chiarire il processo di tesaurizzazione. Fin dall’inizio èrisultato infatti evidente che le monete non furono stoccate casualmente nei varivasi, bensì raggruppate in relazione al decrescere del peso, del modulo e, in par-ticolare, del contenuto in fino di argento: ovverossia, per fasce cronologiche.
Nei casi di gruppi ritrovati con composizione fortemente promiscua, si tratta sempredi monete recuperate non in giacitura primaria bensì in contesti disturbati dall’azionedei mezzi meccanici della ditta affidataria dei lavori per la realizzazione della serra.
Tenendo anche debito conto delle monete ritrovate senza contenitore -tralasciando quelle il cui punto esatto di ritrovamento non è stato purtroppo in-dicato nella pianta generale dello scavo -, converrà soffermarsi in particolare suigruppi di monete restituiti da vasi più o meno integri e comunque esattamentecollocati in pianta.
Le monete dei vasi del cluster A si datano, nella stragrande maggioranza, tra il294 e il 312 ca.; tuttavia, circa 450 nummi, facenti parte dei gruppi 5 e 17, rinvenuti,nel primo caso, all’interno di un piccolo vaso ridotto in frantumi, nel secondo, ap-parentemente senza traccia di contenitore, si datano tra il 315 e il 333 ca.
Le monete dei vasi del cluster B si datano tra il 294 e il 333 ca.I nummi più antichi, di peso pieno, sono conservati a parte (gruppi nrr. 6, 18 =
cluster A; gruppi nrr. 3, 13, 14 = cluster B), oppure insieme a quelli di Massenzioemessi dopo la riforma del 307 (p.e. gruppi nrr. 9, 10 = cluster A; gruppo 12 =cluster B): tuttavia, in qualche caso questi ultimi sono stati conservati, in linea dimassima, separatamente, come prova il contenuto del vaso nr.11 (cluster B), cheha restituito circa 25.000 nummi, ancora in corso di schedatura.
Lo stoccaggio del materiale per cronologia è testimoniato anche per le monete più tarde, complessivamente databili nel ventennio 313/333. Di questo sono indicativii vasi nr. 2 e nr. 4 (cluster B), che hanno restituito, rispettivamente, circa 22.500 e11.000 nummi: nel primo caso si tratta, nella stragrande maggioranza, di esemplaribattuti prima del 318; nel secondo, in epoca posteriore, sino al 333. Anche in questidue casi, tuttavia, non mancano tra il materiale restituito, in misura invero percentual-mente modesta, nummi rispettivamente più tardi (vaso nr. 2) o più antichi (vaso nr. 4).
Le monete più recenti del Tesoro, databili tra il 324 e il 333, oltre che nel vaso
Il grande tesoro monetale di Suk el Kedim (Misurata). Recenti studi e ricerche
241
Fig. 16.
Massimiano
Erculio,
Aquileia, 305-306,
nummus(Sutherland 1973,
p.320, n.64b:
foto G. Fragalà,
IBAM-CNR)
Fig. 17.
Galerio,
Cartagine, 306,
nummus(Sutherland 1973,
p.429, n.43a:
foto G.Fragalà,
IBAM-CNR)
Fig. 18.
Costantino I,
Aquileia, 306-307,
nummus(Sutherland 1973,
p.323, n.82b:
foto G. Fragalà,
IBAM-CNR)
Fig. 19.
Costantino I,
Treviri, 307,
nummus(Sutherland 1973,
p.212, n.725:
foto G. Fragalà,
IBAM-CNR)
Salvatore Garraffo
242
243
Il grande tesoro monetale di Suk el Kedim (Misurata). Recenti studi e ricerche
nr. 4, erano presenti soprattutto nei vasi 8 e 15 (cluster B); il vaso 15 ha restituitoanche, in buona percentuale, pezzi anteriori al 324.
Una riflessione va fatta, infine, sulla possibilità che le monete restituite daicluster di vasi A e B non facciano parte di un unico complesso, bensì di due dif-ferenti, di diversa formazione e cronologia. Tale possibilità esisterebbe in lineateorica, tenendo conto della distanza, invero modesta, tra i cluster di vasi A e B.E tuttavia: l’analisi del sito; la similarità del sistema di distribuzione delle species
nei vari contenitori; la giusta considerazione del fatto che l’ usura dei nummi deivasi del cluster A è in generale pari a quella dei nummi simili dei vasi del clusterB; e, non in ultimo, la presenza, seppur modesta, anche tra le monete dal clusterA, di pezzi databili tra il 316 e il 333 ca., sembrano indicare un unico complessomonetale, c.d. à cachettes multiples. Ad ogni buon conto, la completa cata-logazione di tutte le monete appartenenti ai due cluster potrà rafforzare ulterior-mente questa conclusione oppure sottrarle evidenza e confermerà o smentirà,peraltro, l’assenza di nummi di Costante sino ad ora accertata in ambedue i cluster.
Venendo ora ad alcune considerazioni generali, si ha innanzitutto l’impressioneche i contenitori ceramici usati per l’interramento delle monete siano il frutto dellaraccolta del materiale fittile trovato casualmente sul posto, trattandosi di vasi grandi,medi e di piccole dimensioni, alcuni dei quali già restaurati in antico (Fig. 10).D’altra parte, da quanto osservato in precedenza sulla composizione dei gruzzoliall’interno dei vasi, sembra lecito dedurre che lo stoccaggio delle monete inciascuno di essi per cronologia e per contenuto di argento, certamente intenzionale,non fosse stato ultimato al momento dell’occultamento, forzato sicuramente da unasituazione di pericolo imminente. In qualche caso, non è tuttavia da escludere chela compresenza di monete incoerenti, per cronologia e/o per contenuto in fino diargento, con la grande maggioranza delle altre del medesimo gruppo, sia da spiegarecon l’inquinamento causato dal caterpillar o determinatosi durante il successivo re-cupero delle monete stesse, con particolare riguardo a quelle fuoriuscite dai vasi.
Il complesso monetale ha almeno tre caratteristiche peculiari.La prima è l’intervallo di tempo piuttosto lungo tra l’emissione delle monete
più antiche – senza contare i pochi antoniniani rinvenuti - e di quelle più recenti,un quarantennio, che non trova corrispondenza nei grandi tesori chiusi verso lafine dell’età costantiniana9.
La seconda, complementare alla prima, è costituita dalla presenza molto rile-vante, in percentuale, di nummi di peso pieno e della prima riduzione, soprattuttodi Massenzio: considerando infatti gli attuali record del sistema informativo,grosso modo la metà del tesoro è costituita da pezzi emessi tra il 294 e il 312 (dei quali ca. 11.800 battuti da Massenzio); il 32% ca., da pezzi databili tra il 313 e la fine del 323, e il restante 18% da pezzi emessi tra il 324 e il 333 (il 43% dei qualiappartenenti alle serie Gloria Exercitus, Urbs Roma e Constantinopoli(s). Talesituazione costituisce sinora un unicum per quanto riguarda sia i grandi tesori dicui sopra, che, in particolare, quelli scoperti in Tripolitania (e in Africa) occultatidopo il 318: come ha mostrato J.P.Callu10, nei ripostigli della regione dopo questadata è pressoché assente l’Aes battuto prima del 313.
La terza, è il generalmente buono, e in non pochi casi ottimo, stato di conservazione
9 Ovvero in quello di Colonia (Bahrfeldt 1923) purtroppo disperso, comprendente originaria-mente circa 250.000 monete o in quello, ben più modesto, di Nagytéténi (Alföldi 1921). 10 Callu 2010, p. 361.
Fig. 20.
Massenzio,
Aquileia,
307-309/310,
nummus(Sutherland 1973,
p.326, n.121a:
foto G. Fragalà,
IBAM-CNR)
Fig. 21.
Massenzio,
Ostia, 309-312,
nummus(Sutherland 1973,
p.404, n.37:
foto G. Fragalà,
IBAM-CNR)
Fig. 22.
Licinio I,
Nicomedia,
317-320,
nummus(Bruun 1966,
p.604, n.24:
foto G. Fragalà,
IBAM-CNR)
Fig. 23.
Costantino I,
Roma, 318-319,
nummus (Bruun 1966,
p.314, n.149:
foto G. Fragalà,
IBAM-CNR)
Salvatore Garraffo
244
dei nummi più antichi, compresi quelli battuti nel periodo 294-312.Le tre caratteristiche sopra citate costituiscono l’atipicità del tesoro di Misurata.
Tale atipicità potrebbe essere spiegata con la possibilità che le monete del tesoro,e segnatamente quelle più antiche, facessero originariamente parte di riserve mone-tarie immobilizzate di comunità locali, probabilmente municipali, e /o di patri-moni religiosi (templi, santuari ?)11, sottratte alla circolazione: il che spiegherebbebene il fatto che anche i nummi emessi subito dopo la riforma del 294 siano inbuono e, in qualche caso, ottimo stato di circolazione.
Per quanto riguarda infine le zecche di produzione, i nummi del Tesoro di Misuratasono stati battuti da tutte quelle ufficiali del mondo romano, attive nell’arcocronologico 294-333 ca. Ovviamente, il numero dei nominali rappresentati è di-rettamente connesso con i singoli momenti storici in funzione dell’area geo-politica ed economica di appartenenza della Tripolitania in età tardo imperiale,con il volume di produzione delle singole zecche imperiali, variabile nel corsodel quarantennio di riferimento - che vide anche la chiusura di alcune -, nonchécon la maggiore o minore distanza delle zecche stesse dal luogo di ritrovamento.Così, se fino alla riforma massenziana del 307 le zecche documentate sono, inlarga parte, quelle di Cartagine (soprattutto), Roma, Lugdunum, Treviri, Ticinum,Aquileia e, successivamente, Ostia, a partire dal 313 iniziano a farsi numerica-mente significative le emissioni delle zecche orientali, che diventano predomi-nanti dopo l’ eliminazione di Licinio nel 324, anche a causa, tra l’altro, della loroproduzione generalmente più abbondante. Anche in questo periodo, tuttavia, ilnumero di monete presenti battute dalla zecca di Alessandria, operativa solo condue officine, non è molto elevato.
Ricordiamo, infine, che tra l’enorme numero di nummi restituiti dal tesorodi Misurata si notano non pochi esemplari inediti o rari. Da segnalare le seriedi L. Domitius Alexander, numerosi esemplari di Massenzio, e, più tardi, diCostantino I, Licinio, e rispettivi figli.
Dopo queste brevi considerazioni sul luogo di ritrovamento, sul contenuto deltesoro e sulle modalità dello stoccaggio dei nummi, ci soffermeremo sul progettodi caratterizzazione, mediante analisi non distruttive, di una campionatura signi-ficativa del tesoro.
Lo studio chimico-fisico dei nummi è di grande importanza innanzitutto perla definizione, tenendo conto dell’argento contenuto, del valore reale a frontedi quello nominale anche rispetto alle serie in oro e in argento a valore pieno.È d’altra parte evidente che la ricostruzione delle tecniche adottate per la realiz-zazione dell’arricchimento superficiale in metallo nobile è di grande interesseper la storia della metallurgia antica: per l’identificazione di tali tecnicheè essenziale determinare il variare della quantità di argento alle differenti pro-fondità del tondello usato.
Per quanto riguarda l’analisi elementale, negli ultimi decenni hanno assuntoparticolare rilevanza, oltre a quelle tradizionali, le analisi non distruttive a livellodi superficie, anche con strumentazione portatile, nonché a livello globale, so-prattutto, con l’attivazione neutronica. Tuttavia, risultano abbastanza evidenti iproblemi che affliggono le tecnologie analitiche non distruttive applicate alle nostraclasse di monete, di elevata disomogeneità composizionale nel rapporto superficie/substrato / bulk, anche in relazione ai processi di ossidazione e corrosione verificatisi
Il grande tesoro monetale di Suk el Kedim (Misurata). Recenti studi e ricerche
245
11 Come mi suggerisce l’amico prof. J.-P.Callu; per questo aspetto vedi Bonamente, Fusco 1992.
Fig. 24.
Fausta,
Thessalonica,
318-319,
nummus(Bruun 1966,
p.505, n.51:
foto G. Fragalà,
IBAM-CNR)
Fig. 25.
Costantino I,
Roma 321,
nummus(Bruun 1966,
p.321, n.237:
foto G. Fragalà,
IBAM-CNR)
Fig. 26
Costantino I,
Sirmium, 324-325,
nummus(Bruun 1966,
p.475, n.48:
foto G. Fragalà,
IBAM-CNR)
Fig. 27.
Elena,
Alessandria,
325-326,
nummus(Bruun 1966,
p.709, n.38:
foto G. Fragalà,
IBAM-CNR)
Salvatore Garraffo
246
successivamente alla loro emissione. Per es., l’analisi per attivazione neutronicaoffre una indicazione abbastanza precisa della quantità totale dell’argento presentenelle singole monete esaminate, ma non offre dati attendibili in relazione all’even-tuale variazione del contenuto in argento tra la superficie e il bulk della moneta.
In tale situazione, solo l’effettuazione di sezioni stratigrafiche distruttive, conla mappatura dell' andamento percentuale della presenza di argento in relazionealle diverse profondità del tondello, può offrirci indicazioni precise sia per lacomposizione, che per le tecniche di produzione dei nummi. Tale procedura puòessere tuttavia applicata, per ovvi motivi, solo a pochissimi esemplari: questalimitazione si rivela oltremodo penalizzante ove si tenga presente l’ estrema va-rietà delle diverse serie di nummi che potrebbe avere comportato, come pure èprobabile, processi di produzione differenti.
In occasione dello studio in corso del Tesoro di Misurata, insieme al gruppodi ricerca dei Laboratori Nazionali del Sud (Catania) dell’INFN, coordinato dalprof. Giuseppe Pappalardo, è stato definito un protocollo di tecniche analiticheintegrate non distruttive per la caratterizzazione delle monete, che tiene contodella disomogeneità composizionale delle stesse12. Tale sistema si basa sull’inte-grazione di tecniche di superficie (PIXE-ALFA, BSC-XRF), con la tecnica Deep
Proton Activation Analysis (DPAA), in grado di offrirci indicazioni abbastanzaprecise sul contenuto in argento del bulk senza il condizionamento dall’arricchi-mento superficiale. Dall’esame congiunto dei valori ottenuti con ciascuna tecnicaè possibile avere indicazioni non solo sul contenuto totale in argento delle monete,ma anche sulla distribuzione dell’argento alle differenti profondità (Fig. 32).Anche se il trend generale dell’andamento del contenuto in fino dei nummi, conla sua tendenza alla discesa nell’arco cronologico della loro emissione, è ben notoin letteratura13, le indagini effettuate su un numero molto alto di campioni dellediverse serie e zecche di produzione, rivelano un percorso tutt’altro che lineare,che va attentamente esaminato anche alla luce delle differenti condizioni storicheed economiche dell’impero, nelle diverse aree e nei diversi periodi.
Accanto ai LNS-INFN, altri gruppi di ricerca partecipano attivamente allo stu-dio chimico-fisico del Tesoro di Misurata, e, più in generale, alla monetazione inbronzo arricchita in argento del tardo impero romano: l’ITABC-CNR, il Diparti-mento di Chimica dell’Università di Catania, e il Dipartimento di Chimica,Sezione di Metallurgia dell’Università di Genova.
Presso l’ITABC, il dr. Marco Ferretti, con uno spettrometro portatile XRFappositamente progettato, è stato il primo ad effettuare, nel 2002, una nutrita seriedi misure su una campionatura significativa del tesoro14: esse hanno fruttato unprimo quadro chiaro, seppur provvisorio, della composizione dei tondelli dellemonete nei diversi periodi, anche per quanto riguarda la presenza di elementi intraccia. Attualmente, il filone di ricerca seguito è quello delle analisi morfologichee strutturali al SEM, in particolare in relazione al problema della individuazionedel processo di arricchimento superficiale in argento.
I Dipartimenti di Chimica dell’Università di Catania e dell’Università diGenova sono entrati più di recente a far parte del team di ricerca sul tesoro.
Nel primo caso, il gruppo coordinato dal prof. Enrico Ciliberto, in stretta
Il grande tesoro monetale di Suk el Kedim (Misurata). Recenti studi e ricerche
247
12 Rizzo et alii 2011.13 Vedi per es. Callu 2010, pp. 75-88; 287-331; 401-410.14 Campanella, Chicco, Ferretti, Garraffo 2005.
Fig. 28.
Costanzo II,
Roma, 326,
nummus(Bruun 1966,
p.330, n.290:
foto G. Fragalà,
IBAM-CNR)
Fig. 29.
Urbs Roma,
Roma, 330,
nummus(Bruun 1966,
p.336, n.331:
foto G. Fragalà,
IBAM-CNR)
Fig. 30
Constantinopolis,
Costantinopoli,
330-333,
nummus(Bruun 1966,
p.579, n.63:
foto G. Fragalà,
IBAM-CNR)
Fig. 31.
Costanzo II,
Alessandria,
333-335 (?),
nummus(Bruun 1966,
p.711, n.60:
foto G. Fragalà,
IBAM-CNR)
Salvatore Garraffo
248
collaborazione con i LNS-INFN, si è indirizzato all’impiego di tecniche di super-ficie e microanalitiche (SEM, EDX, XRD) ai fini della verifica e della mappaturadell’ accertata presenza di mercurio su alcune emissioni, che potrebbe indicarel’uso della tecnica ad amalgama per l’effettuazione dell’ argentatura superficiale15.
I risultati delle indagini chimico-fisiche sinora condotte hanno permesso diformulare e portare avanti, insieme con il Dipartimento di Chimica dell’Uni-versità di Genova (dr. Paolo Piccardo) un comune programma di ricerca, coni metodi dell’archeologia sperimentale, per la ricostruzione dell’anticoprocesso di preparazione dei tondelli e della successiva coniazione dei nummi.Una prima serie di provini ha già dato risultati incoraggianti.
Il tesoro di Suk el Kedim costituirà pertanto un cantiere permanente per lostudio a tutto campo dell’Aes arricchito di argento del tardo impero romano.
In conclusione, pur tenendo conto del fatto che solo poco più di tre quarti deltotale delle monete del tesoro sono state catalogate e che non si può pertantoescludere la presenza nel tesoro di monete di Costante - presenza tuttavia nonmolto probabile, dopo la ricognizione generale effettuata -, restano più che maiattuali le tre principali domande che A. Di Vita si poneva nel 200916:
1.- Quale era la funzione del complesso monetale ?2.- Perché esso non fu mai recuperato ?3.- Quale era la funzione dell’edificio con il quale tale complesso era connesso?Per quanto riguarda l’ultima domanda, si potrebbe ipotizzare, come ha fatto il
Di Vita, che le strutture messe in luce siano quelle di una fattoria17. È questa unatesi non contraddetta dalla analisi dei resti, e tuttavia non dimostrabile senzaulteriori indagini nel sito; peraltro, se accettassimo tale tesi, ne conseguirebbe,a nostro avviso, che il complesso monetale appartenesse a un privato. Tale ipotesiè debole per almeno due buoni motivi:
1.- è improbabile che un privato mettesse insieme un complesso di monete in Aes,dal peso complessivo di oltre 500 chilogrammi, ingombrante e difficile da proteggere;
2.- come ha mostrato J.P.Callu18, nei ripostigli della regione dopo il 318 non èpiù presente l’Aes battuto prima del 313.
Le difficoltà si eliminerebbero solo in parte riconoscendo piuttosto nel complessomonetale il tesoro di una banca; venuta meno la prima, rimarrebbe la seconda.
Dobbiamo allora propendere per una proprietà ‘pubblica’ (statale o munici-pale) del complesso monetale. Giungeva in effetti a questa conclusione il DiVita19, ritenendo che il tesoro fosse destinato al pagamento, con monetato valutato
a peso, dei clan o delle tribù pacatae che avevano assunto su di sé l’onore diservire i capi romani e l’onere di contrastare il potente populus degli Austuriani(Laguatan20) che in quel periodo saccheggiavano sistematicamente la provinciaTripolitana. E tuttavia: se il monetato era, nella circostanza, valutato a peso, per-ché era stoccato per modulo, peso e contenuto in argento ?
Tutta la questione non è di facile soluzione. Solo al secondo interrogativo sipuò dare una risposta plausibile: il tesoro non fu recuperato perché coloro i qualiinterrarono i vasi con le monete vennero uccisi a seguito di un pur previsto evento
Il grande tesoro monetale di Suk el Kedim (Misurata). Recenti studi e ricerche
249
15 Su queste attività vedi per ora il sito web del tesoro www.misurata.unict.it.16 Di Vita 2009, p. 6.17 Di Vita 2009, p. 7.18 Callu 2010, p. 361.19 Di Vita 2009, p. 8.20 Vedi Felici , Munzi, Tantillo 2006.
disastroso o, comunque, allontanatisi dal posto, non vi fecero più ritorno.Risposte diverse alla prima e alla terza domanda possono essere date in fun-
zione della definizione della esatta cronologia dell’ interramento del tesoro.Qualora l’assenza di monete battute per Costante Cesare dovesse essere confer-
mata, il termine cronologico finale del complesso monetale può essere stabilito,come si è già rilevato, tra la fine del 333 e gli inizi del 334. In questo caso, per spiegarela formazione del tesoro si può avanzare, seppur con grande cautela, l’ipotesi secondola quale il complesso monetale potrebbe essere il frutto di una imposizione (ordi-naria o straordinaria) che avrebbe comportato anche il prelievo di riserve immobi-lizzate di Aes appartenenti a comunità locali: l’imposizione sarebbe stata funzionale,in tutto o in parte, al finanziamento delle celebrazioni per la fondazione diCostantinopoli e il suo abbellimento, che continuarono anche dopo il 33021.
Allo stesso tempo, il complesso medesimo, con i suoi stock di monete più antiche,più pesanti e più ricche di argento di quelle contemporanee, e pertanto destinate co-munque alla fusione, avrebbe dato un contributo alle nuove serie monetali previsteper il nuovo Cesare Costante. Sappiamo che, di regola, la prima emissione di monetaper gli Augusti, così come per i Cesari, avveniva in diretta connessione temporalecon la loro elevazione al rango. In una fase di rapido svilimento della monetazionein bronzo arricchita di argento, risultava conveniente, oltre che produrre moneta ex
novo con metallo in barre o lingotti, rifondere le monete più antiche di maggior valoreintrinseco per produrre, con la medesima quantità di metallo così ottenuto, un piùalto numero di pezzi, più leggeri e con meno argento. In quest’ottica, sarebbe statapreziosa, già a livello periferico, la suddivisione in diversi gruppi del materiale destinatoalla rifusione, a seconda del diverso contenuto in fino, ovviamente noto e ormai iden-tico in tutte le emissioni nell’Impero: in questo modo le officine delle zecche avreb-bero potuto dosare più rapidamente il materiale da riutilizzare rispetto al metallo inbarre o in lingotti, da aggiungere nella fusione per ottenere la nuova lega.
I proventi delle tasse e similia, sia in natura che in moneta, venivano trasportatitramite il cursus publicus22. Aggiungendo ipotesi a ipotesi, perché non pensare che
Fig. 32.
Variazione del
contenuto in
argento alle
diverse profondità
del tondello di 15
nummi databili
tra il 308 e il 310
(LNS-INFN)
Salvatore Garraffo
250
21 Per la fondazione e l’abbellimento di Costantinopoli vedi Bonamente, Fusco 1992, pp. 281 sgg.22 Kolb 2000, passim.
questo sia stato il caso del nostro tesoro e che pertanto Suk el Kedim non sia illuogo in cui si è formato? Non siamo in grado di affermare se il carro (o i carri) chelo trasportavano procedessero verso Ovest (Leptis Magna) o verso Est (Thubactis).Probabilmente il trasporto, scortato, si stava dirigendo verso un centro di raccoltain attesa che il nostro complesso monetale, insieme ad altri, fosse spedito via marea Roma, più vicina, se non già a Costantinopoli. Il trasporto fece una sosta in unastatio o in una mutatio (Simnana; altre ?) lungo il percorso dove giunse notizia diun imminente attacco degli Austuriani: forse proprio tale notizia fu causa dellasosta. Le monete, già suddivise in gruppi, furono stoccate in ogni genere di vasiche fu possibile trovare in loco, e seppellite nel cortile dell’edificio. Gli Austurianimisero a ferro e fuoco il sito, ma non trovarono le monete abilmente nascoste. Nessunodi “quelli che sapevano” sopravvisse o poté tornare successivamente sul posto.
Forse abbiamo tracciato la trama di un film: e tuttavia, potrebbe essere una storia vera.
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE
Alföldi 1921 = A. Alföldi, Il tesoro di Nagytétény, Rivista Italiana di Numismatica,XXXIV, 1921, pp. 113 sgg.
Bahrfeldt 1923= M. von Bahrfeldt, Münzen Constantinus d. Gr. und seiner Zeit
aus dem Münzfunde von Kőln a. Rh. 1895, Halle 1923.
Bognetti 1929 = G. Bognetti, Guida d’Italia del Touring Club Italiano. Possedi-
menti e colonie: isole egee, Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia, Milano 1929.
Bonamente, Fusco 1992 = G. Bonamente, F. Fusco, Sulla confisca dei beni dei tem-
pli in epoca costantiniana, in Costantino il Grande dall’antichità all’umanesimo,Atti del Colloquio sul Cristianesimo nel mondo antico, Macerata 18-20 dicembre1990, I, Macerata 1992, pp. 171-201.
Bruun 1966= P. M. Bruun, The Roman Imperial Coinage, vol. VII, Constantine
and Licinius, A.D. 313-337, London 1966.
Callu 2010 = J.-P. Callu, La monnaie dans l’Antiquité tardive. Trente-quatre
études de 1972 à 2002, Bari 2010.
Campanella, Chicco, Ferretti, Garraffo 2005 = L. Campanella, F. Chicco, M. Fer-retti, S. Garraffo, Il Tesoro di Misurata: un cantiere permanente di ricerca sulla
monetazione nel Tardo Impero Romano, in S. D’Amico (ed.), L’archeometria inItalia: la scienza per i Beni Culturali. Bressanone, 11-12 febbraio 2004, Padova2005, pp. 357-362.
Di Vita 1964 = A. Di Vita, Il limes romano di Tripolitania nella sua concretezza
archeologica e nella sua realtà storica, Libya Antiqua, I, 1964, pp. 65-98.
Il grande tesoro monetale di Suk el Kedim (Misurata). Recenti studi e ricerche
251
Di Vita 2009 = A. Di Vita, Il Tesoro di Misurata e la Tripolitania in età tardo-
costantiniana (relazione inedita presentata al Convegno Internazionale di Studitenutosi al CNR su ‘Il grande tesoro monetale di Misurata (Libia). Stato deglistudi e prospettive future’, Roma 7 luglio 2009, consultabile on line sul sito webinternet www.misurata.unict.it).
Felici, Munzi, Tantillo 2006 = F. Felici, M. Munzi, I. Tantillo, Austuriani eLaguatan in Tripolitania, in A. Akerraz, P. Ruggeri, A. Siraj, C. Vismara (edd.),L’Africa Romana XVI, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Rabat 16-19dicembre 2004, Sassari 2006, pp. 591-687.
Garraffo 1996= S. Garraffo, Notes on coin production, use and circulation in
Tripolitania and Crete in late Roman and early Byzantine times (résumé), inC. E. King, D. G. Wigg (edd.), Coin finds and coin use in the Roman world.The Thirteenth Oxford Symposium on Coinage and Monetary History, 25 -27.3.1993, Berlin, 1996, pp. 179-184.
Kolb 2000 = A. Kolb, Transport und Nachrichtentransfer im Roemischen Reich,Berlin 2000.
Mattingly 1994 = D. J. Mattingly, Tripolitania, Ann Arbor 1994.
Mattingly 1997 = D. J. Mattingly, Modèles d’occupation agricole et archéologie
des paysages dans les oueds de la Tripolitaine romaine, in La dynamique des
paysages protohistoriques, medièveaux et modernes (XVIIe Rencontres Int.d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes), Sophia Antipolis 1997, pp. 65-71.
Miller 1916 = K. Miller, Itineraria romana: römische Reisenwege and der Hand
der Tabula Peutingeriana, Stuttgart 19162.
Rizzo et alii 2011 = F. Rizzo, G. P. Cirrone, G. Cuttone, A. Esposito, S. Garraffo,G. Pappalardo, L. Pappalardo, F.P. Romano, S. Russo, Non-destructive determi-
nation of the silver content in Roman coins (nummi), dated to 308–311 A.D., by
the combined use of PIXE-alpha, XRF and DPAA techniques, MicrochemicalJournal, 97, 2011, pp.286-290.
Sutherland 1973 = C. H. V. Sutherland, The Roman Imperial Coinage, vol. VI,
From Diocletian Reform (A.D.284) to the death of Maximinus (A.D. 313), London1973.
Talbert 2000 = The Barrington Atlas of the Greek and Roman World edited by
Richard J. A. Talbert, Princeton 2000.
Talbert 2010 = R. J.A. Talbert, Rome’s World: the Peutinger Map Reconsidered,Cambridge 2010.
Salvatore Garraffo
252