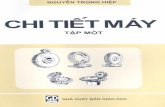Chi era Priscilla? Baronio e le ricerche sulla Roma sotterranea
-
Upload
uni-marburg1 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Chi era Priscilla? Baronio e le ricerche sulla Roma sotterranea
inGo herklotz
Chi era Priscilla? Baronio e le ricerche sulla Roma sotterranea
Nella storia delle indagini sulle catacombe romane e del loro recupero nel-la prima Età moderna una data di assoluto rilievo è concordemente rico-nosciuta nel 31 maggio 1578, quando lavori di scavo per l’estrazione della pozzolana portarono alla casuale scoperta, nei pressi dell’odierna via Ana-po e non lontano dalla via Salaria nuova, di un antico cimitero sotterraneo che fu allora identificato con quello cristiano di Priscilla.1
1. Per la catacomba che fu allora riscoperta lo studio moderno maggiormente appro-fondito è J.G. Deckers, G. Mietke, A. Weiland, Die Kata�ombe “Anonima di Via Anapo”. Repertorium der Malereien, Città del Vaticano 1991. Le fonti relative al suo ritrovamento sono, invece, raccolte in modo quasi completo in G. Ferretto, Note storico-bibliografiche di archeologia cristiana, Città del Vaticano 1942, pp. 104-114, dove pure si sottolinea l’impor-tanza che il fatto ebbe per gli inizi dell’archeologia cristiana e per le finalità apologetiche che caratterizzarono questa disciplina. Su questo aspetto cfr., più di recente, V. Fiocchi Nicolai, Storia e topografia della catacomba anonima di via Anapo, in Deckers, Mietke, Weiland, Die Kata�ombe, pp. 3-23, in part. 3-7; C. Schuddeboom, Philips van Winghe (1560�1592) en het ontstaan van de christlij�e archeologie, Groningen 1996, pp. 121-144; M. Ghilardi, Subterranea civitas. Quattro studi sulle catacombe romane dal medioevo all’età moderna, Roma 2003, pp. 8-10, 59-63. Per una più ampia contestualizzazione del ritrovamento di questa catacomba nella storia della fortuna che interessò le catacombe romane nella prima età moderna cfr., fra i titoli più significativi, G.B. de Rossi, La Roma sotterranea cristiana, I, Roma 1864, pp. 2-82; P. Fremiotti, La Riforma Cattolica del secolo decimosesto e gli studi di Archeologia cristiana, Roma 1926, pp. 62-76, 90-102 e passim; Ferretto, Note storico-bibliografiche, passim; G.B. de Rossi, Sulla questione del vaso di sangue. Memoria inedita con introduzione storica e appendice di documenti inediti per cura di P. A. Ferrua, Roma 1944; Ghilardi, Subterranea civitas, pp. 43-75, in parte ripetuto in Idem, Gli arsenali della fede. Tre saggi su apologia e propaganda delle catacombe romane (da Gregorio XIII a Pio XI), Roma 2006, pp. 13-72. I volumi di Ghilardi contengono indicazioni bibliografi-che esaurienti, almeno per quanto riguarda la letteratura in lingua italiana.
Ingo Herklotz426
Questo ritrovamento ebbe tra i suoi contemporanei un’eco notevole: Antonio Tiepolo, ambasciatore a Roma della Repubblica di Venezia, a di-stanza di poche settimane (era il 28 giugno 1578) ne dava notizia al Sena-to della Serenissima, sottolineando, tra l’altro, che il «Cimiterio di Santa Presilla», subito divenuto meta di una folla di curiosi, aveva attirato anche l’attenzione dell’autorità pontificia, tanto che su ordine del papa esso era stato visitato da Giacomo Savelli, allora cardinale vicario di Roma:
Da quelli, che cavano una certa terra, per fabricare, che si chiama pozzolana, è stato trovato il Cimiterio di Santa Presilla, luogo smarito sino al tempo dell’inondatione de Gotti per le rovine, che fecero, non pure in quella parte, ma per tutta Roma, et Italia. Et in questo Cimiterio, nel quale s’entra con gran fatica, et vi bisognano le torze, vi si veggono molte sepolture de santi con le loro inscrittioni di diverse lingue. Et l’altr’hieri di ordine di sua Santità vi fu l’Ill.mo Cardinale Savello, concorrendovi molta gente, per vedere una antichità, che e forsi la maggiore, che habbino, per quello, che appartiene alla santa Religione, li Christiani.2
In accordo a quanto comunicato dal Tiepolo sono gli Avvisi romani di questo stesso periodo, i quali informano che Savelli fece sbarrare l’in-gresso al complesso ipogeo, anche se la chiusura fu presto rimossa dai visitatori curiosi.3
La scoperta della presunta catacomba di Priscilla, ricordata anche da Cesare Baronio in un passo ben noto del secondo tomo degli Annales Ecclesiastici,4 suscitò una forte impressione nella Roma del tardo XVI se-
2. Archivio di Stato di Venezia, Senato: Dispaccia Ambasciatori, Roma, Filza 13, c. 79v. Un accenno a questo documento è in L. Ponnelle, L. Bordet, St Philip Neri and the Roman Society of his Times (1515�1595), London 1979, p. 96 nota 4.
3. Cfr. gli Avvisi del 29 giugno e del 2 agosto 1578 conservati presso la Biblioteca Apostolica Vaticana (da ora BAV) nel codice Vat. urb. 1046, cc. 256, 302. Citati per la pri-ma volta in A. Valeri, Cenni biografici di Antonio Bosio con documenti inediti, Roma 1900, p. 19 nota 1, essi sono stati successivamente pubblicati più volte, cfr., da ultimo, Ghilardi, Subterranea civitas, pp. 8-10, 59-63; Idem, Arsenali della fede, p. 15. Con gli Avvisi con-corda anche il coevo racconto della scoperta di G. Maffei, Degli Annali di Gregorio XIII. Pontefice Massimo, ... dati in luce da C. Cocquelines sotto gli auspicij della Santità di No�stro Signore Benedetto XIV, I, Roma, Nella Stamperia di Girolamo Mainardi, 1742, p. 376.
4. Il passo, che invero ha intonazione tecnica piuttosto che apologetica, si trova in C. Baronio, Annales Ecclesiastici, II, Romae, Ex Typographia Vaticana, 1590, p. 75 (anno 130): «Mirabile dictu, vidimus, saepiusque lustravimus Priscillae coemeterium haud pri-dem inventum atque refossum via Salaria tertio ab Urbe lapide, quod nullo magis proprio vocabulo dixerimus prae eius amplitudine, multisque atque diversis eiusdem vijs, quàm
Chi era Priscilla? Baronio e le ricerche sulla Roma sotterranea 427
colo, anche perché sebbene del tutto casuale, essa si verificò in un momen-to molto opportuno. Da circa due decenni il passato cristiano di Roma ed i monumenti che ne erano espressione avevano trovato una nuova centralità nella coscienza dei contemporanei. Che questo risveglio riguardasse anche la Roma sotterranea, che durante il Medioevo ed il Rinascimento era stata una realtà in larga parte dimenticata,5 lo dimostra l’esperienza biografica di due protagonisti della coeva riforma religiosa quali Filippo Neri e Carlo Borromeo, che durante la loro gioventù si sarebbero ritirati in meditazio-ne e preghiera nelle catacombe di San Sebastiano.6 Dal 1578 le strutture
subterraneam civitatem; quippe quòd ipsius ingressu primaria via ceteris amplior pateat, quae hinc inde vias diversas habeat, easdemque frequentes, quae rursum in diversos viculos dividantur, et angiportus. Rursus, ut in civitatibus, statis locis velut fora quaedam ampliora sint spatia ad conventus sacros agendos, eademque Sanctorum imaginibus exornata, nec de-sint, licet nunc obstructa, ad lumen recipiendum desuper excisa foramina. Obstupuit Urbs, cum in suis suburbijs abditas se novit habere civitates, Christianorum tempore persecutionis olim colonias, modo autem sepulchris tantum refertas». Un riferimento allo stesso cimitero era in precedenza stato dato da Baronio in Idem, Annales Ecclesiastici, I, Romae, Ex Typo-graphia Vaticana, 1588, p. 460 (anno 57), dove trattando dell’immagine del Buon Pastore, che Tertulliano riferiva essere effigiata sui calici usati dai primi cristiani, Baronio speci-ficava «cuius quidem generis imagines complures inspeximus in antiquissimo Priscillae coemeterio via Salaria nuper refosso». Per le visite compiute da Baronio nelle catacombe romane cfr. anche A. Bosio, Roma sotterranea. Opera postuma ... compita, disposta, et ac-cresciuta dal M. R. P. G. Severani da S. Severino..., Roma, Appresso Guglielmo Facciotti, 1632 [1635], p. 327, e le fonti citate in M.A. Boldetti, Osservazioni sopra i cimiterij de’ Santi Martiri ed antichi cristiani di Roma, Roma, Presso Gio. Maria Salvioni Stampatore Vaticano nell’Archiginnasio della Sapienza, 1720, pp. 243, 246.
5. Per la conoscenza e la frequentazione dei cimiteri sotterranei tra Medioevo e Ri-nascimento cfr. J. Osborne, The Roman Catacombs in the Middle Ages, in «Papers of the British School at Rome», 53 (1985), pp. 278-328; I.T. Oryshkevich, The History of the Roman Catacombs from the Age of Constantine to the Renaissance, Ph.D Thesis, Columbia University, New York 2003; M. Ghilardi, Le catacombe di Roma dal Medioevo alla Roma sotterranea di Antonio Bosio, in «Studi Romani», 49 (2001), pp. 27-56; in parte ripetuto in Idem, Subterranea civitas, pp. 17-41.
6. Per Filippo Neri si veda A. Gallonio, Vita del Beato P. Filippo Neri Fiorentino Fon�datore della Congregatione dell’Oratorio, Roma, Appresso Luigi Zannetti, 1601, p. 10; Il primo processo per san Filippo Neri nel Codice Vaticano latino 3798 e in altri esemplari dell’archivio dell’Oratorio di Roma, a cura di G. Incisa della Rocchetta, N. Vian, C. Ga-sbarri, 4 voll., Città del Vaticano 1957-1963, I, p. 133; III, pp. 92, 178, 257. Fra gli studi più recenti cfr. V. Fiocchi Nicolai, San Filippo Neri, le catacombe di San Sebastiano e le origini dell’archeologia cristiana, in San Filippo Neri nella realtà romana del XVI secolo, Atti del Convegno di studio in occasione del IV centenario della morte di S. Filippo Neri (1595-1995), Roma 11-13 maggio 1995, a cura di M.T. Bonadonna Russo, N. Del Re, Roma 2000,
Ingo Herklotz428
sotterranee acquisirono, invece, un significato diverso, in quanto offrirono nuovi stimoli sia alla nascente archeologia cristiana ed alla riflessione sulla tutela e fruizione dei monumenti antichi, sia ad un rilevante aspetto cultua-le quale quello che riguardava la venerazione delle reliquie.
In questa sede, rispetto a una problematica tanto vasta e complessa, vorrei affrontare, tenendo conto del caso specifico di via Anapo, un aspetto che si profila di grande importanza: quello che riguarda le modalità con cui le scoperte archeologiche furono progressivamente integrate nell’apologe-tica della Controriforma.
Dopo il 1578 i principali problemi che la ricerca archeologica dovette chiarire sul complesso cimiteriale appena riscoperto furono quelli relativi alla sua origine ed alla sua identificazione. Fu il domenicano Alonso Cha-con, storico della Chiesa ed antiquario di origine spagnola, che per primo tentò un’analisi attendibile della struttura di via Anapo.7 Negli studi sulle catacombe romane del tardo XVI secolo Chacon, non è certamente sco-nosciuto poiché dobbiamo a lui le copie di pitture ed iscrizioni cimiteriali conservate nel codice Vat. lat. 5409, dove peraltro accompagnò le immagi-
pp. 105-130, in part. 105-107; Ghilardi, Subterranea civitas, p. 54. Per Carlo Borromeo cfr. le fonti raccolte in Ferretto, Note storico-bibliografiche, pp. 101-102.
7. Su Alonso Chacon, figura di spicco del formarsi, nel tardo XVI secolo, dell’archeo-logia cristiana, oltre la bibliografia citata supra, nota 1, cfr. i saggi biografici, con ampia bi-bliografia precedente: A. Recio, La “Historica Descriptio Urbis Romae”, obra manuscrita de Fr. Alonso Chacón, O. P. (1530�1599), in «Anthologica Annua», 16 (1968), pp. 43-102; S. Grassi Fiorentino, Chacón, Alonso, in Dizionario Biografico degli Italiani, XXIV, Roma 1980, pp. 352-356. Sui suoi interessi archeologici cfr., inoltre, I. Herklotz, Historia sacra und mittelalterliche Kunst während der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, in Baronio e l’arte, Atti del Convegno internazionale di studi, Sora 10-13 ottobre 1984, a cura di R. De Maio, A. Borromeo, L. Gulia, G. Lutz, A. Mazzacane, Sora 1985, pp. 21-74, in part. pp. 50-56, 71-72; A. Recio, Una obra manuscrita de Alfonso Chacon OP (1530�1599): la “Historica Descriptio Urbis Romae”, in «Rivista di Archeologia Cristiana», 78 (2002), pp. 325-428, dove tuttavia l’autore, non avendo tenuto conto degli studi successivi al 1968, ha riproposto alcune imprecisioni presenti nel suo precedente articolo dedicato allo stesso ar-gomento; L. Diego Barrado, Luci rinascimentali. Lo sguardo del Chacon (Alfonso Chacón) all’iconografia paleocristiana e altomedievale della Roma scomparsa, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 127 (2004), pp. 133-176, dove ugualmente non si tiene conto degli studi degli ultimi decenni; I. Herklotz, Alfonso Chacon e le gallerie dei ritratti nell’età della Controriforma, in Arte e committenza nel Lazio nell’età di Cesare Baronio. Atti del Convegno internazionale, Frosinone-Sora 16-18 maggio 2007, a cura di P. Tosini, Roma 2009, pp. 111-142.
Chi era Priscilla? Baronio e le ricerche sulla Roma sotterranea 429
ni – numerose ma poco precise – con scarne notizie di commento.8 In que-sta sede, invece, intendo presentare un suo testo ancora inedito conservato presso il Getty Research Institute di Los Angeles.9 Esso consta di 16 pagine e, datato al 9 luglio 1578, è indirizzato ad un componente non identifica-to del collegio cardinalizio: Chacon auspicava che il prelato convincesse papa Gregorio XIII della straordinaria importanza della catacomba recen-temente scoperta, inducendolo a proteggerla in modo risoluto da qualsiasi danno che le potesse essere arrecato.
Chacon, nel presentare il complesso ipogeo, concordava con i suoi contemporanei sul fatto che, ubicato sulla via Salaria nuova a circa due miglia dalle mura urbane, fosse da identificare con il coemeterium Priscil�lae: si trattava, infatti, dell’unico monumento del genere menzionato nei cataloghi, numerosi quanto sommari, che redatti sin dai primi secoli del Medioevo elencavano i cimiteri del suburbio romano ed i quali costituiva-no l’unica fonte a disposizione del Domenicano.10 Come è stato dimostrato
8. Cfr. BAV, Vat. lat. 5409, in part. cc. 9r�v, 11r�v, 13r�v, 15r, 19r, 28r per le pitture della catacomba di via Anapo. Cfr. anche de Rossi, La Roma sotterranea cristiana, I, pp. 20-25; J. Wilpert, Die Kata�ombengemälde und ihre alten Kopien. Eine i�onographische Studie, Freiburg i. Br. 1891, pp. 4-45; A. Ferrua, Il card. Federigo Borromeo e le pitture delle catacombe, in «La civiltà cattolica», 113/I (1962), pp. 244-250; Deckers, Mietke, Weiland, Die Kata�ombe, Tav. 6s; Schuddeboom, Philips van Winghe, pp. 124-144.
9. Cfr. A. Chacon, De cimiterio S.tae Priscillae Romae invento de anno 1578, (The Getty Center for the History of Art and the Humanities, Archives of the History of Art, No.840005, cc. 70r-78v). Il trattato in questione, che è conservato all’interno di un codi-Il trattato in questione, che è conservato all’interno di un codi-ce miscellaneo insieme a due altri scritti chaconiani, fu segnalato in P.O. Kristeller, Iter Italicum. A Finding�List of Uncatalogued of Incompletely Catalogued Manuscripts of the Renaissance in Italian and other Libraries, 6 voll., London 1963-1997, V, p. 400. Una sua edizione completa ed annotata sarà pubblicata da chi scrive in altra sede. Cfr., per il momento, l’analisi preliminare in I. Herklotz, Christliche und �lassische Archäologie im sechzehnten Jahrhundert: S�izzen zur Genese einer Wissenschaft, in Die Gegenwart des Altertums. Formen und Fun�tionen des Altertumsbezuges in den Hoch�ulturen der Alten Welt, a cura di D. Kuhn, H. Stahl, Heidelberg 2001, pp. 291-307, in part. 292-295. Si segna-Si segna-la infine che una copia, molto frammentaria ed in pessimo stato di conservazione di questo scritto del Chacon si trova nell’Archivio Isolani di Bologna, ai segni CN 59, Int. F. 27-28/1. Esso appartenne in origine al cardinale Gabriele Paleotti, che in quegli stessi anni redasse il suo famoso trattato sulla pittura religiosa. Anche la copia bolognese del trattato chaconiano fu segnalata in Kristeller, Iter Italicum, V, p. 506.
10. Una testimonianza precoce per il «cymeterium Priscillae ad sanctum Silvestrum via Salaria» si trova nel catalogo dei cimiteri di Roma, pubblicato in R. Valentini, G. Zuc-chetti, Codice topografico della città di Roma, II, Roma 1942, p. 60; per la datazione di questo documento cfr. ibidem, pp. 56-58. Dal XII secolo in poi questi cataloghi ebbero
Ingo Herklotz430
dai successivi studi di archeologia cristiana, l’argumentum e silentio ad-dotto da Chacon era erroneo. Quello di Priscilla è stato identificato, infatti, in un altro complesso cimiteriale della via Salaria nuova, leggermente più distante della città e di notevole estensione, mentre il cimitero considere-volmente più piccolo scoperto nel 1578 è ormai correntemente denominato come «catacomba anonima di via Anapo».11
Nel manoscritto di Chacon la cosiddetta catacomba di Priscilla rien-trava tra i quattordici complessi cimiteriali paleocristiani che l’autore si proponeva di presentare in ordine cronologico.12 Fra questi solo il presunto cimitero Vaticano con la tomba di san Pietro risaliva all’età apostolica, mentre gli altri, per la maggior parte dei quali l’autore metteva in rilievo essere stati fondati da facoltosi cristiani su terreni di loro proprietà, data-vano al II o al III secolo. Non erano, infine, ignorati i cimiteri di età tetrar-
ampia diffusione attraverso i Mirabilia Urbis, dove il cimitero di Priscilla appare spesso ac-compagnato da indicazioni quali «ad pontem Salariam» o «via Salaria apud S. Silvestrum», cfr. Ferretto, Note storico-bibliografiche, pp. 42, 44, 89; Ghilardi, Subterranea civitas, pp. 21-22, 47-48, 51.
11. Per il cimitero oggi associato con Priscilla, la quale è stata riconosciuta dalla ricer-ca moderna come una discendente della famiglia di Marco Acilio Glabrione, cfr. F. Tolotti, Il cimitero di Priscilla. Studio di topografia e architettura, Città del Vaticano 1970, e, per un aggiornamento bibliografico, Ph. Pergola, Le catacombe romane. Storia e topografia. Catalogo a cura di P.M. Barbini, Roma 20022, pp. 130-137; R. Giuliani, Genesi e sviluppo dei nuclei costitutivi del cimitero di Priscilla, in Origine delle catacombe romane, Atti della giornata tematica dei Seminari di Archeologia Cristiana, Roma 21 marzo 2005, a cura di V. Fiocchi Nicolai, J. Guyon, Città del Vaticano 2006, pp. 163-175.
12. Secondo l’autore cinque cimiteri erano da localizzare intra urbem: si trattava di quelli di Santa Prassede, nei pressi della chiesa omonima, di Santa Balbina in iugo Aven�tino, di Santa Bibiana «ubi nunc est basilica Sanctae Vibianae», quello dei Santi Pietro e Marcellino ad duas lauros ed un altro presso la chiesa di San Giovanni a Porta Latina. Fuori dalla città si trovavano invece il cimitero vaticano sulla via Trionfale, quelli ad catacumbas, di Sebastiano, Callisto e Pretestato sulla via Appia, il cimitero di Calepodio sull’Aurelia «ubi nunc basilica sancti Pancratii», il cimitero di Priscilla sulla Salaria, quello di Ciriaca vidua presso San Lorenzo fuori le mura, di Santa Lucina presso la basilica di San Paolo. Non è facile, tuttavia, stabilire quali e quanti fra questi antichi luoghi di sepoltura fossero stati realmente visitati da Chacon. I cimiteri ai quali si riferiscono le tavole, eseguite ne-gli anni immediatamente successivi al 1578, contenute in BAV, Vat. lat. 5409 attestano, comunque, una conoscenza diretta di quelli di S. Valentino, di Trasone (anche denomia-to come Coemeterium Novellae), di via Anapo (coemeterium Ostrianum), di Priscilla, di Aproniano, di una regione anonima sulla Via Appia (chiamata da Chacon S. Felicitatis) e quello di Domitilla (detto S. Zephirini). Per l’identificazione di questi complessi si veda la bibliografia citata supra alla nota 8.
Chi era Priscilla? Baronio e le ricerche sulla Roma sotterranea 431
chica e quelli post-costantiniani, i quali evidentemente erano attestati dalle fonti usate da Chacon. All’interno di questa serie cronologica la catacomba di Priscilla era una delle più antiche, in quanto secondo l’erudito domeni-cano essa era stata fondata durante il regno di Traiano, cioè al principio del II secolo, per poi restare in uso, dopo la Pax Ecclesiae, anche nel quarto secolo.
Per l’archeologo odierno i punti deboli del discorso chaconiano sono facilmente riconoscibili. Il Domenicano non muoveva dall’analisi archeolo-gica ma, confidando sulle indicazioni solitamente colorite con annotazioni di carattere apocrifo e leggendario che le fonti letterarie davano sui fon-datori dei singoli cimiteri, collocava la nascita della maggior parte delle catacombe in un ambito cronologico decisamente troppo alto. L’analisi archeologica ha, infatti, dimostrato che nella catacomba di via Anapo non esistono sepolture cristiane anteriori alla metà del III secolo13 ed in ciò essa non differisce da altre catacombe romane, nessuna delle quali – forse con la sola eccezione del nucleo originario del cimitero di Callisto sulla via Appia – fu realizzata prima degli inizi del III secolo.
Le posizioni espresse da Chacon meritano, comunque, la nostra atten-zione. Se si accetta l’opinione comune che l’archeologia cristiana nacque sotto la stretta influenza dell’apologetica della Controriforma, colpisce il fatto che la cronologia chaconiana non permettesse di usare le catacombe come testimonianza diretta degli usi di età apostolica. L’obiettivo princi-pale della storiografia ecclesiastica romana di quegli anni era, infatti, di individuare tali usi, per poi dimostrare come essi fossero stati tramandati in maniera inalterata dalla Chiesa cattolica che, non a caso, Cesare Baronio, negli Annales Ecclesiastici, appellava come «semper eadem», cioè immu-tata nel corso dei secoli e fedele alle sue origini apostoliche.14
13. Deckers, Mietke, Weiland, Die Kata�ombe, pp. 17-23; Pergola, Le catacombe ro�mane, pp. 128-130.
14. Sulla storiografia nell’età della Controriforma esiste una letteratura critica assai vasta. In questa sede mi limito a citare pochi titoli di particolare interesse, dai quali si pos-sono ricavare ulteriori rimandi bibliografici: J.P. de Orella y Unzue, Respuestas catolicas a las centurias de Magdeburgo (1559�1588), Madrid 1976; E. Cochrane, Historians and Historiography in the Italian Renaissance, Chicago-London 1981, pp. 445-478; S. Zen, Baronio storico. Controriforma e crisi del metodo umanistico, Napoli 1994. Si vedano, da ultimi, anche i vari contributi riuniti in Nunc alia tempora, alii mores. Storici e storia in età postridentina, Atti del Convegno internazionale, Torino 24-27 settembre 2003, a cura di M. Firpo, Firenze 2005.
Ingo Herklotz432
Tenendo presente questo sfondo vale la pena osservare come la di-scussione sul cosiddetto cimitero di Priscilla proseguisse durante i decenni successivi al 1578.
Chacon stesso cambiò la sua proposta di identificazione qualche anno dopo la stesura del testo appena presentato. È probabile ciò sia avvenuto in quanto egli, negli anni successivi al 1578, ebbe modo di visitare il vero cimitero di Priscilla: copie di pitture di quest’ultimo si trovano nel codice Vat. lat. 5409, dove Chacon, con una nota di commento, giunse addirittura a riconoscere in una immagine femminile il ritratto della fondatrice Pri-scilla.15 Lo stesso codice, come già accennato, contiene, tuttavia, anche le pitture del cimitero di via Anapo. A questo proposito è interessante che la didascalia «coemeterium Priscillae» riferita dal pittore ad una delle copie fu sostituita da Chacon con quella «coemeterium Ostrianum», a sua volta seguita dalla nota «ubi Petrus praedicavit et baptizavit».16 Al coemeterium Ostrianum, strettamente associato con il soggiorno romano di san Pietro, Chacon non aveva accennato nel trattato del 1578. Esso compariva, inve-ce, fra i quarantatrè cimiteri cristiani di Roma che l’agostiniano Onofrio Panvinio aveva elencato nel suo trattato sugli usi funerari ed i luoghi di sepoltura degli antichi cristiani.17 Questa lista, che fu redatta da Panvinio
15. Cfr. BAV, Vat. lat. 5409, c. 28, dove si trova l’immagine di una donna che dà da mangiare alle pecorelle e ai galli. In realtà si tratta di una riproduzione fantastica di un affresco del Buon Pastore! Cfr. Wilpert, Die Kata�ombengemälde und ihre alten Kopien, pp. 7, 21-22. Sulla stessa carta l’immagine di Noè nell’arca fu riprodotta in modo tanto al-terato da portare Chacon a riconoscervi Marcello I, cioè il papa comtemporaneo di Priscilla, mentre all’immagine di un’orante fu riferita la didascalia «S. Marcelli Papae discipula et sectatrix»! Più tardi Bosio identificò la fondatrice del cimitero con la cosidetta “velata” rappresentata nel famoso arcosolio della stessa catacomba, mentre riconobbe nella presunta scena del suo matrimonio «la consacratione di una Vergine, cioè quando se le dava il sacro Velo; e potrebbe essere, che fosse d’una delle dette due Vergini Prassede, e Pudentiana». Cfr. Bosio, Roma sotterranea, p. 549.
16. Cfr. BAV, Vat. lat. 5409, c. 9r; Deckers, Mietke, Weiland, Cfr. BAV, Vat. lat. 5409, c. 9r; Deckers, Mietke, Weiland, Die Kata�ombe, Tav. 6a. Una correzione simile si riscontra nella didascalia che in BAV, Vat. lat. 5409, c. 17r, correda il disegno di un un bassorilievo proveniente dal cimitero di via Anapo.
17. Cfr. O. Panvinio, De ritu sepeliendi mortuos apud veteres Christianos, et eorun�dem coemeteriis liber, Coloniae, Apud Maternum Cholinum,1568, pp. 18-22. Su Panvinio e la sua vasta produzione storico-erudita, ancora insufficentemente studiata, cfr. D.A. Perini, Onofrio Panvinio e le sue opere, Roma 1899; J.-L. Ferrary, Onofrio Panvinio et les antiqui�tés romaines, Roma 1996. Per il suo contributo allo studio dell’archeologia cristiana, oltre la bibliografia citata supra, nota 1, cfr. Herklotz, Historia sacra, pp. 25-39; Idem, Christli�che und �lassische Archäologie, pp. 295, 299-302, 307.
Chi era Priscilla? Baronio e le ricerche sulla Roma sotterranea 433
quasi esclusivamente sulle fonti letterarie, rimase un testo base per le ricer-che topografiche della prima archeologia cristiana, anche perché l’erudito agostiniano non si limitava, come era avvenuto nei cataloghi di tradizione medievale,18 a fornire un semplice elenco, ma avanzava anche proposte di datazione per i singoli complessi cimiteriali. Nell’Ostrianum, in modo spe-cifico, riconobbe il più antico fra tutti i coemeteria romani. Sembra chiaro che la sua fonte fossero i Gesta Liberii papae, in realtà uno scritto degli inizi del VI secolo, che parla del luogo «ubi Petrus baptizavit».19 La ricerca moderna, che ha continuato ad incontrare difficoltà nell’identificazione di questo cimitero, proponendo di riconoscere l’Ostrianum in aree sia della catacomba di Priscilla vera e propria, sia del coemeterium Maius sulla via Nomentana, concorda però sul fatto che in nessun caso l’Ostrianum può riconoscersi nella catacomba di via Anapo.
A dispetto di ciò, la proposta di Chacon che quello scoperto nel 1578 fosse il coemeterium Ostrianum, ebbe nei decenni successivi un autorevole sostenitore nel maltese Antonio Bosio, che addirittura ribadì, quasi con-ferendole valore ufficiale, tale proposta di identificazione nella sua Roma sotterranea, pubblicata nel 1635 e dedicata ad Urbano VIII.20 È importante dire che Bosio, che in generale costruì la sua opera attraverso il controllo
18. Su queste fonti cfr. supra, nota 10.19. Cfr. Patrologia Latina, VIII, Paris 1844, coll. 1388-1393, in part. col. 1391. Altre
fonti nelle quali ricorre la stessa denominazione topografica sono citate in de Rossi, La Roma sotterranea cristiana, I, pp. 189-194. Per il dibattito intorno al coemeterium Ostria�num, molto acceso nei primi anni del XX secolo, cfr. la bibliografia indicata in L. Spera, E. Smiraglia, Il cosidetto battistero della catacomba di Priscilla a Roma: sistemazione monumentale e segni cultuali, in L’edificio battesimale in Italia. Aspetti e problemi, Atti dell’VIII Congresso nazionale di Archeologia Cristiana, Genova-Sarzana-Albenga-Finale Ligure-Ventimiglia, 21-26 settembre 1998, Bordighera 2001, pp. 975-1002, in part. 985.
20. Bosio, Roma sotterranea, pp. 483, 513. Ibidem, pp. 515-529, sono riprodotti i disegni di Chacon e van Winghe. Bosio sosteneva, in realtà, che il cimitero Ostriano, nato come indipendente, fosse stato successivamente unito a quello di Priscilla. Più in gene-rale su Antonio Bosio, oltre ai numerosi accenni che gli sono dedicati nella bibliografia citata supra, nota 1, cfr. Valeri, Cenni biografici, mentre per una valutazione dell’impatto che ebbe il suo contributo scientifico cfr. S. Ditchfield, Text before Trowel: Antonio Bo�sio’s Roma sotterranea Revisited, in The Church Retrospective, a cura di R.N. Swanson, in «Studies in Church History», 33 (1997), pp. 343-360; Idem, Reading Rome as a Sacred Landscape, c. 1586�1635, in Sacred Space in Early Modern Europe, a cura di W. Coster, A. Spicer, Cambridge 2005, pp. 167-192, in part. 178-189, dove però il contributo archeologi-co del maltese è sottovalutato. Cfr., inoltre, V. Fiocchi Nicolai, Presentazione, in A. Bosio, Roma sotterranea, ristampa anastatica, Roma 1998, pp. 11*-13*.
Ingo Herklotz434
diretto sui monumenti, nei riguardi del cimitero scoperto nel 1578 e della sua identificazione con l’Ostrianum, fidò invece unicamente sull’autorità del Chacon, in quanto non poteva avere una visione diretta del monumen-to, visto che il suo ingresso, ostruito da una frana già pochi anni dopo la sua clamorosa scoperta, fu nuovamente identificato soltanto nel 1921.21
Altri studiosi, alla fine del XVI secolo, non abbandonavano, dal canto loro, l’identificazione del cimitero di via Anapo come quello di Priscilla, tanto che alcuni riconobbero addirittura il ritratto della stessa Priscilla in una delle pitture della catacomba.22 Anche loro avvertivano, tuttavia, la necessità di verificare l’identità della presunta fondatrice del complesso ipogeo. Già un decennio prima della scoperta del 1578 Panvinio, nella sua lista dei cimiteri romani, aveva inserito un coemeterium Priscillae e, se-guendo le notizie delle biografie del Liber pontificalis attribuite a Damaso, aveva affermato che Priscilla era stata una matrona romana esortata da papa Marcello (308-309) a fondare il cimitero che poi ne avrebbe preso il nome.23 La datazione del coemeterium Priscillae al principio del IV secolo formulata da Panvinio fu ribadita, nel 1578, da Pietro Galesini nel suo Martyrologium Sanctae Romanae Ecclesiae.24
21. Sulla riscoperta del 1921 cfr. E. Josi, Relazione del ritrovamento della regione scoperta il 31 maggio 1578 sulla via Salaria nuova, in «Nuovo Bullettino di Archeolo-gia Cristiana», 28 (1922), pp. 120-128; Idem, Note di topografia cimiteriale romana. I. Il “coemeterium Iordanorum” sulla via Salaria nova, in «Studi Romani», 3 (1922), pp. 49-70. L’identificazione, avanzata da Enrico Josi, del complesso di via Anapo quale cimi-tero dei Giordani si rivelò errata soltanto nel 1966, quando si scoprì il vero coemeterium Iordanorum, cfr. U.M. Fasola, Le recenti scoperte nelle catacombe sotto Villa Savoia. Il “Coemeterium Iordanorum ad S. Alexandrum”, in Actas del VIII Congresso Internacional de Arqueologia Cristiana, Barcelona 5-11 ottobre 1969, Città del Vaticano-Barcelona 1972, pp. 273-297. Da allora la catacomba scoperta per la prima volta nel 1578 è stata denominata come “anonima di via Anapo.” Cfr. anche Fiocchi Nicolai, Storia e topografia, p. 7; Ghilar-di, Arsenali della fede, pp. 154-155.
22. Cfr. la relazione anonima sulla scoperta del 1578 pubblicata in H.V. Sauerland, De coemeterio D. Priscillae Romae invento in Canicularibus 1578, in «Römische Quar-talschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte», 2 (1888), pp. 209-217, in part. 211. Lo stesso documento è ripreso in Ferretto, Note storico-bibliografiche, p. 108.
23. Cfr. Panvinio, De ritu sepeliendi, p. 20. Il riferimento a Priscilla ricorre, invero, solo in alcuni manoscritti del Liber pontificalis, cfr. Le Liber pontificalis. Texte, introduc-tion et commentaire a cura di L. Duchesne, Paris 1955-1957, I, pp. 164-165, con la n. 4.
24. P. Galesini, Martyrologium Sanctae Romanae Ecclesiae usui in singulos anni dies accomodatum, Mediolani, Apud Pacificum Pontium, 1578, p. 18.
Chi era Priscilla? Baronio e le ricerche sulla Roma sotterranea 435
Fig. 1. G.B. de’ Cavalieri: Martirio di s. Ignazio d’Antiochia (dall’affresco di S. Stefano Rotondo, Roma).
Ingo Herklotz436
Chacon, dal canto suo, nel trattato del 1578 oggi conservato a Los Ange-les, nell’abbassare tale datazione di quasi due secoli, motivò la sua posizione attraverso due argomenti principali. Poiché in quella fase egli riteneva che il cimitero di Priscilla coincidesse con quello oggi denominato “anonimo di via Anapo”, un primo argomento a favore della sua datazione in età traianea derivava dall’osservazione diretta del complesso ipogeo che fu allora risco-perto. L’enfasi che negli affreschi di questa catacomba era data alla raffigura-zione del martirio di sant’Ignazio di Antiochia esposto alle belve fu spiegato da Chacon in quanto tale episodio, avvenuto nell’undicesimo anno del regno di Traiano, sarebbe stato, nel momento in cui era stata avviata la decorazione della catacomba, un fatto di grande attualità. È superfluo sottolineare che le pitture alle quali si riferiva Chacon non mostravano il martirio che il ve-scovo d’Antiochia aveva patito a Roma, all’interno del Colosseo, dove era stato esposto alle belve – scena che, invece, beneficiava di una certa fortuna nell’iconografia romana del tardo XVI secolo (Fig. 1) –, ma l’episodio ve-terotestamentario di Daniele nella fossa dei leoni (Fig. 2).25 L’errata lettura dello stesso soggetto iconografico fu, del resto, iterata nel XVII secolo, an-che se le pretese raffigurazioni di Ignazio di Antiochia non furono più usate per datare gli ambienti sotterranei che le restituivano.26
25. Ignazio di Antiochia appare nel famoso ciclo di scene di martirio eseguito, fra il 1581 ed il 1584, da Cristoforo Roncalli e dai suoi aiuti nella chiesa romana di S. Stefano Rotondo e successivamente reso popolare dalle incisioni Giovanni Battista de’ Cavalieri, cfr. L.H. Monssen, The Martyrdom Cycle in Santo Stefano Rotondo. Part One, in «Acta ad Archaeologiam et Artium Historiam Pertinentia series altera in 8°», 2 (1982 [1983]), pp. 175-317, in part. 208-213; G.B. Cavalieri, Triumphus martyrum in templo D. Stephani Caeli montis expressus, Romae, Apud Alexandrum Gardanum et Franciscum Coattinum, 1589 (la prima edizione è del 1583), in part. Tav. 12 per il martirio di sant’Ignazio (cfr. nostra Fig. 1). Il vescovo martire è raffigurato anche nel ciclo di affreschi della chiesa romana di S. Vitale attribuito a Tarquinio Ligustri ed eseguito sul finire del XVI secolo, cfr. A. Zuccari, Arte e committenza nella Roma del Caravaggio, Roma 1984, pp. 159-170. Più in generale su Igna-zio d’Antiochia e la sua iconografia cfr. G. Bosio, C. Colafranceschi, Ignazio di Antiochia, in Bibliotheca Sanctorum, VII, Roma 1966, pp. 653-665, e la voce dedicata a questo stesso martire in Lexi�on der christlichen I�onographie, a cura di E. Kirschbaum, W. Braunfels, 8 voll., Rom-Freiburg-Basel-Wien 1968-1974, VI, pp. 575-578. Per l’iconografia di Daniele, comunissima nelle catacombe ed in altri monumenti dell’arte paleocristiana, cfr., invece, la recente monografia R. Sörries, Daniel in der Löwengrube. Zur Gesetzmäßig�eit frühchrist�licher I�onographie, Wiesbaden 2005.
26. Al momento della scoperta del 1578, oltre che da Chacon, gli affreschi in questio-ne furono interpretati come una rappresentazione del martirio di Ignazio di Antiochia anche nella relazione anonima del rinvenimento pubblicata in Sauerland, De coemeterio D. Priscil�
Chi era Priscilla? Baronio e le ricerche sulla Roma sotterranea 437
Fig. 2. Roma, Catacomba anonima di via Anapo: Daniele nella fossa dei Leoni (Foto: Pon-tificia Commissione di Archeologia Sacra)
Ingo Herklotz438
Il secondo argomento addotto da Chacon per datare il cimitero di Pri-scilla al principio del II secolo poggiava sul fatto che fra i primi personaggi che vi erano stati sepolti figurava il senatore Pudente, padre delle sante vergini Pudenziana e Prassede e discepolo dell’apostolo Paolo, dopo che questi, nel 44, era giunto a Roma.27 Poiché le sue figlie morirono al tempo dell’imperatore Antonino Pio (138-161) Chacon collocava la morte di Pu-dente durante il regno di Traiano o, al più tardi, nei primi anni di quello di Adriano. È da notare che l’autore non fornì alcun particolare sull’identità di Priscilla, tranne specificare che la fondatrice del cimitero da poco risco-perto era stata una «virgo Sanctissima et Christi ancilla», volendo forse alludere con ciò al fatto che non si era mai sposata.
Gli elementi principali del racconto chaconiano derivavano dagli Atti di Pudenziana e Prassede, scritto apocrifo del VI secolo che, ricco di elementi leggendari, esalta il senatore Pudente come «amicus apostolorum [...] doctus a beato Paulo».28 Pudente avrebbe trasformato la sua casa sul Viminale in una chiesa, il titulus Pastoris, e sarebbe stato sepolto nel coemeterium Pri�scillae, dove più tardi avrebbero riposato anche le sue figlie e numerosi mar-tiri. Nel porre la morte di Pudente al principio del II secolo Chacon, tuttavia, si allontanava silenziosamente dagli Atti, i quali, malgrado presentassero il senatore romano come un personaggio già adulto alla metà del I secolo, tanto da essere discepolo di san Paolo, lo indicavano come ancora in vita circa un
lae, p. 211. La stessa interpretazione fu riproposta, nel 1612, in uno scritto del gesuita An-gelin Gazet pubblicato in M. van Cutsem, Une lettre inédite du P. Gazet sur la catacombe de Saint�Hermes, in «Analecta bollandiana», 52 (1934), pp. 334-342, in part. 342. Baronio, invece, in anni vicini alla scoperta aveva già correttamente proposto di riconoscere in questi affreschi una raffigurazione di Daniele, cfr. Martyrologium Romanum ad novam �alendarii rationem, et Ecclesiasticae historia veritatem restitutum, Gregorii XIII. Pont. Max. iussu editum. Accesserunt Notationes atque Tractatio de Martyrologio auctore Caesare Baronio Sorano. Romae, Ex Typographia Dominici Basae, 1586, p. 323 (22 luglio).
27. Su questa leggenda, raccontata da Pastore, un presunto fratello di papa Pio I (140/42-154/55), cfr. B. Vanmaele, Potenziana e Prassede, in Bibliotheca Sanctorum, X, Roma 1968, pp. 1062-1072; A. Amore, Priscilla, ibidem, pp. 1113-1114; Lexi�on der christlichen I�ono�graphie, VIII, p. 224.
28. È probabile che per Chacon l’edizione di riferimento per gli Atti di Pudenziana e Prassede fosse quella edita da Bonino Mombrizio nel 1479, cfr. B. Mombrizio, Sanctua�rium seu vitae Sanctorum. Novam hanc editionem curaverunt duo monachi Solesmenses, II, Paris 1910, pp. 353-354, 390-391. Su Mombrizio e la sua opera cfr. S. Spanò Martinelli, Bonino Mombrizio e gli albori della scienza agiografica, in Erudizione e devozione. Le Raccolte di Vite di Santi in età moderna e contemporanea, a cura di G. Luongo, Roma 2000, pp. 3-18.
Chi era Priscilla? Baronio e le ricerche sulla Roma sotterranea 439
secolo dopo, più precisamente durante il pontificato di Pio I. Chacon, inoltre, ometteva un’importante notizia presente negli Atti, quella secondo la quale la madre di Pudente si sarebbe chiamata Priscilla.29 Gli stessi Atti su questo personaggio non facevano, tuttavia, alcun riferimento ad attività caritatevoli e possibili iniziative (come potrebbe essere la fondazione di un cimitero) in favore dei martiri e, anzi, suggeriscono che Pudente abbia iniziato un’esem-plare esistenza cristiana soltanto dopo la morte dei genitori.
Sulle problematiche relative all’identità di Pudente e, soprattutto, quella di Priscilla intervenne Cesare Baronio nelle Notationes al Mart�yrologium Romanum che, edite per la prima volta nel 1586, furono suc-cessivamente più volte ristampate ad aggiornate dallo stesso Baronio.30 In una nota del 16 gennaio, data sotto la quale il Martyrologium Romanum celebrava santa Priscilla, Baronio spiegava che, nella storia cristiana dei primi secoli, si ricordavano almeno tre donne con questo nome: la prima, chiamata anche Prisca, moglie di un certo Aquila ricordata negli Atti degli Apostoli (18, 2) e nelle lettere di san Paolo (Rom. 16, 3; Cor. I, 16, 19; Tim. 4, 19); la seconda madre di Pudente e nonna di Pudenziana e Prassede, menzionata nei loro Atti; la terza, vissuta al principio del IV secolo e con-temporanea di papa Marcello.31 Secondo Baronio la fondazione del famoso cimitero non poteva, tuttavia, essere attribuita alla matrona dell’inizio del IV secolo ricordata nella vita di papa Marcello, in quanto il brano che ne ricordava l’iniziativa era attestato solo in parte dei manoscritti con le vite dei pontefici scritte da “Damaso”. La Priscilla fondatrice si doveva, piut-tosto, riconoscere in quella ricordata negli Atti di Pudenziana e Prassede,
29. Cfr. Mombrizio, Sanctuarium, II, p. 390.30. Sul Martyrologium Romanum ed il ruolo che Baronio ebbe nella sua redazione
e nella sua articolata vicenda editoriale, cfr. G.A. Guazzelli, Cesare Baronio e il Martyro�logium Romanum: problemi interpretativi e linee evolutive di un rapporto diacronico, in Nunc alia tempora, pp. 47-89.
31. Martyrologium Romanum, 1586, p. 32: «Plures fuerunt huius nominis sanctae mulieres, quarum illa antiquior, cuius mentio habetur in actis Apost. cap. 18. et Paul. ad Conrint. I. cap. 16. de qua alia agitur die. Rursus autem alia reperitur Priscilla, de qua men-I. cap. 16. de qua alia agitur die. Rursus autem alia reperitur Priscilla, de qua men-tio fit in Actis sanctarum Pudentianae, et Praxedis, cuius coemeterij etiam Pastor meminit in Actis sanctae Praxedis. Alia item Priscilla reperitur in lib. de Rom. Pont. in S. Marcello Papa; licet complures codices non habeant ea quae de coemeterio nomine sanctae Priscillae via Salaria illic ponuntur; quod quidem Priscillae seniori Pastor tribuit in dictis Actis S. Pra-xedis. Hic itaque agitur de seniori Priscilla, cuius Pastor meminit, quae et fuit Apostolorum discipula, mater verò Pudentis senatoris, ut Acta Pudentianae, quae habemus man. scrip. quae et paulo diversa recitat Mombrit. tom. 2. testantur».
Ingo Herklotz440
che del resto, come lo stesso Baronio specificava in una sua integrazione alla nota originaria pubblicata nel 1598 in una nuova edizione del Martyro�logium Romanum, aveva fondato un altro coemeterium nella sua casa, cioè in quello che poi sarebbe stato denominato titulus Pastoris.32
Basandosi sugli «Acta Pudentianae quae habemus manuscripta» – dei quali purtroppo non specificava dove li avesse consultati – Baronio giun-geva addirittura ad affermare che Priscilla era stata discepola degli apo-stoli, attribuendo a lei una connotazione biografica che, sino ad allora, la tradizione aveva riservato a suo figlio Pudente. Il ragionamento baroniano innescava nel panorama erudito del tardo XVI secolo gravissime conse-guenze, in quanto la catacomba di Priscilla non era più presentata quale fondazione del IV secolo, né del II, ma era datata ad età apostolica e, anzi, era vista come diretta espressione della cerchia aristocratica che era entrata in contatto con gli apostoli durante la loro permanenza a Roma. La mani-polazione baroniana delle biografie di Pudente e Priscilla, in modo del tutto simile alla nuova denominazione di coemeterium Ostrianum, ricollegava la catacomba direttamente al soggiorno romano di san Pietro. Lascia inve-
32. Martyrologium Romanum ad novam Kalendarii rationem et Ecclesiasticae histo�riae veritatem restitutum, Gregorii XIII Pont. Max. iussu editum. Accesserunt Notationes atque Tractatio de Martyrologio Romano, auctore Caesare Baronio Sorano Congregationis Oratorii Presbytero. Tertia editio ab ipso auctore nunc Tit. SS. Martyrum Nerei et Achillei S.R.E. Card. Bibliothecario Apostolico emendata et compluribus aucta, Romae, Ex Typo-graphia Vaticana, 1598, p. 36: «Ceterum in ipso titulo Pastoris, ubi erant thermae Novati, quae et Thimotinae dictae, ipsae balnei inferiores cellae instar porticum sibi concamera-tione coniunctae, quae usque in hanc diem cernuntur pene integrae, coemeterij loco ad sepeliendos occulte martyres inservisse creduntur». Baronio non fu, in realtà, il primo ad indicare un antico cimitero cristiano nelle strutture sottostanti il titulus Pastoris. Sulle spe-culazioni che nel XVI secolo riguardarono la chiesa di S. Pudenziana e gli edifici antichi sui quali essa inisteva cfr., di recente, C. Occhipinti, Pirro Ligorio e la storia cristiana di Roma da Costantino all’Umanesimo, Pisa 2007, pp. 97-102. L’attenzione verso questa chiesa e la sua storia ebbe un nuovo impulso a seguito dei restauri promossi, fra il 1586 ed il 1588, dal cardinale titolare Enrico Caetani, i quali furono ricordati anche in Baronio, Annales Ecclesiastici, II, p. 129 (anno 162). Più in generale sui restauri del Caetani cfr. A. Cozzi Beccarini, La Cappella Caetani nella Basilica di Santa Pudenziana in Roma, in «Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura», 22, 127-132 (1975), pp. 143-158; E. Parlato, La committenza del cardinale Enrico Caetani a Santa Pudenziana, in Arte e comittenza nel Lazio nell’età di Cesare Baronio, pp. 143-164. Secondo le ricerche più recenti le strutture sottostanti S. Pudenziana appartenevano a un ninfeo e furono accomodate al culto cristiano soltanto verso la fine del IV secolo, cfr. H. Brandenburg, Die frühchristlichen Kirchen Roms vom 4. bis zum 7. Jahrhundert. Der Beginn abendländischer Kirchenbau�unst, Regensburg 2004, p. 138, con ulteriore bibliografia.
Chi era Priscilla? Baronio e le ricerche sulla Roma sotterranea 441
ce perplessi il fatto che Baronio non affronti le incongruenze cronologiche che caratterizzano gli Atti di Pudenziana e Prassede e non avanzi nessun dubbio sull’attendibilità di questa fonte apocrifa.
Negli Annales Ecclesiastici, pur senza affrontare in modo diretto il problema della fondazione del cimitero di Priscilla, lo storico oratoriano fornì alcuni ulteriori elementi per definirne l’identità storica. Nel primo tomo Baronio affermò che Pudente aveva accolto in casa sua san Pietro (e non san Paolo come affermato negli Atti di Pudenziana e Prassede!) e, contestualmente, identificava questo personaggio con il Pudente citato nel-la seconda lettera di san Paolo a Timoteo (4, 21), rendendolo di conseguen-za un personaggio la cui storicità era garantita dall’autorità delle Scrittu-re.33 In due distinti passi del secondo tomo, inoltre, Priscilla, anziché madre di Pudente (come invece era affermato negli Atti) fu presentata come sua moglie: resta da capire se si sia trattato di un semplice lapsus o, piuttosto, della voluta manipolazione delle fonti al fine di avvicinare maggiormente la matrona Priscilla all’ambiente apostolico di Roma.34
In ogni caso le posizioni di Baronio ebbero notevole successo. Che la “seconda Priscilla”, vissuta al tempo di Nerone, avesse fondato un cimite-ro sulla via Salaria, fu ripetuto, pur restando dibattuto il problema del sito dove ubicare tale fondazione, nei decenni successivi da molti autori, fra i quali Antonio Gallonio, Pompeo Ugonio, Filippo Ferrari, Antonio Bosio e Jean Bolland.35
Le problematiche cronologiche che emergevano dagli Atti di Pudenzia�na e Prassede e che, almeno in parte, furono ignorate da Baronio, ebbero in particolare un primo tentativo di soluzione nel 1591 nella Historia delle san�te vergini romane di Antonio Gallonio.36 Comprendendo che l’eccessiva du-
33. Cfr. Baronio, Annales Ecclesiastici, I, p. 564 (anno 59). Oltre che in questo passo Pudente è ricordato quale senatore cristiano e «Petri discipulus» anche ibidem, pp. 320 (anno 44), 456 (anno 57).
34. Cfr. Idem, Annales Ecclesiastici, II, pp. 127-128 (anno 159), 145 (anno 166).35. Cfr. A. Gallonio, Historia delle sante vergini romane, Roma, Presso Ascanio e Gi-
rolamo Donangeli, 1591, p. 75; F. Ferrari, Catalogus sanctorum Italiae in menses duodecim distributus, Mediolani, Apud Hieronymum Bordonium, 1613, p. 31; Bosio, Roma sotterra�nea, pp. 479, 583; Acta Sanctorum quotquot toto orbe colluntur, vel a catholicis scriptori�bus celebrantur, cum notis illustravit I. Bollandus Societatis Iesu Theologus. Ianuarii tomus II, Antverpiae, Apud Ioannem Meursium, 1643, p. 2. Per Pompeo Ugonio cfr., invece, il suo manoscritto conservato a Ferrara, Biblioteca Ariostea, ms. I. 161, p. 1076.
36. Gallonio, Historia delle sante vergini, pp. 78-80. Il problema cronologico era, in realtà, già stato evidenziato alcuni anni prima da P. Ugonio, Historia delle stationi di Roma
Ingo Herklotz442
rata della vita del senatore Pudente (ben più di cento anni!) poteva mettere in discussione la credibilità degli Atti, Gallonio abbandonò la proposta del suo confratello Baronio secondo la quale il Pudente menzionato in questo testo coincideva con il personaggio omonimo della seconda lettera di san Paolo a Timoteo. Secondo Gallonio, inoltre, dire che san Pietro era stato accolto «nella casa di Pudente» non equivaleva ad affermare che quest’ultimo fosse già nato al momento dell’arrivo a Roma dell’apostolo; era, invece, più pro-babile che fosse stata sua madre Priscilla «gran christiana, e discepola degli Apostoli» ad accogliere san Pietro in quella che solo la tradizione successiva avrebbe denominato come la «casa di Pudente».37 È evidente che Gallonio, pur distaccandosi dalla lettura baroniana, ne estremizzava la tendenza ad as-segnare alla madre Priscilla, quella vissuta alla metà del primo secolo, il ruolo di discepola ed ospite degli apostoli che negli Atti di Pudenziana e Prassede era invece attribuito al figlio Pudente.38
che si celebrano la Quadragesima, Roma, Appresso Bartholomeo Bonfadino, 1588, cc. 161v-162r.
37. Gallonio, Historia delle sante vergini, p. 79. Si veda anche la sua versione mano-scritta degli Atti in Roma, Biblioteca Vallicelliana, ms. H. 21, cc. 357r-358r.
38. Varrebbe la pena dedicare uno studio specifico alla presenza che i componenti del-la famiglia di Pudente – in particolare Pudenziana e Prassede – avevano nell’iconografia dei secoli XVI e XVII. Uno studio del genere, che di certo non si limiterebbe ai cicli pittorici realizzati nelle chiese dedicate alle due sante, riguarderebbe artisti quali Antiveduto della Grammatica, Nicolas Poussin e Johannes Vermeer. Per una bibliografia iniziale sull’argo-mento, in aggiunta ai contributi citati supra, nota 27, cfr. A. K. Wheelock Jr., St. Praxedis: New Light on the Early Career of Vermeer, in «Artibus et historiae», 14 (1986), pp. 71-89; C. Dempsey, Poussin’s ‘Sacrament of Confirmation’, the Scholarship of ‘Roma Sotterra�nea’, and Dal Pozzo’s Museum Chartaceum, in Cassiano Dal Pozzo, Atti del Seminario in-ternazionale di studi, a cura di F. Solinas, Roma 1989, pp. 247-261; H. P. Riedl, Antiveduto della Grammatica (1570/71�1626). Leben und Wer�, München-Berlin 1998, pp. 100-101, 131-133, 164-167, 183; L. Della Volpe, Antonio Tanari e alcune vicende poco note sulla chiesa di S. Pudenziana a Roma, in «Storia dell’arte», n. 111 (2005), pp. 139-150. Merita, poi, di essere rilevato che, a seguito della scoperta del 1578, si riconobbero le immagini di Pudenziana e Prassede in alcune pitture della catacomba di via Anapo, cfr. Sauerland, De coemeterio D. Priscillae, p. 211; Ferretto, Note storico-bibliografiche, p. 108. Nella chiesa di S. Pudenziana si conservavano non solo le testimonianze della pia attività della famiglia di Pudente, tra cui il famoso “pozzo di sangue”, ma anche reliquie degli apostoli. G. Severa-no, Memorie sacre delle sette chiese di Roma e di altri luoghi, che si trovano per le strade di esse, Roma, Per Giacomo Mascardi, 1630, I, p. 682, attestava, in particolare, la presenza di un’icona in mosaico raffigurante il Salvatore che san Pietro avrebbe regalato a Pudente. Ul-teriori fonti per questa stessa icona sono citate in F. M. Torrigio, I sacri trofei del trionfante Prencipe degli Apostoli San Pietro gloriosissimo, Roma, Per Francesco Moneta, 1644, pp.
Chi era Priscilla? Baronio e le ricerche sulla Roma sotterranea 443
È interessante notare che anche alla Priscilla contemporanea di papa Marcello fu attribuito un ruolo nella storia dell’omonimo complesso ci-miteriale: secondo le riflessioni formulate dal servita Filippo Ferrari nel suo Catalogus sanctorum Italiae del 1613 era probabile che una Priscilla, vissuta agli inizi del IV secolo, colpita dalla coincidenza del suo nome con quello dell’originaria fondatrice, avesse restaurato il cimitero sulla via Sa-laria.39 L’ipotesi sintetizzava le posizioni di due massime autorità dell’eru-dizione ecclesiastica quali Panvinio e Baronio e, forse proprio per questo motivo, fu accolta anche da Bosio nella Roma sotterranea.40
In ambito romano al principio del XVII secolo si colloca pure l’inge-gnoso quadro genealogico che Agostino Manni – un altro erudito oratoriano, sebbene meno famoso di altri suoi confratelli – elaborò sulla famiglia del senatore Pudente a partire dalle posizioni già espresse dal Baronio. Secondo Manni, che fu poi seguito almeno sino al XVIII secolo, con il nome Pudente si indicavano due distinti personaggi, probabilmente padre e figlio, il pri-mo dei quali sarebbe stato Punico Pudente, discepolo di san Pietro e marito di Priscilla, mentre il più giovane sarebbe stato battezzato da san Paolo ed avrebbe sposato una certa Sabina o Sabinella, dalla quale avrebbe avuto le figlie Pudenziana e Prassede.41 Interpretando il nome Pudens come un no�
145-147. Michelangelo Lualdi parlava invece di un «altare portabile di legno [...] dove gia vi celebrava sopra S. Pietro», cfr. M. Delbeke, An un�nown description of Baroque Rome. Michelangelo Lualdi’s Galleria sacra architettata dalla Pietà Romana dall’anno 1610 sino al 1645, in «Bulletin de l’Institut Historique Belge de Rome», 74 (2004), pp. 61-271, in part. 172. Le indagini eseguite nel 1729 sotto l’altare maggiore della basilica di S. Prassede portarono alla luce, oltre i corpi di Pudenziana e Prassede, «un gran pezzo di Spongia, tinta ancora del Sangue, a cui stava attacato per anche un pezzetto d’Osso», che sarbebbe stata la spugna usata da S. Prassede per raccogliere il sangue dei martiri, cfr. C.G. Coda, Due�milatrecento corpi di martiri. La relazione di Benigno Aloisi (1729) e il ritrovamento delle reliquie nella basilica di Santa Prassede in Roma, Roma 2004, pp. 65, 121, e fig. 15.
39. Cfr. Ferrari, Catalogus sanctorum Italiae, p. 32. Per gli studi del Ferrari cfr. S. Spanò Martinelli, Il Catalogus di Filippo Ferrari, in Europa sacra. Raccolte agiografiche e identità politiche in Europa fra Medioevo ed Età moderna, a cura di S. Boesch Gajano, R. Michetti, Roma 2002, pp. 135-145.
40. Cfr. Bosio, Roma sotterranea, p. 479; Ambrogio Landucci in BAV, Barb. lat. 4603, c. 245r. Il passo del Landucci non fa parte dell’edizione parziale del suo scritto in de Rossi, Sulla questione del vaso di sangue, pp. 99-120.
41. Cfr. A. Manni, Selectae historiae rerum memorabilium in ecclesia Dei gestarum, Romae, Apud Bartholomaeum Zannettum, 1612, pp. 745-746; le sue posizioni furono successivamente seguite in T. Caccini, Volume primo della storia ecclesiastica ... in cui descrivonsi con autentici riscontri i principii, e gl’aggrandimenti del Cristianesimo, dal
Ingo Herklotz444
men gentile Manni distendeva la storia cristiana di questa famiglia nell’arco di non meno di tre generazioni che, da quella del primo Pudente, discepolo di Pietro alla metà del I secolo, giungeva a quella delle vergini Pudenziana e Prassede alla metà del secolo successivo. Il legame di questa famiglia con gli apostoli e l’ambiente romano di età apostolica era, in piena coerenza con quanto già affermato da Baronio, comunque garantito.
Solo nel 1685 il bollandista Daniel Papebroch, pubblicando negli Acta Sanctorum una nuova edizione degli Atti di Pudenziana e Prassede, compì un notevole passo in avanti nel liberare questo testo dalle esigenze apolo-getiche che ne avevano legato alcuni personaggi agli apostoli.42 Papebroch evidenziò le discordanze che intercorrevano fra i diversi testimoni mano-scritti del testo agiografico e, soprattutto, provvide a sanare le aporie cro-nologiche che esso presentava, sostituendo i riferimenti a san Paolo, con riferimenti a Pio (papa dal 140 al 155 circa). Così facendo riportò l’intero racconto su Pudente, Pudenziana e Prassede agli anni compresi fra l’inizio e la metà del II secolo. Se, del resto, si fosse voluto mantenere nel testo il nome Paulus, sosteneva ingegnosamente Papebroch, esso non poteva indi-care l’apostolo, ma un presbyter vissuto in un periodo più recente.
Neppure la lettura del bollandista Papebroch, che recideva ogni lega-me dei protagonisti degli Atti di Pudenziana e Prassede con gli apostoli Pietro e Paolo, riuscì ad affrancare l’archeologia cristiana dal suo carico apologetico, dato che tra XIX e XX secolo persino i rappresentati più sti-mati di questa disciplina – mi riferisco a Giovanni Battista de Rossi ed Orazio Marucchi – continuarono a cercare nella catacomba di Priscilla le tracce degli apostoli.43
nascimento di Iesu Cristo fino alla morte di S. Vettorio XV. Papa, seguita l’Anno CCIII, Fiorenza, Nella Stamperia di Gio. Batista Landini, 1639, pp. 246-247; F. Martinelli, Primo trofeo della S.ma Croce eretto in Roma nella Via Lata da S. Pietro Apostolo, Roma, Per Nicolangelo Tinasi, 1655, pp. 41-55; B. Davanzati, Notizie al pellegrino della basilica di Santa Prassede, Roma, Nella Stamperia di Antonio de’ Rossi, nella Strada del Seminario Romano, 1725, pp. 9, 38-48, e passim.
42. Cfr. Acta Sanctorum Maii, collecta digesta illustrata a Godefrido Henschenio et Danie-le Papebrochio e Societate Iesu, IV, Antwerpiae, Apud Michaelem Cnobarum, 1685, pp. 299-301. Per Papebroch ed il contributo dei Bollandisti alla ricerca storico-agiografica cfr. R. God-ding, B. Joassart, X. Lequeux, F. De Vriendt, J. van der Straeten, Bollandistes, saints et légendes. Quatre siècles de recherche, Bruxelles 2007, con ampi rimandi alla bibliografia precedente.
43. Per le ricerche che, a cavallo dei secoli XIX e XX, interessarono il sito «ubi Petrus baptizavit» cfr. Spera, Smiraglia, Il cosidetto battistero, pp. 975, 985 con ampia bibliografia in part. alle note 2 e 20; cfr. anche Ghilardi, Arsenali della fede, pp. 133-134.