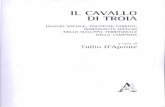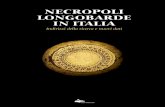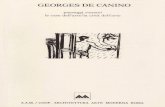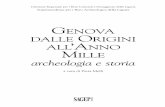Re_urban | De_frag. Progetti per trasformare la circonvallazione di Palermo.
Campania Felix. Ricerche Progetti Nuovi Paesaggi (parziale)
Transcript of Campania Felix. Ricerche Progetti Nuovi Paesaggi (parziale)
Campania felix propone una riflessione su Napoli e la sua città me-tropolitana: lo fa mediante l’illustrazione di ricerche e progetti, svol-
ti a differenti scale di intervento, in tempi differenti e con differenti com-mittenti e interlocutori, ma comunque radicati nel rapporto con la realtàe che a partire da questa rimandano l’uno all’altro; che definiscono, sep-pur per approssimazione, una visione comune. I casi declinano temi spe-cifici – dell’infrastruttura di trasporto, del recupero della città e dei ma-nufatti di antico impianto, della proposta di nuovi modelli urbani e pae-saggi – misurandosi sempre con la medesima realtà territoriale, in rap-porto al medesimo palinsesto: alla sua complessità, alla sua identità, comerestituita da tracce – non solo storia e persistenze ma anche “modernearcheologie” – che concorrono a definire la figura di questi luoghi. Unafigura che emerge fra le giaciture della campagna centuriata, le emer-genze naturali del golfo e del cono vulcanico, le fratture/ricuciture di per-corsi, bacini, infrastrutture, spazi attrezzati e dismessi che solcano, ac-compagnano, confinano, innervano i differenti fatti urbani. Diventa dram-matica nell’accostamento casuale tra le pieghe costituite dai fatti più pre-gevoli i tappeti desertici, i brownfield in estensione, le manomissioni chel’ignoranza e la bramosia lasciano come proprio segno. Questo lavorovuole essere, oltre che narrazione, dichiarazione, assertiva presa d’attodella condizione di fatto e contemporanea prefigurazione di cambiamento.Un’ipotesi che cerca di evitare facili retoriche: non ha pretese di com-pletezza né, persino, d’interna coerenza. Ciò nonostante, sembra descriverealcune sintomatiche aporie.
A08434
AR
AC
NEeuro 12,00
ISBN 978-88-548-5367-6
Fatigati / Formato Cam
pania felixLuisa Fatigati
Enrico Formato
CAMPANIA FELIX
Campania felix
RICERCHE, PROPOSTENUOVI PAESAGGI 2002-2012
5367 copertina_4454-4 copertina 10/12/12 20:42 Pagina 1
La figura non è dunque altro che una coscienza di figura,
ossia la sua esistenza dipende totalmente dalla
consapevolezza che il lettore prende o non prende
dell’ambiguità del discorso che gli viene proposto.
Gérard Genette, Figures, 1966
Indice
9 Introduzione
20 I. Infrastrutture versus territorio Viaggio intorno la stazione alta velocità di Napoli-Afragola
34 II. Archeologia di uno spazio pubblico aperto Atella diruta
42 III. Progettare lo shrinkage Un’ipotesi per la costa vesuviana
52 IV. Reverse city L’anticittà del Clanio
66 V. Difficili equilibri, impossibili convivenze Il waterfront a Napoli Est
84 VI. Le figure ed il piano Acerra: costruire immaginari
94 VII. Back to the landscape Ripensare la suburbia vesuviana
106 VIII. Oltre il «centrostorico»
Recuperare l’antica Visciano: natura e spazio urbano
115 Conclusioni
125 Regesto e crediti
127 Bibliografia
9
Introduzione
2002, 2012
Tracce, finalità, nuovi paesaggi
Questo lavoro propone una riflessione su Napoli e la sua città metropoli-
tana: lo fa mediante l’illustrazione di ricerche e progetti, svolti a differenti scale di intervento, in tempi differenti e con differenti committenti e interlo-
cutori, ma comunque radicati nel rapporto con la realtà e che a partire da questa rimandano l’uno all’altro; che definiscono, seppur per approssimazio-ne, una visione comune.
Una visione in cui l’urbanistica è intesa nella sua essenza di conforma-zione e paesaggio; e dove, tuttavia, il progetto è utilizzato in primis come mezzo di conoscenza: parte dalla realtà dei luoghi, con l’obiettivo di concor-rere alla formazione di nuovi scenari, usi e pratiche. Il risultato di accosta-menti e rimandi tra le ricerche presentate si offre, così, come una sorta di
matrice concettuale, presupposta a ciascuno dei casi studio e, al contempo, da ognuno di essi localmente precisata attraverso il suo farsi territorio.
I casi declinano temi specifici – dell’infrastruttura di trasporto, del recu-pero della città e dei manufatti di antico impianto, della proposta di nuovi modelli urbani e paesaggi – misurandosi sempre con la medesima realtà ter-ritoriale, in rapporto al medesimo palinsesto: alla sua complessità, alla sua identità, come restituita da tracce – non solo storia e persistenze ma anche
“moderne archeologie” – che concorrono a definire la figura di questi luo-ghi. Una figura che emerge fra le giaciture della campagna centuriata, le e-mergenze naturali del golfo e del cono vulcanico, le fratture/ricuciture di percorsi, bacini, infrastrutture, spazi attrezzati e dismessi che solcano, ac-compagnano, confinano, innervano i differenti fatti urbani. Diventa dramma-tica nell’accostamento casuale tra le pieghe costituite dai fatti più pregevoli i tappeti desertici, i brownfield in estensione, le manomissioni che l’ignoranza
e la bramosia – legali o meno, questo non cambia il risultato sul territorio – lasciano come proprio segno.
10 Introduzione
Il disegno – la figura – che tiene assieme questi elementi costituisce il termine di confronto di ciascun intervento. Prima ancora del tema specifico, della specifica occasione dalla quale studi, ricerche e progetti hanno tratto origine, è la piana campana, figura in oscillazione tra attualità e visione, la griglia entro la quale le mosse di ciascuna proposta, gli scarti tra realtà esa-minata e prefigurata, assumono senso. A questa figura tutte le scelte proget-
tuali rimandano (e al contempo attraverso di essa si compongono) nel tenta-tivo di definire nuovi scenari e tendere verso inediti e dinamici equilibri. Il lavoro che segue si può dunque leggere come un racconto: di questo tentati-vo di riappropriarsi della figura della piana, che da sfondo ambisce a diveni-re terreno delle trasformazioni, interpretare e rappresentare le ragioni dei rapporti tra gli assetti e le pratiche, i conflitti e le resistenze. Non ultime le inerzie del palinsesto ad essere ripulito dalle tracce di quanto precedente-mente impresso. Allo stesso tempo questo lavoro vuole essere, oltre che nar-
razione, dichiarazione, assertiva presa d’atto della condizione di fatto e con-temporanea prefigurazione di cambiamento.
Un’ipotesi che tuttavia cerca di evitare facili retoriche: non ha pretese di completezza né, persino, d’interna coerenza. Ciò nonostante, sembra descri-vere alcune sintomatiche aporie.
Castel Volturno, golf club
Introduzione 11
Casi di studio
La trattazione è articolata in casi, ordinati in base alla cronologia di ela-
borazione. Il capitolo primo racconta le trasformazioni prospettate a seguito della lo-
calizzazione della stazione per la ferrovia ad alta velocità al centro del “cu-neo verde” che da Napoli Est risale verso Caserta. Il "cuneo verde" è una fi-gura di riferimento importante, sia per la comprensione della metropoli campana sia per il progetto, che lo propone come uno dei nuovi centri della conurbazione. Analogamente, lo studio di fattibilità per la realizzazione di una linea ferroviaria metropolitana tangenziale, itera il ragionamento su que-
sto vuoto, appoggiato sulla depressione orografica che dall’antica foce del Sebeto risale verso le sistemazioni vanvitelliane di Caserta, con un insieme di parchi, inanellati dalla nuova infrastruttura lineare, che dalla stazione alta velocità, a Est, giunge al mare di Giugliano, a Ovest (una conurbazione con popolazione di circa un milione di abitanti, massimamente priva di servizi e attrezzature superiori). Il ridisegno di questi luoghi mira alla riconfigurazio-ne delle aree di frangia periurbane e al riequilibrio, in termini di attrezzature,
di qualità degli spazi e di qualità della vita. Anche nel capitolo secondo il racconto si raccoglie attorno alla figura di
un vuoto: stavolta il vuoto è però letto a una scala più ridotta, anche se pre-gnante al punto di farsi carico di un’intera città. Al centro di quattro agglo-merati dell’aversano, complessivamente abitati da più di cinquantamila per-sone, è l’area archeologica dell'antica città di Atella, miracolosamente scam-pata agli addendi contemporanei di case, capannoni e scarti
dell’urbanizzazione: un sedime sommerso, uno dei reperti archeologici più importanti della piana, che oggi dà forma ad una “radura” tra le maglie ru-morose e congestionate della conurbazione estesa. Colpisce questo vuoto in-nanzitutto per l'estrema chiarezza formale – le interpoderali tra campi colti-vati che coincidono con cardi e decumani, i cippi stradali con travertini mar-cati da numeri romani. Un vuoto eccellente, dai margini degradati; che e-sprime il paradosso di un’area centrale (per valore posizionale, culturale e ambientale) dal carattere periferico. Grazie a questo vuoto eccellente si può
ancora provare a ribaltare il senso d’interi settori urbani. Il tema del ribalta-mento (di senso e di funzione; nei rapporti reciproci tra insediamenti e vuoto centrale espressi soprattutto lungo i bordi del vuoto) investe allora la desti-nazione di quest’area e il suo significato; fa leva sul suo potenziale, inespres-so e che il progetto cerca di far emergere per significare i quattro centri come “città”: i quattro comuni oggi sono raccolti stancamente ed in modo caotico attorno all’area archeologica, ad essa “danno le spalle”. Un progetto territo-
12 Introduzione
riale e di paesaggio che fonda nel genius loci e assume il suolo come mate-riale e piano di lavoro per la ridefinizione del rapporto tra insediamenti e campagna, città contemporanea e archeologia.
Il capitolo terzo parte dal tema dell’infrastruttura trasportistica per riflet-tere più in generale sulla capacità della stessa di farsi attrezzatura e ridise-
gnare paesaggi. Lo fa, a partire da un contesto delicatissimo quale è quello dell’area vesuviana e da un tema emergenziale che è la sua messa in sicurez-za. La proposta nasce dalla messa in tensione tra le scale del progetto (livello generale e livello locale) e dal tentativo di legare le ipotesi sulle infrastruttu-re viabilistiche a quelle di riconfigurazione degli insediamenti moderni, nell’ambito di una prospettiva di decompressione e contrazione urbana. La ridefinizione urbanistica del sistema insediativo vesuviano, il previsto dira-
damento e la diversa funzione attribuita ad intere parti urbane (con la crea-zione di aree ambientali trasversali ai collegamenti viabilistici anulari) offre l’occasione per ripensare radicalmente il sistema dei percorsi locali, con il duplice obiettivo di restaurare il carattere dei tracciati storici, di più rilevante valenza paesaggistica, e, al contempo, assicurare maggiore razionalità fun-zionale al sistema della viabilità.
Il capitolo quarto tratta di una possibile rinnovata funzione e figura delle
canalizzazioni idrografiche che attraversano le aree metropolitane in rappor-to al caso-studio dei Regi Lagni, al ruolo che essi possono assumere rispetto la metropoli campana in evoluzione. Si scandaglia il mutare di senso che questo corso d’acqua ha assunto in alcune epoche storiche: come elemento in sé, e attraverso i rapporti volta a volta istaurati con il contesto; e si propon-gono possibili operative interpretazioni dei Regi Lagni e delle “tracce” della bonifica come elemento di struttura della città metropolitana. Si riconoscono le interferenze tra i canali e le macrolottizzazioni produttive, le infrastrutture,
gli insediamenti residenziali. Tali rapporti evidenziano una problematica as-senza d'integrazione nella composizione degli elementi di costruzione del territorio, dove la serialità e la distanza (intesa come vuoto in attesa d’utilizzo) convivono con improvvisi accentramenti e sovrapposizioni, di se-gni e funzioni. Attraverso alcune coppie interpretative – continui-tà/frammento, natura/artificio, persistenza/trasformazione, spazio/luogo – si prospetta un possibile ribaltamento di senso per l’area metropolitana, con la
fondazione, in seno alla metropoli stessa, della anticittà del Clanio: uno spa-zio naturale continuo che dai Regi Lagni si ramifica tra i frammenti degli in-sediamenti, rimarcandone e qualificandone le identità, a partire dal confronto serrato tra rinaturalizzazioni, enclaves produttive e parti pubbliche di città.
Il capitolo quinto illustra il caso del Programma innovativo in ambito ur-bano relativo ad una parte della linea di costa di Napoli, avente come bari-
Introduzione 13
centro il quartiere di San Giovanni a Teduccio, presso Napoli Est. Si tratta di una linea di costa storicamente occupata da attività industriali, oggi in larga parte dismesse. Una dismissione che offre l’opportunità di ripensare il rap-porto tra il citato “cuneo verde” ed il mare, nell’ambito degli obiettivi fissati dalla Variante generale al Piano regolatore di Napoli del 2004. Un lavoro di
ricucitura di spazi pubblici e di linee di continuità, sia ecologiche, sia d’uso. Il capitolo sesto tratta di alcune figure tipiche del progetto urbanistico
moderno: la corona di attrezzature, che limita e definisce l’urbanizzato; la rete dei parchi e della mobilità, che si insinua tra le maglie edificate e con-nette l’urbanizzato al sistema ambientale di scala territoriale; l’ orto, nelle varie declinazioni di “spazio concluso” (le aree della periferia urbana), “ca-strum” (la parte coincidente con la città antica), “spazio coltivato” (la cam-
pagna come termine altro rispetto alla città). A partire dall'illustrazione del progetto per il nuovo Piano urbanistico di Acerra, riflette su un modo di fare piano dove l’urbanistica è intesa nella sua essenza di landscape e shaping, predisposizione di trasformazioni di territori e paesaggi.
Il capitolo settimo illustra la proposta di riforma per i territori a bassa densità del versante settentrionale del Somma Vesuvio. A partire dal caso studio, relativo alla costruzione del Piano urbanistico comunale di
Sant’Anastasia, si cerca di illustrare le contraddizioni – non solo fisiche ma anche degli strumenti di pianificazione, vigenti ed in itinere – che costitui-scono la condizione di sfondo per qualsiasi attuale e fattivo ripensamento. Qui, alle falde del Vesuvio, una vera e propria congerie di razionalità diver-genti apre lo spazio ad una terra di nessuno dove prevale il gesto individuale e la trasformazione incrementale; una condizione di sospensione, in bilico tra ipotesi di delocalizzazione, conservazione tassidermica e inerzia dei modelli di comportamento e di modifica dei luoghi.
Il capitolo ottavo racconta il progetto per l’insediamento antico di Viscia-no. Questo caso offre elementi d’interesse, sia per la natura dei luoghi (un nucleo del XV secolo, eccentrico, ancora in parziale rapporto con lo scenario naturale), sia per la presenza di un precedente piano di recupero, redatto, all'indomani del terremoto del 1980, da Agostino Renna: dal confronto tra la realtà fotografata da Renna e la condizione attuale, ma anche tra il progetto "di recupero" dell'architetto irpino e quello di "conservazione" scaturito
dall'approccio di Benevolo (che coordina questo progetto come anche i lavo-ri su Acerra e Sant’Anastasia) si traggono alcune considerazioni di una certa rilevanza scientifica e operativa.
L'ultimo capitolo è dedicato al tentativo di tracciare i possibili sviluppi del progetto territoriale, tentando, come “note a margine”, alcune prime, seppur provvisorie, conclusioni.
14 Introduzione
Campania, felix?
Realtà, struttura
La piana campana è un caso studio emblematico: la crisi dei rifiuti, la
congestione della città costiera, la decadenza della campagna che da terra di produzione (fino a sei raccolti l’anno, perciò queste terre erano felici) è di-ventata terra in attesa (di edificazione, di discariche), il pervasivo abusivi-smo edilizio. Proprio il carattere “eccessivo” rende questi luoghi chiarifica-tori della condizione contemporanea della città e del territorio in Italia; dell’incapacità della politica e dell’urbanistica di governare; della compro-missione del paesaggio e dell’ambiente (Benevolo, 2012). Questo caso, af-
frontato con un’ottica integrata e interdisciplinare, fornisce diversi elementi d’interesse. Il fatto che alcune delle esperienze descritte siano state condotte in collaborazione con Benevolo, aiuta inoltre a posizionare questa condizio-ne nel dibattito generale, a misurare analogie e distanze.
Innanzitutto un dato oggettivo. La conurbazione della piana – area geo-grafica delimitata a Sud dal mare, a Est dalle propaggini dell’Irpinia, a Nord dai rilievi tifatini, ad Ovest dal litorale domizio – si presenta come una vera e
propria metropoli, con circa 3,5 milioni di abitanti distribuiti su una esten-sione territoriale – in parte ricompresa nella Provincia di Napoli, in parte nel-la Provincia di Caserta – di poco più di 1250 kmq. Una città: almeno per densità, popolazione ed estensione, con un numero di abitanti superiore a quello di Roma (2,8 milioni) distribuito su una superficie territoriale parago-nabile a quella della capitale (1285 kmq). In quest’agglomerato c’è via Ca-racciolo con il Golfo da cartolina e il lungomare liberato (dalle auto, non al-tro), le Vele di Scampia con gli infiniti vicoli sovrapposti, il golf club di Ca-
stel Volturno con il mare non balneabile e le torri fantasma del Villaggio Coppola, Pompei antica, una sterminata distesa di case e capannoni produtti-vi sempre uguali, grandi e piccoli residui di campagna sempre meno coltiva-ta, superstrade e ferrovie che segnano giaciture e forniscono orientamento (prevalentemente Est-Ovest le prime, Nord-Sud le seconde), grandi e piccole discariche solo alcune censite, alcune ancora in esercizio, altre provvisoria-mente allestite all’epoca dell’emergenza rifiuti e oggi a contatto, senza solu-
zione di continuità, con i campi agricoli, le case, i canali ed i pozzi dell’acquedotto. Questa città ha una densità più elevata di Roma, ma a diffe-renza della capitale presenta una macro-struttura duale e conflittuale: un cuo-re è nell’ultima città – la Napoli costiera; l’altro è oltre le colline, nella città diffusa che si distende nella piana delimitata dal litorale domizio e dai primi rilievi appenninici.
16 Introduzione
Napoli presenta a tutt’oggi struttura sociale e caratteristiche di tipo tradi-zionale: concentrazione di funzioni e di abitanti, mixitè sociale e funzionale delle parti. Napoli è ancora città perché il suo centro storico (il più esteso d’Europa) è a tutt’oggi un insediamento “vivo”, né museificato, né terziariz-zato. Questa particolarità, storicamente fondata, è insieme la più grande ri-
sorsa e il più grande limite della Napoli contemporanea: è l’eccezione che la rende un modello alternativo al downtown commerciale-terziario che ha cor-rotto in maniera generalizzata i vecchi centri urbani europei. Allo stesso momento, questa condizione rende la città costiera irrisolvibilmente conge-stionata, in perenne attesa di una "pausa": dello spazio che solo la delocaliz-zazione di alcune funzioni potrà riportare. Senza spazio questo coacervo è in perenne vibrazione ma immodificabile nella sostanza.
La conurbazione campana, l'altro polo di questa struttura duale, ha di-mensione e abitanti molto maggiori della stessa città di Napoli; presenta di-versi centri che raramente coincidono con i tessuti storici delle vecchie citta-dine rurali (ad esempio: ad Aversa, a Nola, a Caserta). Spesso questi centri sono rappresentati come gli iperluoghi commerciali e ludici di proprietà pri-vata che ne costituiscono i nodi maggiormente (anche se fintamente) urbani. In realtà la sua vera centralità è reticolare e diffusa, è la rete di superstrade e
vecchie consolari che ne irrora i tessuti, è nelle stazioni di servizio e nei na-stri commerciali spontanei che germogliano lungo i tragitti extraurbani, è nei frammenti di paesaggio aperto che ne ricordano le origini agrarie. Questa conurbazione ha caratteristiche e aspirazioni anti-urbane: il suo mito fonda-tivo è la casa isolata con il giardino e il garage, non ha nulla a che vedere con il capoluogo, che resta, come nella storia di questi luoghi, un’eccezione senza legami economici e di senso con l’entroterra.
Queste sono le asimmetrie più evidenti di Napoli e del suo hinterland:
l’essere, allo stesso momento, estremamente arretrata e fortemente contem-poranea (nella piana campana c’è una densità di mall commerciali superiore a quella di Los Angeles); immobile al centro e vorticoso divenire nei bordi. Una diade irrisolta: l’abiezione urbana
Abiectus, nella Roma antica, è colui il quale è cacciato dal diritto comune, è cioè degenerato dalla condizione di “cittadino”.
Allo stesso modo abbiamo definito “abiezione urbana” quella parte di co-nurbazione che è decaduta da una condizione precedente (urbana oppure ru-rale) a uno stato ibrido, di sospensione, né più rurale né compiutamente ur-bana (Formato, 2010). Una condizione di frammistione città-campagna, co-mune ai territori dello “sprawl” e della diffusione insediativa (Ingersoll,
Introduzione 17
2004) ma che in Campania assume particolari forme e strutture – appunto di “abiezione” – in quanto la colonizzazione del territorio rurale è qui sincopa-ta, lacerata, alterna picchi di grande densità a vuoti assoluti, brownfield, di-smessi ed abbandonati a dispetto della incredibile produttività agricola.
Un territorio fatto di opposti, dove la diffusione insediativa non è riuscita
se non marginalmente a intercettare la richiesta di naturalità – “sole, aria e luce” (Le Corbusier, 1924) – che sta alla base delle aspettative dell’abitare moderno (Secchi, 2005). Tra i due termini, campagna ed edificato, non esi-stono relazioni, né continuità di sorta; anche la prossimità fisica può essere un problema per cui, non di rado, il primo e fondante atto di colonizzazione è la costruzione di un muro che segrega il “lotto”, persino rispetto al paesag-gio che ne costituisce contesto e sfondo. La topologia che ne risulta è discon-
tinua, con asintoti fatti di spazi eterotopici (cioè luoghi legati in modo iperte-stuale ad altri, fisicamente non prossimi) e vuoti atopici (spazi serventi delle attrezzature: parcheggi, bretelle infrastrutturali, sotto-viadotti, ecc.). Il tutto contrappunta con il contesto, che invece conserva la limpidezza dello sfon-do, il colore e lo scintillio della luce mediterranea. Una luce che scolpisce un paesaggio in cui irrompono alcuni elementi di eccezionalità: il Vesuvio, i pi-nus pinea che segnano i canali e le antiche centuriazioni, alcuni frammenti di
sistemazioni agricole storiche (muri, terrapieni, strutture serricole in legno di castagno e manufatti di accesso ai fondi). L’acqua (canali, torrenti, vasche di
Reggia di Carditello: corte esterna
18 Introduzione
laminazione) da fonte di ricchezza (per l’irrigazione, per l’abitare) diventa elemento di preoccupazione: un timore legato, ad esempio sulle prime pen-dici collinari, ai frequenti disastri idrogeologici; in pianura, agli scarichi in-controllati che hanno trasformato la rete idrografica planiziale in infrastruttu-ra di scolo.
La genesi di questa conurbazione è singolare e presenta tratti costanti sia quando le espansioni insediative sono avvenute all’interno delle previsioni urbanistiche vigenti, sia quando, viceversa, hanno avuto un'origine spontane-a, più o meno abusiva.
Dal punto di vista insediativo la colonizzazione della campagna si è “ap-poggiata” sugli antichi tracciati che dunque ne hanno costituito, attraverso aggiustamenti incrementali, l’esile ossatura.
Dal punto di vista topologico, le preesistenze rurali (masserie, aggregati, chiese isolate, infrastrutture come ponti o muri di contenimento) ne costitui-scono l’elemento d'innesco, intorno al quale il nuovo insediamento difatti si è condensato (non di rado il nuovo insediamento assume la denominazione da un preesistente toponimo: “Ponte di Ferro”, “Starza”, “Muro di piombo”, ecc.). Il risultato è la notevole congestione insediativa di un mosaico imper-fetto in cui non si riscontrano né i vantaggi tradizionali della densità urbana
(mixitè, identità, servizi) né, tantomeno, quelli della suburbia a bassa densità (rapporto con la natura, funzionalità).
Esiti
Alcune delle ricerche e delle proposte illustrate in questo libro sono state
svolte in occasione d’incarichi elaborati con il coordinamento scientifico di Leonardo Benevolo, in collaborazione con il suo studio.
Benevolo sostiene che un’esperienza urbanistica si racconta quando si ha oramai chiara la percezione che la stessa resterà in un cassetto, non avrà esiti concreti rilevanti. Il momento istituzionale dell’adozione di un piano ha un valore relativo, di “salvaguardia”; per rendere operativo un piano occorre in-vece un impegno ed un coordinamento pubblico costante ed incisivo, la ca-pacità di realizzare, magari anche con successive verifiche ed affinamenti,
quanto contenuto nello strumento urbanistico generale. Nessuna delle proposte illustrate nel seguito ha avuto, almeno per il mo-
mento, esiti concreti. In alcuni limitati casi si è riuscito a mettere tutt’al più in campo una forma di “resistenza”: con il Piano dei cinque comuni ad e-sempio si è riuscito ad elidere una previsione del Consorzio Asi di Napoli per un centro integrato di alcuni milioni di metri cubi di nuove costruzioni; in altre occasioni forse l’adozione di un piano riuscirà a rallentare il depau-
Introduzione 19
peramento del paesaggio e del territorio. Questo però non basta: del coordi-namento e dell’azione pubblica necessari a incidere su di una realtà tanto complessa e disastrata come quella campana, pochi segnali.
Proprio per questo vale la pena raccontare questi dieci anni di ricerca e proposte. Non perché queste abbiano la pretesa di essere esaustive né in
qualche modo “illuminanti”. Non perché, insomma, in questo racconto ci sia la presunzione di illustrare delle soluzioni, né una strategia di rigenerazione, sviluppo o riforma. Vale la pena farlo, invece, per cercare di approfondire la riflessione su di un decennio che in Campania, come in tutto il mondo, ha vi-sto cambiare le cose in modo radicale, aprire prospettive e comportamenti impensabili giusto qualche anno fa.
Da questa cronaca derivano alcune ipotesi di comprensione e proposizio-
ne che s’intende offrire al dibattito pubblico. Rispetto ad alcune scelte o mancate azioni (perché la nuova stazione di Zaha Hadid cresce al centro di una terra apparentemente di nessuno?) vale la pena senz’altro riflettere. Ri-spetto all’ipotesi di un nuovo assetto istituzionale, con la Provincia di Napoli che si trasforma compiutamente in Area metropolitana, non si può che pro-porre un progetto, territorialmente fondato e fatalmente politico.
53
IV. Reverse city
L’anticittà del Clanio
Tracce, struttura, interferenze
Il tema delle canalizzazioni idrografiche, di una loro possibile rinnovata
funzione e figura in territori che da agricoli diventano metropolitani, è svi-luppato nel presente contributo in rapporto al caso-studio dei Regi Lagni, al ruolo che essi possono assumere rispetto la metropoli campana in evoluzio-
ne. Si scandaglia il mutare di senso che questo corso d’acqua ha assunto in alcune epoche storiche, in quanto elemento in sé, ed attraverso i rapporti vol-ta a volta istaurati con il contesto; e si propongono possibili, operative, inter-pretazioni dei Regi Lagni e delle “tracce” della bonifica, come elemento di struttura della città metropolitana.
Vengono individuate interferenze, attinenti il rapporto tra i canali e le macrolottizzazioni produttive, le infrastrutture, gli insediamenti residenziali.
Tali rapporti evidenziano una problematica assenza di integrazione nella composizione degli elementi di costruzione del territorio, dove la serialità e la distanza, intesa come vuoto in attesa d’utilizzo, convivono con improvvisi accentramenti e sovrapposizioni di segni e funzioni. Serialità e distanza de-scrivono le interferenze con gli insediamenti residenziali; accentramenti e sovrapposizioni sono invece tipici dei macroisolati produttivi e delle infra-strutture.
Attraverso alcune coppie interpretative – continuità/frammento, natu-
ra/artificio, persistenza/trasformazione, spazio/luogo – si prospetta un possi-bile ribaltamento di senso per l’area metropolitana con la fondazione, in seno alla metropoli stessa, della anticittà del Clanio. L’anticittà è uno spazio natu-rale continuo che dai Regi Lagni si ramifica tra i frammenti degli insedia-menti, rimarcandone e qualificandone le identità, a partire dal confronto ser-rato tra rinaturalizzazioni, enclaves produttive e parti pubbliche di città.
54 IV. Reverse city
Bonifica e territorio
Dalle paludi alla proto-metropoli settecentesca
I Regi Lagni sono canali seicenteschi che attraversano per circa 60 Km la
piana campana a Nord di Napoli, da Nola al litorale domizio. I canali, dall’andamento rettilineo, sono parte strutturante di un più gene-
rale intervento di bonifica, progettato da Domenico Fontana nel Seicento e concluso funzionalmente dopo due secoli circa, con la creazione dell’Alveo dei Camaldoli.
La bonifica riguarda il bacino dell’antico fiume Clanio, il cui carattere torrentizio, comportando la costante erosione dei versanti collinari e monta-
ni, generava frequenti impaludamenti a valle, soprattutto nelle aree più de-presse: l’agro acerrano e la costa domizia. L’appoderamento consta di una fitta rete di canalizzazioni di drenaggio delle aree paludose e nella normaliz-zazione del Clanio, l’antico corso d’acqua arginato, rettificato e deviato ver-so una nuova foce, più a Nord dell’originario estuario paludoso, posta dove è oggi il Lago Patria.
L’entità del problema legato al Clanio e alle paludi ad esso relazionate,
aveva causato sin dall’epoca romana il mancato utilizzo agricolo di zone ri-maste a lungo “selvagge”, segnate da boschi e prati, solcate da rari collega-menti stradali. La mancanza di persistenze archeologiche riferibili ai sistemi di aggeratio altrimenti diffusi nella piana, così come la rotazione della gri-glia centuriale in prossimità di Acerra (26° N-O) e Nola (15° N-E), testimo-niano di una prolungata assenza di insediamenti antropici che neppure il complesso meccanismo di ripartizione ed irrigazione del suolo messo in atto dai romani era riuscito a normalizzare (Chouquer, Clavel-Lèveque, Favony,
Vallat, 1987). La persistenza di macchie boschive di considerevole estensio-ne – in località Calabricito, Varignano, Sant’Arcangelo, lungo il litorale do-mizio – è attestata, come risulta dall’ Atlante del Regno di Napoli di Antonio Rizzi Zannoni, fino alla fine del Settecento.
La sezione dei Regi Lagni progettata dal Fontana prevedeva un invaso centrale – definito maestro – maggiore e più profondo, per la raccolta delle acque torrentizie ed il drenaggio in falda, e due canali laterali minori, i con-
trofossi, per la raccolta dei sistemi minori di canali. Gli studiosi concordano nel ritenere che, a macchina perfettamente fun-
zionante, circa la metà delle acque dei Regi Lagni derivava dalla funzione drenante, mentre la restante parte era dovuta alla raccolta delle acque torren-tizie, e quindi stagionali, e delle sorgenti del Mefito, poste a Nord Est di A-cerra, alla base della collina di Cancello (Fiengo, 1988). Il controfosso destro
L’anticittà del Clanio 55
– detto Danubio – scaricava nell’alveo principale in alcuni punti dove ancora oggi l’invaso complessivo risulta più ampio: presso Casapuzzano, al ponte Sant’Antonio, in località Croce dei lagni. Il controfosso sinistro, invece, a-veva uno sviluppo del tutto autonomo e confluiva nel canale principale solo presso la foce.
Per il corretto funzionamento del sistema occorreva una costante opera di manutenzione e pulizia dei fondali, oltre ad interventi di arginatura consi-stenti e stabili. Sin dal Seicento, per rafforzare gli argini, è realizzata una fit-ta e regolare piantumazione di filari di pioppi e pini mediterranei. Queste si-stemazioni arboree, di cui oggi persistono solo alcuni frammenti, molto han-no contribuito alla costituzione del paesaggio della piana, dalla bonifica in poi interamente coltivata.
I territori restituiti alla agricoltura diventano così il nucleo produttivo a-gricolo della piana, la Terra di lavoro (fulcro della Campania Felix) che as-sicura dai tre ai sei raccolti l’anno; gli agglomerati agricoli ed i vecchi a-vamposti ne acquistano in salubrità; le vie di comunicazione tra Napoli, i ca-poluoghi ed i territori dell’entroterra, diventano agevoli. L’operazione di bo-nifica crea insomma le condizioni per una fondamentale integrazione cultu-rale ed economica tra la città di Napoli, storicamente rapportata alle sole vie
del mare, e la piana agricola campana, gravitante su Capua, Aversa e Nola. L’intervento del Fontana costituisce in questo senso la premessa struttura-
le per le intuizioni settecentesche sviluppate da Vanvitelli e Fuga, di proie-zione della città di Napoli in quella dimensione proto-metropolitana segnata da architetture e sistemazioni paesaggistiche come la Reggia di Caserta, i Ponti alla Valle, la città ideale di San Leucio, il complesso reale di Carditel-lo, l’Albergo dei Poveri, i Granili, l’acquedotto del Carmignano. L’ipotesi di una nuova bonifica. La navigabilità dei Regi Lagni
Una razionalizzazione del sistema dei Regi Lagni, all’interno di
un’unitaria proposta di organizzazione metropolitana, viene elaborata nel 1966 da Luigi Cosenza, in occasione di uno studio sui problemi della «boni-fica di irrigazione del comprensorio detto dei Regi Lagni».
Questo lavoro è poi ripreso ed integrato nella proposta “Terramare”, del 1972, per la quale lo stesso Cosenza amplia lo studio sul bacino dei Regi La-gni all’area Vesuviana costiera.
Sin dalla metà degli anni Sessanta, Cosenza lavora sulla ipotesi di rendere navigabile il canale “maestro”. Poi, con la proposta “Terrammare” (contenu-ta nel piano regolatore di Ercolano, 1972) , amplia ed estende il ragionamen-to, coinvolgendo e mettendo a sistema, mediante ulteriori canali (questa vol-
56 IV. Reverse city
ta marittimi) i porti di Pozzuoli, Napoli (foce del Sebeto) e Castellammare di Stabia. Il lavoro di Cosenza parte dal confronto tra le:
«quantità di acqua esistente nel comprensorio in falda freatica come in quella presente in superficie e la irrazionale distribuzione di questa acqua per gli usi sociali e
dell’agricoltura. (…) La conoscenza complessiva del dato di tali portate consente un
calcolo dimensionale del canale principale e di quelli secondari del nuovo sistema i-
drico di progetto, capace di far defluire tutta questa massa d’acqua verso il mare dopo essere passata attraverso vasche di decantazione o impianti di depurazione, a seconda
delle proprie caratteristiche». (Cosenza, 1966)
La messa a sistema e il completamento delle opere di bonifica, anche con l’immissione dei collettori fognari urbani depurati, hanno l’obiettivo di por-
tare ai Regi Lagni una quantità d’acqua molto maggiore rispetto a quella drenata dai canali di Fontana per ottenere una migliore irrigazione e realizza-re la navigabilità a servizio delle aree agricole interne e di quelle industriali costiere. Il canale navigabile avrebbe avuto «larghezza media di 6 metri, pro-
La navigabilità dei Regi Lagni: ricostruzione dello sbocco a mare presso Napoli Est
L’anticittà del Clanio 57
fondità di 2,5 metri, con una velocità di 0,5 m/sec., anche in condizioni di portata magra. (…) Dai calcoli iniziali esso è risultato navigabile da Zattero-ni fino a 600 tonnellate di stazza» (Cosenza, 1966)
La proposta “Terrammare” prevede la realizzazione di un canale a mare ottenuto con la costruzione di un sistema di polder posti parallelamente alla
costa vesuviana ad una distanza di 250 metri, discontinui in prossimità dei porti del Granatello e di Torre del Greco. I polder avrebbero dovuto acco-gliere attrezzature urbane, sistemazioni a verde e residenza per decongestio-nare l’area vesuviana a rischio vulcanico.
Nel complesso, l’intervento prospettato mira ad una forte integrazione ed ulteriore antropizzazione del bacino dei Regi Lagni in una idea di città me-tropolitana policentrica, contraddistinta dalla discontinuità tra i centri resi-
denziali, intorno cui si prevedevano incrementi edilizi misurati. La navigabilità del canale maestro avviene in un quadro di servizio ed in-
cremento della produzione agricola interna, a fronte di una razionalizzazione della produzione e distribuzione dei prodotti agricoli che possono così con-vergere, attraverso la via d’acqua, ai porti di Napoli e Pozzuoli, zone in cui erano concentrati i maggiori stabilimenti produttivi dell’epoca: il complesso siderurgico di Bagnoli, quello tecnologico di Pozzuoli, i depositi con raffine-
rie della zona orientale. Possibili interazioni tra vie d’acqua e trasporto su ferro erano implemen-
tabili in prossimità del passante posto alle spalle della Stazione centrale di Napoli; presso Acerra, dove il canale interseca la ferrovia Napoli-Cancello-Caserta; presso Aversa e nell’area domizia, dove si incontrano le linee ferra-te che conducono a Roma e verso l’Europa.
I Regi Lagni come rete di scolo
Tentativi di industrializzazione
Pur conservando il tracciato antico i Regi Lagni presentano oggi notevoli
mutazioni rispetto la connotazione funzionale e figurale storica. Tali diffe-renze, imputabili sia ad interventi direttamente effettuati sul sistema degli al-
vei che a rinnovate condizioni al contorno, si concretizzano in una ibridazio-ne tra un preesistente modello agricolo e in frammenti di paesaggi industria-li, commerciali e periurbani.
A partire dalla metà degli anni Ottanta è messa in essere una generale o-perazione di cementificazione degli alvei principali (l’intero percorso del Lagno maestro è stato incanalato in una sezione ad “U” di calcestruzzo ar-
58 IV. Reverse city
mato, da Nola alla foce domizia) e d’ “intubamento” dei rami minori. Si trat-ta di interventi che, oltre a mutare radicalmente la figura dei canali, ne hanno limitato la funzione, in particolar modo quella drenante. Non si è in grado, in questa sede, di definire analiticamente le problematiche idrogeologiche ed idrauliche connesse a questa trasformazione, ma interessa senz’altro rilevare
come il modello di funzionamento dei Lagni sia stato ridotto da opera di bo-nifica a rete di scolo, connessa ad esigenze legate ai vari tentativi di indu-strializzazione e al sempre più veloce incedere delle lottizzazioni residenzia-li1.
Negli anni del boom, mentre Napoli costruisce sulle colline, rinunciando alla dimensione territoriale intuita nel Settecento e riproposta nel piano rego-latore cittadino redatto da Piccinato del ’39, e poi, ancora, nella proposta del-
la Variante generale per la ricostruzione redatta da Luigi Cosenza nel 1945, si localizzano nell’entroterra – a partire dall’Alfa Sud a Pomigliano – le cat-tedrali industriali tipiche degli interventi straordinari promossi dalla Cassa per il Mezzogiorno.
1 Molto forti appaiono le analogie tra l’attuale situazione igienica e di senso dei Regi Lagni in rappor-
to al canale Emscher, nella Ruhr pre-bonifica. In una recente ricerca prodotta dall’ENEA intitolata, Anali-
si di specifiche situazioni di degrado della qualita’ delle acque in Campania, in riferimento ai casi che
maggiormente incidono negativamente sulle aree costiere si legge: «Il presente rapporto sullo stato di
qualità ambientale delle acque nel bacino scolante dei Regi Lagni e dei sistemi afferenti l’area di Cuma,
consente di confermare la situazione di estrema gravità ambientale e di rischio igienico sanitario in tutta
l’area oggetto di studio, evidenziata nei criteri di sicurezza ambientale elaborati dal Ministero
dell’Ambiente (…). Sono state condotte campagna di monitoraggio della qualità delle acque superficiali
del canale dei Regi Lagni e delle acque sotterranee nell’area del bacini relativo (…). L’esame dei dati ac-
quisiti ha rilevato un serio degrado della qualità delle acque a tutti i livelli considerati, in prima istanza
classificabili come stato di qualità ambientale “pessimo” (D.Lgs. 152/99). Per i corsi idrici superficiali tali
misure sono state accoppiate con stime e misure di portata idraulica. Sia pure nell’incertezza legata alla
esiguità attuale dei rilevamenti effettuati e tenendo conto della quasi completa impermeabilizzazione dei
Regi Lagni, è stato stimato che le portate fluenti siano nella quasi totalità rappresentate dagli effluenti dei
depuratori e dagli scarichi diretti. Questo aspetto può condizionare fortemente, data la bassa o assente ca-
pacità di diluizione, la effettiva possibilità di ripristino dei corsi d’acqua e di rispetto degli obiettivi di
qualità stabiliti dalla normativa vigente. Tale analisi ha messo in evidenza che gli interventi di potenzia-
mento e adeguamento infrastrutturali (collettamento e depurazione) per il raggiungimento dei limiti allo
scarico imposti dai criteri di sicurezza ambientali, attraverso l’adozione delle migliori tecnologie disponi-
bili, è necessaria ma non sufficiente al raggiungimento dell’obiettivo di stato ambientale di “buono” al
2016. L’analisi ricognitiva delle reti ed infrastrutture igienico sanitarie, supportata da visite tecniche sul
campo e da rilievi fotografici, ha evidenziato un generale stato di grave deterioramento che impone misu-
re urgenti di intervento. (…) L’analisi dei carichi antropici (civili, zootecnici, industriali e agricoli) ha
messo in evidenza una rilevante pressione ambientale sull’intero bacino scolante che impone misure di
razionalizzazione e la necessità di implementare codici di buona pratica e l’applicazione delle migliori
tecniche disponibili per il trattamento dei carichi inquinanti prodotti. (…) Questa prima conclusione rende
evidente la necessità di realizzare il riuso agronomico ed industriale delle acque depurate e gli interventi
di rinaturalizzazione del bacino idrografico per incrementarne la capacità autodepurativa.»
L’anticittà del Clanio 59
Dopo l’insediamento dell’Alfa Sud il Consorzio per lo Sviluppo Indu-striale di Napoli (Asi) redige un Piano territoriale di settore, per l’industrializzazione e l’infrastrutturazione della pianura campana (De Lucia, 1989). Le modifiche più sostanziali alle aree prossime ai Regi Lagni deriva-no proprio da questo piano: mentre i nuclei residenziali mantengono una cer-
ta distanza dai Lagni, da questi separati da quella che storicamente era zona malsana, le aree di sviluppo industriale promosse dall’Asi sono localizzate in alcune “piattaforme” – Nola, Pomigliano d’Arco, Acerra Nord, Pascarola Marcianise, Aversa Nord – poste proprio nelle aree bonificate, in alcuni casi in diretta tangenza con i canali principali.
Il piano di sviluppo industriale intende dunque i canali come infrastruttu-
ra a servizio degli apparati industriali: per la refrigerazione delle macchine, per lo smaltimento dei residui liquidi, ecc.
Non solo non ne considera la valenza testimoniale storica, ma ne sottova-luta fortemente il ruolo rappresentativo che, anche in una mutata condizione industriale, il bacino avrebbe potuto assumere. Invece che la navigabilità dei canali si realizza inoltre una notevole infrastrutturazione su gomma: le due strade a scorrimento veloce (l’Asse mediano e l’Asse di supporto), che a ra-
Regi Lagni, percorso arborato tra il canale maestro e un controfosso
60 IV. Reverse city
gione possono essere considerate rispettivamente, la terza e quarta tangen-ziale di Napoli, dopo la Tangenziale interna e la cosiddetta “Strada degli Americani”.
La presenza delle attività industriali, anche di forte impatto ambientale, contribuisce al notevole ridimensionato delle persistenze agricole di antica
tradizione, sempre più erose e minacciate anche dall’espandersi delle lottiz-zazioni residenziali più o meno spontanee, mai coordinate con lo sviluppo industriale. Accade, insomma, che sviluppo produttivo, permanenza di a-ziende agricole ed espansione residenziale, viaggino su binari divergenti: le industrie usano i Regi Lagni per lo scarico di rifiuti liquidi, talché la presen-za stessa dei lagni è resa incompatibile con l’espandersi delle lottizzazioni residenziali e con l’uso irriguo delle acque. Uso e rappresentazione del si-
stema mutano: non più infrastruttura agricola, i Regi Lagni non riescono tut-tavia ad assumere il ruolo ed il senso di vera infrastruttura urba-na/industriale.
Per certi versi l’area intorno i canali torna gradualmente ad essere “terra di nessuno”, spazio per discariche ed abbandono sempre più marcato. I con-testi locali, profondamente mutati e caratterizzati dal dilagare delle lottizza-zioni residenziali, declinano in vario modo il tema della semplificazione, della separazione dei materiali dell’intervento territoriale – artificio e natura
– spesso attraverso l’occultamento di uno dei due elementi (la natura), tenuto lontano o negato. In questo senso si può spiegare anche l’ansia di ricoprire il tracciato dei canali: l’ intubamento del canale fonda proprio nella necessità
Viadotto dell’alta velocità
L’anticittà del Clanio 61
di separare i due sistemi, quello liquido, della natura, e quello residenziale e produttivo, della città, per incapacità di regolarne le interferenze. Interferenze
Canale/macrolottizzazioni
Nell’ultimo quindicennio, a fronte di un complessivo ridimensionamento
del settore industriale, l’area metropolitana è stata interessata da un progres-sivo processo di terziarizzazione che ha portato alla realizzazione di nuclei
commerciali integrati con attrezzature di massa, secondo lo schema tipologi-co dei grandi malls d’oltreoceano, facilmente raggiungibili in auto. Alcuni di questi insediamenti, segnatamente quello di Afragola e quello presso il Cis di Nola, sono localizzati in aree, ancora di campagna, contermini ai Regi La-gni. Anche le industrie più importanti – come ad esempio la Fiat a Pomiglia-no o la Montefibre ad Acerra – operano un ridimensionamento e una profon-da ristrutturazione della produzione, con conseguente grosso decremento de-
gli addetti. Le nuove piattaforme commerciali si sommano a quelle discen-denti dal Piano Asi, il cui livello di reale occupazione, al di là dei dati forniti dal Consorzio, appare decisamente basso, con tanti manufatti in stato di ab-bandono o comunque sottoutilizzati – per tutti valga l’esempio dell’area per medie aziende di Pascarola, presso Caivano. Nessun rapporto, di uso o di senso, intercorre tra i nuovi macro-insediamenti e la rete dei canali. La pro-grammazione territoriale ha disposto la realizzazione di attrezzature a livello
territoriale in fasce prossime ai Regi Lagni: il Polo Pediatrico ad Acerra, la Stazione alta Velocità ad Afragola, l’Aeroporto a Grazzanise.
Canale/infrastrutture
Forte è l’interferenza delle nuove infrastrutture su ferro con il sistema dei
Regi Lagni. Lo scalo merci di Marcianise, realizzato nei primi anni 90, ha causato una discontinuità nella falda a Nord di Acerra, determinando un ef-fetto diga con consistente riduzione della portata delle sorgenti pedecollinari di Cancello, dell’afflusso idrico ai Lagni e, soprattutto, della funzione dre-nante dei canali della bonifica ottocentesca posti in località Frassitelli, a ca-vallo tra la Provincia di Napoli e quella di Caserta.
La società “Tav” ha realizzato il viadotto su piloni che attraversa, presso Pascarola, i Regi Lagni; e sta completando la Stazione di porta, ad Afragola,
in prossimità del polo commerciale esistente. Per un lungo tratto la nuova li-
62 IV. Reverse city
nea ferrata ha andamento parallelo al corso dei Regi Lagni; presso Acerra il tracciato dei Lagni è costeggiato da tratti di strade a scorrimento veloce.
Canale/residenze
Ancora considerevole è la distanza tra residenze e canale. Per lunghi tratti
è possibile riconoscere addirittura un parallelismo geometrico, una sorta di fascia di rispetto, di circa 5 km, tra agglomerati residenziali e Regi Lagni. Solo nel caso di Acerra le lottizzazioni si sono spinte ai margini dei Canali
Interferenza con un settore urbano di recente formazione
L’anticittà del Clanio 63
principali. Si tratta però di frange periferiche che volgono le spalle all’elemento naturale e all’acqua, sono giunte presso un limite fisico invali-cabile che molti localmente occulterebbero: mentre il rapporto delle città tra le anse del Volturno – Capua, ecc. – è diretto e ricercato, ad Acerra l’approssimarsi al fiume risulta dalla espansione radiocentrica della città; i
Lagni sono percepiti come barriera, limite fisico al dilagamento insediativo, che ha effettivamente impedito il ricongiungimento di Acerra alla conurba-zione continua a Nord di Napoli.
Un ribaltamento: l’anticittà del Clanio
La discontinuità, l’eterogeneità ed il frammento sono le figure che carat-
terizzano la città ed il territorio contemporanei (Secchi, 2000). Di contro le aree metropolitane sono vissute come un grande interno,
senza più nette separazioni tra spazi aperti e città, in qualche modo senza più distanze fisiche tra gli elementi (Zumthor, 1993). In questo senso la città contemporanea della piana può anche essere descritta attraverso il concetto
della continuità. La dualità continuità/frammento genera un oggetto fisico assimilabile ad un patchwork, in cui i pezzi concorrono a definire parti con-tigue ma non coerenti. La continuità virtuale dello spazio metropolitano, che ignora le distanze tra gli elementi che lo costituiscono, è percepita dall’interno come insieme di frammenti privi di rapporti causali.
Interessante sarebbe provare, viceversa, ad invertire i termini di questo processo sottraendo parti alla conclusione del patchwork, i vuoti in attesa, e
caricandoli di senso attraverso la dialettica di persistenza/trasformazione, spazio/luogo, natura/artificio.
I vuoti costruiscono un tessuto connettivo per il quale il frammento, anco-ra distinto e distante, come nel caso del territorio in oggetto, appare come e-lemento definito e circoscritto, oggetto di intensa attività antropica e caratte-rizzazione artificiale. Questo vale per le infrastrutture lineari e puntuali, per le piattaforme insediative, per le nuove attrezzature a scala metropolitana. La
continuità si invera in un modello ad albero che ramificandosi dai canali principali penetra tra le porzioni di città diffusa, richiama la stratigrafia sto-rica di questi territori ora con boschi, ora con zone umide, ora con orti e frut-teti, connessi o meno a manufatti e complessi storici puntuali: Suessola e la Casina Spinelli, i Mulini, le cascine agricole e le tenute nobiliari, il comples-so reale di Carditello.
Dal rapporto persistenza/trasformazione si richiama la pratica archeolo-gica, intesa come interpretazione di senso, come ermeneutica, interpretazio-
64 IV. Reverse city
ne di una stratigrafia, ricerca di una provenienza e di un senso originario che nell’attualità – e dunque da un punto di vista mai neutrale – riconosciamo ad un elemento preesistente. La provenienza, in questo modo, non fa capo ad un dato storico ma si propone come costruzione; più che alla conservazione fa capo alle categorie operative della interpretazione, recupera un senso remoto
capace di ribaltare una situazione di fatto, e dunque di agire fortemente sulla modifica dello stato di fatto2.
I Regi Lagni, in rapporto al territorio attraversato, diventano figura del ri-baltamento dallo spazio al luogo; storicamente essi hanno assunto un ruolo simile a quello della centuriazione in epoca romana: all’origine di queste due opere di ingegneria presiede la volontà di definire un luogo misurando – bo-nificando – uno spazio. E’questa l’ipotesi che, dopo i romani, persegue Do-
menico Fontana e, tre secoli dopo, Luigi Cosenza. Ciò che distingue il luogo dallo spazio è la rottura della continuità, dell’identità del materiale di cui lo spazio si compone. «All’interno dello spazio tutte le parti sono l’un l’altra equivalenti, nel senso che sono sottomesse alla stessa astratta regola (…). Luogo, al contrario, è una parte della superficie terrestre che non equivale a nessun altra, che non può essere scambiata con nessun altra senza che tutto cambi» (Farinelli, 2003: 108).
Se questa parte della piana è stata a lungo palude e foresta, ed in quanto tale spazio dove le differenti parti non si distinguono, non sono separabili per differenze qualitative, i tentativi di aggeratio e le bonifiche mirano ad una appropriazione di questo spazio attraverso la sovrapposizione di una regola diffusa, più o meno seriale: sovrapposizione dell’artificio alla natura, intesa come luogo altro ed opposto alla città e alla stessa campagna, prima misurata poi gradualmente urbanizzata. Le bonifiche introducono una “scala” per i di-versi materiali che compongono il territorio, introducendo elementi di misu-
ra e di integrazione con i contesti. Dunque se lo spazio metropolitano è un continuo (al pari della palude
pre-romana) gli interventi di bonifica introducono gli strumenti di costruzio-ne dei luoghi: dove tale spazio, ancora oggi, pur declinato secondo frammen-ti e discontinuità (così percepiti dall’interno, dall’insider che materialmente percorre il territorio, ad esempio tra Napoli e Caserta, e legge un succedersi di avvenimenti non coerenti, dei quali non coglie i rapporti di scala, di senso,
funzionali, causali, ecc.) è definibile come un continuo (perché le relazioni che ne fanno una estensione isotropa sono immateriali e pertanto sono per-
2 L’operatività di configurazioni e di prassi provenienti dalla interpretazione di processi storici è un
concetto introdotto e sviluppato da Saverio Muratori per lo studio delle tipologie edilizie. Si ritiene che le
intuizioni di Muratori possano costituire un utile metodo per la lettura ed il progetto dei territori e della
città contemporanea. Cfr. Muratori, 1959
L’anticittà del Clanio 65
cepibili solo dall’outsider). Allora sono ipotizzabili nuove discontinuità co-me strumento di costruzione di rapporti, a partire dalla struttura già storica-mente introdotta. Tali discontinuità segnatamente coincidono col tracciato dei Regi Lagni che può essere forzato nella direzione di un vuoto. Quest’operazione porta a riconsiderare il senso archeologico
dell’opposizione di queste terre alla normalizzazione, alla misurazione, all’inurbamento.
Vuol dire sviluppare linee di continuità ecologica a partire dalla elimina-zione delle canalizzazioni in cemento, dalla rinaturalizzazione degli argini, dalla riforestazione lineare e/o concentrata e considerare le piattaforme pro-duttive, con le nuove attrezzature e gli edifici pubblici, riproponendo per es-se quella scala geografica tipica dei manufatti che si giustappongono alla na-
tura senza tentare di normalizzarla.
95
VII. Back to the landscape
Ripensare la suburbia vesuviana
Il capitolo illustra i primi risultati di un lavoro di progettazione urbanisti-ca e del paesaggio, in corso di svolgimento nel territorio del Comune di Sant’Anastasia, sul versante settentrionale del Somma-Vesuvio.
La situazione insediativa ed urbanistica attuale è singolarmente comples-sa e ha richiesto alcuni anni dedicati alla comprensione e alla restituzione di un quadro conoscitivo appropriato, capace di porre le basi per una consape-vole strategia operativa. Questo quadro tiene insieme sia un’interpretazione storicamente fondata dei fenomeni riscontrati (fisici ma anche sociali ed e-conomico-produttivi) sia una sorta di controstoria urbanistica che mette in tensione i fatti concreti con i quadri pianificatori di volta in volta vigenti o
proposti: vecchi programmi di fabbricazione, regolamenti edilizi, piani rego-latori e loro piani esecutivi, piani e vincoli paesistici, piani per l’assetto idro-geologico, piani ed indicazioni del Parco Nazionale del Vesuvio, program-mazione strategico-operativa per la gestione del rischio vulcanico.
Planning
Il risultato della lettura degli strumenti pianificatori è fatto da una parte
prevedibile a priori (lo scostamento tra la realtà e le proposizioni dei piani, fenomeno tristemente noto a livello nazionale) ed una invero inaspettata, ov-vero il disallineamento anche a volte macroscopico tra i livelli ed i diversi
piani operanti e/o in itinere di approvazione. La questione di fondo è che i diversi piani, vigenti o in itinere, fanno rife-
rimento a diverse razionalità: - l’approccio idealista, derivante dalle leggi sul paesaggio ed i beni cultu-
rali di Bottai del 1939 riproposte dall’attuale Codice per i beni culturali, che fonda i vincoli e il piano paesistico;
96 VII. Back to the landscape
- il criterio emergenziale, derivante dalle disposizioni della Legge regio-nale n.21 del dicembre 2003 (legge che istituisce la c.d. “zona rossa” vesu-viana in cui è vietata ogni nuova quantità edilizia a scopi residenziali e sono promossi interventi di messa in sicurezza e vie di fuga in caso di eruzione o sisma) e dei Piani stralcio delle Autorità di bacino (le difficili condizioni i-
drogeologiche costituiscono uno dei fattori di maggiore preoccupazione per gli abitanti, forse più del Vesuvio);
- la razionalità strategica, che informa le narrazioni del Piano Territoriale Regionale nonché del Piano strategico operativo (strumento di coordinamen-to delle operazioni di ristrutturazione urbanistica previste dalla citata legge regionale del 2003) e del Piano del Parco Nazionale;
- la logica deduttiva e regolamentare della proposta di Piano territoriale
di coordinamento provinciale (non ancora pienamente vigente); - la mediazione politica e la composizione degli interessi fondiari che,
con ogni evidenza, ha condizionato tout court le scelte urbanistiche del vec-chio Piano regolatore comunale, varato alla metà degli anni 90 in aperto con-trasto con alcune delle più rilevanti disposizioni vincolistiche del coevo Pia-no paesistico redatto dal Ministero per i beni culturali in sostituzione della Regione, per anni inadempiente.
Di grande importanza è la valutazione degli effetti dovuti all’atterraggio, nel già complesso quadro pianificatorio preesistente, delle disposizioni vin-colistiche dettate dalla citata Legge regionale n.21/2003. Nel condivisibile tentativo di contenere il rischio vulcanico questa legge: a) elimina ogni pre-visione d’incremento residenziale nei comuni della c.d. “zona rossa”; b) de-manda alla redazione di un Piano Strategico Operativo la determinazione delle:
«aree e degli insediamenti da sottoporre a programmi d'interventi e di opere finalizza-te alla decompressione della densità insediativa presente, nonché al potenziamento e
miglioramento delle vie di fuga anche attraverso interventi di ristrutturazione urbani-
stica ed edilizia, di demolizione senza ricostruzione, di riqualificazione e di recupero
ambientale, di valorizzazione dei centri storici, e di riforma in favore delle attività produttive, turistico ricettive, terziarie ed attrezzature pubbliche e di interesse pubbli-
co; le eventuali possibilità di attuazione di interventi compensativi, nelle aree e per gli
interventi già destinati negli strumenti urbanistici vigenti a scopo residenziale,
nell'ambito degli obiettivi per la eliminazione di case ed insediamenti malsani, degra-dati o comunque per processi di riqualificazione urbana, purché non comportanti pesi
residenziali aggiuntivi».
Il problema è che ai vincoli sarebbe dovuta seguire una stagione di coor-
dinamento pubblico, ed opere di riconfigurazione territoriale ed infrastruttu-razione; mentre, di contro, a nove anni dal varo della “zona rossa”, la Regio-
Ripensare la suburbia vesuviana 97
ne non è ancora neanche riuscita ad approvare definitivamente il Piano stra-tegico-operativo che delle disposizioni legislative avrebbe dovuto costituire traduzione tecnica.
Stato dei luoghi
Nei comuni vesuviani della “zona rossa” a bassa densità come
Sant’Anastasia, nell’ultimo decennio il bilancio è il seguente: la popolazione
è pressoché stabile; non si registrano consistenti abbandoni né trasformazioni urbanistiche di rilievo. Si registra invece un incremento dello spontaneismo edilizio e della diffusione edilizia, sia residenziale sia produttiva.
Questo fenomeno ha ragioni economiche precise: nel momento in cui la legge regionale blocca la nuova edilizia residenziale ed in assenza di concreti interventi pubblici di urbanizzazione ed infrastrutturazione territoriale il pa-trimonio edilizio preesistente assume un immediato incremento di valore;
inoltre, anche le aree destinate ad insediamenti produttivi o le vecchie zone destinate all’espansione residenziale dai piani comunali previgenti sono inte-ressate da un generale incremento della rendita differenziale (sono difatti le uniche aree edificatorie residue e in esse, anche se non più case, si possono realizzare attività produttive di pregio come centri commerciali, alberghi, ri-storanti, ecc. Per le piccole attività produttive, poco pregiate (legate alla lo-gistica in particolare) il prezzo delle aree dedicate diventa proibitivo e, in as-senza di zone dedicate, le attività si disperdono sempre più, in modo infor-
male e random, in campagna.
Nuovi territori
Strategie di riforma
Il progetto di riforma territoriale prevede di portare a compimento le am-
biziose proposte avanzate in sede di legislazione regionale: la strategia urba-nistica generale si basa su di una radicale trasformazione dell’attuale model-
lo insediativo, fortemente accentrato sulla città pedemontana, in un sistema bipolare, con la progressiva delocalizzazione di una porzione dei tessuti pe-demontani di recente formazione a valle, presso le frazioni addensate in mo-do congestionato intorno agli antichi aggregati agricoli.
Ripensare la suburbia vesuviana 99
Si tratta di un processo di medio-lungo periodo che interessa in primo luogo le parti urbane più degradate, caratterizzate dalla presenza di criticità idrogeologiche, caos insediativo, intralcio alle vie di fuga, interferenza pae-sistica ed insediativa con i tessuti antichi di maggior pregio.
Nell’ambito di un programma operativo che contiene il consumo di suolo
coltivato (dunque individuando prioritariamente per la delocalizzazione le aree incolte e/o con fattori di disturbo antropico evidenti, come ad esempio l’impermeabilizzazione dei suoli) si prospetta, nel territorio vallivo, la strut-turazione di un settore rurbano a bassa densità territoriale da implementare con modelli morfologici ed accorgimenti paesaggistici atti ad integrare por-zioni edificate preesistenti, aree di nuovo impianto e campagna in una com-posizione equilibrata ma aperta, al contempo urbana, rurale (natura natura-
ta) e naturalistica (natura naturans: frammenti di Terzo paesaggio, rinatura-lizzazione degli alvei con relativa vegetazione, ecc.). Una suburbia orizzon-tale, integrata con centri civici/commerciali di media dimensione (alcuni dei quali preesistenti, da mettere a sistema), in cui gli spazi pubblici ed i percorsi ciclo-pedonali costituiscono valida alternativa all’utilizzo dell’auto e, in caso di emergenza, consentono di raggiungere il contiguo comune di Pomigliano d’Arco (esterno alla “zona rossa” per il rischio vulcanico, dove quindi si
continuano a costruire case) senza mezzi, con al più quindici minuti di cam-mino. A monte, dove i centri antichi sono assediati dalla massiccia edifica-zione degli anni 60 e 70 del 900, a seconda delle fattispecie dell’area di “de-collo” delle quantità residenziali da trasferire a valle, si prospettano diverse soluzioni: a) la ricomposizione dell’area di sedime con relativo ripristino “paesaggistico-ambientale” (in particolare questo accade in presenza di ri-schio idrogeologico e/o elevata interferenza paesistica dell’insediamento moderno con il paesaggio, naturale e storico); b) la sostituzione edilizia con
ristrutturazione urbanistica e cambio di destinazione d’uso; c) la ristruttura-zione edilizia con cambio di destinazione d’uso.
Non sfugge il carattere complesso della manovra urbanistica proposta.
Una manovra in cui il coordinamento pubblico dovrà essere determinate e protratto nel tempo (del resto com’è possibile pensare di risolvere un’emergenza come quella vesuviana, un vulcano attivo abitato da mezzo
milione di persone, senza un adeguato intervento di natura pubblica?) ma in cui anche i privati, nell’ambito della necessaria perequazione tra proprietari delle aree (aree a monte e a valle, ma non solo) e delle compensazioni tra in-teresse pubblico e convenienza privata, possono essere utilmente coinvolti.
Ripensare la suburbia vesuviana 101
Primi esiti operativi
La riforma territoriale illustrata al punto precedente è in corso di defini-
zione a livello operativo. Essa si attua, in primo luogo, mediante la defini-zione di una nuova armatura infrastrutturale, pensata e specificata in modo integrato con il contesto ed i paesaggi (urbano, agricolo, naturale) che essa stessa contribuisce a determinare. Gli elementi strutturali sono: un anello di distribuzione tra quartieri che, mettendo a sistema tracciati esistenti e mode-ste integrazioni viabilistiche, realizza una parkway atta in primo luogo a sca-ricare le storiche strade di risalita dal traffico di distribuzione tra insediamen-ti di valle e città storica di monte; una viabilità locale liberata dai traffici di
attraversamento/distribuzione in cui nuova importanza acquista lo spazio pubblico ciclo-pedonale e podistico (questa finalità è volta al contempo al miglioramento della qualità urbana e al contenimento dei consumi energeti-ci); una chiusura dei percorsi agricoli inurbati con una gemmazione di ovuli di disimpegno dei quartieri e delle piastre produttive e di servizio, esistenti e di nuova realizzazione.
La parkway è una strada dai caratteri unitari, inserita nel paesaggio e dal-
la piacevole percorribilità carrabile e podistico-ciclabile (il percorso è pensa-to con ricorrenze di alberi di alto fusto, siepi e playground in terra e/o prato). Dal punto di vista trasportistico essa drena i flussi provenienti dalla viabilità veloce e consente lo spostamento tra quartieri in modo diretto, senza interes-sare le risalite storiche. Mettendo a sistema tracciati esistenti questa nuova strada funziona anche come tangenziale dell’insediamento a monte, da dove alcune penetranti risalgono le prime pendici collinari attestandosi presso al-
cuni dei nodi di accesso al Parco nazionale (alcune delle “porte” previste dal Piano del parco) e ai tessuti urbani antichi la cui viabilità interna è invece pedonale. Questi nodi, posti a margine dei centri consolidati, sono costituiti da aree di parcheggio adeguatamente arborate e con basso livello d’impermeabilizzazione del suolo. La parkway, raccordata alla viabilità dei comuni confinanti, costituisce anche un percorso di disimpegno dalla storica anulare vesuviana: la vecchia “statale” va sottoposta a forte limitazione del traffico veicolare, aumentandone il comfort urbano e la storica propensione
al commercio minuto. In questa visione le strade di risalita storiche (dagli in-sediamenti vallivi – da sviluppare – a quelli pedemontani – da diradare) di-ventano le dorsali territoriali/urbane principali, con modesti traffici carrabili locali ed ampi e curati spazi pubblici attrezzati per i pedoni e le biciclette. Particolare attenzione è posta nel ricavare nelle sezioni stradali di queste strade degli spazi riservati al trasporto pubblico, da realizzare con bus dedi-cati o tranvia leggera (una monorotaia o una moderna funicolare).
Ripensare la suburbia vesuviana 103
La maglia irrazionale ed incompleta dei tracciati che innervano (insuffi-
cientemente) gli insediamenti più moderni (in particolare le frazioni di valle) è infine completata da un’arabesca che inviluppa e ricollega i monconi stra-dali esistenti (ovvero l’esile ossatura su cui si è strutturata la gemmazione edilizia del dopoguerra), in larga parte declassati a viabilità semi-pedonale direttamente connessa con la sentieristica rurale e gli spazi pubblici civico-commerciali esistenti e di nuovo impianto. Questo modello – derivante da
alcuni riferimenti dell’esperienza moderna come gli insediamenti di Radburn nel New Jersey (1928) o il Lafayette Park a Detroit (1955) – prevedere di doppiare con strade-parco esterne gli insediamenti esistenti e futuri della pe-riferia, e trasformare in assi per il trasporto pubblico, la mobilità dolce, il traffico dei residenti, le attuali strade interne, inadeguate ed inadeguabili alle nuove esigenze dell’insediamento.
L’anello della parkway costituisce elemento di struttura per un parco in-tegrato atto ad ospitare e favorire la sinergia tra attività economiche e di ser-
vizio pubblico (esistenti; in fieri in quanto previste dal vigente Prg; di even-tuale nuova realizzazione). Esso comprende una moltitudine di funzioni: verde pubblico, attrezzature e servizi, attività produttive (di tipo manifattu-riero compatibile, commerciali, terziarie e ricettive). Il carattere complessivo
I “capisaldi” dell’ambito vallivo
104 VII. Back to the landscape
dell’insediamento è di tipo naturalistico, con prevalenza di spazi inedificati ed arborati, prefigurazione di morfologie edilizie a basso impatto, massimiz-zazione delle aree permeabili (una sorta di moderna Mostra d’Oltremare). Nell’ambito del progetto sono salvaguardate e valorizzate le sistemazione agrarie d’interesse testimoniale, i tracciati antichi (come gli “allineamenti
centuriali”, di origine romana), le masserie e gli altri manufatti presenti sulla Mappa Igm del 1956 (per questi sono previste compatibilità funzionali este-se, anche per produzione, servizi e residenza), nonché le aree archeologiche.
Le aree della corona di cemento che attanaglia i centri storici pedemonta-ni (e pesa enormemente sulle condizioni idrogeologiche dei versanti) sono da decomprimere, mediante trasferimenti verso le zone di valle con compati-bilità specifiche, ove si prova a progettare la suburbia.
115
Conclusioni
Tecnica, politica, territorio
Con Olmsted e il Park movement l’urbanistica moderna e con essa
l’architettura si sono liberati dal “peccato originale” che ha fatto del barone Haussman il braccio operativo di Napoleone III. E’ dalle lotte per il social housing nell’Inghilterra della metà dell’800, dalle ricerche del Movimento
moderno sulla casa e sull’urbanizzazione pubblica agli esperimenti di città moderna del dibattito postbellico, che il valore politico delle proposte territo-riali diventa elemento intrinseco (Benevolo, 1963; Secchi, 2005).
La capacità dell’urbanistica di forzare gli scenari e le percezioni comuni – analoga a quella della realtà d’irrompere nel regno sfocato delle interpreta-zioni (Ferraris, 2012) – permette di passare direttamente dalla struttura dei problemi alla configurazione delle soluzioni, consente di eludere l’ideologia e mettere in tensione in modo diretto, attraverso il comune sostrato costituito
dai fatti, la domanda e l’offerta. Non la diade domanda/offerta che per gli economisti liberisti regola il mercato della concorrenza perfetta, naturalmen-te. Ma, più concretamente, quella che costituisce il motore delle trasforma-zioni, che fa del territorio il campo di battaglia e rappresentazione dei pro-cessi di produzione, materiale e sociale, di beni e profitti.
Operare sul territorio assume da quest’ottica rilevanza diretta sulla strut-tura delle questioni: la tecnica non è neutrale, la realtà non può essere classi-
ficata meccanicamente né interpretata come oggetto statico, è costitutiva-mente contraddittoria, cariata, dinamica (Benjamin, 1925; Adorno, Horkei-mer, 1947).
Un esempio può forse contribuire a chiarire meglio questa tesi. Per alcuni storici esistono analogie politiche tra l’America del New Deal,
gli stati fascisti europei e l’Unione sovietica degli anni Trenta. Tali analogie sono considerate come il prodotto di un meccanismo di produzione e di ac-cumulazione analogo, basato sulla pianificazione centralista,
l’organizzazione taylorista della catena di montaggio, la massimizzazione, poi teorizzata da Keynes, dell’incremento della domanda aggregata, ovvero nel contrasto, coordinato dallo Stato, alle cicliche crisi di sovrapproduzione legate all’industrializzazione (Schivelbusch, 2006). Dal punto di vista terri-
116 Conclusioni
toriale quest’analogia è stata riscontrata come tendenza comune che assimila fenomeni antiurbani come la sub-urbanizzazione americana, l’apertura inse-diativa dei Ciam, la bonifica integrale italiana, gli studi dei disurbanisti so-vietici (Basco, Formato, Lieto, 2012). Secondo quest’ipotesi ad una struttura economica analoga corrispondono similitudini nell’organizzazione del terri-
torio, indipendentemente dall’ideologia politica di riferimento, ovviamente differente. In questo senso la proposta di riforma di un territorio, anche at-traverso la sua connotazione formale e i suoi ordinamenti spaziali, può di-ventare materiale operativo, spesso più avanzato e incisivo di un dibattito politico astratto e lontano dalle cose.
Ritornando a Olmsted e alle vicende americane della seconda metà dell’800, non si può non rilevare come tra l’Olmsted-attivita-politico che ot-
tiene al dominio pubblico le aree, e l’Olmsted-progettista, che, insieme a Vaux, progetta il Central Park, ci sia una continuità irrisolvibile: il green-sward, con l’infinito inviluppo di percorsi, gli scorci bucolici e le verdi (arti-ficiali) colline boscate, è, insieme, forma e sostanza, urbanistica e politica. Central park introduce nel cuore di Manhattan l’essenza delle riserve natura-li che lo stesso Olmsted sottrae alla libera iniziativa a scala territoriale (Nia-gara Falls, Yosemite Valley, ecc.). Central park e le riserve territoriali ame-
ricane diventano così la cura al fallimento del mito antiurbano fisiocratico su cui gli Stati Uniti stessi si basano, e invece di assumere a proprio oggetto i sintomi del fallimento ne esaltano l’esito contraddittorio. Nella dualità tra massima concentrazione urbana e tappeto arcadico sintetico (Koolaas, 1979), tra grigliato territoriale perfetto e grandi riserve naturali, si ridefinisce il classico rapporto monumento/tessuto che, nelle città europee è invece tutto risolto intra-moenia.
Central Park e le riserve naturali non sono, dunque, il prodotto di una
scelta istituzionale: non c’entra il congresso o la stanza ovale della White house. Fu la pressione dell’opinione pubblica, stimolata dalle intuizioni e dalle forme inventate da Olmsted e, ancora prima cantate da Thoreau, a for-zarne l’attuazione. Questa soluzione, inventata a partire dal territorio, dalla sua spazialità e dalle sue figure, travalica l’ideologia politica di riferimento, fornisce le soluzioni che essa non è stata in grado di elaborare: si genera così il paradosso per il quale gli Stati Uniti, regno incontrastato del liberismo
smithiano e della libera iniziativa, diventano, nella seconda metà dell’800, inaspettatamente, avanguardia della salvaguardia ambientale, primo paese a tutelare ope legis parti dei propri vuoti. A fare della natura un inedito monu-mento.
Ciò di cui si tratta descrive una sorta di corto circuito che lega, attraverso la forma, la struttura economica-produttiva e lo spazio in cui la vita si svol-
Conclusioni 117
ge. Questo rapporto non è unilaterale ma è reciproco e può a sua volta condi-zionare la politica che invece, secondo la concezione liberale, ne dovrebbe costituire elemento di mediazione: la forma dello spazio può incidere sui processi di riproduzione/accumulazione perché costituisce una forma di e-spressione del dibattito pubblico (Althusser, 1977).
D’altronde, se la forma non è posticcia, ma mira a rispecchiare e forzare la realtà, succede che quando la politica struttura irrimediabilmente le sue forme di controllo ed invadenza sullo spazio, non c’è altra strada che, come fanno i protagonisti della Bauhaus nel 1933, rompere e cercare altri terreni di lavoro.
Tracce di lavoro
I. Il comune di Napoli ha un’estensione troppo piccola (117 kmq) per es-
sere “città metropolitana”, troppo grande per corrispondere alla città costiera. L’attuale conformazione risale alla riforma nittiana degli anni 20, quando al-cuni casali della prima periferia furono annessi al capoluogo.
La conurbazione dell’entroterra è costituita da più di cento comuni, di-stribuiti tra due enti provinciali. Il coordinamento di questa moltitudine di decisori locali è quantomeno farraginoso, probabilmente impossibile. Le tra-sformazioni più massive sono indotte da opere pubbliche calate dall’alto (la ferrovia alta velocità, ad esempio) o realizzate con logica irrazionale e bassa qualità dai singoli comuni (ad esempio i recenti Programmi integrati “Piu Europa”, finanziati dall’Unione europea con alcune centinaia di milioni di
euro ed interamente gestiti dai Comuni, con esiti che già in questa prima fa-se, salvo isolati casi, si rivelano disastrosi, quantomeno improntati ad un im-barazzante dilettantismo). In questo coacervo istituzionale continuano ad o-perare improbabili residui della Prima repubblica come ad esempio il Con-sorzio Asi (Aree di sviluppo industriale), vecchio braccio operativo della Cassa per il Mezzogiorno, sopravvissuto, insieme al suo Piano territoriale del 1968, ad ogni evoluzione temporale. Col paradosso che se almeno un
tempo – indipendentemente dal giudizio su quella stagione, con ragione de-finita “industrializzazione senza sviluppo” (De Lucia, 1989) – l’Asi operava nell’ambito di scelte istituzionali coordinate a livello centrale, oggi lo stesso Ente opera in nome non si sa di quale razionalità, continua ad effettuare e-spropri e pianificazioni in nome di un “interesse pubblico” che non è ben chiaro dove risieda. E, soprattutto, a chi giovi. Molta della “struttura” territo-riale della conurbazione estesa dell’hinterland è stata realizzata tra gli anni 70 e i 90 dal Consorzio: le superstrade Est-Ovest (l’Asse Mediano e l’Asse
118 Conclusioni
di Supporto), le grandi piattaforme produttive – oggi in via di desertificazio-ne – poste lungo i Regi Lagni (trasformati da canali drenanti in reti di scolo) – il Centro servizi del nolano (Cis). Persino Disneyland avrebbe portato ad Afragola l’Asi se solo gli Americani non avessero all’ultimo momento prefe-rito Parigi a Napoli1.
È possibile, nel contesto generale che abbiamo delineato, pensare di ri-spondere all’attuale confusione anche con la costituzione di una nuova forma istituzionale, capace di semplificare e razionalizzare, sul modello di quanto avvenuto in altre città europee, l’attuale condizione. Su questo modello è probabile che più che, “allargare Napoli” o rafforzare l’attuale ente provin-ciale, potrebbe tornare d’attualità contrarre il capoluogo: riportare i confini amministrativi di Napoli al suo centro storico, rifondendo le sue periferie ai
centri dell’hinterland che ne costituiscono naturale elemento di continuità.
II. Una riforma istituzionale non è sufficiente, senza visione. E’ da questa che, viceversa, è opportuno partire, e su di essa calibrare le nuove forme di gestione ed associazione tra enti. In questa visione giocano ruolo primario le terre comuni, i grandi vuoti urbani che a tutt’oggi si dispongono tra le parti urbanizzate.
In Campania l’elevatissima densità di popolazione e funzioni non è iso-tropa e diffusa, funziona come una rete smagliata, con locali addensamenti (edilizi, di funzioni, di senso) e corrispondenti vuoti (le aree verdi che ancora si insinuano tra le parti edificate). Questi vuoti sono una risorsa da tutelare ed assumere come nuove centralità della conurbazione: senza un scarto di senso queste aree libere sono destinate in pochi anni a sparire.
Per salvaguardare questi vuoti (lungo i Regi Lagni, lungo l’Asse Media-no, nel “cuneo” ad Est di Napoli, ecc.), ridare loro nuovo senso, è opportuno
provvedere in via prioritaria a sottrarli alla rendita fondiaria differenziale che ad essi deriva dalla vicinanza dei sistemi urbani ed infrastrutturale; sottrarli alla dismissione agricola che fatalmente ne pregiudica, giorno dopo giorno, la sopravvivenza. Auspicabile sarebbe assumere e trattare queste terre sul modello delle greenbelt fissate nell’ordinamento britannico: centri aperti del-la nuova entità territoriale2.
1 Una storia della fine degli Ottanta. Ma tanto irreale non doveva essere, visto che l’ASI confezionò
ed approvò nel 1987 una variante urbanistica su circa 200 ettari nel Comune di Afragola per la realizza-
zione di un “parco a tema”. Della cosa non se ne fece nulla (EuroDisney atterrò a Parigi, come noto) ma,
dieci anno dopo, quando si trattò di decidere dove localizzare la nuova stazione dell’alta velocità, guarda
caso, la scelta cadde proprio in adiacenza di quelle aree, nel frattempo ricondotte dal Consorzio a centro
direzionale, con alcuni milioni di metri cubi di nuova edificazione a ridosso della futura stazione. 2 La Gran Bretagna, con una legge nazionale del 1995 ripresa dal National Planning Policy Framework del marzo 2012, riscopre ed applica a livello nazionale la figura della greenbelt utilizzata da Abercrombie
Conclusioni 119
Gli elementi di costruzione di senso di questi vuoti sono la produzione agricola, le persistenze ambientali, le continuità ecologiche, la vegetazione, il sistema delle acque, gli spazi di relazione che hanno la capacità di ricostru-ire connessioni tra parti di città e tra parti di natura. Tutto ciò concorre a de-finire; il paesaggio che, infine è la forma con la quale questo spazio si dà al-
la fruizione e alla percezione; il suolo, che attraverso anche, corrugamenti e pieghe diventa la sua materia costitutiva (Smithson, 1987; Secchi, 1988).
Questi vuoti sono solcati dai nuovi decumani che strutturano le direttrici territoriali, economiche e produttive della piana: la linea di costa con i suoi traffici portuali di merci e passeggeri, da ripensare come uno spazio pubblico continuo e un “ritorno” della natura in città (il porto mercantile potrebbe de-localizzarsi, come ipotizzato da Luigi Piccinato già nel 1964, verso il litorale
domizio); la tangenziale con la sua teoria infinita di addetti ai servizi del ter-ziario e del commercio da ripensare come percorso cittadino destinato ad una lenta dismissione (una condizione che sarebbe resa fattibile dalla ipotizzata contrazione); l’asse mediano e l’asse di supporto con i camion dell’edilizia e dei rifiuti, da rivedere come lunghe parkway. Il limite tra gli insediamenti e i grandi vuoti diventa l’elemento di costruzione di nuove attrezzature, retico-lari e continue, sia dal punto di vista ecologico sia da quello civico.
III. Altrettanto rilevante è il lavoro sugli insediamenti. L’attuale condi-
zione è polarizzata tra l’abbandono dei centri antichi, in molti casi dismessi e marginalizzati, e l’espansione dei bordi suburbani, con la proliferazione edi-lizia incrementale e gli smisurati iperluoghi commerciali, produttivi, delle nuove infrastrutture e per gli spazi del loisir. Tra i due termini una sorta di “corona di cemento”, eredità dell’espansione edilizia degli anni del boom. Una parte di città senza qualità, storicizzabile come espansione del dopo-
guerra, la cui proliferazione è continuata anche fino agli anni 80. Questa par-te urbana intensiva si è sviluppata con caratteri analoghi – la strada come matrice di un’edificazione a cortina, ad elevata densità – come ampliamento degli antichi insediamenti, in modo radiale, usando gli stessi tracciati e le stesse centralità dei vecchi aggregati agricoli. Per operare su questi materiali urbani – la città diffusa, i centri antichi, la corona di cemento – le strategie sono differenti ma tra loro interrelate, in quanto l’intervento sull’uno deve
per il Piano della Grande Londra degli anni ’40. «The Government attaches great importance to Green Belts. The fundamental aim of Green Belt policy is to prevent urban sprawl by keeping land permanently open; the essential characteristics of Green Belts are their openness and their permanence. […] Once Green Belts have been defined, local planning authorities should plan positively to enhance the beneficial use of the Green Belt, such as looking for opportunities to provide access; to provide opportunities for outdoor sport and recreation; to retain and enhance landscapes, visual amenity and biodiversity; or to im-prove damaged and derelict land.» (NPPF, 2012: 19).
120 Conclusioni
contribuire alla rigenerazione dell’altro elemento. Tutti risentono, peraltro, delle azioni sui grandi vuoti, necessarie per creare le geometrie aggregative a scala intermedia e regolare, con gli interventi sui bordi, il moto espansivo delle parti più recenti e rade.
Fondamentale appare il lavoro sulla “corona di cemento”. Dal diradamento di questa parte di città e dal riciclo di questo territorio
trarrebbero vantaggio sia i centri antichi (che tornerebbero ad essere ricono-sciuti come manufatti alla scala del paesaggio) sia le parti più moderne e pe-riferiche da riallacciare, mediante nuovi spazi pubblici a rete, tra loro e con il resto della conurbazione.
Materiali urbani
122 Conclusioni
Questo lavoro, per quanto possa oggi sembrare immane, appare sempre
più necessario, anche perché è da qui che occorre ripartire per abbassare i gradi di rischio degli insediamenti: i rischi naturali e quelli antropici, aumen-tati dalla grande esposizione (dovuta all’alta densità abitativa), dai modelli
morfologici degli agglomerati (che pesano non solo metaforicamente sulle altre parti di territorio a cui si sono di fatto “aggrappate”), nonché dalla qua-lità di un’edilizia post-bellica che ha usato la tecnologia del calcestruzzo in modo generalmente inappropriato, certamente al di fuori di ogni standard an-tisismico. Questa parte di città, sebbene recente, è già vecchia, inadeguata al-la vita contemporanea (per la quale la città diffusa offre maggiori comfort) e, al contempo, priva di qualunque valore, civico, storico o testimoniale. Ini-
ziando dai “casi di eccezionale gravità” come quelli legati alla mitigazione del rischio nei comuni vesuviani, la Piana campana potrebbe al riguardo strutturarsi come un vero e proprio laboratorio, ove sperimentare metodi e tecniche di controllato shrinkage degli insediamenti più densi della prima
Diffusione insediativa sul versante settentrionale del Somma-Vesuvio (particolare)
Conclusioni 123
modernità (Ricci, 2011). Più che la “città pubblica” è questa “città-Fanfani” stimolata dall’omonimo Piano casa degli anni 50 ed esplosa nell’anno di mo-ratoria della Legge ponte (1967) che costituisce la vera emergenza, quella dove, appena piove un po’ in più, c’è bisogno di chiudere le scuole e riparar-si ai piani alti dei casermoni d’abitazione.
Parallelamente sembra opportuno agire sulle parti rade e diffuse della co-nurbazione – dell’abiezione urbana – caratterizzate da una suburbanizzazio-ne incompleta, né più città né ancora sobborgo.
Per queste parti serve innanzitutto un progetto di territorio e di paesaggio, che assuma il tema della città a bassa densità senza pregiudizi, e ne ipotizzi un razionale completamento: individuati alcuni nodi di densificazione – fun-zionale prima ancora che quantitativa – bisogna progettare la “bassa densità”
evitando di dare ad essa una forma compiuta – mossa di per sé non compati-bile con il carattere “anamorfico” ed “aperto” della città diffusa. Né per e-spandere all’infinito un insediamento che comunque dovrà riassorbire, alme-no in parte, le quantità espulse dalla “corona di cemento” (naturalmente pri-vilegiando allo scopo le aree in qualche modo già compromesse, ad esempio le piattaforme produttive residuate dalle politiche Casmez, dove ci sono e-normi spazi disponibili al “riciclo”, e sempre avendo a fronte il quadro geo-
grafico delle terre comuni e dei loro bordi). Quanto, piuttosto, per misurarsi con quel tema della “città-paesaggio” che, pur costituendo lo sfondo e l’ambizione di ogni dispersione contemporanea, solo raramente nell’Italia meridionale è riuscita a precisarsi.
In questa visione pare assumere una certa importanza la riforma del si-stema infrastrutturale locale, con i percorsi attuali, inadeguati e privi di ogni gerarchia, ripensati in chiave prevalentemente ciclo/pedonale.
In questa ipotesi, nuove strade-parco, integrate ed immerse nel paesaggio,
innervano i tessuti della diffusione dall’esterno, in una sorta d’infinita arabe-sca, che adatta al landscape, all’orografia e al contesto, gli schemi ipotizzati da Hilberseimer per Detroit e Chicago (Hilberseimer, 1955; Waldheim, 2004).