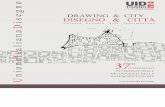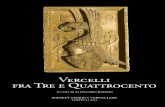Il Vercelli Book nella tradizione grafica anglosassone alla luce delle ricerche recenti, in...
Transcript of Il Vercelli Book nella tradizione grafica anglosassone alla luce delle ricerche recenti, in...
NOTE E DOCUMENTI
Il Vercelli Book nella tradizione grafica anglosassonealla luce delle ricerche recenti
Per la cultura italiana il Vercelli Book è uscito dal suo enigmatico iso-lamento solo in tempi relativamente recenti. Si può anzi dire che nei suoiconfronti non si sia mai manifestata attenzione da parte degli storici italia-ni della scrittura e del libro. Le ragioni saranno state soprattutto linguisti-che, o insieme linguistiche e cronologiche, appartenendo il Vercelli Book auna tarda età anglosassone che non attirava ancora l’interesse degli studio-si della Penisola. Quale che ne fosse la ragione, esso restava insomma, an-che dopo la scoperta del Bluhme, quello che era stato sino ad allora: un li-ber ignoti idiomatis, giunto sino a noi sugli scaffali di una prestigiosa bi-blioteca ecclesiastica padana grazie a una inopinata e straordinaria inerziaconservativa 1. Eppure i paleografi italiani, a partire da Luigi Schiaparelli,hanno dato un contributo e fornito degli strumenti concettuali importantiper la comprensione, se non del Vercelli Book in sé e per sé, certo dei ca-
Ringrazio la Fondazione Museo del Duomo e Archivio Capitolare di Vercelli e in par-ticolare la Coordinatrice dei Comitati Tecnico-Scientifici dott.ssa Anna Cerutti e il Respon-sabile del Comitato Tecnico-Scientifico Archivio e Biblioteca Capitolare Timoty Leonardiper l’autorizzazione a pubblicare le immagini che illustrano questo contributo e per la cor-tesia con cui hanno facilitato le mie ricerche. Un ringraziamento vada anche al dott. Raffae-le Cioffi per il materiale bibliografico che ha generosamente messo a mia disposizione e peravermi aiutato a risolvere i problemi tecnici connessi con la riproduzione dei caratteri spe-ciali dell’alfabeto anglosassone.
1 M. FOERSTER, Introduzione, in Il codice vercellese con omelie e poesie in lingua an-glosassone per concessione del ven. Capitolo metropolitano di Vercelli la prima volta intera-mente riprodotto a cura della Biblioteca Vaticana, Roma 1913, pp. 40-49; ID., Der Vercelli-Codex CXVII nebst Abdruck einiger altenglischer Homilien der Handschirift, Halle 1913,pp. 38-48. La scoperta dello storico del diritto Friedrich Bluhme risale al novembre del 1822:F. BLUME, Iter Italicum, I, Berlin-Stettin 1824, pp. 87, 99.
ANTONIO OLIVIERI
ratteri peculiari della complessa tradizione grafica di cui esso è un celebreprodotto.
Intanto, andrà subito chiarito che il Vercelli Book si iscrive salda-mente, dal punto di vista grafico, entro il ramo minuscolo della grande tra-dizione della scrittura insulare (essendo l’altro ramo costituito dalla scrit-tura che Schiaparelli definì semionciale insulare e Lowe maiuscola insula-re) 2. Occorre anzi dire che in Inghilterra, dopo l’VIII secolo, il panoramagrafico appare, salvo casi eccezionali di impiego della semionciale, intera-mente dominato dalla minuscola. Quest’ultima assunse nel X secolo unastilizzazione particolare, definita dai paleografi, per le sue forme squadra-te, Square minuscule 3: è questa la scrittura in cui venne vergato il VercelliBook, un manoscritto che si può sin d’ora assegnare alla parte finale del Xsecolo, scritto probabilmente nel sud-est dell’isola, nel Kent 4. È dunque
2 L. SCHIAPARELLI, Intorno all’origine e ad alcuni caratteri della scrittura e del sistemaabbreviativo irandese, in ID., Note paleografiche (1910-1932), a cura di G. CENCETTI, Tori-no 1969, pp. 189-312, in partic. pp. 215-241; per la definizione di Elias Avery Lowe si vedal’introduzione a Codices Latini Antiquiores, edited by E. A. LOWE, II, Oxfod 1935, p. xi sg.;cfr. G. CENCETTI, Lineamenti di storia della scrittura latina. Dalle lezioni di paleografia (Bo-logna, a. a. 1953-54), ristampa a cura di G. GUERRINI FERRI, Bologna 1997, pp. 82-88; B. BI-SCHOFF, Paleografia latina. Antichità e medioevo, Edizione italiana a cura di G. P. MANTO-VANI e S. ZAMPONI, Padova 1992, pp. 117-136 (che parla senz’altro di semionciale, trala-sciando la definizione del Lowe, e di minuscola). Va ricordato che in Inghilterra fino all’VIIIsecolo ebbe grande tradizione anche l’onciale importata nell’isola dai missionari romani: cfr.E. A. LOWE, English Uncial, Oxford 1960.
3 Cfr. N. R. KER, Catalogue of Manuscript containing Anglo-Saxon, Oxford 1957, pp.XXV-XXXIII, 464 (in quest’ultima p. sulla scrittura del Vercelli Book, se ne veda la citaz.oltre, n. 50); nel catalogo di Ker il Vercelli Book reca il n. 394, pp. 460-464; T. A. M. BISHOP,An early Example of the Square Minuscule, in «Transactions of the Cambridge Biblio-graphical Society », IV (1966), pp. 246-252; D. N. DUMVILLE, English Square minusculeScript: the Background and earliest Phases, in «Anglo-Saxon England», 16 (1987), pp. 147-179; ID., English Square minuscule Script: the mid-century Phases, in «Anglo-Saxon En-gland», 23 (1994), pp. 133-164. In italiano si dispone di due ottime sintesi: P. CHERUBINI, A.PRATESI, Paleografia latina. L’avventura grafica del mondo occidentale, Città del Vaticano2010, pp. 190-192; A. M. LUISELLI FADDA, Tradizioni manoscritte e critica del testo nel Me-dioevo germanico, Roma-Bari 1994, pp. 42-51.
4 DUMVILLE, English Square minuscule Script: the mid-century Phases cit., p. 140; ma siveda soprattutto D. G. SCRAGG, The compilation of the Vercelli Book, in «Anglo-Saxon En-gland», 2 (1973), pp. 189-207; The Vercelli Book. A late Tenth-Century Manuscript Contai-ning Prose and Verse. Vercelli, Biblioteca Capitolare, CXVII, edited by C. SISAM, Copenha-gen 1976, in partic. p. 32 sgg.
522
IL VERCELLI BOOK NELLA TRADIZIONE GRAFICA ANGLOSASSONE
sulla Square minuscole che ci si soffermerà in modo particolare nelle pagi-ne che seguono. Oggetto in anni recenti di intensi studi, soprattutto daparte di David N. Dumville, essa deve la sua apparenza quadrateggiantenon solo a un aspetto generale della scrittura «ma allo sforzo evidente daparte di certi scribi di ridurre le forme di lettera o (escludendo le asteascendenti e discendenti, comunque di minima estensione) il corpo dellelettere a proporzioni quadrate » 5. Ora, qui è bene precisare che l’apparte-nenza di questa scrittura alla tradizione insulare non è dovuta alla sua cur-vatura stilistica, alla sua ‘squareness’, ma alla sua adesione a uno specificolinguaggio grafico, quello già detto della minuscola insulare. Rispetto allecaratteristiche di quest’ultima la specificità della Square minuscule procededa una semplificazione delle forme, in particolare mediante una riduzionedel ricco patrimonio di legature tra lettera e lettera, di cui restano soltan-to quella di e alta e quella della legatura ti 6. Cose queste che si vedrannomeglio nella parte conclusiva di questo breve lavoro, con citazione diesempi dal Vercelli Book e da manoscritti le cui riproduzioni fotografichesono facilmente reperibili in rete.
Intanto però urge una precisazione: quando si parla di ‘legature’ nel-la minuscola insulare, si intende riferirsi non a quel fatto, essenziale nelladinamica dello scrivere corsivo, che consiste nel collegamento organico tralettere mediante tratti costitutivi della loro struttura, e conseguente modi-fica della loro forma e talvolta della loro posizione rispetto al rigo di scrit-tura, oppure mediante tratti supplementari, come accade perlopiù nelle mi-nuscole corsive attuali. Si intende piuttosto riferirsi all’imitazione degli ef-fetti della corsività mediante la riproduzione di forme – per dir così, ‘con-gelate’ e comunque tracciate con ductus posato – di lettere in legatura. Nelcaso specifico della minuscola insulare, imitazione eseguita ‘al tratto’, con
5 Traduco liberamente da DUMVILLE, English Square minuscule Script: the Backgroundcit., p. 153, di dove cito qui con maggiore ampiezza: « It is generally agreed that in Englandin the tenth century the locally practised form of Insular minuscule entered a ‘square’ pha-se. Precise yet comprehensive description has proved rather elusive, however. The ‘square-ness’ has been taken to reside not merely in the general aspect of the script when seen inquantity on a page but in evident efforts of some scribes to reduce letter forms or (exclu-ding ascenders and descenders, however minimal) the bodies of letter forms to consistent,square dimensions ».
6 Op. cit., p. 153 sg.
523
ANTONIO OLIVIERI
mano posata, delle legature presenti nelle scritture di glossa dei codici tan-doantichi (scritture usate talvolta anche per interi testi di codici di qualitàdimessa) che i paleografi chiamano semicorsive (e che Elias Avery Lowedenominava, impropriamente come ebbe ad osservare Giorgio Cencetti,quarter uncial) 7.
Il problema dell’origine delle forma delle legature presenti nella mi-nuscola insulare non si può dire tuttavia risolto in questi termini: proprioCencetti – paleografo più di altri attento nel richiamare il rilievo dellescritture di glossa tardoantica nei processi genetici di scritture altomedie-vali – se da una parte ipotizzava l’influenza sulle insulari di codici « scrit-ti (...) in qualche calligrafico tipo di minuscola primitiva » e la «derivazio-ne diretta da modelli romani di minuscola primitiva diversa dalla semion-ciale » per certe lettere tipiche della minuscola insulare (come la r a formadi n con la prima asta desinente sotto il rigo), dall’altra faceva notare lamarcata differenza tipologica delle legature insulari rispetto a quelle con-tinentali, differenza che – diceva – « si spiega facilmente se si riflette che lelegature continentali risalgono a tracciati originari della minuscola corsivaromana, mentre quelli insulari sono prodotti spontanei della tecnica scrit-toria locale » 8.
Come che sia, si è giunti a un punto di snodo del discorso che si in-tende svolgere qui. Ci si potrebbe, infatti, chiedere il motivo per il quale,in una sintesi breve che mira a rendere ragione della scrittura di un solocodice, per quanto importante, si sia voluto insistere su chiarimenti del ge-
7 L. BIELER, Insular Paleography. Present State and Problems, in « Scriptorium», III(1949), pp. 267-294, in partic. p. 273 sgg.; J. BROWN, Tradition, Innovation and Invention inInsular Handwriting of the Seventh and Eight Centuries, in A Palaeographer’s View. Selec-ted Writings of Julian Brown, edited by J. BATELY, M. BROWN, J. ROBERTS, London 1993,pp. 179-200, in partic. 188 sgg. Alle scritture di glossa, come è noto, Giorgio Cencetti ha at-tribuito un ruolo importante negli sviluppi della scrittura latina nell’alto medioevo; tra le ‘se-micorsive’ influenzate dalle forme delle scritture di glossa non comprese la minuscola insu-lare: CENCETTI, Lineamenti di storia cit., pp. 72 (dove anche sta il rifiuto della denomina-zione «quarto d’onciale »), 85-87; ID., Postilla nuova a un problema paleografico vecchio: l’o-rigine della minuscola « carolina », in ID., Scritti di paleografia, a cura di G. NICOLAJ, Zurich1993, pp. 109-134 (l’ediz. orig. dell’articolo è del 1955).
8 CENCETTI, Lineamenti di storia cit., citazioni rispettivamente dalle pp. 84, 85, 96. Sul-la formazione e morfologia della minuscola corsiva romana, anche detta corsiva nuova (peropposizione alla corsiva antica, maiuscola), basti qui il rimando alla sintesi di CHERUBINI,PRATESI, Paleografia latina cit., pp. 63-85.
524
IL VERCELLI BOOK NELLA TRADIZIONE GRAFICA ANGLOSASSONE
nere. La ragione risiede, come subito si vedrà, su un carattere peculiare del-la scrittura insulare a caratteri latini dalle sue origini altomedievali fino al-l’invasione normanna a metà circa del secolo XI, carattere che ne fa un ca-so particolarissimo nel quadro della storia più generale della scrittura lati-na per tutto il corso dell’alto medioevo.
La vasta parte d’Europa di cui qui ci si occupa, comprendente quellache oggi chiamiamo Gran Bretagna e l’Irlanda, è stata per tutto il corso delmedioevo un’area di grande complessità dal punto di vista delle tradizioniculturali, linguistiche, religiose e politiche. La tradizione grafica latina vi fuimportata come elemento estraneo, dopo che a causa delle invasioni deibarbari (Angli, Sassoni, Iuti e altre genti) tra IV e V secolo d. C. si eranospenti nella Britannia, già sotto il dominio imperiale, gli echi della culturagrafica romana, che proprio sul suolo inglese aveva avuto manifestazioni –quali le celebri tavolette lignee di Vindolanda 9 – peculiari per certi aspet-ti, ma perfettamente inquadrabili nella koinè grafica latina. Il vettore del-l’importazione di questo elemento graficamente e linguisticamente estra-neo fu il cristianesimo, vettore che, per ciò che qui più interessa, si con-cretizzò in libri e scritture librarie. Le basi della cultura scritta anglo-cel-tica furono quindi esclusivamente librarie e librarie ne furono tutte le ma-nifestazioni 10. Se quindi non appare dubbia, come già si accennava, la co-noscenza delle semicorsive librarie utilizzate per le glosse marginali o peril testo di libri di fattura dimessa, quello che invece mancò fu la conoscen-za diretta delle forme della corsiva nuova e – fatto, si sarebbe tentati di di-re, ancor più importante – delle sue funzioni documentarie, che sul conti-nente costituivano una tradizione initerrotta che dagli ultimi secoli delmondo antico sarebbe continuata, attraverso un lungo travaglio, sino al se-colo XI 11. La cultura grafica dell’alto medioevo insulare risulta quindi del
9 Si veda, per un profilo sintetico, A. K. BOWMAN, Life and letters on the Roman fron-tier: Vindolanda and its people, London 1994; rimando anche al magnifico sito VindolandaTablets Online (http://vindolanda.csad.ox.ac.uk/) diretto da A. BOWMAN, C. CROWTHER eJ. PEARCE.
10 Riprendo qui, anche sotto il riguardo espressivo, quanto scritto da CENCETTI, Li-neamenti di storia cit., p. 84.
11 Cfr. G. CENCETTI, Dall’unità al particolarismo grafico: le scritture cancelleresche ro-mane e quelle dell’alto medioevo, in ID., Scritti di paleografia cit., pp. 227-263 (l’ediz. orig.dell’articolo è del 1962). Del tutto impropria, almeno dal punto di vista qui assunto, appare
525
ANTONIO OLIVIERI
tutto priva di quel filone corsivo che, come rilevò Emanuele Casamassima,costituisce un carattere peculiare dell’esperienza grafica occidentale 12. InIrlanda e Gran Bretagna vergati in scrittura libraria furono quindi anche idocumenti: in onciale prima, poi in minuscola 13.
La scrittura libraria dei documenti dei re anglosassoni non fu neppu-re soggetta a quei fenomeni di conservatorismo grafico con funzione au-tenticante e solennizzante 14 che fu un carattere costitutivo dei diplomiemanati dai monarchi carolingi e postcarolingi. La libraria dei documentipercorse vicende in tutto simili alle vicissitudini delle librarie dei codici,tanto che metodo consolidato per attribuire una data approssimativa a co-dici inglesi di età anglosassone consiste nel confrontarne la scrittura conquella dei diplomi 15. Questo vale anche per la Square minuscule, « that
quindi per la minuscola insulare usata per documenti e libri la definizione di corsiva insula-re (CENCETTI, Lineamenti di storia cit., p. 87), corrente invece tra i paleografi di lingua in-glese: cfr., per es. M. P. BROWN, A Guide to Western Historical Scripts from Antiquity to1600, London 1990, p. es. p. 56, dove la scrittura del Book of Armagh (Dublin, Trinity Col-lege Library, ms. 52) viene definita « Insular Cursive minuscule » (e si veda, per contro, ladefinizione del termine cursive a p. 8). D’altra parte è caratteristico che a una storica, che pu-re discute i caratteri dell’Anglo-Saxon charter proponendo un confronto con l’« outwardform of a regular Italian charter », l’aspetto più bizzarro del documento altomedievale in-glese appaia la « complete absence of any outward mark of validation», senza fare alcun ac-cenno ai caratteri grafici propri delle due tradizioni documentarie: S. KELLY, Anglo-Saxonlay society and the written word, in The Uses of Literacy in Early Medieval Europe, Editedby R. MCKITTERICK, Cambridge 1990, p. 42 sg.
12 E. CASAMASSIMA, Tradizione corsiva e tradizione libraria nella scrittura latina delMedioevo, Roma 1988.
13 Chartae Latinae Antiquiores, edited by A. BRUCKNER and R. MARICHAL, III, Briti-sh Museum London, Olten and Lausanne 1963; Chartae Latinae Antiquiores cit., IV, GreatBritain (without British Museum London), Olten and Lausanne 1964; Facsimiles of Anglo-Saxon Charters, edited by S. KEYNES, Oxford 1991. Magnifiche riproduzioni fotografichedei documenti anglosassoni possono oggi essere consultate, previa autorizzazione, nel sitohttp://www.kemble.asnc.cam.ac.uk/ Sono grato a Emma Connolly, responsabile della pro-gettazione e sviluppo del sito web, per avermi consentito la consultazione del « Single SheetDatabase ».
14 Destinato ad assicurare, insieme con altri elementi, la tipicità di caratteri formali deidiplomi a garanzia di sicura origine e come marca di prestigio dell’autorità emanante: CEN-CETTI, Dall’unità al particolarismo grafico cit.
15 Si veda per es. The Tollemache Orosius (British Museum Additional Manuscript47697), edited by A. CAMPBELL, Copenhagen 1953 (Early English Manuscripts in Facsimi-le, 3), p. 16; ma soprattutto K. SISAM, Studies in the History of Old English Literature,Oxford 1953, p. 148 sg.
526
IL VERCELLI BOOK NELLA TRADIZIONE GRAFICA ANGLOSASSONE
quintessentially tenth-century script form» 16, sviluppo stilistico – lo ripe-to – del filone minuscolo della scrittura insulare, il cui irraggiamento, li-mitato per cronologia a una spanna poco più che secolare, anche spazial-mente fu ristretto, dato che interessò le scritture della sola Inghilterra me-ridionale, soprattutto in quella parte di essa situata a sud della linea dei fiu-mi Severn e Tamigi 17.
È appena il caso di ricordare che i diplomi costituiscono un’impor-tante pietra di paragone grafico perché recavano di norma – come accadetutt’ora per gli scritti documentari in genere – una formula di datazione euna formula di localizzazione, volte a individuare momento e luogo in cuil’atto giuridico documentato veniva posto in essere. Ciò a differenza dei li-bri manoscritti, che solo assai raramente recavano esplicite dichiarazionidella data e luogo della loro produzione 18. È dunque grazie ai documentiregi del secolo X, scritti come i codici dello stesso periodo in Square mi-nuscule, che diventa possibile tentare con maggiore speranza di successo didatare sulla base dei caratteri grafici i libri inglesi vergati con questa stessascrittura.
La minuscola quadrata anglosassone (Anglo-Saxon square minuscole)nacque nell’Inghilterra meridionale nei primi anni del X secolo nel solcodella tradizione insulare, dopo la crisi grafica che caratterizzò la, per altroscarsa, produzione scrittoria della seconda metà del IX secolo 19. Il caso havoluto che proprio per il periodo di formazione della nuova minuscola
16 DUMVILLE, English Square minuscule Script: the mid-century Phases cit., p. 133.17 Nelle non molte testimoniante scritte nortumbriche del decimo secolo di cui si di-
spone la Square minuscole non ha alcun peso: DUMVILLE, English Square minuscule script:the background cit., pp. 148-150.
18 Va aggiunto, a parziale limitazione di quanto ora detto, che non è sempre facile, da-ti i loro caratteri grafici e diplomatistici, dare un giudizio sicuro del carattere di originale ocopia degli esemplari di documenti anglosassoni su carta sciolta: si veda, p. es., S. KEYNES,The Diplomas of King Æthelred ‘the Unready’. 978-1016. A Study in their Use as HistoricalEvidence, Cambridge 1980 (Cambridge Studies in Medieval Life & Thought - Third Series,13), p. 28 sgg. e, soprattutto, P. CHAPLAIS, Some Early Anglo-Saxon Diplomas on SingleSheets: Original or Copies?, in « Journal of the Society of Archivists », III (1965-1969), pp.315-336.
19 D. N. DUMVILLE, English Script in the Second Half of the Ninth Century, in LatinLearning and English Lore. Studies in Anglo-Saxon Literature for Michael Lapidge, editedby K. O’BRIEN O’KEEFFE and A. ORCHARD, I, Toronto 2005, pp. 305-325 (vd. già ID., En-glish Square minuscule script: the background cit., pp. 156-158).
527
ANTONIO OLIVIERI
manchino del tutto originali di diplomi regi: per buona parte del regno diEdward the Elder (Edoardo I il Vecchio) e fino al regno di Æthelstan, trail 904 e il 931 20. I quattro diplomi originali di Æthelstan 21 e un codice con-tenente le due vite di san Cuthbert composte dal venerabile Beda, donatoalla sede episcopale di Durham dallo stesso re 22, costituiscono i testimoni-guida della square minuscole di questo periodo: in essi si osserva una scrit-tura già canonizzata, testimone quindi di una fase successiva al periodoformativo di essa, periodo di cui costituisce un ottimo specimen il cosid-detto ‘Junius Psalter’ della Bodleian Library di Oxford, latino con tradu-zione interlineare in antico inglese, riconducibile con ogni probabilità alregno di Edward the Elder 23. I caratteri grafici generali di questa scritturaconsentono da un canto di ricondurla agevolmente nell’alveo della grandetradizione grafica insulare, dall’altro fanno emergere con pari evidenza glielementi innovativi. Sembra accertato che una delle fonti di ispirazione delrinnovamento grafico fu la minuscola ibrida insulare della prima metà delIX secolo, in esemplari come il ‘Book of Nunnamister’ 24, ma occorre an-
20 Il regno di Edward va dal 901 al 924; quello di Æthelstan dal 924 al 940. L’elenco deidiplomi regi tràditi su carta sciolta giudicati originali o scritti comunque in data coincidentecon la data risultante dai diplomi stessi si può leggere in S. KEYNES, A Classified List of An-glo-Saxon Charters on Single Sheets scaricabile dal sito Kemble - The Anglo-Saxon ChartersWebsite, Website of the British Academy - Royal Historical Society Joint Committee on An-glo-Saxon Charters hosted by the Department of Anglo-Saxon, Norse, and Celtic, Univer-sity of Cambridge, all’URL <http://www.kemble.asnc.cam.ac.uk/node/63>. Per un elencocompleto dei documenti anglosassoni superstiti, comprendente naturalmente i diplomi regi,tràditi in originale o in copia, sia genuini sia falsi o falsificati, cfr. P. SAWYER, Anglo-SaxonCharters: an Annotated List and Bibliography, London 1968 (d’ora in poi cit. come SAWYER
più il numero d’ordine del documento censito). Un edizione rivista e aggiornata del catalo-go di Peter Sawyer, nota come ‘Revised Sawyer’, arricchita di informazioni aggiuntive da Su-san Kelly e Rebecca Rushforth, è consultabile nel sito The Electronic Sawyer. Online cata-logue of Anglo-Saxon charters all’URL <http://www.esawyer.org.uk>. Cfr. comunque DUM-VILLE, English Square minuscule Script: the mid-century Phases cit., p. 157 sg.
21 SAWYER 416 (a. 931), 425 (a. 934), 447 (a. 939), 449 (a. 939).22 Cambridge, Corpus Christi College, ms. 183. Una riproduzione a bassa risoluzione
dell’intero codice è disponibile gratuitamente all’URL <http://parkerweb.stanford.edu/parker/actions/page_turner.do?ms_no=183>, dove è disponibile anche un’accurata descri-zione dello stesso.
23 Oxford, Bodleian Library, ms. Junius 27. Riproduzione parziale del codice disponi-bile all’URL <http://bodley30.bodley.ox.ac.uk:8180/luna/servlet/view/search/?&q=junius%20psalter>.
24 London, BL Harley 2965 (CLA II, 199): scheda dettagliata e magnifiche riprodu-zioni all’URL http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=8827
528
IL VERCELLI BOOK NELLA TRADIZIONE GRAFICA ANGLOSASSONE
che considerare le influenze esercitate da libri e scribi provenienti dalle areeceltiche della Britannia 25. In ogni caso converrà qui porre in rilievo alcu-ne peculiarità grafiche della scrittura nella sua fase di compiuta formazio-ne, attingendo agli studi condotti a suo tempo da Terence Bishop e a quel-li più recenti di David Dumville. Si tratta di una scrittura minuscola cheprocede da una notevole semplificazione delle forme della precedente mi-nuscola insulare: le sue lettere hanno un corpo che tende al quadrato, la iquando segue a t le è strettamente congiunta e si prolunga sotto il rigo; lay è piccola e priva del puntino (come accade anche per altri codici insula-ri dell’età precedente); la terminazione triangolare della aste superiori ten-de a essere enfatizzata 26; la f ricorre in due diverse forme; sono presentiabbreviazioni insulari arcaiche (in particolare per ur, soprattutto in -tur);si riscontra la tendenza ad ammettere la a in legatura sotto il rigo, ma so-lo negli esemplari più antichi 27; nei manoscritti più calligrafici va segnala-to l’uso di d, r, s onciali, di C alta, di i-longa, della forma semionciale in-sulare di a, delle legature di e alta a destra 28. La lettera a è forse la più ca-ratteristica della Square minuscule: in essa l’elemento superiore della a mi-nuscola è formato da un tratto autonomo, dritto e talvolta leggermente
&CollID=8&NStart=2965 Cfr. DUMVILLE, English Square minuscule script: the backgroundcit., p. 158 sg. e J. BROWN, The Irish Element in the Insular System of Scripts to circa A. D.850, in A Palaeographer’s View cit., pp. 201-220, in partic. pp. 209-211.
25 DUMVILLE, English Square minuscule script: the background cit., p. 159 sg.26 Si tratta del cosiddetto wedge, tipico della scrittura insulare: gli « inevitable wedge-
shaped shafts of tall letters », nella formulazione di Lowe (CLA 2, p. XII), o gli « spatula-shaped terminals » della traduzione della Paläographie di Bischoff (B. BISCHOFF, Latin Pa-laeography. Antiquity and the Middle Ages, traslated by D. Ó Cróinín and D. Ganz, Cam-bridge 1990, p. 84).
27 Come il ms. Cambridge, Trinity College B. 15. 33 (368) una copia delle Etymologiaedi Isidoro di Siviglia, di cui si veda una riproduzione in DUMVILLE, English Square minu-scule script: the background cit., tav. I e pp. 165 sg., 169 sg.: la sua scrittura non si può peròancora definire Square minuscule, anche se è importante per gli sviluppi successivi.
28 Si veda ancora il ms. cit. alla nota preced. o meglio, per un esemplare in schiettaSquare minuscule della prima fase, il ‘Tollemache Orosius’, London, British Library, Add.47967, del quale alcune ottime riproduzioni al link http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=8372&CollID=27&NStart=47967; cfr. T. A. M.BISHOP, Notes on Cambridge Manuscripts. Part IV: Mss. Connected with St. Augustine’sCanterbury, in «Transactions of the Cambridge Bibliographical Society », II (1957), pp. 323-336, in partic. 324-326; DUMVILLE, English Square minuscule script: the background cit., p.178; ID., English Square minuscule Script: the mid-century Phases, p. 141 sg.
529
ANTONIO OLIVIERI
ascendente da sinistra a destra 29. Si tenga presente che alcuni fra questi ca-ratteri grafici non si troverano più nella fase finale di diffusione di questascrittura, alla quale proprio il Vercelli Book appartiene. Se ne riparlerà al-la fine di questo contributo. Intanto sarà bene annotare che tale estremoperiodo di vita di questa stilizzazione grafica fu comunque anteriore allarealizzazione di manoscritti appartenenti ai decenni finali dell’età anglo-sassone, vergati in una scrittura che non si può più definire Square minu-scule 30. Occorrerebbe ancora accennare almeno al persistere di alcuni de-gli speciali usi codicologici insulari, in particolare nella rigatura e nella di-sposizione reciproca dei fogli di pergamena all’interno del fascicolo 31; eprendere in considerazione i mutamenti introdotti nella scrittura nelle fasisuccessive al periodo della formazione e della stabilizzazione dei suoi ca-ratteri distintivi (come l’abbandono di consuetudini abbreviative o di cer-te forme di lettera), mutamenti che diedero luogo a una varietà di deter-minazioni stilistiche che consentono di enucleare un succedersi di fasi disviluppo grafico di cui qui ci si limiterà a ricordare l’esistenza, rimandan-do per il resto ai saggi già citati 32.
Per comprendere almeno nei tratti principali la complessità del con-testo culturale che ha consentito la nascita di libri come il Vercelli Book,occorre tuttavia una volta di più ampliare la visuale per considerare le vi-cende che, nei decenni centrali del X secolo, mutarono profondamente il
29 KER, Catalogue of Manuscripts cit., p. XXVIII; DUMVILLE, English Square minuscu-le script: the background cit., p. 153: « its <della Square minuscule> singular defining chara-teristic has always seemed to be the systematic use of a form of the letter a, found very oc-casionally in earlier Insuler script, in which an open a is in effect topped by a separate andstraight stroke ».
30 D. DUMVILLE, Beowulf came lately. Some Notes on the Palaeography of the NowellCodex, in Britons and Anglo-Saxons in the Early Middle Ages, Aldershot 1993, saggio VII(ediz. orig. del saggio 1988), pp. 49-63. Si veda oltre, n. 44 e testo corrisp.
31 Per esempio nel fascicolo preparato al modo insulare il lato pelo della pergamena –pergamena che, data la particolare preparazione, in genere si dice vellum, in omaggio a unaabitudine inaugurata da Lowe – si trova all’esterno del fascicolo, mentre all’interno di essoil lato carne fronteggia il lato pelo, tranne naturalmente che nel bifoglio centrale, tutto ciòcontrariamente agli usi continentali, nei quali il fascicolo presenta il lato carne all’esterno eall’interno si ha un affronto pelo-pelo, carne-carne: si veda, oltre alle pagine introduttive delLowe al II volume dei suoi Codices Latini Antiquiores (cit. qui a n. 2), il saggio di J. BROWN,The Distribution and Significance of Membrane prepared in the Insular Manner, in A Pa-laeographer’s View cit. (sopra, n. 7), pp. 125-138.
32 In particolare a quelli dovuti a David Dumville citati nelle note precedenti.
530
IL VERCELLI BOOK NELLA TRADIZIONE GRAFICA ANGLOSASSONE
volto delle istituzioni ecclesiastiche inglesi e con esso l’articolazione com-plessiva della produzione scrittoria inglese in tutti i campi della sua espres-sione. La riforma monastica di Dunstan, Æthelwold e Oswald ebbe infat-ti un significato che andò ben oltre l’introduzione di una osservanza be-nedettina legata a prestigiosi esempi continentali, in particolare quello delmonastero di Fleury 33. Il monachesimo riformato inglese si pose infatti al-la guida di un movimento di rinascita che aveva avuto le sue prime radici,alla fine del IX secolo, nelle vigorose iniziative del re Alfredo il Grande eche venne continuato dai sovrani successivi, culminando negli anni di Ed-gar (959-975). Fu una rinascita dapprima, certo, soprattutto militare e po-litica, poi anche ecclesiastica, manifestatasi inizialmente nel rinnovamentodella vita cenobitica e culminata poi nella conquista delle principali sedi ve-scovili da parte dei riformatori benedettini (Dunstan fu eletto prima perbreve tempo vescovo di Worcester e Londra, poi fu elevato alla sede diCanterbury nel 959, Æthelwold fu eletto vescovo di Winchester nel 963,Oswald, vescovo di Worcester nel 961, divenne poi arcivescovo di York nel972 continuando a reggere anche la sede di Worcester) 34. E fu insieme unarinascita culturale ed educativa, all’interno della quale, accanto a un rifio-
33 C. CUBITT, The tenth-century Benedictine Reform in England, in «Early MedievalEurope », VI (1997), pp. 77-94; per l’influenza di Fleury, oltre al saggio della Cubitt ora cit.,si veda M. MOSTERT, Le sejour d’Abbon de Fleury à Ramsey, in «Bibliothèque de l’École deschartes », CXLIV (1986), pp. 199-208 e ID., Relations between Fleury and England, in En-gland and the Continent in the Tenth Century. Studies in Honour of Wilhelm Levison (1876-1947), Edited by D. ROLLASON, C. LEYSER and H. WILIAMS, Turnhout 2010, pp. 185-208;nello stesso volume S. VANDERPUTTEN, Flemish Monasticism, Comital Power and the Arch-bishops of Canterbury: a Written Legacy from the late Tenth Century, pp. 67-86.
34 Per una utile ricostruzione delle vicende si può ricorrere ancora con grande profitto– tenendo presenti le necessarie correzioni storiografiche sintetizzate nel lavoro di Catheri-ne Cubitt cit. nella nota preced. e nel volume di John Blair cit. qui oltre – a F. M. STENTON,Anglo-Saxon England, second edition, Oxford 1962, p. 438 sgg. L’interpretazione da meproposta è, per esigenza di sintesi, piuttosto tradizionale, mentre le più recenti proposte sto-riografiche tendono a enfatizzare la continuità della vita ecclesistica inglese costituita dallapersistente importanza della rete di minsters secolari per tutto il X secolo e oltre: cfr. J.BLAIR, The Church in Anglo-Saxon Society, Oxford 2006, in partic. alle pp. 341-354, che ri-leva da parte degli storici delle vicende ecclesiastiche una persistente avversione, che restaistintiva anche se oggi è meno esplicita, per lo stile di vita dei minsters secolari come rifles-so di una « contemporary partisanship absorbed into a historiographical tradition which hasprivileged the centre over the localities, and the ideals of reformers over the realities andneeds of grass-roots religious life » (p. 346).
531
ANTONIO OLIVIERI
rire degli studi latini, che si giovava di indispensabili contributi continen-tali, ebbe un peso decisivo – e del tutto originale rispetto al coevo panora-ma della cultura scritta occidentale – la produzione e diffusione di operein antico inglese, a partire dalle celebri traduzioni di classici di età patristi-ca dovute alla cerchia del grande sovrano Alfredo del Wessex 35. Questo èun punto centrale, anche se non è facile dosare in modo corretto le tona-lità nel tentativo di dipingere il quadro complesso della storia culturale in-glese del X secolo: in ogni caso, come ha sostenuto Michael Lapidge in unalezione spoletina del 1990 36, occorre restituire unità al periodo che va dal-l’età di Alfredo il Grande (871-899) all’età della riforma del monachesimobenedettino e quindi più in generale della chiesa inglese (a partire dal quin-to decennio del secolo X circa e poi soprattutto nel corso del regno di Ed-gar, dal 959 al 975); come pure è importante considerare in una visioned’insieme la letteratura in latino e la letteratura vernacolare, dato che «oc-corre sempre ricordare che opere in latino e opere in vernacolo venivanocopiate insieme negli scriptoria anglosassoni, ed erano probabilmente com-poste insieme nelle scuole anglosassoni » 37. Questa contestualità ha certa-mente un significato molto rilevante e la sua comprensione costituisce unproblema di grande fascino. Si pensi soltanto – per avere un’idea dellacomplessità dei fattori connessi con questo bilinguismo letterario – allegrandi linee della vicenda grafica inglese del periodo, che si può rappre-sentare, in modo a dire il vero un poco schematico, come costituita da duefasi successive. Infatti, a un filone scrittorio unitario che si mosse nei pri-
35 Questa continuità, articolata in una fase di leadership regia e in una fase di passaggiodel testimone della riforma, per così dire, nelle mani dei riformatori benedettini è sostenutada D. N. DUMVILLE, Wessex and England from Alfred to Edgar. Six Essays on Political, Cul-tural and Ecclesiastical Revival, Woodbridge 1992, pp. 185-205; per il profondo coinvolgi-mento dei vertici del potere regio inglese nella riforma monastica, secondo il coevo model-lo continentale ottoniano e l’ispirazione dei precedenti carolingi, in particolare di Ludovicoil Pio, CUBITT, The tenth-century cit.
36 M. LAPIDGE, Schools, Learning and Literature in Tenth-Century England, in Il se-colo di ferro: mito e realtà del secolo X, XXXVIII Settimana di Studio del Centro Italiano diStudi sull’Alto Medioevo (Spoleto, 19-25 aprile 1990), II, p. 951-998; si veda inoltre, nella di-scussione della lezione di Lapidge, l’intervento di Teresa Pàroli alle pp. 999-1003.
37 «we should always remember that works in latin and the vernacular were copied to-gether in Anglo-Saxon scriptoria, and were arguably composed together in Anglo-Saxonschools »: op. cit., p. 952 nota 1.
532
IL VERCELLI BOOK NELLA TRADIZIONE GRAFICA ANGLOSASSONE
mi decenni del X secolo, con l’elaborazione delle prime forme di Squareminuscole, articolandosi nei tre ambiti della produzione diplomatica, dellaproduzione libraria latina e della produzione libraria vernacolare, si sosti-tuì un panorama più mosso, anche se in via di definizione lungo linee piut-tosto chiare. Le prime tracce documentabili in Inghilterra di uso della scrit-tura carolina – vale a dire di quella minuscola che, attraverso un comples-so processo di selezione di forme grafiche antiche e altomedievali, si eraandata formando negli ultimi decenni dell’VIII secolo, l’età di Carlo Ma-gno e della sua riforma culturale e scolastica, negli scriptoria dell’Europadominata dai franchi 38 – si hanno a partire dal regno di Æthelstan (924-939). Furono, allora, scribi forestieri ad usare per la prima volta la caroli-na su suolo inglese, e si sarebbe dovuto attendere ancora un decennio eforse più dalla morte di quel re per avere i primi esempi di carolina scrit-ta da mani indigene 39. I primi esempi di carolina databili con precisionesono costituiti, ancora una volta, da diplomi regi 40; tuttavia sembra assaiprobabile che essa sia penetrata nella pratica scrittoria inglese dapprima neimonasteri e negli episcopi guidati dai leaders della riforma monastica e chepoi la nuova consuetudine grafica abbia raggiunto la cancelleria regia. Sipuò fare l’esempio dell’abbazia di Glastonbury, al centro dell’attuale con-tea del Somerset, guidata da Dunstan fino all’ascesa al trono di Eadred(946), di cui fu uno dei principali consiglieri; o si può pensare piuttosto diassegnare un ruolo di maggiore rilievo ad Æthelwold, già allievo di Dun-stan a Glanstonbury, poi abate di Abingdon, dove favorì intensi rapporticon le correnti monastiche riformatrici del continente, quindi protagonistadella battaglia riformatrice nella sede vescovile di Winchester, di cui fu elet-to vescovo nel 963. Le fonti non consentono, in realtà, agli storici dellascrittura e del libro di assegnare priorità e precedenze. Ciò che più impor-ta è ricordare come la carolina in Inghilterra fu accolta come la grande
38 BISCHOFF, Paleografia latina cit., p. 153 sgg.; CHERUBINI - PRATESI, Paleografia lati-na cit., p. 357 sgg.
39 D. N. DUMVILLE, English Caroline Script and Monastica History: Studies in Bene-dictinism, A. D. 950-1030, Woodbridge 1993 (Studies in Anglo-Saxon History, VI), pp. 16sg., 92, 141 sg., 151 sg.
40 DUMVILLE, English Caroline, cit. pp. 16, 142: due documenti rispettivamente del 956e del 961, conservati entrambi originariamente nel monastero riformato di Abingdon. Cfr.SAWYER, nn. 594 e 690: <http://www.esawyer.org.uk/charter/594.html; http://www.esawyer.org.uk/charter/961.html>.
533
ANTONIO OLIVIERI
scrittura internazionale della nuova koiné grafica (e libraria) latina – e chevenne reinterpretata da uomini, almeno nella prima generazione di scribiinglesi in carolina, che avevano imparato a scrivere libri in minuscola an-glosassone, dunque in un ambiente di monografismo relativo (sempre chesi voglia escludere da questa veloce disamina la scrittura runica 41) –, e checrearono uno stile peculiare, l’English Caroline minuscule, per riprendereil titolo di un celebre libro di Terence Bishop 42. Una operazione di mu-tuazione grafica complessa, che generò certamente tensioni e difficoltà – dicui è un testimone strepitoso, sotto il profilo paleografico, l’Oxford, Cor-pus Christi College, ms. 197, una regola benedettina a capitoli alternati inlatino e nella traduzione in antico inglese, in cui l’unico scriba procede conbuona coerenza a vergare in carolina il testo latino e in Square minusculeil testo in antico inglese, salvo influenze stilistiche reciproche dell’unascrittura sull’altra, e salvo cadute nella scrittura insulare in passi latini, perstanchezza, distrazione, fastidio verso una scrittura straniera, così difficileda scrivere 43.
Nel procedere del discorso, ci si trova così di nuovo a un punto disvolta, che è poi quello della tendenziale specializzazione delle due scrit-ture, la carolina e la minuscola insulare, ciascuna per un suo uso linguisti-co: il latino per la prima, l’antico inglese per la seconda. Tendenziale, per-ché esso divenne esclusivo solo più tardi, nel secolo XI, quando però laSquare minuscole era già stata sostituita da un’altra forma di scrittura, lacosiddetta English Vernacular minuscule, anch’essa di radici insulari mafortemente influenzata dalla carolina 44. Fatte queste riserve, costatando l’e-
41 La quale, d’altra parte, sembra che nel tardo periodo anglosassone fosse uscita dal-l’uso comune e fosse considerata «primarily as an esotic script with criptic possibilities »:KELLY, Anglo-Saxon lay society cit., p. 37 sg.; cfr. del resto R. I. PAGE, An Introduction toEnglish Runes, Second Edition, Woodbridge 1999, p. 41 sg. e passim; C. GILIBERTO, La tra-dizione runica del Mare del Nord. L’Inghilterra anglosassone, in Le rune. Epigrafia e lette-ratura, a cura di V. DOLCETTI CORAZZA e R. GENDRE, Alessandria 2009, pp. 19-63. Sui con-cetti di multigrafismo e monografismo assoluti e relativi si veda A. PETRUCCI, Digrafismo ebilettrismo nella storia del libro, in « Syntagma. Revista del Instituto de historia del libro yde la lecura », I (2005), pp. 53-75.
42 T. A. M. BISHOP, l’English Caroline minuscule, Oxford 1971. Per una sintesi in ita-liano si veda LUISELLI FADDA, Tradizioni manoscritte cit., pp. 52-56.
43 DUMVILLE, English Caroline Script cit., pp. 19-35; KER, Catalogue of Manuscriptscit., pp. xxvi, 430-432 (sch. 353).
44 DUMVILLE, English Square minuscule Script: the mid-century Phases, p. 151 sgg.; ID.,
534
IL VERCELLI BOOK NELLA TRADIZIONE GRAFICA ANGLOSASSONE
sistenza di eccezioni, occorre dire che il senso della scelta è chiaro, anchese rimanda a opzioni culturali e insieme ideologiche che restano, mi sem-bra, ancora da esplorare nella loro complessiva portata.
Scritto – come si ricordava all’inizio – nella seconda metà del X seco-lo e, come sembra probabile, nel Kent, il Vercelli Book è stato attribuitoallo scriptorium del monastero di Sant’Agostino di Canterbury e la datadella sua realizzazione ristretta all’ultimo quarto dello stesso secolo 45.Queste ultime sono attribuzioni ampiamente ipotetiche, cui altre se ne pos-sono affiancare: tenendo per ferma l’origine sud-orientale del manoscrittoper ragioni di carattere linguistico, si può pensare a una datazione oscil-lante tra il tardo X secolo e i primi anni del successivo 46, o di attribuirnel’origine all’officina scrittoria di una cattedrale, come quella di Roche-ster 47. Converrà lasciare agli specialisti di dibattere su questi particolari,che pure non sono, come potrebbe sembrare a prima vista, trascurabili. IlVercelli Book resta per molti aspetti un libro enigmatico, la cui presenza aVercelli partire dal tardo XI - primo XII secolo è un aspetto tutto som-mato secondario, date le componenti di mera casualità cui può essere do-vuta una circostanza del genere 48. I libri viaggiavano e non tutti i viaggi sa-ranno stati provvidenziali e miracolosi come quello di quel libro dei van-geli, « romana littera optime scriptum», che a metà dell’VIII secolo giunsenavigando per mare, con buona scorta di reliquie, fin sulle coste della Nor-mandia 49. Tra i molti dubbi e quesiti – alcuni dei quali insolubili, almenoallo stato delle fonti storiche disponibili – quello della scrittura 50 non è tra
Beowulf come lately cit.; ma si veda ora P. A. STOKES, English Vernacular Minuscule fromÆthelred to Cnut c. 990 - c. 1035, Cambridge 2014.
45 SCRAGG, The compilation of the Vercelli Book cit.46 Si veda poi l’introduz. di Celia Sisam a The Vercelli Book. A late Tenth-Century Ma-
nuscript Containing Prose and Verse. Vercelli, Biblioteca Capitolare, CXVII, edited by C. SI-SAM, Copenhagen 1976, p. 32 sgg., in partic. p. 36 dove la studiosa, sulla base di un passodell’omelia XI (f. 73rv) e di considerazioni di carattere storico, propone una data posterioreal 986.
47 DUMVILLE, English Square minuscule Script: the mid-century Phases cit., p. 140.48 Si vedano in proposito le limpide pagine di Kenneth SISAM, Marginalia in the Ver-
celli Book, in ID., Studies in the History of Old English Literature cit., pp. 109-118.49 Chronique des abbés de Fontenelle (Saint-Wandrille), texte établi, traduit et com-
menté par P. PRADIÉ, Paris 1999, p. 116 sg.50 Trascrivo qui per comodità del lettore la descrizione della scrittura del Vercelli Book
535
ANTONIO OLIVIERI
i più ardui, almeno a giudicare dalla comoda posizione di chi si colloca avalle, per così dire, di molti decenni di accurate esplorazioni del patrimo-nio manoscritto superstite dell’Inghilterra del X secolo. A chi guardi anchesoltanto le poche riproduzioni presenti in questo contributo 51 risulterà im-mediatamente evidente che il Vercelli Book venne vergato in una regolaree ben allineata square Minuscule, il cui aspetto generale – ma non le formedi lettera – risente in modo chiaro dell’influsso ordinatore della scritturacarolina 52. Tra le lettere più caratteristiche citerò ancora la a, il cui trattoautonomo superiore è fine e ascendente dal basso in alto; la e ha il primotratto verticale con un forte elemento di attacco, mentre l’ultimo trattoorizzontale piega talvolta all’estremità leggermente verso l’alto; la s è pre-sente in tre forme: la tipica forma insulare minuscola (come a r. 1 di fig. 1:« his »), una alta s minuscola con un forte elemento di attacco del primotratto (r. 7 di fig. 1: « sƿylcne », dove il segno p è in realtà un riadattamen-to grafico della runa wynn) 53, la s tonda in tutte le posizioni, iniziale, me-diana, finale (fig. 1).
Altre lettere da menzionare sono la y, anch’essa in tre forme: le pri-me due molto simili, si distinguono solo per il fatto che il secondo ele-mento desinente sotto il rigo termina talvolta con un evidente empatte-ment, talvolta ne è invece privo (fig. 2, prima forma a fine r. 1, « fyr », r. 4,«þasynfullan »; seconda forma fine r. 2, « himhirdon»); la terza, che è laforma tradizionale della lettera nella minuscola insulare, è invece più pic-cola, con un primo elemento curvo simile a una s, terminante sotto il rigo,
dovuta a KER, Catalogue of Manuscripts cit., p. 464: «The script is a square Anglo-Saxonminuscole of s. X2, which varies somewhat in appearance, bus is almost certainly in one handthroughout : a has a straight, sloping top : regular high e ligatures, including the ea ligature: tall i occurs before n : low, round and long forms of s, but the last does not occur finally: straigth-limbed, rounded, and f-shaped y, the first two sometimes dotted. Accents mainlyon long monosyllables. Headings in Latin are in square black capitals (f. 80v-94), and hea-dings in OE in the script of the text. Zoomorphic and knotwork initials on ff. 49, 106v, 112;others plain black capitals ». Si veda anche l’accurata analisi della SISAM, The Vercelli Bookcit., p. 20 sgg.
51 È prevista una riproduzione digitale integrale del VB a cura di Roberto Rosselli delTurco e dei suoi collaboratori.
52 Cfr. KER, Catalogue of Manuscripts cit., p. XXV sg.53 Sull’accoglimento nella scrittura anglosssone dei due segni runici ᚦ (thorn) e ᚹ (wynn)
LUISELLI FADDA, Tradizioni manoscritte cit., p. 28 sg.; PAGE, An Introduction to English Ru-nes cit., p. 186 sgg.
536
IL VERCELLI BOOK NELLA TRADIZIONE GRAFICA ANGLOSASSONE
e il secondo elemento prodotto da una breve rotazione della penna versodestra, costituito da un breve tratto parallelo all’attacco del primo tratto edesinente in un pesante stacco verticale (fig. 2, r. 7, terzo «mycel »); la p,che si distingue dal segno utilizzato per la semivocale bilabiale /w/ per ave-re un occhiello più grande e costituito da un tratto che termina sull’asta di-scendente a uncino (fig. 2, r. 5, «Petrus », e cfr. il « ƿite » del r. 1).
Elementi peculiari sono anche le legature della e a destra (che sonopoi tutto quel che resta del sistema delle legature dei precedenti stadi del-la minuscola insulare 54): nelle figg. 1 e 2 si possono osservare et, ea, eg, eo(fig. 1, rr. 1 e 2: «Petrus », « ealdor þegn», « dreorig »), en, un’altra formadi et (fig. 1 r. 4, « hælendes »; r. 7 e fig. 2, r. 1, « ðæt »), es (con s minusco-la), ec, er (fig. 2, r. 1, « neoðemestan », « ece »; r. 5, « bereð »). Si noti anchel’assimilazione grafica æ, che sembra ricorrere solo quando il segno ha uneffettivo valore fonetico (come a fig. 2, r. 1, « ðæt », r. 2, « ƿæs»), ma nonquando la pronunzia delle due vocali è disgiunta (fig. 2, r. 4, « cear »).
Altre lettere e forme grafiche sono comuni della tradizione insulare:f e g semionciali, r a forma di n con il primo tratto desinente sotto il rigo,attacchi delle aste alte a spatola (nel Vercelli Book molto evidenti, e pro-dotti con un movimento speciale della penna, che traccia prima un sottile
54 KER, Catalogue of Manuscripts cit., p. XXXII sg.
537
Fig. 1. Partic. del f. 84v - riproduzione autorizzata.
ANTONIO OLIVIERI
filetto obliquo e attacca poi il vero e proprio wedge), ð di forma oncialecon l’asta piuttosto breve, che si prolunga quanto la lettera, mediante il ta-glio dell’asta, rappresenta il suono interdentale fricativo /th/. Occorre poi,come si diceva di sopra, porre bene in evidenza che il Vercelli Book con-divide con altri celebri e meno celebri manoscritti angloassoni coevi, unasemplificazione delle forme della Square minuscule mediante l’abbandonodi forme di lettere e legature caratteristiche delle prime fasi della scrittura:abbandono della a semionciale, della c alta, della legatura ti con i desinen-te sotto il rigo 55.
Un’ultima annotazione sulle scritture distintive, vale a dire sulle scrit-ture speciali usate per i titoli – quando esistano elementi paratestuali assi-milabili per funzione al concetto moderno di titolo –, per la prima linea diun testo, per i capilettera. Per quanto ne so alle scritture distintive dei co-dici contenenti opere in antico inglese non è stato dedicato uno studio spe-cifico. Neil Ker ha dedicato però ad esse alcune interessanti osservazioni,rilevando come anche in questo ambito si abbia nel X secolo una distin-
55 Si veda, per esempio il ms. Cambridge, Corpus Christi College, 183 <http://parkerweb.stanford.edu/parker/actions/page_turner.do?ms_no=183>
538
Fig. 2. Partic. del f. 85r - riproduzione autorizzata.
IL VERCELLI BOOK NELLA TRADIZIONE GRAFICA ANGLOSASSONE
zione funzionale nella scelta delle scritture d’apparato a seconda della lin-gua: per i testi in latino la scelta cadde sulla capitale rustica, aderendo co-sì alla tradizione della carolina, mentre per i testi in antico inglese si adottòla capitale quadrata o l’onciale. Titoli e capilettera – seguo sempre Ker –venivano vergati in genere ricorrendo allo stesso inchiostro del testo. Lescritture distintive del Vercelli Book corrispondono bene a questi caratte-ri 56, sono infatti tracciate con lo stesso inchiostro marrone scuro del testo,salvo per pochi limitati casi concentrati ai ff. 71v-76v, dove venne usato ilrosso per i titoli, vergati con la stessa scrittura del testo e con modulo unpoco più grande, e per la prima o le prime parole del testo, scritte invecein capitale quadrata di modulo maggiore 57.
Titoli come quello riprodotto a fig. 3 sono presenti soltanto nei fogliappena citati, in testa alle omelie XI-XIV. Altrove il comportamento delloscriba è stato diverso: l’omelia XV ha un titolo latino in capitale quadrataabbastanza regolare (80v, una assimilazione me e una c quadrata) e lo stes-so accade per le omelie XVI-XVIII, i cui titoli appaiono però, almeno neiprimi due casi, piuttosto sgraziati (85v, 90v, 94v). Non ci sono nel libro al-tre scritte distintive con funzione di titolo. L’omelia II (9v) è aperta da unprimo rigo in capitale quadrata di grande formato, con un capolettera dimodulo maggiore ma privo di decorazione e una e onciale. In capitale qua-drata di grande formato sono anche il primo rigo dell’omelia XX (109v) eil primo rigo dell’omelia XXI (112r). In quest’ultimo caso però l’iniziale m
56 SISAM, The Vercelli Book cit., pp. 19 sg. (ornamentazione), 25 (capitali).57 Corrispondenti alle omelie XI-XIV, fascc. 9 e 10: op. cit., pp. 11, 15, 20.
539
Fig. 3. Partic. del f. 76v - riproduzione autorizzata.
ANTONIO OLIVIERI
di «men» è costituita da una grande lettera onciale decorata con una pro-tome zoomorfa e motivi fitomorfi, mentre a f. 109, dopo alcuni tentatividi tracciare dei grandi capilettera m in capitale quadrata, poi erasi, lo spa-zio venne lasciato bianco. A f. 106v è presente un m decorata praticamen-te identica a quella del f. 112r. L’unica altra iniziale decorata si trova al f.49r: anch’essa a penna dello stesso inchiostro del testo, è una h con moti-vi zoomorfi e vegetali, dello stesso stile delle altre due.
Celia Sisam ha citato a confronto due h simili presenti nel celebre ms.Junius 11 della Bodleian Library dell’Università di Oxford 58. Si potrebbe-ro fare altri esempi cui accostare le tre iniziali decorate del Vercelli Book,tra i quali alcune delle magnifiche iniziali del ms. Harley 5431 della Briti-sh Library 59, cui anzi mi sembrano più vicine, fatto salvo il livello infe-riore del Vercelli Book. Sarebbe, ancora una volta, opportuno un richiamo
58 SISAM, The Vercelli Book cit., p. 19: « similar, though inferior, to the zoomorphic ini-tials in Junius 11 » (si vedano in partic. le pp. 58 e 143 del cit. ms.). Il Junius 11 è riprodot-to in facsimile fotografico nel sito «Early Manuscripts at Oxford University » e consultabi-le all’URL http://image.ox.ac.uk/show?collection=bodleian&manuscript=msjunius11.
59 Una regola di san Benedetto in minuscola carolina di data vicina al Vercelli Book:scheda e riproduzioni di alta qualità all’URL http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=7321&CollID=8&NStart=5431
540
Fig. 4. Partic. del f. 112r - riproduzione autorizzata.
IL VERCELLI BOOK NELLA TRADIZIONE GRAFICA ANGLOSASSONE
a un contesto più ampio, che è poi quello della tradizione decorativa del-le iniziali librarie nell’Inghilterra del X secolo, studiata da Francis Wor-mald in un articolo fondamentale del 1945 60. Basterà qui dire che, anche
60 Cito qui la riedizione in volume: F. WORMALD, Decorated Initials in English Manu-scripts from A.D. 900 to 1100, in ID., Collected Writings, I, Studies in Medieval Art from theSixth to the Twelfth Centuries, Edited by J. J. G. ALEXANDER, T. J. BROWN, J. GIBBS, Lon-don 1984, pp. 47-75.
541
Fig. 5. Partic. del f. 49r.
ANTONIO OLIVIERI
nel caso dell’ornamentazione delle iniziali, si osserva nell’Inghilterra del Xsecolo un convergere degli elementi propri della cultura insulare – in que-sto caso costituiti dai motivi zoomorfi – con componenti di ispirazioneclassica mutuate dalla grande cultura carolingia – quali la decorazione a fo-glie d’acanto –, che i miniatori inglesi potevano osservare in manoscrittidecorati al modo del celebre Sacramentario dell’arcivescovo di Metz Dro-gone (826-855) 61.
Iniziali decorate a parte, il linguaggio grafico delle scritture distintivedel Vercelli Book appare simile a quello dell’Exeter Book e dei manoscrit-ti ad esso associati 62. Occorre però dire che le scritture distintive del co-dice conservato a Vercelli non rispondono ad un progetto coerente di or-ganizzazione della demarcazione del testo. Ma questa scarsa coerenza, co-me è noto, è un tratto comune ad altri aspetti di questo celebre libro.
ANTONIO OLIVIERI
61 Paris, Bibliothèque Nationale, ms. lat. 9428, di cui si veda la riproduzione digitale al-l’URL: ark:/12148/btv1b60000332
62 R. GAMESON, The origin of the Exeter Book of Old English poetry, in «Anglo-SaxonEngland», 25 (1996) pp. 135-185.
542