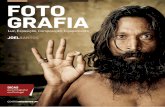Roger Ballen: Immagini dal Sudafrica attraverso l'ambigua lente della Fotografia
Transcript of Roger Ballen: Immagini dal Sudafrica attraverso l'ambigua lente della Fotografia
2 | P a g .
GLI UOMINI DI ROGER BALLEN:
Immagini dal Sudafrica attraverso la lente ambigua della fotografia
Indice degli argomenti:
0. Introduzione………………………...……………………………………….……………………….. pag. 2
I. Conoscere:
1.1 Chi è Roger Ballen? L’uomo, il fotografo e la sua fotografia……………………….pag.3
1.2 I primi lavori: Le serie Dorps: Rural town of South Africa e Platteland: Images from
rural South Africa………………………………………………………………….…………pag. 6
1.3 Sorpassare un orizzonte fotografico: Il progetto Outland e i successivi Boarding
House e Shadow Chamber…………………………………………...………………………pag.8
1.4 Afrikaaner: L’influenza dal contesto sociale e il confronto con i fotografi sudafricani
David Goldblatt e Santu Mofokeng…………………………………………………...…pag. 13
II. Capire:
2.1 I ritratti di Roger Ballen: surreale realismo…………………………………...………..pag. 18
2.2 L’immaginario simbolico: linee, maschere, bambole e zoomofismo……………..pag. 23
2.3 Scelte stilistiche: Il formalismo tecnico di Ballen………………………………...…..pag. 27
2.4 Roger Ballen e Diane Arbus: estetiche ‘freaks’ a confronto……………………......pag. 29
III. Guardare: Analisi visuale
3.1 Immagine 1: Sickroom; 2000……………………………………………………………...pag. 33
3.2 Immagine 2: Loner; 2001…………………………………………………………………..pag. 34
3.3 Immagine 3: Alter Ego; 2010. ……………………………………………………………pag. 35
3.4 Immagine 4: Die Antwoord; 2012………………………………………………………..pag. 36
IV. Vedere:
4.1 Asylum of the Birds: Roger Ballen oltre la sua fotografia…………………………..pag. 38
4.2 Intervista con Roger Ballen. Roma, 25 Settembre 2014. …………………….……..pag. 43
V. Lista delle immagini ……………………………………………………………………............pag. 46
Bibliografia…………………………………………………………………………………......pag. 47
3 | P a g .
Introduzione
Questo progetto di ricerca su Roger Ballen
nasce, paradossalmente alla sua fotografia, in
piena Europa e quasi accidentalmente.
Ricordo che verso la fine del 2013, durante
un periodo di studio all’estero, volli assistere
0.Shadow Chamber, Apparences, 2003 ad un’esposizione personale dell’artista presso
la Nikolaj Kunsthallen di Copenhagen dopo aver visto i manifesti pubblicitari con l’immagine
Apparences (2003) sparsi per tutta la città. Questa composizione bizzarra e straniante aveva per me
qualcosa di assolutamente intrigate e scioccante allo stesso tempo, aveva un punctum come
direbbe Barthes.
Le pagine che seguono cercano dunque di tracciare l’evoluzione della ritrattistica e più in generale
del ruolo della figura umana all’interno della fotografia di Roger Ballen ed insieme di
contestualizzarli. La ricerca bibliografica si è basata fondamentalmente sulle pubblicazioni ed i
cataloghi dello stesso Ballen, fortunatamente reperibili quasi tutti tra la provincia di Bologna, Forlì-
Cesena e Modena, e su di un cospicuo numero di articoli. Essendo la lingua inglese utilizzata in
buona parte delle letture, si è resa necessaria una mia traduzione per procedere poi con la stesura
scritta. Parallelamente, il fortunato contatto tramite posta elettronica con Roger Ballen e il suo
assistente Sami Modli mi ha consentito un avvicinamento maggiore alla materia, nonché la
possibilità di un incontro ed intervista in occasione dell’esposizione personale del fotografo presso
il MACRO di Roma, all’interno del festival FOTOGRAFIA: PORTRAIT.
Se Ballen ha affermato che la fotografia è stato un medium per esplorare il suo Io e la psiche
umana, questo progetto è stato per me un modo per tentare di andare in profondità nel significato
delle sue immagini e della fotografia stessa.
4 | P a g .
Conoscere
1.1 Chi è Roger Ballen? L’uomo, il fotografo e la sua fotografia.
“Apprendere il mondo attraverso la fotografia può avere risultati felici o disastrosi:
dipende solo da come un semplice fatto verrà mostrato:
isolato, staccato o no dal suo contesto di tempo, di luogo e di umanità.”
Henri Cartier-Bresson
Il 1973 è l’anno dall’effimera tregua all’interno del sanguinoso conflitto tra Vientnam e
U.S.A., della nascita della musica Punk sudafricana in risposta all’ Apartheid e delle proteste dei
giovani Hippies negli Stati Uniti. Il 1973 è anche l’anno in cui il ventitreenne Roger Ballen, fresco
di una Laurea in Psicologia presso la Berkley University (California), perde prematuramente la
madre, decide di impegnare sé stesso con la fotografia e di partire per il viaggio che definirà la
prima parte della sua produzione fotografica, riassunta nella serie Boyhood (1979). Così come Henri
Cartier-Bresson aveva fatto nel 19311, anche Ballen sceglie l’Africa quale meta del viaggio di
iniziazione verso il medium fotografico, e nell’arco di quattro anni attraversa il continente da Il
Cairo a Cape Town, salvo poi spostarsi da Istanbul alla Nuova Guinea, ritornando e soggiornando
infine per un periodo più lungo in Sud Africa.
“Ho ricevuto una vera introduzione alla Fotografia e ho sviluppato una passione per qual
campo dall’età di 23 anni. C’erano tutte queste foto appese alle pareti dateci da vari fotografi o che
mia madre aveva comprato. Ho finito per assimilarle e quando ho iniziato a fare fotografia
seriamente, avevo una specie di subconscia idea del livello a cui aspiravo ”2, ha dichiarato Ballen.
La “vera introduzione” a cui fa riferimento è quella regalatagli dalla madre, editrice per l’agenzia
Magnum Photography nonché fondatrice di una delle prime gallerie d’arte fotografica negli Stati
Uniti, grazie alla quale il giovane Ballen entra in stretto contatto visivo con i lavori di Cartier-
Bresson, Eliott Erwitt e soprattutto André Kertesz, artisti che per sua stessa ammissione influenzano
profondamente la sua poetica e sguardo fotografico.
Instaurando nuovamente un’analogia con la figura istrionica di Henri Cartier-Bresson, anche
Roger Ballen si interessa brevemente alla pittura sempre a ridosso del 1973, guardandosi bene però
dal mantenere l’arte quale dimensione parallela al suo percorso accademico e di vita. La pittura di
Ballen, composta essenzialmente disegni e schizzi a matita, sembra preparare ulteriormente il
terreno per la sua fotografia, defilandosi in un primo momento e riaffiorando, come vedremo,
soltanto in seguito sotto forma di elemento delle sue composizioni fotografiche più mature. La
5 | P a g .
fotografia per Roger Ballen rappresenta quindi inizialmente una fidata compagna di viaggio, un
medium per catturare esperienze bizzarre ed extra-ordinarie attraverso le quali “darsi un senso di
compiacimento” e “tuffarsi dentro sé stessi”2.
Il fuoco dell’arte si rende inevitabilmente visibile già nei primi lavori: l’approccio di Ballen è
istintivo ma lucido e attento allo stesso tempo e riesce così a cogliere le sfumature della realtà
nell’ istante decisivo, così come Cartier-Bresson e a seguire Hine, Evans e Frank l’avevano inteso.
Le numerose immagini in bianco e nero scattate a molteplici soggetti ma in particolare a giovani
incontrati in wasteland3 tra Africa, Asia e Stati Uniti, si trasformano infine, a distanza di tempo e
spazio, in un libro fotografico, Boyhood appunto, nel biennio 1977 – 1979 al ritorno di Ballen in
America.
Nelle parole dello stesso Ballen il progetto Boyhood è una sorta di tentativo di ritrovare l’infanzia o
più probabilmente di elaborarla. I ragazzini qui ritratti appaiono sorridenti e giocosi, ma non sono
semplici passanti della fotografia di strada (Immagine 1 e 2). Il fotografo inizia già qui a gettare le
basi della sua interazione con coloro che vengono ritratti, basti vedere lo sguardo fisso in camera
del bambino in Blown up boy, East Malesia (1976), oltre a non distaccarsi dall’uso del bianco e
nero. In Ceylon (1979) appare poi evidente come la composizione, intesa come ritmo di superfici,
linee e valori da cogliere nella realtà (Cartier Bresson,
2006),sia già insita nell’occhio di chi scatta.
Nel 1982, dopo aver conseguito un Phd in Geologia,
Ballen torna definitivamente in Sud Africa, paese nel quale
si era sentito “a proprio agio nonostante i problemi legati
alla politica dell’Apartheid”4. Questo ritorno, seppur spinto
da motivi lavorativi legati alla sua attività di geologo e di
natura personale, segna definitivamente il suo sguardo di
fotografo ed in particolare la scelta dell’elemento umano da
cogliere. I biografemi di cui ha scritto Barthes5, si instillano
così nella sua attività fotografica che si lega
indissolubilmente alla sua vita e di conseguenza al
contraddittorio contesto sudafricano.
1. Boyhood, Blown up boy, Malesia 1976
6 | P a g .
Nel corso degli ultimi trent’anni perciò
Roger Ballen, dopo aver scelto di vivere
stabilmente in uno dei paesi
antropologicamente più stratificati e
artisticamente più indipendenti, ha iniziato
un viaggio fotografico che come vedremo,
ha modificato gradualmente il suo sguardo
dapprima influenzato dalla neutralità
scientifica del suo lavoro di geologo.
Verrebbe quasi da dire che la fotografia sia
stata per Ballen una sorta di vocazione
illuminata. Un’epifania, come .
2. Boyhood, Ceylon, 1979 scriverebbe Joyce, e che il Sud Africa, libero dai
condizionamenti dell’arte contemporanea occidentale, sia stato lo specchio più adatto per riflettere
la sua mente di uomo e di artista.
La visibilità delle immagini di Ballen è in costante crescita soprattutto dall’inizio degli anni
Duemila, dalla pubblicazione cioè del suo quarto libro Outland, grazie alla relativa espansione del
mercato dell’arte contemporanea extra occidentale e alle sua collaborazione con la popolare band
sudafricana, non a caso composta da discendenti di etnia boera, Die Antwoord. Negli ultimi anni la
sfera artistica di Roger Ballen ha prevalso ed è finalmente diventata l’unica occupazione del
fotografo.
Recentemente Ballen ha istituito una sua Fondazione5 al fine di dare spazio al campo dell’
educazione e della cultura fotografica contemporanea in Sud Africa, ed affianca sempre più alla
pubblicazione dei suoi volumi fotografici numerose esposizioni personali in gallerie e musei di tutto
il mondo.
1. Nel 1931 Henri Cartier-Bresson, a 22 anni, viaggia in Africa acquistando in Costa D’Avorio la
sua prima Leica ed avvicinandosi definitivamente alla tecnica del reportage fotografico. Nel
1947 invece insieme ai colleghi Robert Capa, David Seymour, George Rodger e William
Vandivert fonda l’ agenzia Magnum Photography, per la quale la madre di Ballen lavorerà in
qualità di editore (Henri Cartier Bresson, 2005).
2. Roger Ballen intervistato da Jonathan Blaustein per la rivista Photo Editor, Marzo 2013.
Trad.mia.
3. Wasteland, tradotta in Italiano come “Terra desolata”, è qui usata nella sua duplice accezione,
fisica e psicologica, originaria dell’omonimo romanzo di T.S. Eliott.
4. Vedi nota 2.
5. Roland Barthes ,“La Camera Chiara” ,Einaudi editore 1980. p.38
7 | P a g .
1.2 I primi lavori: Le serie Dorps: Rural town of South Africa e Platteland
“Vedere non è abbastanza, devi sentire quello che fotografi.”
André Kertesz
“ Credo che il periodo dal 1982 al 1986, quando
ho lavorato alla serie Dorps, sia stato il
momento più importante nella mia carriera
fotografica. È coinciso con la definizione di me
stesso. A causa del fortissimo sole sudafricano
ero impossibilitato a fare fotografie in esterno,
così fui costretto a spostarmi dentro le
abitazioni, andai all’interno sia fisicamente che
metaforicamente”6 ha affermato Roger Ballen. È
infatti dopo il definitivo trasferimento in Sud
Africa che la sua fotografia riconosce la sua
vera materia: bussando alla porta di isolate case
3. Dorps, Bedroom of a railway worker, De Aar, 1984 ai margini delle metropoli, Ballen scopre un
universo fatto di cavi elettrici penzolanti, segni incisi sui muri e in ultimo, introduce i soggetti
umani tipo con i quali collaborerà da lì in avanti. In Bedroom of a railway worker, De Aar (1984)
Ballen, senza interagire o modificare lo scenario, immortala per la prima volta quei fili elettrici che
diventeranno parte inscindibile del suo bagaglio simbolistico. Il risultato è un ambiente pregno di
storia di “vita vissuta” ma al contempo quasi surreale per la sua stranezza.
Mentre lo stile dell’autore rimane e rimarrà fedele all’uso della pellicola in bianco e nero e
dell’obbiettivo 80 mm, è evidente come in Dorps e Platteland il fotografo si sia trovato interessato
da due opposti modus operandi fotografici: il reportage documentario, con soggetti “trovati” nei
loro movimenti naturali o immagini di quotidiane abitazioni, e le foto innegabilmente pensate in
posa di Sudafricani inquieti e inquietanti in stile Arbus, scattate all’interno di abitazione sghembe e
sperdute.
I soggetti umani, per lo più Afrikaaner, e più in generale i luoghi del Sudafrica che Ballen decide di
ritrarre in questa prima fase vengono sempre definititi geograficamente, temporalmente e
sociologicamente. Platteland in lingua Afrikaans significa appunto “terra piatta” , in riferimento
alle realtà pianeggianti ad ovest di Johannesburg con cui Ballen si scontra grazie al suo lavoro di
geologo. I “Poor Whites” che le abitano vengono inseriti dall’autore in un preciso contesto sociale e
8 | P a g .
temporale. Ballen ha ancora il bisogno di specificare l’occupazione lavorativa del Sergente F. de
Bruin , un po’ come aveva fatto August Sander nel sua collezione antropologica Uomini del XX
Secolo , seppur senza le stesse pretese di accuratezza scientifica.
La serie Dorps. Small towns of South Africa (1986) e Platteland (1994), entrambe pubblicate
in volumi fotografici, esprimono quindi la necessità di Ballen di catturare la natura espressiva di
piccoli e marginali villaggi del Sud Africa e dei suoi abitanti, di definire un’ estetica dell’inusuale
prima che di compiere un analisi psicologica su se stesso. In questo senso Ballen adempie ai
requisiti dell’instancabile fotografo documentario, sulle orme di Walken Evans, Robert Frank e
altri, ma “diversamente da Evans, Ballen intuisce che la realtà documentaria è più mutevole che
stabile”7.
4. Platteland, Sergeant F de Bruin, Orange Free State, 1992
6. Roger Ballen Foundation :
http://www.rogerballen.org/
7. Robert A. Sobiezek su Ballen, prefazione del volume Boarding House, 2005.Trad. mia.
9 | P a g .
1.3 Sorpassare un orizzonte fotografico: Il progetto Outland e i successivi Shadow Chamber
e Boarding House
“Mi è sempre parso che un’ambiguità veramente artistica e veritiera - se mi è concesso usare una frase
così paradossale - sia la più perfetta forma di espressione. Nessuno vuole sapere nulla in realtà…oserei
dire che l’ambiguità nasca dall’evitare scontate e superficiali verità.”
Stanley Kubrick8
Dopo una pausa durata tutta la seconda metà degli anni Novanta, nel 2001 Ballen
pubblica per la prima volta con la casa editrice Phaidon il volume Outland valicando quello che
era stato il suo personale orizzonte fotografico di stampo documentario sino a quel momento. Le
sue fotografie continuano ad essere contingenti 9
, il fotografo persiste nell’ usare un
apparecchio analogico e perciò quello che lo spettatore vede è realmente presente, ma le
immagini non sono più facilmente codificabili perché l’autore inizia ad intervenire sui soggetti
fotografati: Persone, oggetti o animali che essi siano.
Non è forse un caso che ciò avvenga dopo la fine del regime dell’Apartheid: La materia
fotografica che prima Ballen si premurava di cogliere ed esprimere, ovvero la condizione
isolata, di estrema povertà e soprattutto taciuta di bianchi sudafricani ora non ha più ragione
d’essere. Con l’apparente rottura della segregazione sociale dei suoi soggetti il fotografo è in un
certo senso libero di porre se stesso al centro della opera e di creare “immagini sempre più
complesse e sempre più chiare in termini di intensità di visione”10
, in quella che può essere vista
come una discesa psicologica nella mente di chi scatta.
Come in Blow Up di Michelangelo Antonioni, anche nelle fotografie di Roger Ballen ora
lo spettatore attento si trova a domandarsi dove risieda la verità nei frammenti di realtà
fotografica che gli vengono proposti, ma invano. Nella serie Outland, come nelle successive
Shadow Chamber (2005) e Boarding House (2009) la rassicurante realtà documentaria del
medium viene a mancare, sostituita invece da un surreale iper-realismo di un mondo duplicato e
“teatralizzato” come lo definirebbe Susan Sonntag.L’immaginario del fotografo si arricchisce
così di oggetti carichi di simbolismo, ma non modificati essi stessi come facevano i primi
surrealisti sulla scia di Breton: stratificazioni di primordiali disegni appaiono sui muri, i cavi
elettrici si moltiplicano, gli animali vengono inseriti con pari notabilità degli esseri umani, in
funzione di una definizione dell’universo interiore di Ballen così come, per riflesso, di
qualunque altro fruitore.
10 | P a g .
5. Outland, Portrait of sleeping girl, 2000
6. Outland, Puppy between feet, 1999,
Nello specifico, Portrait of a sleeping girl del
2000, contenuto nella serie Outland incarna perfettamente il passaggio di transizione di Ballen
dall’impronta documentaria dei primi lavori all’elaborazione di una visione fotografica strettamente
personale che può essere definita surreale, iper-reale, o oltre-reale. Nell’immagine infatti sono
presenti per la prima volta i tipici disegni ricreati sulla parete in secondo piano e al contempo il
volto della bambina. Nei lavori successivi invece, questa doppia presenza tautologica volti-segni
non Si ripresenterà praticamente più.
In un’altra fotografia-chiave della serie invece, Puppy between feet (1999), è racchiuso il
passaggio di Roger Ballen verso una più variegata vicinanza focale con i propri soggetti. In
quest’immagine infatti il fotografo si avvale di una macro lente da 90mm, anziché quella utilizzata
fino ad allora da 80mm, in modo da potersi avvicinare di più, sia fisicamente che concettualmente.
La “giusta distanza” imposta dalla fotografia di reportage svanisce gradualmente per lasciare spazio
all’immaginario mutevole e ambiguo di Ballen.
11 | P a g .
Se Outland assume i tratti di un progetto di transizione, appare coerente ciò che Robert A.
Sobiezeszek scrive nel’introduzione della successiva pubblicazione di Ballen, Shadow Chamber
(2005):
“Un fotografo come Roger Ballen è portato a smettere di pretendere che il suo compito sia quello
di rappresentare il mondo; lui sa, ora più di prima, che il suo compito è quello di crearne
uno…Così come il romanziere crea parole partendo da quello che è il linguaggio, il fotografo
modella la realtà attraverso le immagini, compiendo un’ azione ancora più sconcertante,
disturbatrice e radicale”11
.
In termini visivi, questo si traduce con una riflessione sul ritratto e lo still-life, con una crescente
attenzione alla composizione e con la scomparsa o modifica dell’elemento umano. I soggetti di
Ballen, ancora per lo più Afrikaner, ora non forniscono più al fruitore alcuna indicazione sulla loro
reale condizione, ma iniziano a coprirsi con maschere o ad essere sostituiti da inquietanti manichini
e bambole (vedi immagine 7). Al contempo le immagini iniziano ad arricchirsi di quelli che
diverranno i suoi riconoscibili stilemi: cavi elettrici, animali e disegni stilizzati impressi sulle pareti.
Il tutto fotografato in ambienti chiusi, ma assolutamente non in studio, abitazioni private
probabilmente di cui però non ci è dato sapere e che l’autore è solito chiamare “The Shadow
Chamber Building”.
È il principio del distaccamento di Ballen dalla realtà del Sudafrica e dell’avvicinamento ad
un tipo di surrealismo che riflette la realtà interiore di chi fotografa. Allo stesso tempo la storia e
l’impronta del contesto sociale faticano a staccarsi del tutto dale sue fotografie e sfogliando
Shadow Chamber ancora si trovano immagini
ambigue con una forte impronta di reportage, come
nel caso di Lunchtime (2001, vedi immagine 8). La
difficile codifica di queste immagini porta quindi il
fruitore di esse a porsi sempre più domande
riguardo la loro origine, significato e locazione
spazio-temporale.
7. Shadow Chamber, Chamber of the Enigma,2003
12 | P a g .
8. Shadow Chamber, Lunchtime, 2001 9. Shadow Chamber, Head inside a shirt, 2001
L’evoluzione fotografica di Roger Ballen prosegue con la pubblicazione di Boarding House
nel 2009. In questo progetto l’immaginario di Ballen si arricchisce ulteriormente intensificando la
consistenza delle superfici, accentuando i giochi di luci in bianco e nero e curando la composizione
fino a giungere ai picchi di astrattismo propri di Kertesz, dichiarata fonte d’ispirazione. Anche i
soggetti perdono il loro ruolo centrale per diventare parte di un tutto, smettono di guardare in
camera ed anzi i loro volti si oscurano quasi del tutto: nascosti da mani, rifugiati dentro abiti
consunti, fasci di ombre o sostituiti da disegni e animali sovrapposti ad essi in un sapiente gioco di
accumulo di feticci. Le immagini diventano sempre più disturbanti per lo spectator12
perché
l’operator12
Ballen instilla sempre più la sua visione nella realtà che ritrae, ma per contro la
presenza umana si universalizza diventando traccia di emozioni e paure condivise.
Anche i titoli dei lavori di questa serie si semplificano da un lato, ma assumono valenze
vaghe e doppie dall’altro: “Imitazione” (orig. Inglese = Mimicry), “Elogio funerario” (orig. inglese=
Eulogy), “Nascosto” (orig. inglese=Concealed), “Metamorfosi”(orig. Inglese=Metamorphosis),
“Rovistando tra i rifiuti” (orig. inglese= Scavenging) sono parole emblematiche della fotografia di
Ballen e al contempo fanno riferimento al contenuto delle relative immagini senza appesantirle di
una dimensione morale e supplementare.
Le immagini di Ballen che coprono l’arco temporale 1999-2009 appaiono in conclusione
estremamente coerenti dal punto di vista formale e mostrano l’evoluzione di una fotografia basata
sul contrasto a livello contenutistico tra il reale “vissuto” e l’ esplicitazione, sempre più
predominante, di un mondo interiore ricreato e surreale. Il passaggio che avviene è inoltre quello
lento e graduale che dal canone del ritratto arriverà a quello dello still life. È sufficiente porre a
confronto due immagini proprio di Boarding House: Metamorphosis (2006) e l’omonima Boarding
House (2008), per notare la crescente tendenza alla mis-en-scène e progressiva esclusione
13 | P a g .
dell’uomo in quanto unico referente delle immagini
(vedi immagine 10 e 11). Tralasciando i risvolti
psicologici, che tratteremo più avanti, è indubbio
che in questa evoluzione creativa Ballen scolpisca in
modo intellegibile una sintassi fotografica legata al
contempo alla psiche umana e allo specifico
ambiente del Sud Africa.
10. Boarding House, Metamorphosis, 2006
11. Boarding House, Boarding House, 2009
8. Stanley Kubrick in un intervista con Robert Emmet Ginna per Horizon Magazine, 1960. Trad.
mia.
9. Barthes definisce tutta la fotografia contingente ovvero fuori senso e bisognosa di una maschera
per individuarlo.
10. Robert A.Sobieszek su Ballen nell’introduzione del volume Boarding House, 2005 Trad. mia
11. Robert A.Sobieszek citando parzialmente lo scrittore W.H. Glass a pag. 10 dell’introduzione di
Shadow Chamber, Phaidon, 2005. Trad. mia.
12. Secondo Roland Barthes una foto può essere l’oggetto di tre pratiche differenti: L’opearator è il
fotografo, lo spectator è chi fruisce le immagini e lo spectrum è chi è fotografato. Citato da
Alfredo de Paz in Fotografia e Società, Liguori editore,2001. Pag.36
14 | P a g .
1.4 Afrikaaner: L’influenza dal contesto sociale e il confronto con i fotografi sudafricani
David Goldblatt e Santu Mofokeng
“Check it,
I represent South African culture.
In this place you get a lot of different things:
Blacks, Whites, Coloured, English, Afrikaans, Xhosa, Zulu, watookal.
I'm like all these different things,
all these different people,
fucked into one person.”
Whatever man, Die Antwoord
13
“Non si può parlare del Sud Africa senza parlare della politica sudafricana”. Esordisce con
queste parole Roger Ballen nel suo cortometraggio documentario Platteland (1995), ed in effetti
tutta la sua attività fotografica si attua all’interno di un contesto antropologico molto complesso, o
“stratificato” per usare una definizione a lui cara, come quello della società sudafricana.
Quest’ultima appare infatti profondamente segnata dal sistema politico dell’ Apartheid e prima
ancora dalla lunga serie di guerre civili, in particolare, per citarne una su tutte particolarmente
inerente alla poetica del fotografo, quella tra i bianchi boeri o Afrikaans e i bianchi inglesi,
conclusasi agli inizi del secolo scorso con la vittoria dei secondi e la relativa annessione delle
repubbliche boere ai territori britannici.
Quando Ballen si stanzia stabilmente in Sudafrica agli inizi degli anni ottanta infatti la
situazione nel paese è ai picchi massimi di tensione e la popolazione sottoposta ad una quotidiana
violenza sia fisica e che psicologica, vedasi ad esempio l’incarcerazione di Nelson Mandela,
perpetrata dal National Party (NP)14
. Le molteplici etnie, citate nel brano dei Die Antwoord posto
all’inizio di questa pagina, convivono all’interno degli stessi confini politici e geografici ma sono
sottoposte ad un regime segregativo che, ormai dalla fine del secondo dopoguerra, influenza la
politica, la cultura, l’economia e l’urbanizzazione.
In generale, il governo del NP si propone di controllare i flussi di popolazione e il mercato
del lavoro in toto isolando i Blacks all’interno delle cosiddette Homeland o Bantustan (letteralmente
“terre del popolo”), aree desertiche e inospitali a ridosso dei giacimenti minerari, rispetto ai bianchi
residenti negli agglomerati urbani, nelle zone residenziali delle grandi metropoli o in fattorie delle
floride campagne ad ovest del paese. Conseguentemente, soprattutto nel corso degli anni ’60 e ’70,
15 | P a g .
milioni di persone sono costrette allo sfratto e al ricollocamento forzato gestito in toto dal governo
allo stesso modo delle occupazioni lavorative, con cospicue falle.
Un clima politico così denso ed instabile non può che condurre ad una cultura basata su
principi xenofobi, sulla paura del diverso, e ad un settore artistico sterile se non inesistente. Non a
caso, escludendo Ballen, l’unica fotografia a fiorire in quel periodo in Sud Africa è quella di
reportage improntata alla denuncia. Fotografi come David Goldblatt prima e Santu Mofokeng poi,
entrambi nati in Sudafrica, scelgono di ritrarre il dramma di una società basata sulla contraddizione
mostrando la difficile quotidianità a partire da ambienti a loro vicini: quello della nuova piccola
borghesia bianca per Goldblatt e dei neri esclusi o in rivolta per Mofokeng.
12. David Goldblatt, A land owner, his wife and his son having lunch, Wheatlands Randfonteein, Transvaal, 1962
13. Santu Mofokeng, Afoor family bedroom, 1986
16 | P a g .
Roger Ballen decide invece, con la prima parte della sua produzione fotografica, di mettere a
fuoco una crepa del sistema Apartheid: Afrikaans dimenticati dal governo che avrebbe dovuto
garantire loro il privilegio del benessere, abitanti dei Bantustian, lavoratori minerari o contadini. Dal
punto di vista di una fotografia sociale, il primo Roger Ballen sceglie quindi di ironizzare sul
fallimento di un regime insensato incapace persino di adempiere alle proprie promesse fatte ad a
meno del 10 della popolazione totale del tempo15
.
Prima di intraprendere qualunque genere di confronto fra le tre personalità della fotografia
sudafricana, è necessario ricordare che a differenza di Goldblatt e Mofokeng, Ballen non è un
autoctono e si inserisce in una relazione maggiormente distaccata e neutrale con il contesto che lo
circonda. Lo statunitense di nascita inoltre, come già postulato in precedenza, non abbraccia mai
totalmente la fotografia di stampo documentario e, sempre a differenza dei colleghi che
sperimentano invece la fotografia commerciale, mantiene la sua attività fotografica libera da vincoli
editoriali ed economici, indirizzandosi da subito verso un’ottica maggiormente artistica. Va infine
sottolineato che per quanto poveri possano risultare agli occhi di uno spectator occidentale, i
soggetti delle immagini di Ballen restano comunque incasellati nella middle-class sudafricana sulla
base del reddito medio pro capite.
Rispetto a Roger Ballen Santu Mofokeng, anche se suo coetaneo, risulta apparentemente
distante a causa della sua scarsa attenzione all’estetica e alla composizione dell’immagine oltre che
alla scelta dei soggetti. Anche lui però dichiara di essere stato influenzato dalla lezione di August
Sander e di Diane Arbus, oltre che dallo stile documentario di Goldblatt e quando afferma che
“Documentare è raccontare la verità ma alcune verità sono soppresse dalla storia”16
si avvicina in
un certo senso all’universo degli esclusi ritratti dal nostro fotografo.
Con David Goldblatt invece Ballen condivide la ricerca di un ritmo formale all’interno delle
proprie immagini e l’interesse per la minoranza rappresentata dagli Afrikaans. Uno delle prime
raccolte fotografiche di Goldblatt è infatti intitolata Some Afrikaners photographed (1975) ed
anticipa di circa una decade Platteland di Ballen, progetto con il quale condivide innegabilmente il
punto e le impostazioni di partenza: entrambi dichiarano infatti nei titoli delle loro immagini a chi,
dove e quando esse sono state scattate . Dove si trova il bivio tra i due fotografi allora? La risposta
può essere trovata forse nella giustapposizione di una fotografia di Goldblatt con una di Ballen
scattata con contesto e soggetti simili (vedi immagini 14 e 15, pagina successiva).
17 | P a g .
14.David Goldblatt, A plot helder with the daughter of a Servant, Wheatlands Randfonteein, Transvaal, 1962
15. Roger Ballen, Man and maid in northern cape, 1992
Se nell’immagine di Goldblatt ciò che si vede appare perfettamente coerente con il sistema
Apartheid: l’anziano bianco seduto in poltrona, la servetta nera che si copre in parte il viso per
timidezza verso l’apparecchio fotografico, i fiori soprammobili, la fotografia sullo sfondo dello
stesso anziano in gioventù e abiti militari; in quella di Ballen riecheggia una certa dissonanza:
anzitutto i ruoli sono invertiti ed è la giovane nera ad essere seduta in posizione predominante sulla
poltrona mentre il bianco adulto sta ora in piedi a fatica sorretto da una stampella, sullo sfondo non
si trovano più foto di un passato perduto ma poster, di propaganda militare e di stampa
pornografica. In parole Barthiane, si osserva nel primo caso di un immagine studium e nel secondo
di un punctum. La stranezza che riesce a cogliere Ballen è l’elemento che rimarrà impresso lo
spettatore perché differente, è la questione sociale che diventa estetica. Sia Goldblatt che Ballen
comunque vengono guardati con sospetto da afrikaans, bianchi, neri poiché mettono in luce,
volontariamente o meno, una verità minore e scomoda su di una nazione che cerca di rimanere
defilata dalla ressa mediatica occidentale.
Per concludere, sia Goldblatt che Mofokeng che Ballen si sono trovati nella situazione di
confrontare la propria fotografia con un contesto frammentato e disomogeneo. Non è quindi un caso
se tutti e tre i fotografi ampliano il loro raggio d’azione fotografico dopo la fine della segregazione
18 | P a g .
imposta dall’Apartheid, nel 1994: Goldblatt passa alla fotografia a colori, Mofokeng inizia ad
inserire brevi essay a spiegare le sue immagini e Ballen vira verso le surreali profondità della psiche
umana.
Il critico Joan Fontcuberta ha scritto che “la fotografia non impone solo una nuova estetica
nel modo di raffigurare il mondo ma stabilisce anche nuove categorie etiche come la precisione e
l’obbiettività, sottolineando la differenza tra veridicità storica e veridicità percettiva”17
. Risulta
quindi legittimo, seguendo questo filo logico, il ricorso di Ballen a alla trasmutazione della
veridicità storica sudafricana in una realtà percettiva influenzata dalla complessità di una nazione
estremamente difficile, in un processo creativo post-moderno.
.
13. Testo dal brano Whateverman (trad. “Un uomo qualunque”) della band Die Antwoord, con la
quale Ballen ha collaborato alla realizzazione di un progetto fotografico e video nel 2012.
14. National Party: partito nazionalista sudafricano (NP), fondato su principi ideologici vicini al
nazionalsocialismo e composto principalmente da bianchi Afrikaner. Prende il potere
ufficialmente nel 1948 attraverso elezioni politiche a cui solo i bianchi, e parzialmente i coloured
potevano prendere parte.
15. Percentuali tratte da: David M. Smith, The Apartheid city and beyond, 1992 pag. 59
16. Santu Mofokeng in Chasing Shadow, 2011. Pag.16 Trad. mia.
17. Joan Fontcuberta, La (foto)camera di Pandora, Contrasto, 2012. pag.117
19 | P a g .
II. Capire
2.1 I ritratti di Roger Ballen: Surreale realismo
“L’assurdo dipende tanto dall’uomo quanto dal mondo, ed è, per il momento,
il loro solo legame.”
Albert Camus
Nel film Nymphomaniac (2013), un numero di personaggi disturbati vengono ritratti dal
regista Lars von Trier in maniera realistica, attraverso la successione di nove episodi all’interno
di quttro ore di lungometraggio. Se si azzardasse a paragonare queste quattro ore di immagini ai
40 anni di produzione fotografica di Roger Ballen, risulterebbe evidente come in tutti e due i
casi si tratti di un viaggio all’interno della contorta psiche umana, sia nel caso della protagonista
del regista e dei suoi personaggi, sia per quando riguarda il fotografo Ballen. Altra analogia tra i
due prodotti artistici risulterebbe il dramma creato dal contrasto fra la volontà di chi crea,
ovvero Ballen e Von Trier, di imprimere una propria visione e la discontinuità che invece
emerge naturalmente dai soggetti ritratti. È chiaro per il regista danese si tratti di finzione pura,
una realtà angosciante ricreata con attori professionisti, ma anche nel caso delle immagini di
Ballen, soprattutto quelle comprese tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila, troviamo un
numero crescente di soggetti messi “in posa” e in ambienti reali ma teatralizzati, più vicini
perciò ad un set cinematografico che alla fedele documentazione di tipi in stile Sander.
A differenza del predecessore fotografo tedesco infatti, la ritrattistica Ballen non vuole
giungere ad una “schedatura di tipi”, a degli archetipi bensì, per usare le sue stesse parole, egli
vuole “trasformare un individuo in uno statement fotografico”1 attraverso il suo occhio “trans-
psicologico”2. Stravolgendo così la retorica del ritratto fotografico, forzatamente legata
all’istituzionalità. Ballen vuole cioè utilizzare gli archetipi per esprimere le profondità della
psiche umana attraverso di essi. Questo processo avviene soprattutto nella sua produzione
fotografica fino ad Outland, e definita face-centric3.La fotografia Woman, man and dog (1995)
mostrata nella pagina successiva ad esempio, incarna alla perfezione l’archetipo della donna
pazza, o della strega, e al contempo enfatizza la situazione di isolamento nella quale vivono gli
Afrikaans di Ballen: le spalle dell’uomo sono voltate verso la figura femminile e persino il cane
sembra ridere di lei. L’unica azione che rimane da compiere alla donna è aprire la bocca in una
risata forzata ed isterica.
20 | P a g .
La scelta del fotografo di focalizzarsi
solo su una parte ristretta della
popolazione sudafricana è prima di
tutto ovviamente personale ma può
essere forse intesa attraverso una frase
del sociologo francese Jean Baudrillard
(1990) :
“Gli esseri che possono essere
meglio fotografati sono quindi quelli
per cui l’altro non ha esistenza o non ha
più esistenza. Sono i non civilizzati, i
reietti, le vittime, gli oggetti o ciò che è
ridotto allo stato di oggetto… è tale il
prezzo da pagare affinchè sia operante
una sorta di sbigottimento
reciproco…”4
16. Outland,Woman, man and dog, 1995
In quest’ottica prima gli Afrikaans, e poi i manichini e i disegni di astratte figure umane
vengono a ricoprire un ruolo di soggetto ideale per Ballen e per lo spettatore poiché mettono in
luce una realtà sconosciuta e scioccante che può quindi assumere qualunque valore con cui si
decida di caricarla.
Appare inoltre fondamentale l’approccio esplicito che il fotografo ha con i propri soggetti:
Ballen non ruba fotografie ai passanti per strada, ma bussa alle loro porte chiedendo il
permesso, li conosce e frequenta, li fotografa nel corso del tempo e li coinvolge. Come Diane
Arbus aveva fatto in precedenza, l’apparecchio fotografico gli da una sorta di licenza per
integrarsi con personalità uniche e “diverse” e confondere così ulteriormente, oscillando tra un
estremo e l’altro, il labile confine tra identificazione poetica o identità documentaria del ritratto.
Della realizzazione di Prowling (2001), il cui titolo significa letteralmente “aggirandosi
furtivamente”, Ballen racconta di aver conosciuto per lungo tempo sia il ragazzo mascherato da
gatto che la madre, di averli persi a causa dei loro continui spostamenti e ritrovati solo nel 2001
quanto fece questo scatto al ragazzo allora convinto di essere un gatto. Se prima della
spiegazione dell’autore il fruitore si poteva porre in questione l’autenticità dell’immagine,
ovvero se Ballen avesse fatto indossare appositamente la maschera al ragazzo, ora il dubbio è
svelato. L’ambiguità dell’immagine invece resta, destata soprattutto del palmo della mano del
ragazzo intonso dalla vernice di cui invece appaiono impronte sul muro in secondo piano.
21 | P a g .
17. Shadow Chamber, Prowling,
2003
Se in La camera chiara
(1980) Roland Barthes scrive
che “la semiologia della
fotografia è legata ai
ritrattisti”, asserendo quindi
che il ritratto possieda una
capacità verbale oltre che
visuale, nei ritratti di Ballen
questa affermazione viene
capovolta: un po’ come aveva
fatto Mac Adams nella serie
Mysteries (1973-1980), in queste immagini nulla appare esplicito ma tutto risulta ambiguo e
tendente ad una dimensione surreale. Ad ogni modo, nonostante i ritratti di Ballen si evolvano
nel tempo e paradossalmente si svuotino dell’elemento umano, ma le sue immagini continuano a
permeare di un messaggio ed un valore denotativo, legato cioè al vero, oltre che connotativo5.
Per concludere il discorso sulla ritrattistica di Roger Ballen, nei progetti più recenti,
dopo la fine dell’apartheid la figura umana si è come liberata dalla referenza obbligata che
aveva prima nei confronti di ruolo e contesto sociale ed ora si “frammenta”. Forse
inconsciamente il fotografo non ha più la necessità di inserirsi all’interno di un sistema sociale
segregativo: ecco allora che i soggetti non guardano più in macchina ed appaiono mani, piedi,
teste senza corpo che prendono parte a composizioni più ampie.
Non vi è tuttavia disperazione o richiesta di aiuto in questi gesti, vi à piuttosto la
creazione di un rapporto tra un essere animato e altri elementi della composizione, siano essi
animali viventi o esseri inanimati.
22 | P a g .
Si veda a questo proposito un'opera come Bite (2007),dove il braccio, la mano e il dito dello
18. Shadow Chamber, Bite, 2007
spectrum si prolungano nella forma del serpente e trovano il loro corrispettivo nel filo del telefono
e nella cornetta che li sovrastano: una sintesi di tre elementi assurdamente collegati tra loro ma
paradossalmente coerente. Il corpo del soggetto diviene quindi una parte, spesso minoritaria, di un
equilibrio compositivo e bizzarro in grado di donare una ragion d'essere all’immagine. Se il
fotografo sia intervenuto fisicamente sull’animale non ci è dato sapere ma certamente ciò che
rimane dell’uomo è soltanto una sua traccia. L’elemento umano fotografato da Roger Ballen
diviene ancora più universalizzante e denso di stratificazioni ed interpretazioni psicologiche, ed
egli raggiunge così una fotografia unaria, in grado cioè di plasmare il reale senza altresì
sdoppiarlo.
23 | P a g .
Per concludere, se David Goldblatt aveva in precedenza affermato:
“Prima pensavo di voler fotografare gli Afrikaner. Mi ci volle tempo per capire che un progetto del
genere sarebbe stato terribilmente pretenzioso e probabilmente impossibile da realizzare in tutti i
sensi”6
Ballen invece sembra essere riuscito nell’impresa distaccandosi dalla realtà e superando la distanza
sociale e la distanza del tempo, attraverso una personale visione che valica i limiti del reale.
1. Roger Ballen, dichiarazioni rilasciate nel video Platteland (1995). Trad. mia.
2. Ibidem.
3. Ibidem.
4. Alfredo de Paz cita Jean Beaudrillard in, Fotografia e società, 2001, pag. 40
5. Roland Barthes nella sua prospettiva critica strutturalista definisce due impressioni possibili a livello
di ricezione fotografica: quello denotativo, cioè oggettivo, legato alla tecnica e quello connotativo,
cioè di senso intrinseco all’immagine stessa.
6. David Goldblatt, Fotografie, 2006, pag.13
24 | P a g .
2.2 L’immaginario simbolico: Linee, maschere, bambole e zoomorfismo
“…Il fotografo creativo libera i contenuti umani degli oggetti e
conferisce umanità al mondo inumano che lo circonda.”
Charles John Laughlin
Il termine “feticcio”, ovvero un oggetto inanimato al quale viene attribuita un invisibile
forza extra-umana, e in ambito psicoanalitico un significato sessuale acquisito attraverso il
meccanismo di simbolizzazione, aderisce perfettamente alla più recente fotografia di Roger
Ballen, intrisa com’è di oggetti ambigui ed animali enigmatici.Nelle le immagini di Ballen
ricorrono in particolare alcuni oggetti: cavi elettrici, giocattoli, disegni appesi ai muri e
maschere che poi evolveranno in manichini a partire da Shadow Chamber.
Le bambole rotte, pupazzi ed automi angoscianti che si ritrovano nella fotografia di
Ballen sono in realtà oggetti già indagati dall’arte dada, promotrice delle marionette in quanto
veicoli di giochi di ruolo e più ancora dal Teatro del Bauhaus fondato a metà anni venti e
improntato alla “trasfigurazione della forma umana” e alla rivelazione delle “fantasie più
audaci”7. Il denominatore comune delle tre esperienze l’unheimelich freudiano, il perturbante,
ovvero quella “quella sorta di spaventoso che risale a quanto ci è noto da lungo tempo, a ciò che
ci è familiare”8
ma allo stesso tempo estraneo perché generato da una situazione nuova, che crea
una scissione disarmante all’interno del fruitore. Le bambole e i pupazzi che Ballen utilizza
sono infatti un doppio dei suoi soggetti umani, una sorta di sosia, che lo spettatore ricollega alla
fantasia infantile di possibile immortalità non più accettata nella sfera adulta. In aggiunta Ballen
riesce a creare una sensazione di ulteriore disagio
emotivo frammentando i corpi delle bambole e
dei pupazzi in modo da creare nuove forme
compositive e semi-umane sculture da
immortalare poi. Si veda a questo proposito
Kitchen counter (2001), immagine in cui una
testa di bambola è crudamente poggiata su dei
detriti e ospita un inquietante insetto sulle proprie
guance . La percezione di questi assemblaggi
umani possiede forse per Ballen anche un risvolto
19. Shadow Chamber, Kitchen Counter, 2001
25 | P a g .
perversamente erotico ed un richiamo alla paura
della mutilazione e della perdita, ma senza calcare
troppo la mano si può tranquillamente affermare che
un’azione del genere richiama una sorta di memento
mori per lo spettatore.
In realtà un’operazione del genere era già
stata affrontata dal fotografo Hans Bellmer con le
sue Poupeée intorno al 1938 ma con risultati molto
più eroticamente orientati e per nulla legati al
contesto esterno (vedi immagine 20), come invece
continua ad essere Ballen. Per il momento il
fotografo sudafricano d’adozione non ha ancora
esaurito gli stimoli ad utilizzare bambole e pupazzi e
forse la sua prossima evoluzione sarà avvicinarsi a
Bellmer nell’aprire questi feticci giocattolo per
mostrarne l’interno. 20. Hans Bellmer, Anxiety, 1938
Non lascia così tanto spazio di movimento invece l’uso che Ballen fa delle maschere,
dato che in ogni caso, volti dei suoi soggetti assumono la funzione di maschera in senso
mitologico in quanto trasposizione di
turbamenti psicologici. Questi oggetti
possono quindi essere un richiamo all’arte
tribale così come un gioco psicologico:
usare una maschera è per lui il primo passo
per universalizzare il corpo umano e quindi
aprire le porte degli scavi nel subconscio.
Allo stesso tempo il fotografo ne fa talvolta
un uso quasi ironico e giocoso.
Maschere posizionate male o indossate
parzialmente, esattamente come avviene al
protagonista della novella Doppio Sogno di
Arthur Schnitzler durante il fatidico ballo
mascherato8, liberano l’inconscio sia dell’
21.Shadow Chamber, Room of ninja turtles, 2003 operator che dello spectator.
26 | P a g .
Anche per quanto riguarda i disegni sui muri, che Ballen spesso commissiona ai suoi soggetti ,
appare evidente l’influenza dell’arte tribale ed anche dell’art brut, o outsider art , di Jean Dubuffet.
Si tratta spesso di visi e uomini stilizzati, che fungono ancora così da iniettori di sentimento del
perturbante nelle immagini e più in generale rafforzano il senso d’isolamento e degrado che trasuda
dalle pareti delle abitazioni della campagna sudafricana.
I cavi elettrici, in principio presenti a vista in tutte le abitazioni sudafricane, con il passare
del tempo si moltiplicano sempre più prepotentemente nelle fotografie di Ballen ed altro non sono
se non trasportatori di energia, di materia. Come lo erano stati per Joseph Beyus fungono da
metafora per la vita umana aiutando ancora una volta ad abbattere le confuse barriere tra arte e vita
reale. Il fatto che in Cut Loose (2005) i fili sembrino soffocare il soggetto centrale può essere inteso
come un ulteriore spunto di riflessione e introspezione.
. 22. Shadow Chamber, Cut loose, 2005
Questo accumulo di materia inanimata nelle immagini di Ballen crea il nesso con il Nouveau
Realisme di Arman , Gérard Deschamps e Daniel Spoerri . Tutti accomunati dalla volontà di
conferire una nuova identità e significato agli oggetti materiali della vita quotidiana e da un “nuovo
approccio percettivo al reale” come lo definiva il fondatore del movmento Pierre Restany10
. In
27 | P a g .
Ballen manca però la critica al consumismo borghese che avevano mosso i francesi, motivata in
parte dalla sua appartenenza a una generazione successiva o più semplicemente da un suo maggiore
interesse all’universo freudiano del subconscio piuttosto che ai malanni della società post-moderna.
Infine, Roger Ballen inserisce nelle sue fotografie anche “oggetti animati”, come l’uomo
appunto, ma anche piccoli animali: cani, gatti, ratti, conigli… manifestando la sua volontà di porli
sullo stesso piano dialettico della presenza umana. Il suo obbiettivo è dunque creare una
connessione tra l’uomo e l’animale, costruendo una composizione in cui entrambi abbiano
comportamenti analoghi ed interscambiabili, similarmente a quello che aveva fatto una delle sue
influenze fotografiche Eliott Erwitt. È il “divenire animali” descritto da Gilles Deleuze11,
e la sua
accettazione. A questo proposito Ballen dedica un intero libro Animal Abstraction (2011)
raccogliendo solo le immagini in cui sono le figure animalesche, reali o posticce, ad essere soggetti.
23. Shadow Chamber, Trails, 2003
7. Hal Foster, Arte dal 900, 2011. Cap. 1925c pag.214
8. Sigmund Freud, Saggi sull’arte, la letteratura e il linguaggio. Cap. Il perturbante (1919)
9. In Doppio sogno di Arthur Schnitzler…
10. Kerstin Stremmel, Realismo, 2004, pag.13
11. Gilles Deleuze, Abecedario, Ediz. Deriveapprodi, 1996
28 | P a g .
In generale quindi, Roger Ballen sembra riuscire a cogliere la “bellezza lirica”, come l’aveva
definita Kértesz, degli oggetti animati o non, trasformandoli in segni e riuscendo ad incastrare i vari
elementi in composizioni che ben presentano un punctum, e sono in grado quindi di smuovere
emozionalmente chi osserva.
2.3 Scelte stilistiche: Il formalismo tecnico di Roger Ballen
“Tutto, al mondo, esiste per finire in un libro.”
Stephane Mallarmè
Se la scrittrice Susan Sontag ha saggiamente contraddetto la citazione dell’esteta
ottocentesco Mallarmé posta all’inizio di questa pagina, affermando che oggi “tutto esiste per finire
in una fotografia” a causa della coazione alla fotografia12
, Roger Ballen è apparentemente riuscito a
conciliare i due estremi critici. Da una parte infatti, come abbiamo visto, la sua materia fotografica è
disturbante e bizzarra ai limiti dell’osceno, dall’altra il suo approccio estetico e stilistico è
incredibilmente rigoroso: Gli obbiettivi utilizzati sono quelli da 80mm e 90mm, la stampa è
rigorosamente in formato quadrato e Bianco/Nero. Mentre il canale di fruizione preferito è proprio
quello del libro fotografico, come istituito da Henri Fox Talbot con The Pencil of Nature nel 1844.
Dunque riprendendo le fila del discorso lo statement di Ballen risulterebbe “Tutto, al mondo oggi,
esiste per finire in una fotografia, che esiste per finire in un libro”.
Il formato quadrato, usato tra gli altri anche da Diane Arbus, ha successo , così come il
sonetto in poesia, solo quando riesce a mantenere l’equilibrio tra le restrizioni formali e la libertà
concettuale. In Ballen la forma quadrata fa convogliare più facilmente il significato all’interno della
sua struttura, e sfrutta la naturale simmetria visuale. Basti vedere l’immagine Trails (2003) nella
pagina precedente, in cui le figure di una lucertola e un pesce rosso sono immortalate esattamente al
centro dell’immagine, circoscritte in un cerchio. Il quadrato permette al fotografo di prestare
attenzione estrema ai dettagli e all’equilibrio compositivo, considerando che l’occhio dello
spettatore non avrà la possibilità di muoversi sul piano spaziale, e lo spinge ad utilizzare i suoi
“segni” per rafforzare ulteriormente l’immagine dal punto di vista formale.
Per quando riguarda la scelta di Ballen di servirsi di una palette di colori che va dal bianco al
nero, essa presenta una duplice funzione: da una parte l’effetto puramente estetizzante di immagini
de-saturate giocate su contrasti di luci ed ombre, e dall’altra l’affermazione dichiarata dello
specifico fotografico della riduzione della realtà. Rifiutando in toto il colore infatti, il fotografo
29 | P a g .
compie un primo distaccamento dalla realtà e in un certo senso circoscrive il suo campo d’azione
senza tuttavia trasformare ciò che viene fotografato. Si veda ad esempio Study of a boy and plant
(1999) in cui elementi compositivi che nulla avrebbero in comune si conciliano in modo bizzarro
ma credibile grazie all’attenta struttura compositiva e al gioco di luci ed ombre. Va aggiunto che
questo ha un effetto di “strano rovesciamento nella percezione”13
per il fruitore delle immagini,
predisponendo così chi guarda alla stranezza perturbante del contenuto.
Per concludere, sottolineando l’uso costante e fedele di una fotografia analogica, Ballen ha
affermato che usare la fotografia digitale e per poi modificare le proprie immagini sia un po’ come
comprare vestiti della taglia sbagliata per poi cercare di aggiustarli una volta a casa14
. Risiede in
queste parole dunque la ragione del formalismo inaspettato di Roger Ballen.
24. Outland, Study of a boy and plant,1999
12. Susan Sontag, Sulla fotografia, pag.57
13. Elio Grazioli, Corpo e figura umana nella fotografia, 1998, pag. 291
14. Intervista dell’autore con Roger Ballen, Roma Settembre 2014, Trad.mia
30 | P a g .
2.4 Diane Arbus e Roger Ballen: Estetiche Freaks a confronto
“Io non dubito che la maestà e la bellezza del mondo
siano latenti in qualunque loro particella…
Io non dubito che nelle banalità, negli insetti, nelle
persone volgari, negli schiavi, nei nani, nei rifiuti
ci sia molto più di quanto ho immaginato…”
Walt Whitman15
25.Diane Arbus, A young brooklyn family going 26. Roger Ballen. Scrapyard Worker and Family, Central
For a Sunday outing, N.Y.C., 1966 Transvaal, 1993
Siamo già a conoscenza del fatto che sia Diane Arbus che Roger Ballen siano degli
affezionati dello square format, ma le analogie tre i due fotografi si intrecciano ben al di là della
scelta del formato fotografico. Quest’ultimo può essere comunque considerato un punto di partenza
per osservare come entrambi i fotografi preferiscano operare una riduzione di campo spaziale e
analogamente di soggetti.
Come si può osservare nelle immagini sovrastanti, Diane Arbus trova la materia fotografica
ideale negli ambienti urbani di N.Y.C, o comunque degli Stati Uniti perché brulicanti di soggetti
scarsamente adattati alla società, di deformi, di reietti o finti normali, in una sola parola di “freaks”.
Questa categoria di “ultimi uomini”, per usare la schedatura alla Sander, sono scelti anche da Ballen
per i suoi scatti che però traspone il tutto in una nazione a lui estranea ma ricca di “diversi” come
quella sudafricana. Questo spostamento forse permette al fotografo di mantenere un punto di vista
più distaccato e neutrale rispetto a quello più empatico della Arbus. In entrambi i casi comunque i
lavori fotografici che ne risultano sono privi di qualunque sentimentalismo ma estremamente
31 | P a g .
toccanti per l’osservatore. L’obbiettivo comune dei due è quello di proporre un livellamento
dell’umanità, paradossalmente accentuandone le diversità, con la sola postilla che nel caso di Ballen
il procedimento di introspezione psicologica dell’autore risulta molto più esplicito.
Se però Arbus afferma che “il soggetto della fotografia sarà sempre più importante
dell’immagine”16
per Ballen non è esattamente così: rispetto alla Arbus infatti egli non è uno street
photographer puro, e presta molto più attenzione alla composizione formale, intervenendo anche
manualmente sull’ambiente e i soggetti dei propri scatti. Egli non vuole fare “brutte fotografie” in
favore della novità di rappresentazione ma cerca di conciliare i due estremi poetici.
Rimane indubbio comunque che entrambi, almeno per una parte dei loro lavori, abbiano
sperimentato la fotografia di posa. La differenza principale tra i due sta nel fatto che la modifica
di Arbus al contesto ante-scatto rimane legata alla posizione delle figure umane che , nella
stragrande maggioranza dei casi vengo fatti posizionare immobili e goffi precisamente di fronte
all’obbiettivo, mentre Ballen si distacca da questo modello ed interviene ad un livello più
profondo. Nella sua fase più matura infatti, a partire da Outland cioè, Ballen ritrae gli Afrikans
nelle pose più disparate ed innaturali quasi fossero delle One-minute-sculpture di Erwin Wurm
ed inserisce nell’ambiente surreali oggetti-simbolo.
27. Diane Arbus, Identical twins, Roselle, N.J., 1967 28. Roger Ballen, Dreasdie and Cassie, 1993
Come dimostrano le celebri coppie de gemelli in foto, i due condividono uno spiccata
tendenza nel proporre immagini perturbanti basate sul concetto di sosia ed infatti utilizzano
spessissimo coppie di figure come soggetti. Il risultato è spaventoso e grottesco allo stesso tempo
ma i soggetti ritratti sembrano ignorarlo.
32 | P a g .
29. Diane Arbus, Child with a hand toy grenade in Central Park, 1962 30. Roger Ballen, Roar, 2002
Un aneddoto di Ballen sul suo scatto in questione, ovvero la sorpresa nello scoprire il
secondo gemello uscire da una stalla mentre stava per scattare una fotografia al primo, riconduce al
curioso ed aperto approccio dei due nei confronti dei loro spectrum. E per entrambi, come scrive
Susan Sontag, “la rivelazione dell’io si manifesta con ciò che è strano, insolito, sghembo” e che fa
apparire questa folla di freaks in posa “immagini di se stessi”. Per questa ragione identificativa forse
i due fotografi sembrano coltivare la stessa passione nell’immortalare bambini e giovani, che
facilitano un’ immedesimazione introspettiva da parte del fruitore e donano un risvolto naif ed
inaspettato all’estetica dei freaks.
In conclusione, dati i recenti sviluppi di Roger Ballen verso lo still life e la fotografia di
luoghi personificati (vedi Asylum of the birds) è interessante notare come anche Diane Arbus alla
fine della sua carriera si fosse concentrata sull’immortalare vecchi ospedali psichiatrici o manicomi
abbandonati. Sarebbe stato l’inizio per un processo creativo simile a quello di Ballen? Forse,
guardando le ultime immagini di Arbus in cui appaiono sempre più maschere ma non ci è dato
sapere. Quello che ci è dato sapere, o meglio vedere, è l’affermazione di due artisti nel creare una
fotografia che non rifletta un immagine, ma ne colga una per sempre.
33 | P a g .
31. Diane Arbus, Untitled III, 1970-1971
15. Walt Whitman nell’ introduzione al catalogo sulla retrospettiva personale di Walker Evans presso il
MoMa, 1971.
16. Susan Sontag, Sulla fotografia, 1973, pag.33
34 | P a g .
III. Guardare : Analisi Visuale
“La verità si troverebbe nel mezzo? Nient’affatto. Solo nella profondità.”
Arthur Schnitzler
3.1 Sickroom, 2000
Un bambino paffuto e sghignazzante occupa la posizione centrale della disarmante Sickness.
Sotto di lui è disteso un vecchio scarnificato, già protagonista di altre fotografie di Ballen, che tiene
nonostante tutto una sigaretta tra le labbra. Il bambino tiene le braccia aperte creando una croce col
proprio corpo pingue e facendo intuire un presagio di morte per l’altro soggetto. Nell’equilibrio
compositivo che viene retto da questa strana coppia bianca si viene dunque a creare una situazione
di forte contrasto: tra la fisicità del bambino e quella del vecchio, tra l’espressione gaudente di uno e
moribonda dell’altro che riflette gli enormi contrasti della società sudafricana. Non sono presenti
segni evidenti dell’intervento del fotografo ma l’effetto prodotto da quest’immagine è quello di uno
still-life composto da figure animate, profondamente metaforico e perfettamente architettato.
35 | P a g .
3.3 Loner, 2001
In Loner una spoglia croce fatta con sottili rami secchi è appesa in posizione centrale al muro in
secondo piano. La figura di Cristo normalmente annessa ad essa è qui sostituita da una disturbante
bambola dalle fattezze umane il cui collo penzola angosciantemente. Un pezzo di carta sotto questa
composizione reca la scritta “God”, Dio appunto, ed ancora più in basso un uomo senza maglietta e
dai piedi tanto sporchi da essere neri, giace disteso su un letto di fortuna con il volto rivolto verso il
muro. Inaspettatamente, un piccolo cane bianco è appoggiato al fianco dell’uomo e guarda
esattamente in camera fissando chi sta dall’altra parte. Ballen è evidentemente riuscito a catturare
questo momento fugace creando così una scena in cui l’animale sembra guardare con compassione
all’esperienza umana. Il fatto che gli occhi del cane, e del pupazzo-Dio abbiano la stessa
inclinazione e forma e che la parola “dog”, cane in inglese, sia “God” scritto al contrario, rafforzano
questa tesi. La composizione risulta improntata verso la verticalità ma bloccata dal formato
quadrato della foto a marcare l’effetto di trascendenza fallita.
36 | P a g .
3.3 Alter Ego, 2010
Un uomo in piedi, imprigionato nel mezzo di quello che sembra un angolo di una stanza ricoperta
da innumerevoli fili elettrici cascanti. Le mani dell’uomo sono legate ai lati del corpo verso l’alto, a
formare ancora una volta una sorta di crocefisso. Il volto si scopre per metà dietro un’imponente
maschera di una bestialità non ben definita. Lo straniamento provocato dall’immagine deriva dal
fatto che la reale testa dell’uomo sembra non appartenere più al suo corpo, sostituita dal feticcio
maschera. Così come le mani imprigionate del soggetto creano una figura ossimorica con le due
colombe bianche racchiuse in esse, e simbolo di pace e libertà nell’immaginario collettivo.
L’attenzione dello spettatore si trova inoltre distratta da una smisurata quantità di disegni che
ricoprono le pareti, così come dal corpo dell’uomo ricoperto di striature più scure. Quest’immagine
presenta dunque una composizione zoomorfa difficilmente inquadrabile e per questo perturbante.
37 | P a g .
1.4 Die Atwoord, 2012
I due componenti della band sudafricana, Die Antwoord, uomo e donna, siedono palesemente in
posa davanti all’obbiettivo di Roger Ballen. Il fotografo però, anziché porre il centro spaziale
dell’immagine sulla coppia, lo pone su di una bambola-manichino della grandezza di un bambino
che fa appoggiare nel mezzo delle due figure umane a formare una composizione piramidale. La
bambola assume ruolo predominante quindi, e crea un effetto di doppio con la figura femminile per
l’impressionate somiglianza espressiva ma allo stesso tempo con quella maschile per la fisionomia
38 | P a g .
analoga. Lo spectator dell’immagine è dunque portato a chiedersi se sia il fantoccio ad imitare vero
o viceversa, stravolgendo l’ordinaria azione fruitiva e creando un effetto di angosciante
straniamento. In secondo piano, coerentemente con gli ultimi lavoro del fotografo, disegni stilizzati
di volti vagamente umani ricoprono le pareti e dei pezzi di cartoni ritagliati su misura e sparsi per la
stanza. In questo caso i disegni sembrano anche espandersi sui corpi dei due soggetti umani
attraverso stampe e tatuaggi, inglobandoli ulteriormente in una ricreata atmosfera surreale e
disturbante. “I fink u freaky (and I like you a lot)”1, ovvero “penso che tu sia bizzarro( e mi piaci un
sacco)” è non a caso il testo di un brano dei Die Antwoord per cui Ballen ha curato la regia del
relativo video, e che calza perfettamente quest’immagine. Il bizzarro crea dunque una nuova
estetica che non può essere comunemente racchiusa nei macro-contenitori del bello o del brutto.
Ultima nota da tenere in considerazione è il formato della fotografia: rettangolare e non quadrato, ad
indicare forse che quello rappresentato non è una pura trasposizione dell’inconscio di Ballen ma una
collaborazione tra diversi immaginari artistici.
Note III:
1. Testo dal brano I Fink U Freaky della band Die Antwoord, dall’album Tension, 2012
39 | P a g .
IV. Vedere
4.1 Asylum of the birds: Roger Ballen oltre la sua fotografia
“Negli ultimi quarant’anni il mio obbiettivo nel fare fotografia
è stato in definitiva mettere a fuoco me stesso.
Si è trattato fondamentalmente di un viaggio psicologico ed esistenziale.”1
Roger Ballen
Riprendendo la
citazione dello stesso Ballen
riportata all’inizio di questa
pagina, i suoi lavori
fotografici più recenti che
egli ha scelto di riunire sotto
il titolo di Asylum of the
birds, rappresentano
l’ennesima evoluzione di un
percorso che dalla realtà
sudafricana hanno portato il
fotografo verso gli abissi più
oscuri dell’Io e dal ritratto
verso lo still life attraverso
l’uso della mise-en-scène.
Proprio come accade nella
prima scena di Blue Velvet di
David Lynch, in cui con una
32. Asylum of the birds, Place of the eyeballs, 2012 carrellata si passa dalla placida
quotidianità del vicinato di periferia alle viscere brulicanti del terreno2. Nel film fa da tramite il
malore mortale dell’anziano che così come per Ballen è il costante memento mori suscitato dal
Sudafrica post-Apartheid a spingerlo ad indagare la psiche e le sue paure universali.
Se di prende in considerazione l’immagine Place of the eyeballs (Immagine 32 in questa
pagina) ad esempio, risulta evidente come l’intervento dell’artista, attraverso l’uso di biglie al posto
degli occhi, sia applicato all’unica figura umana così come ai manichini e ritratti pittorici appesi alle
40 | P a g .
pareti. Sembra di assistere ad una rivisitazione del ritratto di famiglia, nel quale però il padre è un
fantoccio che segue le mimiche di una madre umana ma simile ad una strega, il figlio è un
bambolotto abbandonato a se stesso su di una sedia mentre i genitori tengono in mano corvi
impagliati. Alle spalle di questo ensemble, due ritratti dipinti ricordano appunto le due figure in
primo piano in tempi forse più giovani.
Il titolo di questa serie mette in luce il ruolo centrale degli uccelli, in quanto creature in
grado di toccare picchi inaccessibili all’uomo, ma contemporaneamente, nelle parole dello stesso
autore, difficili da fotografare perché incessantemente in movimento e liberi di volare in qualunque
direzione. In effetti la prima fotografia in cui Ballen ritrae una colomba, Five Hands (2006), scattata
in una casa di Johannesburg dove cinque persone condividevano lo stesso letto e risalente alla serie
Boarding House, può essere considerata come l’inizio della passione del fotografo per queste
creature e della loro integrazione nel suo immaginario
personale. Gli uccelli assumono così un significato enigmatico,
diventano quasi mentori nel viaggio fotografico di Ballen,
poiché spesso si trovano nella posizione di testimoni di questa
esplorazione. Essi sono presenti in ogni immagine della serie in
forma reale, di feticcio o anche solo di disegno o stampa.
Ricongiungendosi poi al titolo di questo capitolo, nei
suoi ultimi lavori Roger Ballen sembra oltrepassare il medium
della fotografia perché crea delle vere e proprie installazioni che
poi immortala. Questi scenari ricordano le angoscianti installazioni 33. Five Hands, 2006
di Ed Kienholz, e proprio come quest’ultimo nel video documentario di Asylum of the birds il
fotografo rende palese la sua inquieta ricerca di oggetti bizzarri, bambole, manichini, quadri feticci
da inserire nelle sue composizioni.
Questi objet trouvé provengono da mercatini, catasti, aste e discariche e contengono perciò
una ricerca accurata da parte di Ballen, il quale pur dislocando la sua produzione sul territorio dello
still life continua a mantenere l’approccio curioso che aveva avuto nella suo periodo più ritrattista e
ancor prima nella sua attività di geologo: Ballen sembra possedere la capacità di “scavare”, tra
rocce così come nella psiche umana, utilizzando tutti i mezzi possibili ma mantenendo il medium
fotografico come suo unico e vero strumento. Lo “scavare” operato dal fotografo è dimostrato a
livello metaforico anche dal crescente utilizzo di richiami alla sessualità umana e quindi
freudianamente più vicini alle profondità del subconscio (si veda Immagine 34, pagina successiva).
41 | P a g .
34. Asylum of the birds, Crucified, 2009
Nell’ambiguità di simboli e metafore questa raccolta di fotografie di Ballen, propone un una
sorta di realismo onirico. Come conferma Didi Bozzini nell’introduzione del libro Asylum of the
Birds3, non ci troviamo mai a dubitare della verità di ciò che vediamo pur essendo di fronte ad una
realtà ricreata. La condizione umana rappresentata da Ballen, proprio come le omonime tele di Renè
Magritte5, è così ambigua e complessa da diventare universale, proprio perché si trova ad oscillare
tra realtà e immaginazione, tra bene e male, bello e brutto. Proprio come il pittore belga, anche nella
fotografia di Roger Ballen le illusioni ottiche sono svelate, le finzioni dichiarate ma si mantiene
presente il labile confine tra mondo immaginato e mondo esistente per lo spettatore. Se in Magritte
si può parlare di meta-quadro poiché la tela dipinta rappresenta al sua interno un’altra tela, Ballen
non solo pone numerose fotografie, soprattutto ritratti di famiglia, all’interno delle suoi scatti ma
sovrappone anche una sua immagine del mondo all’immagine che si trova nella realtà. Riportando
una celebre dichiarazione dello stesso Magritte, appare chiaro come Roger Ballen sembri averla
assorbita a perfezione:
“Misi di fronte a una finestra, vista dall’interno d’una stanza, un quadro che rappresentava
esattamente la parte di paesaggio nascosta alla vista del quadro. Quindi l’albero rappresentato nel
42 | P a g .
quadro nascondeva alla vista l’albero vero dietro di esso, fuori della stanza. Esso esisteva per lo
spettatore, per così dire, simultaneamente nella sua mente, come dentro la stanza nel quadro, e fuori
nel paesaggio reale. Ed è così che vediamo il mondo: lo vediamo come al di fuori di noi anche se è
solo d’una rappresentazione mentale di esso che facciamo esperienza dentro di noi”4
Non sembra per nulla fuori luogo il parallelismo che le riflessioni di Magritte vengono a
creare con i lavori più recenti di Ballen non solamente per il tautologico gioco con la realtà che
entrambi, anche se con medium diversi attuano, ma anche per la concezione dell’umanità che tutti e
due gli artisti sembrano condividere: L’uomo vede la realtà attraverso la propria mente. Per usare le
parole di Roland Barthes quindi, nel caso di Ballen il reale viene trasformato, non sdoppiato, fino al
raggiungimento della cosiddetta
fotografia “unaria”5.
Nella fase di elaborazione di
Asylum of the birds è interessante
notare infine come Ballen si sia
aperto a diverse collaborazioni
come quella già citata con la band
Die Antwoord e quella, sicuramente
più interessante dal punto di vista
fotografico, con l’artista danese
Asger Carlsen6. La commistione
delle opere dei due ha creato uno
straordinario ibrido tra le figure
digitalmente modificate e mutanti di
Carlsen e i simboli feticci di Ballen,
riuscendo tuttavia a farne risultare
una fotografia credibile grazie
all’attentissimo formalismo tecnico
ed estetico. L’importanza di questa
collaborazione per Ballen sorpassa
in un certo senso il medium
fotografico ed apre le porte a sue
nuove ed inaspettate evoluzioni
artistiche. 35. Roger Ballen & Asger Carlsen, Untitled, 2013
43 | P a g .
Con Asylum of the birds l’opera di Roger Ballen diventa in sintesi una sorta di rito
sciamanico, che mira a rivelare ciò che ogni fotografia occulta dietro il proprio aspetto di
riproduzione oggettiva della realtà. Talismani, feticci, manichini ed animali prendono prima parte
ad un rito funebre, ed in seguito celebrano magicamentela rinascita. Proprio come gli uccelli
simboleggiano la caduta e il volo, la fotografia dell’artista ondeggia tra il paradiso e l’inferno delle
sue visioni.
36. Asylum of the birds, Caged, 2011
1. Roger Ballen in conversazione con Doug McClemont, Saatchi - Gallery.uk, 31 marzo 2009. Trad.
mia.
2. Particolare carrellata con steady-cam dall’alto verso il basso, nella sequenza iniziale di Blue Velvet,
regia di David Lynch (1986).
3. Didi Bozzini, intoduzione di Asylum of the birds, Thames and Hudson, 2012. Pag.9 Trad. mia.
4. Renè Magritte da:
http://www.tuttomagritte.altervista.org/
5. Roland Barthes, La camera chiara, 1980 pag. 42
6. Asger Carlsen & Roger Ballen :
http://www.asgercarlsen.com/index.php?/projects/collaboration-ballencarlsen/
44 | P a g .
4.2 Intervista con Roger Ballen. Roma, 25 Settembre 2014
In occasione dell’esposizione presso Macro, museo di arte contemporanea di Roma, all’interno di
FOTOGRAFIA: Portrait XIII Festival internazionale di fotografia, incontro Roger Ballen. Ecco di
seguito il resoconto della nostra piccola intervista1.
ZP : Henri Cartier-Bresson ha scritto che ha imparato a “vedere” grazie al cinema di Ejzestejn,
Dreyer, Griffith e personalmente le sue opere mi hanno ricondotto a Von Trier, Kubrik, Lynch.
Qual è la sua relazione con il cinema? Si sente influenzato da registi o film in particolare?
RB : Devo dire che quand’ero più giovane, intorno ai vent’anni ero molto interessato al cinema e
quindi c’erano molti registi al tempo che mi ronzavano per la testa: Fellini, Bresson,
Ejzenstejn…Non sono però esattamente sicuro che questi registi abbiano influenzato la mia
fotografia. Oserei forse dire di no. La mia fotografia al momento è il risultato di 64 anni di vita e di
alcuni miliardi di anni di evoluzione sul nostro pianeta. Sai, il cervello è qualcosa di veramente
misterioso e complicato, è formato da un numero spropositato di cellule e non sappiamo
esattamente come interagiscono ed operano tra di loro per creare connessioni.
ZP : Lei è qui a Roma per un’esposizione in occasione del Festival di fotografia. Ho letto che però
che è molto legato alla pubblicazione dei suoi volumi fotografici perché ritiene che siano qualcosa
di permanente. Con il successo degli ultimi anni sta forse cambiando il suo atteggiamento verso le
esposizioni d’arte o considera ancora il libro il canale fruitivo più adatto a lei?
RB : Sì, vorrei sempre produrre un libro
per le mie fotografie ma le mostre in un
certo senso riflettono le mie pubblicazioni.
I libri sono alla base della catena tra una
serie e l’altra, concatenati tra loro e sì, sono
stati una parte fondamentale della mia
carriera. I libri sono più permanenti, gli
show vanno e vengono, al massimo
possiamo trovare un articolo a proposito
della tal mostra ma questo è tutto. Le
esposizioni non hanno memoria, il libro si.
. 37. Ballen presenta Asylum of the birds , MACRO 26 settembre 2014
45 | P a g .
ZP : Questo è assolutamente vero, però io credo che le esposizioni permettano di impressionare
maggiormente gli spettatori e di raggiungere un pubblico più vasto, mentre una pubblicazione
risulta più selettiva.
RB : Sì è vero, hai ragione. Le immagini stampate così come i video hanno sicuramente un impatto
maggiore dei libri, ma i libri sono un altro tipo di medium. Le persone interessate alla mia
fotografia dovrebbero provarli tutti.
ZP : Ho notato che i suoi ultimi lavori sembrano essere più focalizzati sugli oggetti che sull’uomo,
come lo erano una volta. Mi domandavo se ci fosse una ragione specifica per ciò o se lei stia
seguendo solamente la sua naturale evoluzione.
RB : Credo che questo sia avvenuto per piccoli passi in un lungo periodo di tempo. Ho fatto quello
che ho fatto e poi ho cercato nuove sfide. Non credo abbia molto senso continuare a fare la stessa
cosa, fotografare lo stesso soggetto, ancora e ancora. È stata un’evoluzione dal 1995 al 2003. Nel
2003 ho iniziato a fotografare still-life che sono poi diventati sempre più predominanti.
ZP : Esattamente. Questo progresso ed evoluzione nella sua fotografia è forse quello che la
differenzia così tanto. Insieme al fatto che ha mantenuto il sua professione di geologo per lungo
tempo e ha fotografato per passione. Forse è per questo che il pubblico rimane così impressionato,
perché vede qualcosa di autentico.
RB : Si è corretto. Non ho mescolato la fotografia commerciale con quello che amavo fotografare.
Ho fotografato focalizzandomi su passione e disciplina. Questo vuol dire impegnare se stessi con la
fotografia e non lo si può fare con nient’altro legato al mercato. Quindi questo credo che abbia
davvero giocato un ruolo fondamentale. E anche il fatto che abbia lavorato per trent’anni in
Sudafrica, che è un luogo abbastanza isolato dal mercato dell’arte contemporanea. Perciò quando le
persone mi chiedono cosa mi ha ispirato io rispondo “il muro bianco di fronte alla mia scrivania”.
Una buona fotografia viene da dove ci sei tu, da dove vivi tu.
ZP : Dunque da questo punto di vista sembra che il contesto sudafricano l’abbia influenzata ma al
contempo no. Crede che potrebbe iniziare a fotografare in una paese occidentale?
RG : Tutto reagisce a livello cinetico e ambientale. Sono diverso da qualunque altra persona al
mondo ma vivo in una cultura uguale a quella degli altri che mi influenza. Vivo in Sudafrica da 32
anni ormai e certamente se avessi vissuto in un altro paese la mia fotografia sarebbe differente ma è
piuttosto imprevedibile come processo.
46 | P a g .
ZP : La mia ultima domanda è puramente un mio interesse personale. Provando io stessa a
fotografare e usando una macchina fotografica analogica, mi chiedevo se anche lei usasse ancora il
rullino o fosse passato alla fotografia digitale.
RB : Utilizzo solo i rullini. Ho usato la stessa macchina per 32 anni, una Rollflex 6x6.
ZP : E per quanto riguarda il formato quadrato delle sue immagini? Credo sia sicuramente un
formato interessante ma scivoloso allo stesso tempo.
RB : Amo il formato quadrato, tutto deve essere perfettamente calibrato perché non si ha molto
spazio. Inoltre non ci sono macchine digitali con cui ottenere il formato quadrato.
ZP: Bisognerebbe intervenire a posteriori e ritagliare l’immagine, ma non è la stessa cosa.
RB : Esatto. Non è la stessa cosa. Sarebbe come comprare un vestito di una taglia sbagliata per poi
tentare di aggiustarlo a casa. Non credo sia una buona idea. Abbiamo l’infinito davanti a noi e
sarebbe un peccato perdere l’occasione di estrapolare un’immagine viva da esso.
Dopo l’intervista, che ha avuto
luogo nel bookshop del
MACRO di via Nizza, Roger
Ballen mi ha cortesemente
chiesto di parlare con
l’assistente alla vendita per
chiedere informazioni riguardo
i suoi cataloghi mancanti
nell’esposizione. Era
preoccupato che i suoi amati
libri non arrivassero.
38. Roger Ballen durante l’allestimento della sua sezione espositiva per FOTOGRAFIA.
1. Intervista originale tenuta in lingua inglese, Trad. mia.
47 | P a g .
Lista delle immagini :
0. Shadow Chamber, Apparences, 2003
1. Boyhood, Blown up boy, Malesia 1976
2. Boyhood, Ceylon, 1979
3. Dorps, Bedroom of a railway worker, De Aar, 1984
4. Platteland, Sergeant F de Bruin, Orange Free State, 1992
5. Outland, Portrait of sleeping girl, 2000
6. Outland, Pupy between feet, 1999
7. Shadow Chamber, Chamber of the Enigma,2003
8. Shadow Chamber, Lunchtime, 2001 9. Shadow Chamber, Head inside a shirt, 2001 10. Boarding House, Metamorphosis, 2006
11. Boarding House, Boarding House, 2009
12. David Goldblatt, A land owner, his wife and his son having lunch, Wheatlands Randfonteein, Transvaal, 1962
13. Santu Mofokeng, Afoor family bedroom, 1986
14. David Goldblatt, A plot helder with the daughter of a Servant, Wheatlands Randfonteein, Transvaal, 1962
15. Roger Ballen, Man and maid in northern cape, 1992
16. Outland,Woman, man and dog, 1995
17. Shadow Chamber, Prowling, 200
18. Shadow Chamber, Bite, 2
19. Shadow Chamber, Kitchen Counter, 2001
20. Hans Bellmer, Anxiety, 1938
21. Shadow Chamber, Room of ninja turtles, 2003
22. Shadow Chamber, Cut loose, 2005
23. Shadow Chamber, Trails, 2003
24. Outland, Study of a boy and plant,1999
25. Diane Arbus, A young brooklyn family going For a Sunday outing, N.Y.C., 1966
26. Roger Ballen. Scrapyard Worker and Family, Central Transvaal, 1993
27. Diane Arbus, Identical twins, Roselle, N.J., 1967
28. Roger Ballen, Dreasdie and Cassie, 1993
29. Diane Arbus, Child with a hand toy grenade in Central Park, 1962
30. Roger Ballen, Roar, 2002
31. 31. Diane Arbus, Untitled III, 1970-1971
32. Asylum of the birds, Place of the eyeballs, 2012
33. Boarding House, Five Hands, 2006
34. Asylum of the birds, Crucified, 2009
35. Roger Ballen & Asger Carlsen, Untitled, 2013
36. Asylum of the birds, Caged, 2011
48 | P a g .
Bibliografia:
1. Boarding House. Introduction by David Travis. Phaidon Press, London 2009
2. Shadow Chamber. Introduction by Robert A Sobieszek. Phaidon Press, London 2005
3. Outland. Introduction by Peter Weiermair. Phaidon Press, London 2001
4. Boyhood. Introduction by Roger Ballen. Chelsea House Publishers, New York-London 1979.
1. Roger Ballen: Fact of Fiction. Galerie Kammel Menour, Introduction by Serge Guibourgé, pp.1-10
2. On Photography. Susan Sontag, Picador USA, 1973 (ediz.2006)
3. Camera Lucida: Reflections on Photography. Roland Barthes, FGA Books, 1980
4. Fotografia e Società. Alfredo de Paz, Liguori editore, 2001
5. Della fotografia trasgressiva, saggio su Diane Arbus. Pino Bertelli, prefazione di Alfredo de Paz,
NdA Press, 2006
6. La (foto)camera di Pandora. Joan Fontcuberta, Contrasto, 2012
7. La fotografia. Illusione o rivelazione?. Claudio Marra Francesca Alinovi, Il Mulino, 1981 (parte I
capitolo VI, parte II capitoli II e IV)
8. Corpo e figura umana nella fotografia, Elio Grazioli, Mondadori ,1998
9. L’immaginario dal vero , Henri Cartier-Bresson, Abscondita Edizioni, 2005
10. The Apartheid city and beyond : urbanization and social change in south Africa edited by David M.
Smith London ; New York : Routledge ; Johannesburg : Witwaterstand university press, 1992
11. Arte dal 900, Foster-Krauss-Bois-Buchloh, Zanichelli, 2011
12. La trasparenza impossibile. Aforismi e riflessioni, Arthur Schnizler
13. Saggi sull'arte, la letteratura e il linguaggio, Sigmund Freud, Bollati Boringhieri, Torino 1990
14. Chasing Shadow, Santu Mofukeng Thirty years of photographic essays, Santu Mofokeng, Prestel,
2011
15. David Goldblatt, Fotografie. Edizione Contrasto, Roma , 2006.
16. Realismo, Kerstin Stremmel, a cura di Uta Grosenick, Taschen, 2004
Articoli:
Disturbing, potent lens of Ballen in mid-life, Marc Corrigal, Sunday Indipendent South Africa, 13
Marzo 2007
The Roger Ballen Strategies, Walter Guadagnini, Giugno 2010
Roger Ballen Interview, Jonathan Blaustein per A photo Editor, Marzo 2013
Zooning in. An Interview with Roger Ballen, Robert Enright per Mois de la Photo 2011
49 | P a g .
Roger Ballen: The asylum, Walter Guadagnini, 2012
Roger Ballen: uncanny animals, Anne Biroleau, Robert Cook e Giovanni Aloi, Antannae
Magazine, 2008
David Goldblatt: Photographer bears witness to Apartheid, Dianne McCarthy e Lauren Said-
Moorhouse, CNN, 8 Novembre 2013
Roger Ballen in Conversation with Doug McClemont, Saatchi-Gallery.uk, 31 marzo 2009
Video:
Dorps (1986)
Platteland (1995)
Conversations with Photographers: Roger Ballen –Lens Culture
Roger Ballen – ARTE Channel
Roger Ballen's Asylum of the Birds, diretto da Ben Crossman (2012)
Sitografia:
Phaidon online: Roger Ballen, The journey to Boarding House
http://it.phaidon.com/agenda/photography/picture-galleries/2010/july/01/roger-ballen-the-journey-
to-boarding-house/?idx=3
www.roger-ballen.com
www.tuttomagritte.altervista.org
www.asgercarlsen.com