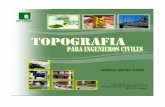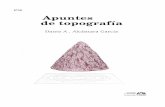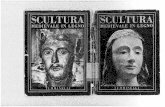Corso di Topografia medievale Ia - Lezione 2: Gli strumenti della topografia medievale: le fonti...
Transcript of Corso di Topografia medievale Ia - Lezione 2: Gli strumenti della topografia medievale: le fonti...
Sapienza Università di Roma Facoltà di Lettere e Filosofia – Dipartimento di Scienze dell'Antichità
Corso di laurea di primo livello in scienze archeologiche
Corso di Topografia medievale IA (2°anno) e II (3°anno) – 36 ore/6CFU
Dott. Carlo Citterhttps://unisi.academia.edu/CarloCitter
Lezione 2: Gli strumenti della topografia medievale: le fonti scritte
Fonti letterarie narrative e storiche
Le fonti scritte hanno un ricco potenziale informativo per lo studio dei paesaggi e delle caratteristiche di un territorio, ma dobbiamo fare alcune precisazioni.
1. sotto un unico termine indichiamo fonti molto diverse fra loro:a) epigrafi
b) fonti narrative
c) atti normativi
d) atti notarili
2. All'interno di una stessa categoria:a) un atto notarile dell'VIII secolo è molto diverso per struttura e dettagli che
interessano l'archeologo rispetto ad uno del XIV
b) così un pur dettagliato polittico carolingio è molto diverso dal catasto fiorentino del 1427
c) un cippo miliario con iscrizione di restauri tardoantichi e un'epigrafe medievale (prevalentemente in ambito urbano) danno informazioni diverse
d) il viaggio di Rutilio e la cronica di Giovanni Villani sono fonti narrative a carattere storico, con dati topografici, ma la prospettiva è molto diversa
Fonti letterarie narrative e storiche
I restauri occorsi fra Massenzio e Teodosio devono essere stati modesti, anche a giudicare dal fatto che talvolta si incide una pessima iscrizione su cippi più antichi.
Che cosa possiamo trarre allora dal suo racconto? La descrizione delle città distrutte o abbandonate sono reali o frutto della sua visione ideologica?
Fonti letterarie narrative e storiche
Cominciamo con il viaggio di Rutilio Namaziano in fuga da Roma nel 417 d.C.
1) il suo non è un diario di bordo sullo stile degli esploratori come James Cook
2) il suo è un componimento letterario che trae spunto da appunti di viaggio
3) quindi il suo intento non è fornirci una descrizione topografica dettagliata della situazione della costa in quel preciso momento
4) pagano in fuga, non manca occasione per accentuare gli elementi di degrado per dimostrare al suo uditorio che abbandonare gli antichi culti per il Cristianesimo ha portato alla rovina
5) non viaggia per mare perché i Goti hanno distrutto sistematicamente ogni basolo di tutte le strade romane, ma perché il sistema del cursus publicus, cioè la manutenzione delle strade, i ponti e le stazioni di posta non funziona più come prima e di questo abbiamo anche indicazioni archeologiche.
Fonti letterarie narrative e storiche
Ad Centumcellas forti defleximus Austro;Tranquilla puppes in statione sedent. Molibus aequoreum concluditur amphitheatrum,anngustosque aditus insula facta tegit;attollit geminas turres bifidoque meatufaucibus artatis pandit utrumque latus.Nec posuisse satis laxo navalia portu:ne vaga vel tutas ventilet aura rates,interior medias sinus invitatus in aedesinstabilem fixis aera nescit aquis,qualis in Euboicis captiva natantibus undasustinet alterno brachia lenta sono.
Nosse iuvat Tauri dictas de nomine Thermas,nec mora difficilis milibus ire tribus.Non illic gustu latices vitiantur amarolymphaque fumifico sulphure tincta calet:purus odor mollisque sapor dubitare lavantemcogit, qua melius parte petantur aquae.
Ricostruzione del porto romano di Civitavecchia
La descrizione di Civitavecchia (I, 236-254)
Fonti letterarie narrative e storiche
Abbiamo piegato verso Centocelle per via del forte Austro;fanno sosta, le navi, in una rada calma.L'anfiteatro d'acqua circoscritto da moli,e un'isola creata apposta copre gli accessi angusti:eleva torri gemelle , e nel doppio passaggioestende, sulle strette imboccature, entrambi i lati.Non basta aver disposto gli arsenali dentro il portospazioso:perché la brezza instabile non scuota le barche già al sicurouna baia più interna ospitata fino in mezzo alle casenon conosce il variare del vento grazie alle sue acque ferme;come nuotando nelle piscine dell'euboica urna, dove l'onda prigionierasostiene le braccia che si flettono con ritmo alterno.
Ci fa piacere visitare le Terme che prendono il nome dal toro:non porta via tempo, né è pesante camminare per tre miglia.Le acque lì non sono guastate da un gusto amaro,né la loro linfa si scalda tingendosi di zolfo fumoso:l'odore puro e il suo sapore dolce costringono i bagnantia non sapere bene in che maniera servirsi meglio di essa.
Fonti letterarie narrative e storiche
Abbiamo piegato verso Centocelle per via del forte Austro;fanno sosta, le navi, in una rada calma.L'anfiteatro d'acqua circoscritto da moli,e un'isola creata apposta copre gli accessi angusti:eleva torri gemelle , e nel doppio passaggioestende, sulle strette imboccature, entrambi i lati.Non basta aver disposto gli arsenali dentro il portospazioso:perché la brezza instabile non scuota le barche già al sicurouna baia più interna ospitata fino in mezzo alle casenon conosce il variare del vento grazie alle sue acque ferme;come nuotando nelle piscine dell'euboica urna, dove l'onda prigionierasostiene le braccia che si flettono con ritmo alterno.
Ci fa piacere visitare le Terme che prendono il nome dal toro:non porta via tempo, né è pesante camminare per tre miglia.Le acque lì non sono guastate da un gusto amaro,né la loro linfa si scalda tingendosi di zolfo fumoso:l'odore puro e il suo sapore dolce costringono i bagnantia non sapere bene in che maniera servirsi meglio di essa.
Le fonti itinerarie antiche
Common map
IA Common map
TP Anonimi Ravennatis Cosmographia
Sebbene utilizzate principalmente negli studi di topografia antica, proprio perché le strade romane erano infrastruttura ad alto impatto ambientale, la loro permanenza nel medioevo le rende importanti anche negli studi di topografia medievale.
Le principali strade sono riportate negli itinerari:
Le fonti itinerarie antiche
Due sono I tipi di itinerari: picta, cioè con cartografia, e adnotata, cioè solo liste. La tabula peutingeriana appartiene al primo tipo, l'itinerarium provinciarum o Antonini imperatoris al secondo.
C'erano ovviamente molte altre strade che non sono riportate perché considerate minori, ma che per uno studio di topografia sono invece rilevanti.
Le fonti itinerarie antiche
Luoghi comuni da sfatare:
I Romani utilizzavano verosimilmente l'odometro, uno strumento che faceva cadere un sassolino in un contenitore ad ogni miglio.
1) I Romani misuravano quindi le distanze in miliari, cioè la distanza fra un cippo e l'altro, e non in frazioni come facciamo oggi con le nostre automobili.
Inizio percorso1 miglio
1o miliario 2° miliario
2 miglia
mansio “si mangia bene”
Ad pirum
Incrocio per Ad pirum
Le fonti itinerarie antiche
Lo schema precedente è ben chiaro in questo tratto della via Aurelia nel Lazio. Le distanze misurate sulla base GIS, quindi con le frazioni, non corrispondono a quelle indicate negli
itinerari che considerano solo gli interi. Ovvero: fino a 1,999 miglia per loro significa 1 miglio, cioè prima del secondo miliario. Erano I miliari I segni visibili sul terreno con i quali
ci si poteva orientare, non il contachilometri, né il gps.
Centum cellis
Forum Aureli
XXIIII
Le fonti itinerarie antiche
Fonti più tarde come l'anonimo ravennate che scrive alla fine del VII ma su fonti di cancelleria che giungono almeno fino agli inizi del secolo, registrano in parte la rete viaria
romana, in parte le modifiche effettuate durante il periodo bizantino.Modifiche che, come abbiamo visto per la Francigena, significano selezione di tracciati un
tempo secondari, ma funzionali alle nuove esigenze.
Fonti letterarie narrative e storiche
Passiamo ora a una fonte di cancelleria, le varie di Cassiodoro. Si tratta di una raccolta di lettere che egli ebbe sotto mano durante il suo lungo periodo di servizio alla cancelleria della corte gota in Italia. Fonte ufficiale dei primi decenni del VI secolo, che lui raccolse in una serie di volumi quando si ritirò in Calabria presso il suo Vivarium. In particolare il documento che segue è Variae, VIIII, 3, ca. 527 d.C.
Cerchiamo di vedere:
1) se vi sono indicazioni utili per uno studio topografico
2) osserviamo anche lo stile con cui la cancelleria affrontava temi specifici, legati ad un territorio
3) quale grado di dettaglio raggiungeva 4) quali erano le finalità della produzione del documento (cruciale per valutare soprattutto l'assenza di determinati dettagli)
Fonti letterarie narrative e storiche
Si labor omnis assiduus adeo diversos exigit fructus, ut aurum argentumque ea solita
commutatione mercetur, cur non ipsa diligenter exquirimus, propter quae alia poscre
videbamur? Italia dives inferat nobis et aureos fructus. omnis proventus adquiritur, ubi
metallum fulvidum reperitur. nam quid necesse est terram multiplici fecunditate lassari, si
ipsa magis pretia in ea potuerint inveniri? frumenta nobis usualiter natura industria
suffragante concedit: passim se vina profundunt: metallum raro proditur, ut studio ius
expetatur. Quapropter ad massam iuris nostri Rusticianam in Bruttiorum provincia
constitutam magnitudinem tuam iubemus chartarium destinare et si, ut ab artifice harum
rerum Theodoro dicitur, memoratis rebus terra fecunda est, officinis sollernniter institutis
montium viscera perquirantut: intretur beneficio artis in penetrale telluris et velut in
thesauris suis natura locuples inquiratur. Cameris enim ingeniosa praesumptione
revolutis, talpinum animal imitantes, itinera fodium quae nullis ante patuerunt. sic ambitio
nil relinquit absconditum nec ubi interdum sustinere possit extremum.
Fonti letterarie narrative e storiche
Si labor omnis assiduus adeo diversos exigit fructus, ut aurum argentumque ea solita
commutatione mercetur, cur non ipsa diligenter exquirimus, propter quae alia poscre
videbamur? Italia dives inferat nobis et aureos fructus. omnis proventus adquiritur, ubi
metallum fulvidum reperitur. nam quid necesse est terram multiplici fecunditate lassari, si
ipsa magis pretia in ea potuerint inveniri? frumenta nobis usualiter natura industria
suffragante concedit: passim se vina profundunt: metallum raro proditur, ut studio ius
expetatur. Quapropter ad massam iuris nostri Rusticianam in Bruttiorum provincia
constitutam magnitudinem tuam iubemus chartarium destinare et si, ut ab artifice harum
rerum Theodoro dicitur, memoratis rebus terra fecunda est, officinis sollernniter institutis
montium viscera perquirantut: intretur beneficio artis in penetrale telluris et velut in
thesauris suis natura locuples inquiratur. Cameris enim ingeniosa praesumptione
revolutis, talpinum animal imitantes, itinera fodium quae nullis ante patuerunt. sic ambitio
nil relinquit absconditum nec ubi interdum sustinere possit extremum.
Fonti letterarie narrative e storiche
L'itinerario di Sigerico, ovvero una serie di tappe nel deserto. Nell'anno 990 l'arcivescovo Sigerico di Canterbury si mise in viaggio per Roma per ricevere l'investitura papale. Il suo viaggio durò 80 giorni, facendo 79 tappe e camminando per circa 27 km al giorno per un
totale di 1600. La sua minuziosa annotazione delle tappe è tuttavia molto simile agli itinerari romani: non compaiono infatti annotazioni sul paesaggio.
Fonti letterarie narrative e storiche
Pur non annotando come gli itinerari romani la distanza fra una sosta e l'altra, le località sono abbastanza note, quindi la percorrenza media è calcolabile. Non è un caso che
anche l'itinerario antonino segnali una distanza di circa 20 miglia come percorso giornaliero (circa 30 km). È piuttosto evidente che solo con il motore a scoppio è stato
possibile cambiare dei ritmi millenari.
Fonti letterarie narrative e storiche
al-Sharif al-Idrissî vive nel XII secolo e scrive per il re normanno Ruggero II il libro di Ruggero o Al-Kitâb al-Rujâri, una vera rivoluzione nella geografia medievale, che metteva in discussione molte teorie correnti. Sebbene la sua descrizione della Sicilia indulga un po' all'adulazione, egli resta una fonte preziosa perché descrive per mercanti e non per filosofi o poeti. Quindi egli riporta distanze, dettagli topografici utili a chi doveva viaggiare per affari
e, ovviamente, molto utili anche per noi.
Fonti letterarie narrative e storiche
La cronica di Giovanni Villani, uomo politico fiorentino vissuto fra XIII e XIV secolo, è un grande salto in avanti per quello che a noi interessa. La sua narrazione delle vicende politiche è intrisa di dati topografici sulla città e sul territorio che circonda la più grande città medievale europea.Prendiamo ad esempio due brani. Il primo riguarda la guerra gotica, quindi fatti molto lontani dal suo tempo, rielaborati mescolando fonti antiche e osservazioni contemporanee.
Libro IIII, 1. “E poi che Totila l'ebbe così consumata di genti e dell'avere [Firenze], comandò che fosse distrutta e arsa e guasta e non vi rimanesse pietra sopra pietra; e così fu fatto, se non che da l'occidente rimase una delle torri che Igneo Pompeo avea edificata, e dal settentrione e dal mezzogiorno una delle porte, e infra la città presso posrta casa, sive domo, interpretiamo il Duomo di Santo Giovanni, chiamato prima casa di Marti.”
Fonti letterarie narrative e storiche
Quando invece parla di eventi più vicini a lui, il grado di dettaglio è molto maggiore e decisamente più attendibile. Egli infatti aveva avuto accesso a documenti ufficiali. Qui la breve descrizione dell'assedio del castello di Ostina vicino all'abbazia di Vallombrosa.
Libro VIII, 32. “Nel detto anno [1269], del mese di settembre, essendo rubellato il castello d'Ostina in Valdarno, e entrativi I Ghibellini usciti di Firenze co' Pazzi di Valdarno, I Fiorentini v'andarono ad oste, e stettonvi infino a l'ottobre, e per difalta di vittuaglia non potendosi più tenere, e quegli d'entro uscendone una notte, furono quasi tutti morti e presi, e' Fiorentini ebbono il castello e disfeciollo”.
Fonti letterarie narrative e storiche
Flavio Biondo, ovvero il tentativo di riscrivere la storia. I primi eruditi del Rinascimento tentarono di scrivere la storia grazie alla riscoperta di numerose fonti greche e latine. Tentarono anche di fornire dati topografici basandosi però su letture errate e talvolta fantasiose.
Ma consultarono fonti, che per molti secoli ancora saranno inedite, quindi preziose, talvolta pure scomparse o non più reperibili nella forma in cui la videro loro.
Fonti di autorità pubbliche laiche ed ecclesiastiche
La letteratura nel corso del XX secolo ha posto con estrema chiarezza l’accento sulla veridicità delle rivendicazioni aretine su un certo numero di pievi disposte, per intendersi, da S. Marcellino in Chianti a nord fino a Torrita a sud, includendo Montalcino, Pienza, Montepulciano e S. Quirico d’Orcia.
La lite comincia assai presto ,appena ristabilita la diocesi sense (intorno al 650), ed è fra l’altro uno dei documenti più antichi di età longobarda (a testimonianza che si scriveva solo quando c’era effettivo bisogno) e prosegue a tappe fino al XIII secolo.
Il famoso caso senese-aretino: ovvero come partire dalle fonti scritte, confrontarsi con I dati archeologici e, utilizzando il metodo regressivo, proporre nuove letture sull'estensione dei territori delle città etrusche, romane e altomedievali.
Fonti di autorità pubbliche laiche ed ecclesiastiche
Cerchiamo di fare ordine anche nella documentazione conservata.
In primo luogo non abbiamo documenti originali, ma copie.
E queste copie sono state realizzate tutte ad Arezzo.
Rimanendo all’età longobarda abbiamo
CDL I, 4 (ca. 650) primo accordo fra i vescovi di Arezzo e Siena
CDL I, 17 (714, agosto) Ambrogio, maggiordomo di Liutprando conferma ad Arezzo le chiese e i monasteri contesi con Siena
CDL I, 19 (715, giugno, 20) il notaio regio Gunteram conduce un’inchiesta per conto del re Liutprando sulla materia del contendere
CDL I, 20 (715, luglio, 5) i vescovi di Pisa, Lucca, Fiesole, Firenze e il notaio regio Gunteram giudicano in favore di Arezzo
CDL III, 1, 12 (715, marzo 6) il re Liutprando conferma il giudicato del maggiordomo Ambrogio)
CDL III, 1, 13 (715, ottobre 14) il re Liutprando conferma il giudicato dei vescovi di Fiesole, Pisa, Firenze e Lucca a favore di Arezzo
Pasqui (750, maggio, 20) Stefano II conferma il possesso delle pievi e dei monasteri al vescovo aretino
Fonti di autorità pubbliche laiche ed ecclesiastiche
Dunque copie aretine di documenti che, almeno nel primo caso del 650 ca. (un papiro) erano in pessimo stato di conservazione.
A pensar male si commette peccato, ma…
Anche il periodo è importante. In un primo momento Luigi Schiaparelli, l’editore del Codice Diplomatico Longobardo, ipotizzò per la lunga
pergamena che contiene gran parte dei documenti della disputa la metà dell’XI secolo, ma successivamente Carlrichard Brühl, nel commentare l’edizione delle conferme di Liutprando, spostò con validi argomenti la datazione fra la metà del IX e I primi decenni del X. Con la probabilità
che questi documenti fossero stati redatti per l’audizione papale a Roma (Manaresi, I, 53, 850, aprile). Che guarda caso è l’unica a rovesciare il
verdetto e di fronte a due personaggi importanti come l’imperatore Ludovico II e il Papa Leone IV.
Fonti di autorità pubbliche laiche ed ecclesiastiche
Diocesidi Siena
La non perfetta sovrapposizione fra diocesi e distretto civile senese in età longobarda (le pievi erano in diocesi aretina, ma sotto il gastaldo di Siena) è stata spiegata come accrescimento del distretto civile senese a causa di azioni militari dei Longobardi senesi ai danni di Arezzo. La diocesi senese, una volta reinsediato un vescovo a partire dalla metà del VII secolo, si sarebbe uniformata a questa nuova situazione. E infatti la disputa nasce proprio in quegli anni.
Il problema sembrerebbe risolto se non venissero altri elementi a complicarlo, mi riferisco in particolare alle ricerche sulla centuriazione romana, unite ad un riesame dei dati epigrafici e archeologici per il periodo etrusco-romano. Se riteniamo che quelle argomentazioni possano avere un fondo di verità, occorrono riflessioni ulteriori per spiegare i motivi di una vicenda assai intricata, anche sotto il profilo documentario. Che non si esaurisce nel giudicato del 715 dove è evidente che il vescovo aretino aveva ragione da vendere, ma limitatamente alla situazione di quei decenni.
Diocesi di Arezzo
disputa
Gastaldato di Siena
Fonti di autorità pubbliche laiche ed ecclesiastiche
Proviamo a fare qualche ipotesi. Tracce di centuriazione romana mostrerebbero un territorio aretino molto più modesto in estensione e chiuso a sud lungo l’asse Cortona-Rapolano dal municipium di Cortona. Ma anche verso ovest l’area di S. Marcellino in Chianti mostrerebbe una centuriazione identica a quella rinvenuta presso Siena, smentendo dunque il vescovo di Arezzo. Per concludere in prossimità di Asciano, un altro dei punti rivendicati da Arezzo, la centuriazione rimanderebbe al modello di Chiusi.
Fonti di autorità pubbliche laiche ed ecclesiastiche
Altri elementi archeologici, per il periodo etrusco-romano, testimoniano la forte influenza di Chiusi su Sinalunga, ma anche la presenza di centuriazione aretina nei pressi di Torrita. Qui la famiglia degli Umbricii, legati ad Arezzo, aveva possedimenti e una fornace per la produzione di ceramica. Questi elementi rendono difficile accettare che proprio ad Asciano sia stata rinvenuta centuriazione di Cortona, perché il corridoio aretino di Sinalunga e Torrita ne avrebbe interrotto la continuità.
Fonti di autorità pubbliche laiche ed ecclesiastiche
Stessa situazione a Bettolle dove sono attestati influssi chiusini e più tardi famiglie imparentate con i Cilnii di Arezzo. Inoltre a Pienza, Montepulciano e Montalcino sono attestati gli Aulnii che sono di origine chiusina o cortonese, ma non certo aretina. Per inciso da Montalcino viene un’altra iscrizione di un Seinal che sembrerebbe rimandare proprio a Siena (C.I.E. 308).
Fonti di autorità pubbliche laiche ed ecclesiastiche
Una ricostruzione del territorio chiusino proposta da Mansuelli esclude Asciano, Sinalunga e Trequanda, ma include Montalcino, Pienza e parte del versante occidentale dell’Amiata (Torelli 1984, fig. 81). Nella redazione del CIE gran parte del territorio oggetto della contesa senese-aretina viene definito per l’età etrusca «ager inter Saenam Clusiumque situm» ovvero una terra di nessuno.
Fonti di autorità pubbliche laiche ed ecclesiastiche
Anna Rastrelli pone a Torrita un confine fra Chiusi e Arezzo in età ellenistica, mentre Sinalunga sarebbe anche per lei in agro aretino (Rastrelli 1992, p. 311 e 313). Per completare il quadro non possiamo tralasciare le considerazioni fatte da Ranuccio Bianchi Bandinelli nel suo celebre saggio su Chiusi (Bianchi Bandinelli 1925, in particolare pp. 511 e ss). Anche per lui il confine fra Arezzo e Chiusi sarebbe da porre fra Torrita e Sinalunga, ponendo questa e l’area di Bettolle in ambito aretino.
Fonti di autorità pubbliche laiche ed ecclesiastiche
Quasi tutti pongono l’area dell’abbazia di Farneta in ambito chiusino, piuttosto che cortonese, ma per associazione retrospettiva con i documenti del pieno medioevo.
Fonti di autorità pubbliche laiche ed ecclesiastiche
Vediamo di fornire una lettura di questi elementi contrastanti.
3. Allora l’estensione del controllo ecclesiastico di Arezzo potrebbe essere cominciato già nel V secolo. Rimane da chiarire quando il vescovo di Chiusi avrebbe perso gran parte del suo territorio, peraltro piuttosto fertile, a favore di un città apparentemente tranquilla come Arezzo.
1. Innanzitutto è evidente la tarda sovrapposizione della diocesi aretina sul territorio di Cortona, qualunque fosse la sua estensione al momento dell’annessione
2. Non è improbabile, data la sua posizione, che Cortona sia stata distrutta durante le numerose e intricate campagne militari sull’asse Roma-Ravenna che coinvolsero Perugia e Città di Castello. La mancata citazione in Procopio, che pure si sofferma sulle vicine Chiusi e Perugia, potrebbe fornire già un terminus ante quem.
Fonti di autorità pubbliche laiche ed ecclesiastiche
Anche se non prendiamo per buone le indicazioni di centuriazione chiusina segnalate da Fatucchi presso Asciano, gli altri elementi archeologici nell’area contesa fra Siena e Arezzo mostrano che il vescovo aretino rivendicava la cura d’anime su un territorio che almeno fino ai primi secoli dell’impero non poteva appartenere né al distretto civile aretino né a quello ecclesiastico. In particolare mi sembra che tutti siano concordi nell’escludere una dipendenza da Arezzo della zona di Montalcino, Pienza e Montepulciano.
Fonti di autorità pubbliche laiche ed ecclesiastiche
Tuttavia l’area di S. Antimo, proprio per la dedica ad uno dei compagni di S. Donato, patrono di Arezzo, rimanderebbe alla sfera di questa città. Rimane da chiarire se questo fenomeno abbia avuto un parallelo nella sfera civile: ovvero se la giurisdizione laica si fosse adeguata alla giurisdizione ecclesiastica erodendo i territori di Chiusi e Siena e inglobando quello di Cortona.
Fonti di autorità pubbliche laiche ed ecclesiastiche
Se la metà del VII secolo è il terminus ante quem, e diciamo la riforma dioclezianea della fine del III secolo è un credibile terminus post quem, il periodo in cui questo passaggio può essere avvenuto si restringe, di fatto, ai secoli V e VI. Possiamo pertanto ipotizzare che la progressiva eclissi di Cortona come centro urbano abbia reso necessario appoggiarsi al vescovo aretino per tutte le necessità quotidiane e che infine questi abbia incluso l’ex diocesi cortonese nella propria.
Nel giudicato di Liutprando del 715 c’è riferimento alla sola sfera religiosa di Arezzo. Tuttavia il silenzio su un gastaldo potrebbe essere indice del contrario, cioè che in quella zona la sfera civile non si era mai estesa, pertanto la presenza del gastaldo aretino non era necessaria. Questa interpretazione consentirebbe di rimarcare che il distretto civile di Arezzo sarebbe rimasto sostanzialmente identico a quello di età romana, forse con la sola acquisizione di parte del territorio cortonese.
Fonti di autorità pubbliche laiche ed ecclesiastiche
Non dimentichiamo che l’unico tesoro goto rinvenuto in Tuscia, quello di Galognano, sta proprio sulla strada che poi sarà detta Francigena, presso Colle Val d’Elsa, 20 Km. a nord di Siena. Al quale ora si aggiunge anche il tesoretto di Pava e quello di poco posteriore di Farneta. E non dimentichiamo neppure che Montepulciano è un castello già nell’VIII secolo. Ricordiamo per inciso che i vecchi preti interrogati nel primo atto della disputa del 650 circa parlano espressamente dei tempi di Narsete, mentre nei documenti più tardi viene detto semplicemente al tempo dei Romani. Che un vecchio sacerdote come il testimone Tropus intorno al 650 potesse avere comunque notizia certa di fatti avvenuti meno di un secolo prima è plausibile.
È comunque sempre il vescovo aretino a chiedere giustizia. Le chiese sicure del 650 circa sono 6, quelle del 715 sono 19. Dunque fra 650 e 721 il vescovo senese, ristabilita la diocesi, si era espanso ulteriormente ai danni di Arezzo che a sua volta si era espansa ai danni di Siena, Chiusi e Cortona nella ridefinizione dei poteri e della geografia urbana progettata da Narsete.
Fonti di autorità pubbliche laiche ed ecclesiastiche
Una sanzione ufficiale di questa situazione potrebbe quindi essersi verificata alla fine della guerra gotica. La formale restaurazione giustinianea dello status
quo ante deve essersi scontrata da subito con gruppi di Goti non ancora pacificati, con gruppi di ausiliari, fra cui Longobardi, da tenere sotto controllo,
con un crescente peso dell’elemento militare, con le scorrerie franche nel nord della penisola, con le difficoltà di rapporti con ciò che rimaneva del ceto dei
possessores di nuovo sottoposto al fisco imperiale, con lo scisma tricapitolino e le sue conseguenze anche in Toscana (nella Tuscia annonaria), senza contare
la situazione di profondo degrado sia delle città che delle campagne.
Durante la prima età longobarda Chiusi e Siena tornarono ad essere punti strategici e come tali tornarono ad avere un ruolo propulsore. In realtà Chiusi, pur sede di ducato, sembra decisamente in secondo piano rispetto a Siena. Dunque neppure in questo periodo possiamo pensare che la giurisdizione ecclesiastica abbia potuto in qualche modo rivendicare i vecchi territori. Né quella civile sembra aver avuto interesse o forza di contrapporsi a Siena.
Pressata da quest’ultima a nord-ovest e stretta su Perugia bizantina a nord-est l’unica spinta chiusina è infatti verso ovest, verso l’Amiata rosellano, fino
all’enclave presso le saline costiere di Castiglione della Pescaia.
Fonti di autorità pubbliche laiche ed ecclesiastiche
Fra le fonti altomedievali che vengono più utilizzate da storici e archeologi figurano I cosiddetti polittici, ovvero degli inventari di beni di proprietà di grandi enti monastici. Come
sempre c'è stato un dibattito sul significato di questi elenchi così insolitamente dettagliati per l'altomedioevo. Ovvero: quanto rappresentano una realtà concreta e quanto sono
un'aspirazione? Vediamo in questo caso un passo del polittico di S. Giulia di Brescia, e in particolare il passo che riguarda la curtis di Temulina, oggi Timoline nel comune di Corte Franca in provincia di Brescia. Il documento è edito in Castagnetti A., Luzati M., Pasquali
G., Vasina A. a cura di 1979. Inventari altomedievali di terre, coloni e redditi. Istituto storico italiano per il Medioevo, fonti per la storia d'Italia, 104. Roma.
In curte Temulina casas III, caminatas III, terra arabilis ad seminandum mod(ia) XXX[II], vinea ad anf(oras) LX, de prada ad car(ra)d(as) VI; prebendarii infra curte: masculi maiores III, feminas IIII, infantes VII; boves III, por[cos X]VI, oves XII, aucas IIII, pullos XXX; de frum(en)to mod(ia) IIII, de segale mod(ia) XXX, s(e)s(taria) III, de ordeo mod(ia) III: et sunt insimul mod(ia) XXXVII, s(e)s(taria) III; [de gran]o mod(ia) XL, de vino anf(oras) XL; et sunt manentes XVII, qui reddunt de vino medietate ... XVII, de argento sol(i)d(os) V et den(arios) VII, pullos XXXIII, ova CLX, et faciunt toti insimul opera in anno II milia CCL; et supra nominati [pre]bendarii accipiunt in anno de grano mod(ia) CLVIIII. De beneficio Gariverti kanabarii hab(et) sorte(m) absente(m) I, qui redd(et) vinu(m) mediu(m) et opere medietate(m), pullos II, ova X.
Fonti di autorità pubbliche laiche ed ecclesiastiche
Fra la fine del XIII e I primi del XIV sono stati redatti due importanti elenchi da parte della chiesa di Roma: le cosiddette rationes decimarum, cioè l'elenco delle decime pagate dalle chiese di tutta l'Italia alla chiesa. Questo elenco è prezioso per due motivi:
1) perché fa l'elenco di chiese e pievi su base diocesana
2) perché ci informa della ricchezza di ciascuna in base a quanto paga.
Tuttavia non è una fonte priva di criticità. La più evidente è che se un ente religioso non dipendeva dal vescovo, non pagava le decime, quindi non veniva registrato. Per esempio tutti i monasteri erano in regime di autonomia. Questo significa che il quadro è certamente attendibile, ma non è esaustivo. Non ci sono tutte le chiese realmente presenti entro una diocesi in quel periodo.
Fonti di autorità pubbliche laiche ed ecclesiastiche
In età comunale la massa dei documenti aumenta in modo esponenziale tanto che ancora oggi le fonti a partire dal XIV secolo sono in gran parte inedite. Cambia anche la qualità delle fonti. Dove prima avevamo raramente dettagli sulle quantità e la topografia, ora i registri dei comuni sono invece molto precisi, proprio per la loro natura fiscale.Qui a lato una tavoletta di Biccherna, cioè il frontespizio di uno di questi registri redatti dalle magistrature senesi a partire dal 1258.
In genere queste fonti sono molto puntuali, ma non danno molte informazioni sulla topografia.
Atti notarili dai Longobardi ai Comuni
Passiamo ora ad un documento molto diverso: un atto privato, redatto da un notaio, chierico, che stabilisce una serie di obblighi reciproci fra due liberi nella Toscana longobarda.
Notiamo in particolare:
1) il dettaglio topografico
2) il dettaglio degli obblighi reciproci
3) il contesto in cui viene redatto il documento
E cerchiamo di estrarre dati topografici (e non solo).
Il documento è CDA I, 19 (772, marzo)
Atti notarili dai Longobardi ai Comuni
In D(e)i nom(ine). Regnantibus domnis hac piiss(imis) d(om)n(o)
Desiderio et Adelchis regib(us), anno regni eor(um) sexto decimo et tertio decimo, mense
martio, p(er) ind(ictione) decima. Consta me Guntifridi v(iri) d(evoti), filio q(uon)d(am) Tati,
exercitalis Clusine civitatis, hac d(ie) firmasse et firmavi te Auderado, filio Querini, in
medietate de casa genituri tuo, que havire visu sum Rosell(e), trans fluvio Umbrone, ubi
dicitur !uncarico, cum vineis, terris, silvis, pascuis, cultu et incultu, seo semoventibus
intrinsecus case, eramen, ferro, peculis, omnia et ex omnibus quantum ad ipsa medietate
de s(upra)s(crip)ta casa, qui mihi da P(er)tingo, consobrino meo, in partem advinet; in tali
viro tenure, ut tam tu q(ui) s(upra) Auderado quam eridis tus mihi iam dieta Guntifridi quam
ad eridis meus) p(er) unumquequem annos p(er)solvere divea[s] ividem, infra loco, tertia
ebdomada, tam ad mano quam et cum boves, et traere novis de dom[nico] in istate,
quando tempus fuerit, ad civitate dece modia sale.
Atti notarili dai Longobardi ai Comuni
In D(e)i nom(ine). Regnantibus domnis hac piiss(imis) d(om)n(o)
Desiderio et Adelchis regib(us), anno regni eor(um) sexto decimo et tertio decimo, mense
martio, p(er) ind(ictione) decima. Consta me Guntifridi v(iri) d(evoti), filio q(uon)d(am) Tati,
exercitalis Clusine civitatis, hac d(ie) firmasse et firmavi te Auderado, filio Querini, in
medietate de casa genituri tuo, que havire visu sum Rosell(e), trans fluvio Umbrone, ubi
dicitur !uncarico, cum vineis, terris, silvis, pascuis, cultu et incultu, seo semoventibus
intrinsecus case, eramen, ferro, peculis, omnia et ex omnibus quantum ad ipsa medietate
de s(upra)s(crip)ta casa, qui mihi da P(er)tingo, consobrino meo, in partem advinet; in tali
viro tenure, ut tam tu q(ui) s(upra) Auderado quam eridis tus mihi iam dieta Guntifridi quam
ad eridis meus) p(er) unumquequem annos p(er)solvere divea[s] ividem, infra loco, tertia
ebdomada, tam ad mano quam et cum boves, et traere novis de dom[nico] in istate,
quando tempus fuerit, ad civitate dece modia sale.
Atti notarili dai Longobardi ai Comuni
Et quod menime fieri non credo, [si] ego Gunti[fridi]•) vel meus eridis tjbi Auderado vel ad
tuos eridis amplius sup(er)inposuerimus quam supra decrivi, et exinde de ipsa casa vel ris
expellerimus, alli cognuscentis D(e)o timentis homenis, quod n(ostr)a fuerit culpa, tunc
spundeo mi ego Guntjfridi una cum meus eridis tibi Auderado vel ad tuos eridis, ut det
vobis parte de ris movile secundum usu loci istius Rosell(e), et insup(er) conpunamus
vobis sol(idos) viigintj. Unde spundeo mi ego Auderado una cum meus eridis tjbi Guntjfridi
vel ad tuus eridis, si in s(upra)s(crip)ta casa tua non residderimus et vobis angaria vel ip[so
sa)le non traerimus, omnia qual(iter) superius decrivistis non p(er)solseremu, aut de ipsa
casa egressi fuerimu seo alivve inavitaverimus, p(er) n(ostr)a sup(er)via alii cognuscentjs
D(e)i tjmentjs homenis, quod n(ostr)a fuerit culpa, tunc spundeo mi ego Auderado una cum
meus eridis tjbi Guntjfridi vel ad tuos eridis, ut exeamus inanus et vacuus de ipsa ris ubi
me superius confirmastis, et insup(er) conpunamus vobis sol(idos) viginti.
Atti notarili dai Longobardi ai Comuni
Et quod menime fieri non credo, [si] ego Gunti[fridi]•) vel meus eridis tjbi Auderado vel ad
tuos eridis amplius sup(er)inposuerimus quam supra decrivi, et exinde de ipsa casa vel ris
expellerimus, alli cognuscentis D(e)o timentis homenis, quod n(ostr)a fuerit culpa, tunc
spundeo mi ego Guntjfridi una cum meus eridis tibi Auderado vel ad tuos eridis, ut det
vobis parte de ris movile secundum usu loci istius Rosell(e), et insup(er) conpunamus
vobis sol(idos) viigintj. Unde spundeo mi ego Auderado una cum meus eridis tjbi Guntjfridi
vel ad tuus eridis, si in s(upra)s(crip)ta casa tua non residderimus et vobis angaria vel ip[so
sa)le non traerimus, omnia qual(iter) superius decrivistis non p(er)solseremu, aut de ipsa
casa egressi fuerimu seo alivve inavitaverimus, p(er) n(ostr)a sup(er)via alii cognuscentjs
D(e)i tjmentjs homenis, quod n(ostr)a fuerit culpa, tunc spundeo mi ego Auderado una cum
meus eridis tjbi Guntjfridi vel ad tuos eridis, ut exeamus inanus et vacuus de ipsa ris ubi
me superius confirmastis, et insup(er) conpunamus vobis sol(idos) viginti.
Atti notarili dai Longobardi ai Comuni
Unde due carte Trasimund(us) p(res)b(ite)r amico n(ostr)o scrivere rogavim(us). Act(um)
Rosell(e), ad s(an)c(t)o Donato, mense et regnum et ind(ictione) s(upra)s(crip)ta; fel(iciter).
Signu(m) + m(anus) Guntifri v(iri) d(evoti) firmaturi et conserbaturi,
qui hanc chartul(am) fieri rogavet
Signu(m) + m(anus) Auderadi repromissuri et conserbaturi
Signu(m) + m(anus) Karoli v(iri) d(evoti) testis
Signu(m) + m(anus) Muzziuli act(oris) v(iri d(evoti) testis
+ Ego Aluartu v(ir) v(enerabilis) p(res)b(ite)ro rogus ad Guntifrit et
Tetteup(er)tui) me testis subcribsit
Ego Trasimund(us) indignus p(res)b(ite)r post tradita conplevi et dedit.
Atti notarili dai Longobardi ai Comuni
Unde due carte Trasimund(us) p(res)b(ite)r amico n(ostr)o scrivere rogavim(us). Act(um)
Rosell(e), ad s(an)c(t)o Donato, mense et regnum et ind(ictione) s(upra)s(crip)ta; fel(iciter).
Signu(m) + m(anus) Guntifri v(iri) d(evoti) firmaturi et conserbaturi,
qui hanc chartul(am) fieri rogavet
Signu(m) + m(anus) Auderadi repromissuri et conserbaturi
Signu(m) + m(anus) Karoli v(iri) d(evoti) testis
Signu(m) + m(anus) Muzziuli act(oris) v(iri d(evoti) testis
+ Ego Aluartu v(ir) v(enerabilis) p(res)b(ite)ro rogus ad Guntifrit et
Tetteup(er)tui) me testis subcribsit
Ego Trasimund(us) indignus p(res)b(ite)r post tradita conplevi et dedit.
I primi catasti e la trasformazione della documentazione dal XIV sec.
La storia delle campagne britanniche può beneficiare di una preziosa fonte redatta da Guglielmo il conquistatore: il Domesday Book (1086-1087). Esso è il primo censimento pervenuto della storia, è stato al tempo stesso una grande opportunità e un ostacolo per gli archeologi britannici.
La cassa di legno dove fu conservato il Domesday Book fino al 1600
Il testo è una fotografia molto dettagliata della situazione delle contee appena conquistate. Quindi non riguarda tutte le isole britanniche, ma è una fonte che ha finalità fiscali, quindi il censimento è capillare e preciso. Non esiste altra fonte simile nel medioevo europeo fino al catasto fiorentino del 1427.
I primi catasti e la trasformazione della documentazione dal XIV sec.
Questa è la traduzione in Inglese. Noterete diverse parole derivanti dal sassone che non sono oggi di immediata comprensione. Hide= appezzamento di terra di ca. 120 acri, plough teams= aratro con otto buoi, bordars= persone sopra ai serfs e sotto ai villeins nella gerarchia sociale
della fattoria, burbium=sorta di borough, sokeman= libero, francigena= franco
I primi catasti e la trasformazione della documentazione dal XIV sec.
Il grado di dettaglio è così elevato che si possono estrarre dati quantitativi con possibilità di effettuare calcoli statistici attendibili che per il resto d'Europa sono possibili solo in età moderna.
In queste due immagini la contea del Bedforshire con la copertura del bosco calcolata sulla base del numero di maiali che vi potevano pascolare e in percentuale sul totale della superficie di ogni zona all'interno della contea.
I primi catasti e la trasformazione della documentazione dal XIV sec.
Il catasto fiorentino del 1427 è un altro censimento a fini fiscali, esattamente come il domesday book. È un calcolo preciso proprio perché la finalità è un'imposizione fiscale equa che tenga conto del reddito reale. Quindi le stime furono effettuate sulla totalità dei beni di proprietà di ciascun cittadino. E con grande senso di modernità, la stima delle tasse si basava su un imponibile al netto di oneri e spese necessarie.
Le fonti epigrafiche
Le epigrafi son un'altra importante fonte scritta. Tuttavia è ben noto il silenzio sugli elementi del paesaggio per l'altomedioevo. Questa terminazione della chiesa di S.
Pietro a Heppenheim (Rheinland-Pfalz) riferita al tempo di Carlo Magno è abbastanza eccezionale.
HEC E(ST) T(ER)MINATIOa) · ISTIVSb) · ECCL(ESI)E · GADERO · RVODHARDESLOCH · ANZEN · HA/SAL · HAGENBVOCHA · SVP(ER) MONTEM · EM[M]INESBERC · VSQ(VE) AD CI/LEWARDESDORSVL · KECELBERC · RORE[N]SOLVN · AHVRNENECGA / VSQ(VE) · AD · ISHENBACH · A · ISHENBACH · SVP(ER) RA[Z]EN · HAGAN · A · RAZEN · HA/GAN · VSQ(VE) AD PARVV(M) · LVDEN[WISS]COZ [A] LV[D]ENWISSCOZ · VSQ(VE) · AD / MITDELECDRVN · RICHMANNESTEN · VSQ(VE) ALBENESBACH · VNA · AL/BENESBACH · HVC · ALTERA · ILLVC · F[R]ONERVT · STENNENROS ·VSQ(VE) / SCELMENEDAL · MEGEZENRVT · S[V]LZBAC · VSQ(VE) AD MEDIVM FRETV(M) / WAGENDENROR · BLVENESBVOH[E]L · HADELLENBAC · HERDENGES/RVNNO · SNELLENGIEZO · VSQ(VE) IN MEDIV(M) · WISGOZ · ET IN ME/DIETATE · WISGOZ · VSQ(VE) · AD GADEREN · HEC · T(ER)MINATIOa) · FACTA · E(ST) · / ANNO · DOMINICEc) · I(N)d) · CARNATIONISb) · D · CCC · V · A · MAGNO · KAROLO · ROMANOR(VM) · I(M)P(ER)ATORE
Le fonti epigrafiche
Così nella massa di iscrizioni dedicatorie o, nel periodo comunale, di disposizioni per la vita cittadina, abbiamo anche qualche elemento topografico come nel caso di donazioni fatte alle chiese. Normalmente questi atti venivano scritti su pergamena, come tutti gli altri atti notarili di donazione e compravendita. Il fatto che siano riportati su pietra ne denota ovviamente il livello di importanza. In Italia a Milano e a Roma se ne conservano alcuni esemplari ascrivibili ad un ampio arco temporale fra l'VIII e il XII secolo.Questa per esempio è un'iscrizione dalla chiesa dei SS. Giovanni e Paolo al Celio a Roma sulla cui datazione è stato un acceso dibattito (fra VIII e XII).