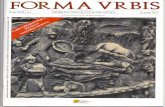Statistica e archeologia. Metodi, esempi e ...qualche ortaggio
QUIRÓS CASTILLO J. A., 2014, Archeobiologie e Archeologia Medievale. Dall’archeometria...
Transcript of QUIRÓS CASTILLO J. A., 2014, Archeobiologie e Archeologia Medievale. Dall’archeometria...
Qua
rant
’ann
i di A
rche
olog
ia M
edie
vale
in I
talia
€ 48,00
ISSN 0390-0592ISBN 978-88-7814-607-5
Numero Speciale
Numero Speciale
Quarant’anni di Archeologia Medievale in ItaliaLa rivista, i temi, la teoria e i metodia cura di Sauro Gelichi
All’Insegna del Giglio
Quarant’anni di ARCHEOLOGIA
MEDIEVALE in italia
La rivista, i temi, la teoria e i metodi
a cura di Sauro Gelichi
2014Numero Speciale
IndIce
Sauro GelichiIl ‘canto delle sirene’ e l’archeologia medievale del futuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sauro GelichiI quarant’anni di Archeologia Medievale e l’archeologia in Italia negli ultimi quarant’anni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Vincenzo Fiocchi nicolaiArcheologia medievale e archeologia cristiana: due discipline a confronto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21cristina TonghiniArcheologia medievale e archeologia islamica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Marco MilaneseDall’archeologia postclassica all’archeologia postmedievale . Temi e problemi, vecchie e nuove tendenze . . . . . . . . . . . . . . . 41Juan Antonio Quirós castilloArcheobiologie e Archeologia Medievale . Dall’archeometria all’archeologia ambientale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Franco cambiArcheologia medievale e storia e archeologia dei paesaggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63enrico GiannicheddaArcheologia della produzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75Alessandra MolinariArcheologia medievale e storia economica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95Irene BarbieraSepolture e necropoli medievali nei quarant’anni di vita di Archeologia Medievale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111Marco ValentiArcheologia delle campagne altomedievali: diacronia e forme dell’insediamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123Gian Pietro BrogioloCostruire castelli nell’arco alpino tra V e VI secolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143Giovanna BianchiArcheologia della signoria di castello (X-XIII secolo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157Andrea AugentiArcheologia della città medievale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173Guido Vannini, Michele nucciotti, chiara BonacchiArcheologia pubblica e archeologia medievale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183Martin Oswald Hugh carverMedieval archaeology: families and freedoms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197Richard HodgesMedieval Archaeology and Civic Society: Celebrating 40 years of Archeologia Medievale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205chris WickhamReflections: forty years of Archeologia Medievale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
51
Numero Speciale, 2014, pp. 51-62
1. INtroduzIoNe
La rivista Archeologia Medievale. Cultura Materiale, Insediamenti, Territorio è stata negli ultimi 40 anni una delle realtà più importanti dell’archeologia di età storica del Sud d’europa, sia per la sua capacità di stimolare e creare nuove dinamiche che hanno portato al rinnovamento continuo dello studio delle società medievali mediterranee, sia per la sua coerenza teorica e metodologica che ha segnato in modo decisivo le sorti della nostra archeologia postclassica. Intorno alla rivista si sono, inoltre, organizzate numerose iniziative editoriali sotto forma di monografie o atti di convegni che costituiscono una solida massa critica di studi che non ha pa-ralleli nell’europa meridionale. Non dobbiamo dimenticare, infine, che, insieme a Medieval Archaeology o Lund Studies in Medieval Archaeology, Archeologia Medievale è la rivista di maggior impatto scientifico in questo campo secondo diversi ranking internazionali 1.
Nell’editoriale, che nel lontano 1974 apriva il primo nu-mero della rivista, si presentava un vero programma di ricerca per lo sviluppo di una disciplina ancora non esistente e che, con il tempo e con le logiche discontinuità di un progetto quarantennale (Brogiolo 2009, pp. 160-162), è stato portato a termine in molte delle sue sfaccettature e ambizioni. oltre ad una densa e ricca banca dati d’interventi archeologici realizzati su centinaia di siti archeologici 2, ripercorrendo le pagine della rivista si ritrovano le basi dell’archeologia dell’architettura, dell’archeologia della produzione o dell’ar-cheologia postmedievale – soltanto per citare alcune delle branche più riconoscibili –, assieme a contributi fondamen-tali sull’archeologia urbana, sull’archeologia dei castelli e i villaggi abbandonati o sull’archeologia dei paesaggi. Sono anche molto consistenti gli articoli nei quali si riscontra un
* universidad del País Vasco/euskal Herriko unibertsitatea. Questo lavoro è stato condotto nell’ambito del progetto di ricerca “desigualdad en los paisajes medievales del norte peninsular: los marcadores arqueológicos” HuM 2012-32514 finanziato dal Ministero di economia e Competitività e dell’attività del “Grupo de Investigación en Patrimonio y Paisajes Culturales / ondare eta Kultur Paisaietan Ikerketa taldea” (It315-10) finanziato dal Governo Basco e la uFI Storia, Pensiero e Cultura Materiale.
1 european Science Foundation: https://www2.esf.org/asp/erIH/Foreword/search.asp; Scopus: http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId = 16000154766. Vedi anche le valutazioni espresse da Lluró 1988, p. 60 e Wickham 2001, pp. 296-297.
2 Purtroppo ancora non si ha a disposizione un indice aggiornato delle annate, che sarebbe di grande utilità per la sua gestione e lo studio. Lo strumento più importante è la banca dati realizzata all’interno del progetto di San Vincenzo al Volturno, che include anche i convegni di archeologia medievale organizzati dalla SAMI, ma che è aggiornata fino al numero dell’anno 2006 http://www.sanvincenzoalvolturno.it/indinf/ricerca.asp.
confronto serrato con gli storici che hanno portato a riscrivere e ripensare la storia dell’alto Medioevo italiano (meno quella del basso Medioevo) attraverso una pluralità di approcci e tematiche (insediamenti, castelli, città, chiese e monasteri, circolazione di merci, rituali funerari, manufatti, etc.). Non mancano neppure i contributi di natura teorica e di carat-tere più strumentale, studi su diversi tipi di materiali, saggi sulla tutela e la gestione dei beni culturali, oppure lavori che mostrano come l’archeologia sia passata dall’essere una spe-cialità accademica a una professione e una risorsa culturale per il presente. In definitiva, Archeologia Medievale mostra uno spaccato molto preciso di quanto è successo nella nostra disciplina negli ultimi 40 anni. Ma se questi sono alcuni dei temi più curati – e negli anni ci sono alcune sintesi molto utili per seguire questa storia e i suoi esiti (delogu 1986; Francovich 1987; Gelichi 1996; Wickham 1999; Gelichi 2007; Brogiolo 2009; Augenti 2009) – altre tematiche non hanno avuto lo stesso sviluppo o, addirittura, sono state trascurate.
In questa sede, dunque, si prende in considerazione una di queste aree, le archeobiologie 3, il cui apporto all’archeolo-gia medievale del sud d’europa non è ancora così rilevante. Nell’elenco delle linee guida per l’archeologia medievale raccolte nel già ricordato editoriale del primo numero della rivista si faceva riferimento, tra le altre tematiche, anche alla ‘storia dei rapporti tecnico-economici con le risorse ambien-tali’. Questo è l’unico passo di tutto il testo che può essere collegato con i dati archeobiologici, ed è formulato secondo il filtro epistemologico marxiano che impernia tutto il testo, e in generale, la miglior archeologia italiana degli anni 70 (Barbarena 1998; terrenato 1998). Anche nel sottotitolo della rivista – Cultura Materiale, Insediamenti, territorio – è chiaro quali siano state le priorità operative sulle quali è nato ed è cresciuto questo progetto. e anche se sulla spinta di tiziano Mannoni l’archeometria si è fatta spazio ed è riuscita a cristallizzarsi in una archeologia della produzione (Mannoni 1994; Mannoni, Giannichedda 1996), non è avvenuto altrettanto con l’archeobiologia, che infatti è stata più volte inserita o diluita all’interno del grande contenitore dell’archeometria (Mannoni, Molinari 1990). In modo paradossale questa scelta ha comportato che – come ha
3 In questa sede si è deciso di utilizzare questa nomenclatura che pone l’accento sulla dimensione archeologica dell’analisi dei reperti biologici, anche se è piuttosto comune il termine bioarcheologico, coniato dai biologi, o altri concetti (Shackley 1981; Francovich 1990; Motta 2000a; o’Connor, evans 1999; Wilkinson, Stevens 2003). Questa disparità riflette, in definitiva, una notevole diversità disciplinare, accademica e anche concettuale.
Juan Antonio Quirós Castillo*
ArCHeoBIoLoGIe e ArCHeoLoGIA MedIeVALe. dALL’ArCHeoMetrIA ALL’ArCHeoLoGIA AMBIeNtALe
52
J.A. QUIRÓS CASTILLO
fig. 1 – Quantificazione dei lavori realizzati in Archeologia Medievale (1974-2012).
fig. 2 – Quantificazione dei lavori editi nei convegni SAMI (1997-2012).
sottolineato M. Barceló (1988, p. 26) – l’archeologia della produzione abbia trascurato precisamente i settori produttivi più rilevanti delle società preindustriali, cioè l’agricoltura e l’allevamento, e che quindi non sia stata possibile la costru-zione di una vera archeologia agraria (Kirchner 2010). In ogni caso, negli ultimi anni si sta cambiando tendenza, foca-lizzando in modo crescente l’attenzione, le risorse e i progetti archeologici intorno ad approcci sistematici che valorizzano i record archeobiologici.
Questo lavoro è diviso in tre parti principali: nella prima si fa una valutazione complessiva dell’archeobiologia attraverso un’analisi bibliometrica della rivista Archeologia Medievale e di altre sedi editoriali con lo scopo di tracciare una sorta di bilancio critico. Successivamente si esplorano alcune delle problematiche che pone lo studio di questi record e infine, si propongono alcune tematiche di lavoro per il futuro. talvolta si faranno alcuni riferimenti necessari alla situazione spagnola che presenta molti punti di contatto con quella italiana.
53
ARCHEOBIOLOGIE E ARCHEOLOGIA MEDIEVALE. DALL’ARCHEOMETRIA ALL’ARCHEOLOGIA AMBIENTALE
fig. 3 – Quantificazione dei lavori editi in «Medieval Archaeology» (1957-2012).
fig. 4 – Quantificazione dei termini ‘Archeologia Medievale’, ‘Archeobotanica’, ‘Archeozoologia’, ‘Antropologia fisica’ e ‘Archeometria’ in Google books Ngram Viewer (1830-2008).
2. LA dIAGNoStICA
Quando cominciai a preparare questo contributo ero certo che un’analisi di carattere bibliometrico delle pri-me 39 annate della rivista Archeologia Medievale avrebbe offerto un quadro abbastanza preciso del rapporto dell’ar-cheologia medievale italiana con i record archeobiologici.
Ciononostante, la schedatura mostrò delle cifre piuttosto modeste. Negli anni 1974-2012 soltanto 113 contributi editi su Archeologia Medievale, meno del 10% degli articoli, sono dedicati specificamente allo studio di record archeobiolo-gici o sono scavi o progetti che includono studi settoriali su archeobotanica, archeofauna o osteoarcheologia (fig. 1). Soltanto 16 di essi, inoltre, sono ricerche multi-proxy, che
54
J.A. QUIRÓS CASTILLO
prendono in considerazione diversi record. Nei sei convegni nazionali organizzati tra gli anni 1997-2012 dalla Società degli Archeologi Medievisti Italiani soltanto 16 contributi (7%) prendono in considerazione questi record (fig. 2) 4. Questi numeri, sono rappresentativi di quanto è successo in Italia negli ultimi quaranta anni per quanto riguarda lo studio dell’archebiologia? Quasi certamente no, soprattutto tenendo conto che molti di questi studi specialistici sono stati utilizzati per le edizioni monografiche dei siti, per sedi e riviste specializzate o per convegni tematici nei quali hanno avuto più spazio. Ciononostante, non si tratta di un caso straor-dinario, giacché cercando un confronto con altre esperienze europee si è potuto vedere che nei 56 numeri della rivista Medieval Archaeology (1956-2012) soltanto 78 contributi prendono in considerazione questi record (fig. 3). tranne che per l’edizione di alcuni progetti o numeri tematici 5, questa situazione è comune a quella che si osserva nelle riviste della penisola iberica dedicate alle stesse tematiche (Arqueologia Medieval, Boletín de Arqueología Medieval, Arqueología y territorio Medieval, revista Catalana de Arqueología Medieval, debates de Arqueología Medieval).
un altro strumento di valutazione è l’applicazione Google Books Ngram Viewer che permette di quantificare la frequen-za con la quale compaiono diversi termini nella banca dati dei testi digitalizzati in Google Books (fig. 4). un confronto condotto sui testi italiani dei termini ‘Archeologia Medievale’, ‘Archeobotanica’, ‘Archeozoologia’, ‘Antropologia fisica’ e ‘Archeometria’ a lungo termine (1830-2008) ci mostra la precocità della tradizione dell’antropologia fisica, attestata appunto dall’anno 1830, il notevole sviluppo del termine Archeologia Medievale dagli anni Sessanta del secolo scorso e, soprattutto, il ritardo dei riferimenti alle discipline bio-archeologiche o all’archeometria. È, inoltre, da sottolineare come la frequenza dei termini archeozoologia, archeobota-nica, antropologia fisica e archeometria sia sempre inferiore a quello di Archeologia Medievale. e anche se questa quan-tificazione raccoglie unicamente un campione parziale, cioè i testi digitalizzati da Google, alcuni di questi trend trovano riscontro anche su altri indicatori.
Ma se l’approccio quantitativo ha dei grossi limiti nel cogliere le principali tendenze dell’archeobiologia applicata allo studio delle società medievali italiane, e in particolare per quanto riguarda l’archeobotanica, l’archeofauna e l’antropo-logia fisica, un approccio qualitativo permette di delineare alcuni dei principali filoni di queste ricerche (vedi anche Salvadori 2008; Grasso, Fiorentino 2009).
Semplificando in estremo si potrebbe dire che – anche se ci sono antecedenti importanti per quanto riguarda lo studio biologico dei singoli record – lo sviluppo sistematico delle ricerche archeobiologiche sono il risultato dell’affermazione dagli anni 60 della New Archaeology (evans 2003). Come è noto, le correnti processualiste hanno realizzato un forte
4 Non sono state quantificate in modo sistematico altre serie quali Quaderni di Archeologia Medievale, documenti di Archeologia, ricerche di Archeologia, Biblioteca di Archeologia Medievale e Altomedievale, Biblioteca del dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti, Quaderni del dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti. tuttavia, i saggi campionati realizzati in queste serie mostrano tendenze in linea con quanto riportato prima.
5 Vedi ad esempio il numero 4 della rivista portoghese Arqueologia Medieval dedicato all’alimentazione (Formas de habitar e alimentação na Idade Média).
investimento nello studio della dimensione ecologica delle culture, e quindi hanno sviluppato notevolmente le arche-obiologie sia dal punto di visto metodologico che da quello teorico-concettuale (ad es. Butzer 1982). In questo contesto risulta comprensibile che siano state le scuole anglosassoni di Environmental Archaeology a primeggiare. Nel resto d’eu-ropa sono emersi con forza i gruppi indirizzati allo studio delle società preistoriche, tenendo conto sia la loro diversa impostazione disciplinare rispetto all’archeologia di età storica, sia la loro maggior coscienza teorica. Infatti, ancora oggi i laboratori universitari spagnoli di archeobiologia si trovano nei dipartimenti di biologia, medicina o preistoria, nonostante la loro crescente attenzione verso lo studio delle società di età storica.
Con questi antecedenti non risulta strano che il primo lavoro realizzato in Italia sull’archeofauna di età medievale sia stato condotto da un autore britannico impegnato all’epoca nell’archeologia preistorica e caratterizzato da una marcato approccio processualista, G. Barker (Barker 1973), Questo autore ha realizzato negli anni Settanta importanti ricerche in più siti del centro d’Italia e una prima sintesi sulla fauna e l’economia medievale in Italia (Id. 1973, 1977, 1981). Ma in realtà Barker non è stato che uno dei tanti ricercatori britan-nici impegnati nello studio degli ecofatti dell’Italia medievale, com’è ben visibile attraverso volumi quali i Papers in Italian Archaeology (Blake, Potter, Whitehouse 1981), la stessa rivista della British School at Rome o le monografie pubblicate dalla scuola britannica di roma. da questo punto di vista il confronto con la Spagna, carente quasi completamente di archeologi britannici indirizzati allo studio delle società di età storica, è molto notevole.
tuttavia, negli anni in cui nasce la rivista Archeologia Medievale buona parte degli studi archeometrici, geoarcheo-logici o bioarcheologici condotti in Italia appartengono a iniziative quasi personali, spesso realizzate ai margini dell’ac-cademia o almeno nelle sue periferie 6. Questo è il caso delle ricerche del già ricordato t. Mannoni intorno allo studio archeometrico dei manufatti oppure le ricerche realizzate da Lanfredo Castelletti sull’archeobotanica a partire già dagli anni 70 (Mannoni 1994; Castelletti 1975). La situazione è più complessa per quanto riguarda l’antropologia fisica, che può contare su una lunga traiettoria di studi medici forensi piuttosto frammentati (fig. 4), anche se il contributo di pio-nieri quali Francesco Mallegni ha permesso di impostare una formulazione più prettamente archeologica di questa tematica (Ginatempo 1988; Marinato 2013). In generale il retroterra accademico, concettuale e metodologico dell’archeologia del sud d’europa non era, comunque, articolato allora intorno allo studio degli ecofatti, considerati spesso come una specia-lità secondaria o periferica rispetto all’analisi dei manufatti, dei monumenti o delle sedi abitate e abbandonate.
Gli anni ottanta si aprono con una felice iniziativa promossa dalla rivista Archeologia Medievale: il convegno dedicato alla storia dell’alimentazione nell’Italia medievale, edito nel numero VIII. In questa sede, che accoglie diversi
6 Per quanto riguarda l’archeozoologia in Spagna, che vede anche il transito delle iniziative isolate a realtà più articolate e strutturate accademicamente, vedi Morales Muñiz 1992.
55
ARCHEOBIOLOGIE E ARCHEOLOGIA MEDIEVALE. DALL’ARCHEOMETRIA ALL’ARCHEOLOGIA AMBIENTALE
contributi archeobiologici (Barker 1981; Biasotti, Isetti 1981; tozzi 1981; Fornaciari, Mallegni 1981), si sono confrontati gli storici e gli archeologi utilizzando diversi re-cord bioarcheologici, e aprendo la strada per la realizzazione di alcune sintesi tematiche (Montanari 1979; Ginatempo 1984, 1988) oppure per l’edizione in termini interdisciplinari delle monografie di diversi siti. Infatti, è negli anni ottanta che la rivista Archeologia Medievale accoglie il maggior nu-mero di articoli incentrati sull’archeobiologia, come si indica nella figura 1, e ed è il momento in cui riscontriamo in modo crescente nelle memorie di scavo appendici o capitoli orientati allo studio degli ecofatti.
In questo periodo, inoltre, si incrementa in modo signi-ficativo il numero di ricercatori britannici (Clark 1987), francesi (Bossard Beck 1984) e soprattutto italiani impe-gnati nello studio delle società medievali attraverso la bioar-cheologia. È in questo contesto che si organizza nel 1990 il secondo ciclo di lezioni sulla ricerca applicata in Archeologia promosso dall’università di Siena e dedicato alle ‘Scienze in Archeologia’ (Mannoni, Molinari 1990) 7. Nonostante nella presentazione degli atti r. Francovich sottolineasse le difficoltà esistenti in Italia per articolare una Archaeological Science nel modo britannico e il carattere occasionale della ricerca archeometrica (Francovich 1990), in questo volume trovarono posto i “freelance italiani” che dagli anni Settanta studiavano i “reperti naturalistici” (Mannoni, Molinari 1990).
Ma se l’alimentazione è stato forse il principale filone di studio intorno al quale si sono articolate queste ricerche, è invece da sottolineare come le archeobiologie non siano riuscite a trovare un loro posto all’interno dell’archeologia dei paesaggi, dove ha prevalso un approccio molto più legato alla topografia e allo studio dell’insediamento inteso come manufatti e architetture (Cambi, terrenato 1994, pp. 13-43; Cambi 2011, 17-24). Nel quarto ciclo di Lezioni sulla ricerca Applicata all’Archeologia dedicato proprio all’archeologia del paesaggio tutti i contributi che utilizzano l’“approccio paleo-ecologico” sono realizzati soltanto da ricercatori britannici, evidenziando questa asimmetria (Bernardi 1992).
Negli anni Novanta, oltre a moltiplicarsi il numero di ricercatori attivi sul campo e la consistenza critica dei loro contributi (ad es. Baker, Clark 1993), si pubblicano diversi manuali e numerose edizioni di progetti archeologici comin-ciano ad integrare in modo organico i record archeobiologici nello studio dei siti. Si tratta spesso solamente di appendici tematiche che raramente trovano spazio nella discussione e nell’interpretazione globale dei siti (Mannoni 1990, p. 38), ma la loro rilevanza è crescente. A rischio di fare un torto a tanti volumi editi negli anni ottanta e Novanta, credo che uno dei progetti più rilevanti in questi anni sia quello di Monte Barro, pubblicato nell’anno 1991 (Brogiolo,
7 Questi cicli di lezioni riflettono in modo molto netto le preoccupazioni dell’archeologia storica italiana degli ultimi 25 anni: 1 Archeologia e restauro dei monumenti; 2 Scienze in Archeologia; 3 dalla diagnosi all’edizione; 4 Archeologia del paesaggio, 5 Archeologia delle attività estrattive e metallur-giche; 6 Acculturazione e mutamenti. Prospettive nell’archeologia medievale nel Mediterraneo; 7 Sistemi informativi e reti geografiche in Archeologia, 8 Archeologia subacquea – Come opera l’archeologo sott’acqua; 9 Musei e parchi archeologici; 10 Archeologia teorica, 11 remote Sensing in Archaeology, 12 Archeologia e urbanistica.
Castelletti 1991). Anche se il volume non include un ca-pitolo di discussione e analisi complessiva del sito, è evidente l’attenzione rivolta agli aspetti ambientali.
un’accelerazione degli studi bioarcheologici si riscontra invece dalla fine degli anni Novanta e con il cambio di millennio. Non è possibile menzionare in questa sede tutti i lavori rilevanti, ma la quantificazione bibliometrica della produzione edita su Archeologia Medievale mostra ora un secondo valore massimo (fig. 1).
oltre alla quantità di studi, vorrei comunque porre l’accento su alcune questioni qualitativamente rilevanti. Prendendo in considerazione soltanto la toscana, ad esempio, i lavori sull’archeozoologia condotti da F. Salvadori sono stati centrali per l’interpretazione storica di siti quali Campiglia Marittima o Poggibonsi (Salvadori 2003, 2004, 2008; Valenti, Salvadori 2003; Bianchi 2003). Nel sito di rocca San Silvestro lo studio osteoarcheologico ha permesso di capi-re aspetti rilevanti sugli stili di vita dei minatori residenti nel villaggio (Francovich, Gruspier 1999). L’archeobotanica è stata anche molto importante per l’interpretazione delle fasi carolingie del sito di Montarrenti, come centro di raccolta di rendite (Cantini 2003). In definitiva, in questi anni va prendendo forma l’idea che gli ecofatti possono e devono essere centrali nello svolgimento delle ricerche archeologiche delle società medievali.
Ci sono diversi indizi che dimostrano l’importanza di questa svolta. Nel dizionario di archeologia del 2000 edito da r. Francovich e d. Manacorda, che rappresenta una sintesi di quello che è stata l’archeologia italiana di età storica in termini concettuali in quegli anni, trova ampio spazio l’arche-ologia ambientale in diverse voci (Boscato 2000; Mallegni 2000; Motta 2000a, 2000b, 2000c). Sempre nel 2001 F. Giovannini pubblica il suo lavoro sulla paleodemografia medievale (Giovannini 2001), nel quale cerca di costruire un’agenda di ricerca indirizzata a processare la gran massa di dati e studi osteoarcheologi prodotti negli ultimi decenni.
un altro elemento rilevante nello sviluppo degli studi archeobiologici in questo periodo è rappresentato dalla riforma degli studi universitari dell’anno 1999 (dM MIur 509/1999). Anche se non sono stati ancora condotti studi sull’impatto reale che ha avuto nell’archeologia italiana la creazione delle lauree triennali e specialistiche in archeo-logia, molte università iniziarono in quegli anni corsi di archeobotanica, archeozoologia o antropologia fisica anche attraverso contratti e collaborazioni con altri dipartimenti. una valutazione quantitativa degli insegnamenti attivati in quel momento e della loro ricaduta in termini di ricerca e di creazione di laboratori sarebbe, senz’altro, interessante per comprendere il significato di questa riforma, e di quella poste-riore del 2004 (dM 270/04). Hanno soltanto contribuito alla diffusione delle diverse branche disciplinari, oppure hanno veramente stimolato la creazione di laboratori specializzati e la realizzazione di ricerche di base? È sostenibile un sistema formativo che offra tanti corsi di laurea in archeologia?
A questo proposito un aspetto che merita di essere sotto-lineato è che, mentre in Italia l’iniziativa dello studio degli ecofatti nei contesti medievali è stata portata avanti da parte delle università e da centri di ricerca come il Museo Civico di Como, in Spagna ed altri paesi vicini è stata l’archeologia
56
J.A. QUIRÓS CASTILLO
fig. 5 – Quantificazione dei contributi presenti nei diversi convegni di Archeozoologia.
commerciale, e in particolare le cooperative e le ditte private, a portare avanti questi studi nel contesto di grandi progetti preventivi. Certamente, l’orientamento di molti di questi archeologi verso lo studio della preistoria – e quindi l’uso dei protocolli dell’archeologia preistorica –, la disponibilità di risorse per investire in progetti preventivi ambiziosi, e la coscienza che l’esecuzione di questi progetti ha determinato sempre la distruzione dei siti, spiega come l’archeologia pre-ventiva in diversi settori della Spagna sia stata una delle realtà più creative e innovatrici degli ultimi decenni.
In ogni caso, a partire da questo periodo abbiamo a di-sposizione un maggior numero di indicatori che mostrano la maturità degli studi archeobiologici e la crescente centralità raggiunta da parte di più gruppi di ricerca. Nei convegni nazionali di archeozoologia italiana il numero di contributi incentrati sul periodo postclassico, appena esistenti venti anni fa, rappresentano oggi un numero molto rilevante (fig. 5), l’attività di specialisti universitari e non (ad. es Museo di Como) sull’archeobotanica indirizzato allo studio del Medioevo è piuttosto intensa, e anche nei convegni della Società degli Archeologi Medievisti Italiani ci sono dei lavori di sintesi e di complessità crescente.
oggigiorno disponiamo di studi territoriali e di ricer-che tematiche che, sebbene non siano confrontabili con le esperienze del nord d’europa per quanto riguarda la massa critica dei dati, sí lo sono per quanto riguarda la comples-
sità e la natura delle analisi eseguite (Grasso, Fiorentino 2009; Salvadori 2010; Marinato 2013). dobbiamo inoltre sottolineare che nonostante le ricerche archeobiologiche siano state registrate sostanzialmente per i siti del nord e del centro Italia, negli ultimi anni sono assai rilevanti gli studi realizzati nel Meridione, in corrispondenza con il grande sviluppo raggiunto dall’archeologia medievale dell’Italia meridionale nell’ultimo decennio (ad es. Fiorentino 2004; Grasso 2011; de Venuto 2013) e con la formazione di nuovi laboratori e centri di ricerca. Non mancano progetti archeologici complessi nel trattamento degli ecofatti – come ad esempio è stato il caso dell’edizione di Campiglia (Bianchi 2003), Collegno (Pejrani 2004), San Michele alla Verruca (Gelichi, Alberti 2005), Miranduolo (Valenti 2006), Via de’ Castellari (Cantini et al. 2007), Faragola (Volpe, turchiano 2010), Nogara (Saggioro 2011), trezzo sull’Adda (Lusuardi Siena, Giostra 2012), rocchette Pannochieschi (Grassi 2013) –, ricerche tematiche (Castiglioni, rottoli 2010; 2013), oppure studi multi-proxy che propongono im-portanti percorsi di ricerca (ad es. Fiorentino et al. 2010; Arthur, Fiorentino, Grasso 2012). In definitiva, il salto qualitativo avvenuto nel primo decennio del nuovo secolo è molto rilevante giacché da allora l’archeobiologia non è più un altro invitato a cena, ma piuttosto una risorsa operativa e concettuale potente, gestita dai principali gruppi di ricerca, con la quale capire meglio le dinamiche politiche e socioeco-nomiche delle società medievali.
Gli ultimi anni, sempre difficili da valutare, pongono numerosi dubbi sulla sostenibilità della ricerca e sulla disci-plina archeologica come l’abbiamo conosciuta negli ultimi decenni. dopo la riforma Gelmini (legge 240/2010) che ha determinato gli accorpamenti dei corsi di laurea dei beni culturali, cambiamenti normativi sulla contrattazione e la disposizione di un numero massimo di docenti, sembra inevitabile lo smantellamento degli specialismi disciplinari in termini formativi. Inoltre, la riduzione dei fondi destinati ai progetti archeologici sta affievolendo ulteriormente i già magri gruppi di ricerca e riducendo l’attività sul campo. Il rischio è quello della forte settorializzazione dell’analisi degli ecofatti in ridotti sempre più limitati, tornando, di fatto, ad una situazione più prossima a quella degli anni ottanta. Il problema è che non c’è ritorno in termini concettuali, e quindi questa contrazione soltanto potrà realizzarsi a costo di grossi sacrifici della ricerca (riduzione del numero di progetti e della loro capacità analitica degli ecofatti, affidamento ai più dinamici e meglio finanziati ricercatori nordeuropei e anglossassoni, etc.).
3. eCoFAttI e ArCHeoLoGIA MedIeVALe
Sarebbe comunque un errore considerare questo salto qualitativo come una semplice innovazione di carattere tecnico, che certamente c’è stata, oppure una concessione alle metodologie archeologiche. L’esperienza, ad esempio, dell’archeologia agraria (Kirchner 2010) ci mostra come siano le agende di ricerca e gli approcci teorici quelli che determinano lo sviluppo di nuovi protocolli d’indagine, l’integrazione di nuovi specialismi e, spesso, l’innovazione metodologica. e anche se permane talvolta nell’epistemologia
57
ARCHEOBIOLOGIE E ARCHEOLOGIA MEDIEVALE. DALL’ARCHEOMETRIA ALL’ARCHEOLOGIA AMBIENTALE
processualista un approccio totalizzante basato nella neces-sità di raccogliere tutti i “dati” per garantire a posteriori lo studio di tutte le “informazioni” (Carver 1990) o l’idea che quanti più specialisti sono coinvolti più rigorosa possa essere la ricerca, l’assenza di un progetto cognoscitivo previo spiega l’inutilità e/o le limitazioni che hanno tanti scavi preventivi realizzati in Spagna negli ultimi quindici anni, realizzati con lo scopo di dare risposta alle normative e legislazioni (Quirós Castillo 2013a). Sono, quindi, gli approcci teorici e la natura dei questionari di ricerca che stanno alla base della crescente complessità del record archeologico e della centralità degli ecofatti. Prenderemmo in considerazione un paio di esempi.
Spesso gli archeologi analizzano le gerarchie e le forme di potere nel Medioevo in termini di dominio sulle persone o sulle risorse, ma poi quello che in realtà studiamo sono le forme di rappresentazione del potere: oggetti importati, elementi di prestigio, monumenti, rituali funerari, tecniche e tipi costruttivi, articolazione degli insediamenti, etc. e anche se attraverso questi indicatori si fanno inferenze sulle strutture di potere sottostanti, la verità è che spesso risulta più facile capire le strategie di distinzione che il vero funzionamento del potere e i meccanismi di dominio. diverse ricerche condotte negli ultimi anni sugli ecofatti hanno dimostrato la loro capacità spiegativa per analizzare non soltanto le rap-presentazioni del potere, ma anche i livelli e gli stili di vita e quindi le forme di dominio sociale (Ashby 2002; Lobeluck 2007, 2009; Sykes 2007, 2010). Le inferenze realizzate uti-lizzando anche questi indicatori all’interno di progetti più densi riescono ad essere molto più potenti di quelle realizzate in modo esclusivo sui manufatti (Quirós Castillo 2013b). L’esperienza accumulata nello studio delle società altomedie-vali ispaniche negli ultimi quindici anni ha mostrato che il campionamento e il trattamento dei record bioarcheologici è uno dei criteri di base per costruire record archeologici di qualità, con i quali ottenere inferenze significative e analitiche sulle strutture sociali, politiche ed economiche dei villaggi o dei centri di potere (ad es. Vigil-escalera 2003; Quirós Castillo 2013c). Per quanto riguarda i primi, molti di loro sono privi di strutture in posizione primaria e si conservano soltanto depositi secondari formati da residui domestici che riempiono strutture scavate nella roccia. In assenza di un’ana-lisi sistematica degli ecofatti, siti così poco eloquenti rendono difficile comprendere le complesse società rurali medievali. Altrettanto si può dire per quanto riguarda, lo studio delle sedi del potere, che finiscono per diventare monumenti spiegabili con reti politiche, ma spesso decontestualizzati in termini sociali.
un’altra tematica dove risulta particolarmente sorprenden-te il limitato contributo delle archeologie medievali europee è quello dello studio della formazione dello Stato. Si tratta, senz’altro, di uno degli argomenti sui quali si è costruita più teoria sociale e sul quale lavora un ampio numero di arche-ologi americani ed europei (Lull, Micó 2007). e anche se l’europa postromana è un laboratorio ideale dove analizzare sia i fallimenti che i processi di formazione di strutture po-litiche complesse, articolate a più scale, spesso usiamo nel sud d’europa delle nozioni di stato, aristocrazie, contadini o poteri locali piuttosto imprecise e ambigue che finiscono per creare pseudoproblemi rispetto alla caratterizzazione
delle società altomedievali. Lo studio dei sistemi economici del ‘lungo ottavo secolo’ (Hansen, Wickham 2000) attra-verso i manufatti e l’urbanesimo prima (Hodges 2013), e degli ecofatti recentemente (ad es. Crabtree 2010; Arthur, Fiorentino, Grasso 2012), sta permettendo di gettare luce su alcuni dei principali processi di conformazione della com-plessità politica di questo periodo. C’è ancora molta strada da fare, ma il contributo delle archeobiologie sarà decisivo nei prossimi decenni.
Le sfide proposte dallo studio di queste problematiche alla ricerca archeologica e archeobiologica non possono essere, comunque, risolte semplicemente integrando nelle fasi del postscavo degli specialismi o gestendo le analisi archeome-triche attraverso laboratori esterni, spesso indirizzati all’ar-cheologia preistorica o ad altre tematiche piuttosto distanti. Il salto qualitativo descritto nel paragrafo precedente non è il risultato di una moltiplicazione delle risorse analitiche disponibili per lo studio dei siti di età storica, che si sarebbe tradotto in un aumento quantitativo degli studi bioarche-ologici, ma piuttosto il risultato della problematicizzazione storica degli ecofatti e della sua compartecipazione in sede interpretativa. tutto questo richiede e sta richiedendo, un complesso processo di alfabetizzazione bioarcheologica da parte di archeologi, che sono stati formati con un retroterra culturale molto diverso. occorre, infatti, non soltanto capire le potenzialità analitiche e interpretative, ma soprattutto individuare i limiti di tutti questi record e le loro forme di uso incrociato che permettano di costruire nuovi problemi.
Bisogna, inoltre, tenere in considerazione che l’inseri-mento dello studio degli ecofatti nella progettazione ope-rativa condiziona in modo definitivo le strategie d’indagine archeologica. Questo comporta che lo scavo sia condotto in modo molto diverso giacché, spesso, privilegia le strategie di campionamento rispetto all’estensione indagata, modifica sostanzialmente le procedure di lavoro (creazione di sezioni, strumentale impiegato, sistema di documentazione, …) e determina le scelte operative sul campo. ovviamente, anche la fase postscavo è notevolmente stravolta per quanto riguarda le risorse impiegate, i tempi della ricerca, la gestione dei fondi (ad esempio, la decisione di quali datazioni radiocarboniche eseguire in funzione anche degli ecofatti) e, in generale, dell’articolazione del processo interpretativo. Altrettanto si può dire per quanto riguarda lo studio estensivo del territorio, molto incentrato nelle nostre tradizioni sull’analisi delle scelte insediative piuttosto che sulla loro integrazione in larghi studi paleoambientali (vedi per cfr. Leveau et al. 1999).
un’altra questione di carattere teorico, che ha inevitabili risvolti pratici, è quella che riguarda l’organizzazione scientifi-ca e la formazione di nuovi ricercatori. L’impegno concettuale per non esternalizzare i record bioarcheologici dal cuore della storia e dalla ricerca archeologica costituisce, al mio avviso, una delle principali scommesse per le prossime generazioni di archeologi. In un modello universitario com’è quello dell’eu-ropa meridionale – tendenzialmente monodisciplinare e dove le discipline archeologiche continuano ad essere saldamente ordinate sotto il rigido paradigma dello storicismo tradotto in compartimenti diacronici o tematici (com’è l’anacronismo dell’archeologia cristiana) – è assai difficile consolidare una carriera accademica in archeologia con un forte background
58
J.A. QUIRÓS CASTILLO
articolato nell’archeofauna, nell’antropologia fisica o nell’ar-cheobotanica 8. È enorme la differenza con altre tradizioni universitarie, come nel caso delle università britanniche dove gli specialisti in Science Archaeology sono inseriti in modo organico nei dipartimenti di Archeologia 9.
Sono piuttosto scarsi, inoltre, in tutto il sud d’europa laboratori forti e strutturati in grado sia di accogliere la crescente domanda di studi archeobiologici che di formare nuovi ricercatori. dovremmo scommettere sulla formazione in discipline bioarcheologiche dei laureati in archeologia oppure concentrarci nel potenziare questi pochi centri di ricerca esistenti, dove predominano gli specialisti formati in scienze biologiche o mediche, accentrandovi un volume massiccio di ricerche che permetta il loro consolidamento e la creazione di forme di dialogo stabile con gli archeologi?
Queste problematiche operative sono oggi, più che mai, fondamentali per capire il futuro delle bioarcheologie nello studio delle società di età storica. La crescita che abbiamo conosciuto negli ultimi vent’anni è messa oggi a dura prova dalla crisi economica e, in Spagna, dalla scomparsa quasi totale dell’archeologia preventiva.
4. GuArdANdo VerSo IL Futuro
L’obiettivo di questo contributo non è tanto quello di mettere in risalto le debolezze e le minacce che gravano sulle archeobiologie, quanto piuttosto lanciare un messaggio posi-tivo e fiducioso per quanto ci aspetta nel futuro, in primis per quanto riguarda gli studenti. Anche se i corsi di laurea sono spesso orientati alla formazione di archeologi con competenze molto simili tra di loro, la diversificazione curriculare è una via fondamentale per garantire ai nuovi archeologi medie-visti di trascendere certi limiti concettuali e operativi. La specializzazione nello studio degli ecofatti, sia in sede oppure attraverso dei master realizzati a scala europea, garantisce un plus che arricchisce anche il loro futuro professionale. d’altra parte bisogna tener conto che gli studi degli ecofatti hanno raggiunto progressivamente una sua maturità, perdendo il carattere dipendente rispetto all’archeologia. Anzi, la sua crescente rilevanza in altre indirizzi di ricerca che accedono a fondi di ricerca più importanti di quelli disponibili per l’archeologia, quale è la paleoclimatologia, determinerà a breve un suo sviluppo. In questo nuovo scenario il problema principale sarà quello di evitare la separazione tra l’archeologia e le ricerche ambientali (Iriarte Chiapusso, zapata 2013).
È invece impossibile tracciare in queste poche pagine un’agenda di ricerca per il futuro. Ma non c’è dubbio che la potenzialità degli ecofatti per lo studio delle società medievali sia enorme, ed è sicuramente uno degli approcci che maggior proiezione ha nell’archeologia storica del XXI secolo. Basta rendersi conto che nelle grandi sintesi realizzate negli ultimi anni intorno a tematiche come, ad esempio, l’alto Medioevo
8 Anche se, talvolta, ci sono delle eccezioni. Sono più frequenti sicuramente nei dipartimenti di preistoria che in quelli di archeologia di età storica. Soltanto per sottolineare un esempio relativo al Medioevo vedi durand 1998.
9 Basta dire che nel volume edito recentemente per celebrare i 50 anni della rivista Medieval Archaeology una delle cinque parti è dedicata alle “Scientific perspectives on Medieval Archaeology” (Glichrist, reynolds 2009). Anche nel recente volume che celebra i 30 anni di Archeologia Medievale in Francia c’è una ampia rassegna su “Les sciences et l’archéologie” (Chapelot 2010).
ancora non c’è spazio per lo studio degli ecofatti. In volumi fondamentali come quello di C. Wickham (2005) i record archeologici come i manufatti o le sedi abitative sono sistema-tizzate in modo organico e complesso, ma l’impiego di altre risorse come quelle relative ai paesaggi, l’alimentazione o gli stili di vita avrebbero senza altro alterato alcuni dei quadri proposti e aperte nuove linee di lavoro (vedi ad esempio i re-centi lavori di McCormick 2003; davis, McCormick 2008).
Per quanto riguarda lo studio delle città, tenendo conto che gran parte dell’archeologia fatta nelle città riesce con molta difficoltà a generare veri progetti di archeologia urbana, l’Italia costituisce un luogo straordinario dove analizzare i complessi sistemi di produzione agraria e le pratiche di con-sumo alimentare, che stanno alla base di uno dei più densi sistemi urbani di tutta europa. Sono convinto che ricerche impostate su questa linea di lavoro possano essere di grande interesse, non soltanto per quanti lavorano sul Medioevo o sull’europa, ma anche per numerosi archeologi, antropologi, geografi e storici. e anche se finora gli studi sull’alimentazione urbana o sull’archeologia della produzione agraria e dell’alle-vamento sono piuttosto scarsi 10, pongono importanti quesiti rispetto alla strutturazione delle società medievali italiane.
Lo studio dei resti umani, che ha conosciuto un notevole sviluppo negli ultimi anni, costituisce senz’altro una forma di studio diretto, sia della diversità sociale che delle pratiche alimentarie o delle condizioni di vita in età medievale. Anche in questo campo, come del resto in buona parte dell’Archeo-logia Medievale italiana, si osserva una forte asimmetria tra gli studi condotti sull’alto e sul basso Medioevo. Aspetti come l’identità, l’etnicità o la mobilità sono centrali nei lavori più recenti condotti sui contesti longobardi e in generale alto-medievali (Pejrani 2004; Lusuardi Siena, Giostra 2012; Marinato 2013), e le nuove ricerche attualmente in corso sembrano molto promettenti. Per quanto riguarda il basso Medioevo sono numerosi gli scavi di cimiteri, talvolta anche grandi, ma raramente meritano l’attenzione degli studiosi. In alcune provincie spagnole questi resti archeologici non vengono di norma neppure raccolti, con la scusa che non c’è posto nei magazzini dei musei 11.
Per quanto riguarda l’Italia sono ancora scarsi i grandi cimiteri che sono stati scavati e studiati in modo sistematico e che permettano quindi di fare inferenze statistiche signi-ficative, in linea con quanto succede in altri paesi europei (Francovich, Gruspier 1999; Negro Ponzi Mancini 1999; Gelichi, Alberti 2005; Milanese 2010; ricci et al. 2012; per confronto robert, Cox 2003). Questa sarebbe, quindi, una delle priorità operative per disporre di una base quantitativa e qualitativamente significativa.
Sia per quanto riguarda lo studio paleogenetico come quello isotopico dei cimiteri medievali tuttora esiste una notevole differenza tra il regno unito e il resto dell’europa. In particolare sono ancora piuttosto scarse le ricerche rea-lizzate in Italia sugli isotopi dei resti umani (Salamon et al. 2009; ricci et al. 2012; Fornaciari et al. 2013), che si sono
10 Comunque è da segnalare per la sua rilevanza i lavori realizzati dal gruppo di Modena (ad es. Mazzanti et al. 2005; Bosi, Mercuri 2009; Bosi et al. 2011).
11 Naturalmente c’è sempre spazio per i resti umani preistorici o per la ceramica medievale, specialmente se decorata. Non si ha neanche notizia di monete che siano state rifiutate da parte di un museo.
59
ARCHEOBIOLOGIE E ARCHEOLOGIA MEDIEVALE. DALL’ARCHEOMETRIA ALL’ARCHEOLOGIA AMBIENTALE
dimostrate di grande utilità per abbordare tematiche quali lo status, le identità sociali o di genere oppure per studiare i cambiamenti negli stili di vita in termini sincronici e diacro-nici (Müldner 2009; Quirós Castillo 2013d) 12.
un’altra linea di lavoro che ancora non ha avuto uno sviluppo rilevante nel sud d’europa è lo studio degli eventi paleoclimatici e le trasformazioni paleoambientali che sono leggibili, tra gli altri record, attraverso gli ecofatti (Grove, rackham 2003; Lewit 2009). Le ricerche multi-proxy con-dotte da F.L. Cheyette (Cheyette 2008) e M. McCormick (McCormick et al. 2010), o quelle realizzate sulle fonti scritte (Squatriti 2010) pongono degli importanti problemi per la ricostruzione dei paesaggi, che hanno bisogno di un confronto territoriale, per di più tenendo conto che tante serie palinologiche sono già disponibili ma ancora non sono state processate dagli archeologi.
Sicuramente la principale sfida dell’archeologia medievale è riuscire a dialogare in modo organico con proxies molto diversi, superando la frammentazione delle singole branche disciplinari e degli specialismi. Questo richiede, non soltanto una certa dimestichezza di carattere tecnico-metodologico, ma piuttosto una certa impostazione concettuale. In termini teorici, le bioarcheologie hanno un grande potenziale nella costruzione di nuovi paradigmi olistici e sintetici orientati al superamento della frammentazione tematica-concettuale del posprocessualismo e del positivismo del processualismo. ed è qui dove emerge la centralità e la responsabilità dell’ar-cheologo nella costruzione dei record e nell’interpretazione archeologica, in stretto confronto, non soltanto con gli storici, ma anche con altre discipline come le bioarcheologie. È in questo contesto che la generica archeometria, richiamata alla fine degli anni ottanta come il grande contenitore della Archaeological Science (Mannoni, Molinari 1990), si articola in approcci più complessi e definiti.
5. CoNCLuSIoNI
In definitiva, la crescente tecnicizzazione della pratica archeologica e la compartecipazione disciplinare pone a dura prova il ricercatore che, nel 2013, deve operare delle scelte, talvolta drammatiche, nel disegno dei progetti archeologici. È oramai superato l’ingenuo impegno tuttologico che portava alla raccolta e documentazione integrale di tutte le informa-zioni ora che, grazie ad esperienze come l’archeologia urbana, sappiamo che senza una progettualità i record sono soltanto potenziali dati per un incerto futuro, spesso inutilizzabili o di scarsa utilità (Carver 2011).
Inoltre, la crisi attuale mette a repentaglio la sostenibi-lità dei gruppi pluridisciplinari di ricerca che, nei decenni precedenti, hanno potuto affrontare ricerche di una certa complessità. Quest’archeologia della crisi potrebbe diventare un’archeologia in crisi se non si è in grado di costruire record di qualità e con la complessità che gli impegni scientifici e sociali attuali richiedono. In Spagna, dove la crisi ha colpito in particolare l’archeologia commerciale (Quirós Castillo 2013a), sopravvivono spesso le ditte che trovano poche cose
12 Anche il terzo numero della rivista PCA raccoglie più contributi dedicati a questa tematica.
o che utilizzano protocolli di lavoro poco costosi rinuncian-do allo studio, tra gli altri record, degli ecofatti e portando ad una svalutazione degli interventi archeologici. In questo contesto, le realtà in processo di consolidamento come sono le archeobiologie rischiano profondamente di tornare alla sussidiarietà che hanno avuto prima degli anni Novanta.
La pianificazione della ricerca, delle risorse, della forma-zione di nuovi archeologi e, in generale, la presa di coscienza che un’altra archeologia è possibile diventa l’unica strada per-corribile perché, tra altri 40 anni, si possa tornare a celebrare il progetto di ‘Archeologia Medievale’.
RingraziamentiVorrei ringraziare a Sauro Gelichi per avermi affidato il
compito di ripercorrere queste tematiche, che sicuramente se-gneranno il futuro della nostra disciplina nei prossimi decenni. ringrazio inoltre per tutti i loro commenti e per i materiali forniti Leonor Peña, Francesca Grassi, Sonia Gobbato, Frank Salvatori, Cinzia Mantello, Gaetano di Pasquale e Giovanna Bianchi. tutti gli errori e le mancanze sono comunque respon-sabilità unica dell’autore.
BIBLIoGrAFIA
Albarella u. (ed), 2001, Environmental Archaeology: Meaning and Purpose, dordecht.
Arthur P., Fiorentino G., Grasso A.M., 2012, Roads to recovery: An investigation of early medieval agrarian strategies in Byzantine Italy in and around the eighth century, «Antiquity» 86, pp. 444-443.
Ashby S.P., 2002, The role of zooarchaeology in the interpretation of socioeconomic status: a discussion with reference to medieval Europe, «Archaeological review from Cambridge» 18, pp. 37-59.
Augenti A., 2009, Medieval Archaeology in Italy: From Prehistory to the Present Day, in r. Gilchrist, A. reynolds (eds.), «reflections: 50 year of Medieval Archaeology», London, pp. 131-154.
Baker G., 2000, Society and economy in Northern Italy in the Early Medieval Period (c. 6th11th). A Zooarchaeology Study, London.
Baker P., Clark G., 1993, Archaeozoological evidence for Medieval Italy: a critical review of the present state of research, «Archeologia Medievale», XX, pp. 45-77.
Bandini Mazzanti et al. 2005 = Bandini Mazzanti M., Bosi G., Mercuri A.M., Accorsi C.A., Guarnieri C., Plan use in a city in Northern Italy during the late Mediaeval and Renaissance periods: results of the archaebotanical investigation of “The Mirror Pit” (14th15th century A. D.) in Ferrara, «Vegetation History and Archaeo-botany» 14, pp. 442-452.
Barbanera M., 1998, L’archeologia degli italiani. Storia, metodi e orientamenti dell’archeologia classica in Italia, roma.
Barbiera I., 2008, Il mistero delle donne scomparse. Sexratio e società nel Medioevo italiano, «Archeologia Medievale», XXXV, pp. 491-501.
Barbiera I., della zuanna G., 2008, Population dynamics in Italy in the Middle Ages: new insights from Archaeological findings, «Popula-tion and development review» 35-2, pp. 367-389.
Barceló M., 1988, Los husun, los castra y los fantasmas que aún los habitan, «Castillos y territorio en al-Andalus», Granada, pp. 10-41.
Barker G., 1973, The economy of medieval Tuscania: the archaeological evidence, «Papers of the British School at rome» 41, pp. 155-177.
Barker G., 1981, Studi sulla fauna e l’economia medievale in Italia, «Archeologia Medievale», VIII, pp. 59-70.
Beldini e., 1990, Introduzione alla determinazione dei reperti faunistici, in t. Mannoni, A. Molinari (a cura di), «Scienze in Archeologia», Firenze, pp. 233-262.
Bernardi M. (a cura di), 1992, Archeologia del paesaggio, Firenze.Bertoldi F. Giacomello F., 2005, Analisi paleobiologica e paleopato
logica degli inumati, in S. Gelichi, A. Alberti (a cura di), L’aratro e il Calamo. Beneditti e Cistercensi sul Monte Pisano. Dieci anni di archeologia a San Michele alla Verruca, Pisa, pp. 239-274.
60
J.A. QUIRÓS CASTILLO
Bianchi G. (a cura di), 2003, Campiglia. Un castello e il suo territorio. I. Ricerca Storica; II. Indagine archeologica, Firenze.
Biassotti N., Isetti P., 1981, L’alimentazione dell’osteologia animale in Liguria, «Archeologia Medievale», VIII, pp. 239-236.
Bisio e., 2005, I referti faunistici: le carni per i monaci, per le guarnigioni militari e per i carbonai del Monte Grande, in S. Gelichi, A. Alberti (a cura di), L’aratro e il Calamo. Beneditti e Cistercensi sul Monte Pisano. Dieci anni di archeologia a San Michele alla Verruca, Pisa, pp. 405-431.
Blake H., Potter t., Whitehouse d., 1981, Papers in Italian Archaeology 1: The Lancaster Seminar. Recent Research in Prehistoric, Classical and Medieval Archaeology, oxford.
Boscato P., 2000, Archeozoologia, in r. Francovich, d. Manacorda (a cura di), «dizionario di Archeologia. temi, concetti e metodi», roma, pp. 34-39.
Bosi et al. 2011 = Bosi G., Mazzanti M., Florenzano A., Massamba N’siala I., Pederzoli A., rinaldi r., torri P., Mercuri A. M., Seeds/fruits, pollen and parasite remains as evidencian of site funcion: Piazza Garibaldi a Parma (N Italy) in Roman and Medieval times, «Journal of Archaeological Science» 38.7, pp. 1621-1633.
Bosi G., Mercuri A.M., 2009, Luxury food and ornamental plants at the 15th century A.D. Reinassance court of the Este family (Ferrrara, northern Italy), «Vegetation History and Archaeobotany» 18, pp. 389-402.
Bossard Beck C., 1984, Le mobilier ostéologique et botanique, in J. Pe-sez (a cura di), Brucato. Histoire et archéologie d’un habitat médiéval en Sicile, roma, pp. 615-670.
Brogiolo G.P., 2009, Italian Medieval Archaeology: Recent Developments and contemporary challenges, in r. Gilchrist, A. reynolds (eds.), Reflections: 50 year of Medieval Archaeology, London, pp. 155-171.
Brogiolo G.P., Castelletti L., 1991, Archeologia a Monte Barro 1. Il grande edificio e le torri, Lecco.
Butzer K.W., 1982, Archaeology as human ecology, Cambridge.Cambi F. (a cura di), 2011, Manuale di archeologia dei paesaggi. Meto
dologie, fonti, contesti, roma.Cambi F., terrenato N., 1994, Introduzione all’archeologia dei pae
saggi, roma.Canci A., Minozzi S., 2005, Archeologia dei resti umani. Dallo scavo
al laboratorio, roma.Cantini F., 2003, Il castello di Montarrenti. Lo scavo archeologico
(19821987). Per la storia della formazione del villaggio medievale in Toscana (secc. VIIXV), Firenze.
Cantini et al. 2007 = Cantini F., Cianferoni C., Francovich r., Scampoli e. (a cura di), Firenze prima degli Uffizi. Lo scavo di via de’ Castellani: contribute per un’archeologia urbana fra tardo antico ed età moderna, Firenze.
Carver M., 1990, Digging for data: archaeological approaches to data definition, acquisition and analysis, in r. Francovich, d. Mana-corda (a cura di), Lo Scavo archeologico dalla Diagnosi all’edizione, Firenze, pp. 45-120.
Carver M., 2011, Making Archaeology Happen. Design versus dogma, Walnut Creek.
Castelletti L., 1975, I carboni della vetreria di Monte Lecco, «Archeo-logia Medievale», II, pp. 99-122.
Castelletti L., 1990, Legni e carboni in Archeologia, in t. Mannoni, A. Molinari (a cura di), Scienze in Archeologia, Firenze, pp. 321-394.
Castelletti L., tozzi C., 1985, Archeologia e ricostruzione ambientale: la situazione italiana, in A. Moroni et al. (ed.), Atti del II Congresso nazionale della Società italiana di ecologia, Parma, pp. 909-912.
Castiglioni e., rottoli M., 2010, Il sorgo (Sorghum bicolor) nel medioevo in Italia settentrionale, «Archeologia Medievale», XXXVII, pp. 485-495.
Castiglioni e., rottoli M., 2013, Broomcorn millet, foxtail millet and sorghum in north Italian Early Medieval sites, «PCA» 3, pp. 131-144.
Chapelot J. (dir), 2010, Trente ans d’archéologie médiévale en France. Un bilan pour un avenir, Caen.
Cheyette F.L., 2008, The disappearance of the ancient landscape and the climatic anomaly of the early Middle Ages: a question to be pursued, «early Medieval europe» 16.2, pp. 127-165.
Clark G., 1987, Stock economies in medieval Italy: a critical reviwe of the archaeozoological evidence, «Archeologia Medievale», XIV, pp. 7-26.
Clark G., 1989, Animals and animal products in medieval Italy: a discussion of archaeological and historical methodology, «Papers of the British School at rome» 57 pp. 152-171.
Crabtree P. J., 2010, Agricultural innovation and socioeconomic change in early medieval Europe: evidence from Britain and France, «World Archaeology» 42.1 pp. 122-136.
davis J.r., McCormick M., 2008, The long morning of Medieval Europe. New Directions in Early Medieval Studies, London.
de Grossi Mazzorin J., 2008, Archeozoologia. Lo studio dei resti animali in archeologia, roma.
de Venuto G., 2013, Carni, lane e pellame nell’Italia del medio e basso versante adriatico, tra X e XV secolo, «PCA» 3, pp. 199-219.
delogu P., 1986, Archeologia Medievale: un bilancio di vent’anni, «Archeologia Medievale», XIII, pp. 493-505.
di Pasquale G., 2001, Che cos’è l’archeobotanica, roma.durand A., 1998, Les paysage médiévaux du Languedoc (XeXIIe
siècles), tolouse.evans J.G., 2003, Environmental Archaeology and the social order,
London.Fiorentino et al. 2010 = Fiorentino G., Caracua V., Volpe G.,
turchiano M., Quarta G., d’elia M., Calcagnile L., The first millennium AD climate fluctuactions in the Tavoliere Plain (Apulia, Italy): New preliminary data from the 14C AMSdated plant remains from the archaeological sites of Faragola, «Nuclear Instruments and Methods in Physics research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms» 268.7-8, pp. 1084-1087.
Fornaciari G., Aretini P., Lubritto C., 2013, Economie alimentari medievali e postmedievali italiane: I risultati delle analisi isotopiche dirette e I resti umani, F. redi, A. Forgione (a cura di), VI Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (L’Aquila 2013), Firenze, pp. 693-697.
Fornaciari G., Mallegni F., 1981, Alimentazione e paleopatologia, «Archeologia Medievale», VIII, pp. 353-368.
Francovich r., 1987, Archeologia e storia del medioevo italiano, roma.Francovich r., 1990, Premessa, in t. Mannoni, A. Molinari (a cura
di), Scienze in Archeologia. II Ciclo di lezioni sulla ricerca applicata in Archeologia, Firenze, pp. 5-10.
Francovich r., Gruspier K., 1999, Relating cemetery studies to regional survey: Rocca San Silvestro, a case study, in J. Bintliff, K. Sbonias, Reconstructing past population. Trends in Mediterranean Europe (3000 BCAD 1800), oxford, pp. 249-257.
Gelichi S., 1997, Introduzione all’archeologia medievale. Storia e ricerca in Italia, roma.
Gelichi S., 2007, La Arqueología Medieval en Italia: un balance, in A. Molina, J.A. eiroa, Tendencias actuales en Arqueología Medieval, Murcia, pp. 135-161.
Gelichi S., Alberti A. (a cura di), 2005, L’aratro e il Calamo. Beneditti e Cistercensi sul Monte Pisano. Dieci anni di archeologia a San Michele alla Verruca, Pisa.
Gilchrist r., reynolds A. (eds.), 2009, Reflections: 50 year of Medieval Archaeology, London.
Ginatempo M., 1984, Per la storia degli ecosistemi e dell’alimentazione medievali: recenti studi di archeozoologia in Italia, «Archeologia Medievale», XI, pp. 35-63.
Ginatempo M., 1988, Corpi e uomini tra scienza e storia: studi di osteoarcheologia umana per l’Italia medievale, «Archeologia Medievale», XV, pp. 7-65.
Giovannanini F., 2001, Natalità, moratlità e demografia dell’Italia medievale, BAr IS 950, oxford.
Grassi F. (a cura di), 2013, L’insediamento medievale nelle Colline Metallifere (Toscana, Italia). Il sito minerario di Rocchette Pannocchieschi dall’VIII al XIV secolo, BAr IS 2532, oxford.
Grasso A.M, Fiorentino G., 2009, Studi archeobotanici per l’Italia medievale: una sintesi, in G. Volpe, P. Favia (a cura di), V Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (ManfredoniaFoggia 2009), Firenze, pp. 120-125.
Grasso A.M., 2011, Analisi archeobotaniche a Supersano (LE): una comunità autosufficiente?, «PCA» 1, pp. 297-308.
Grove A.t., rackham o., 2003, The nature of Mediterranean Europe. An Ecological History, Yale.
61
ARCHEOBIOLOGIE E ARCHEOLOGIA MEDIEVALE. DALL’ARCHEOMETRIA ALL’ARCHEOLOGIA AMBIENTALE
Gruspier K., 1990, Methodology and problems in the excavation and analysis of human skeletal remains, in t. Mannoni, A. Molinari (a cura di), Scienze in Archeologia, Firenze, pp. 263-276.
Hansen I.L., Wickham C., 2000, The Long Eight Century. Production, Distribution and Demand, Leiden.
Hodges, r., 2012. Dark Age Economics. A new audit, London.Iriarte Chipausso M.J., zapata L., 2013, Por un paisaje con figuras,
«Arkeogatze» 3, pp. 23-25.Kirchner H. (ed.), 2010, Por una arqueología agrarian. Perspectivas
de investigación sobre espacios de cultivo en las sociedades medievales hispánicas, BAr International Series 2062, oxford.
Leveau et al. 1999 = Leveau P., trément F., Walsh K., Barker G. (eds), Environmental reconstruction in Mediterranean landscape. The Archaeology of the Mediterranean landscape, Populus monograph 2, oxford.
Lewit t., 2009, Pigs, presses and pastoralism: farming in the fifth to sixth centuries AD, «early Medieval europe» 17.1, pp. 77-91.
Lluró J.M., 1988, Nuevas tendencias en Arqueología y la historia del feudalismo, in M. Barceló, Arqueología medieval. En las afueras del “medievalismo”, Barcelona, pp. 53-72.
Loveluck C.P., 2007, Rural settlement, lifestyles and social change in the Later First Millennium AD: AngloSaxon Flixborough in its wider context. Excavations at Flixborough, vol. 4, oxford.
Loveluck C.P., 2009, The dynamics of elite lifestyles in the rural world, AD 6001150: archaeological perspectives from northwest Europe, F. Bougard, r. Le Jan, r. Mckitterick (ed.), La culture du haut moyen âge, une question d’élites, turnhout, pp. 139-170.
Lull V., Micó r., 2007, Arqueología del origen del Estado. Las teorías, Barcelona.
Lusuardi Siena S., Giostra C., 2012, Archeologia Medievale a Trezzo sull’Adda. Il sepolcreto longobardo e l’oratorio di San Martino. Le chiese di Santo Stefano e San Michele in Sallianense, Milano.
Mallegni F., 2000, Paleoantropologia, in r. Francovich, d. Mana-corda (a cura di), Dizionario di Archeologia. Temi, concetti e metodi, roma, pp. 211-214.
Mannoni t., 1990, Introduzione all’archeometria, in t. Mannoni, A. Molinari (a cura di), Scienze in Archeologia. II Ciclo di lezioni sulla ricerca applicata in Archeologia, Firenze, pp. 27-39.
Mannoni t., 1994, Venticinque anni di Archeologia Globale. 5. Archeometria. Geoarcheologia dei manufatti, Genova.
Mannoni t., Giannichedda e., 1996, Archeologia della produzione, torino.
Mannoni t., Molinari A. (a cura di), 1990, Scienze in Archeologia. II Ciclo di Lezioni sula ricerca applicata in Archeologia, Firenze.
Marinato M., 2013, Gli studi di bioarcheologia dei cimiteri medievali in Italia, «PCA» 3, pp. 113-130.
McCormick M., 2003, Rats, Communications and Plague? Toward and Ecological History, «Journal of Interdisciplinary History» 34, pp. 1-25.
McCormick et al. 2012 = McCormick M., Büntgen u., Cane M.A., Cook e.r., Climate change during and after the Roman Empire: reconstructing the past from scientific and historical evidence, «the Journal of Interdisciplinary History» 43.2, pp. 169-220.
Milanese M. (a cura di), 2010, Lo scavo del cimitero di San Michele ad Alghero (fine XIIIinizio XVII), Pisa.
Morales Muñiz A., 2002, 35 years of Archaezoology in Spain: a critical review, «Archaeofauna» 11, pp. 103-116.
Motta L., 2000c, Archeobotanica, in r. Francovich, d. Manacor-da (a cura di), Dizionario di Archeologia. Temi, concetti e metodi, roma, pp. 14-18.
Motta L., 2000b, Bioarcheologia, in r. Francovich, d. Manacor-da (a cura di), Dizionario di Archeologia. Temi, concetti e metodi, roma, pp. 44-46.
Motta L., 2000a, Archeologia Ambientale, in r. Francovich, d. Manacorda (a cura di), Dizionario di Archeologia. Temi, concetti e metodi, roma, pp. 3-4.
Negro Ponzi Mancini M.M. (a cura di), 1999, San Michele di Trino (VC): dal villaggio romano al castello medievale, Firenze.
o’Connor t., evans J.G., 1999, Environmental Archaeology. Principles and Methods, Sutton.
Pejrani Barrico L. (ed.), 2004, Presenze longobarde. Collegno nell’alto medioevo, torino.
Quirós Castillo J.A. (dir.), 2013a, La materialidad de la Historia. La Arqueología a inicios del siglo XXI, Madrid.
Quirós Castillo J.A., 2013b, Archaeology of power and hierarchies in early medieval villages in Northern Spain, J. Klápštē (ed.), Hierarchies in rural settlements, ruralia IX, turnhout, pp. 199-212.
Quirós Castillo J.A. (ed.), 2013c, El poblamiento rural de época visigoda en Hispania. Arqueología del campesinado en el interior peninsular, Bilbao.
Quirós Castillo J.A., 2013d, Los comportamientos alimentarios del campesinado medieval en el País Vasco y su entorno (siglos VIIIXIV), Historia Agraria 59, marzo 2013, pp. 13-41.
ricci et al. 2012 = ricci P., Mongelli V., Vitiello A., Campana S., Sirignano C., rubino M., Fornaciari G., Lubritto C., The privileged burial of the Pava Pieve (Siene, 8th century A), «rapid Communication Mass Spectrometry» 26, pp. 2393-2398.
riedel A., 1995, L’archeozoologia in Italia oggi, in AA.VV., Atti del I Convegno Nazionale di Archeozoologia (rovigo-Accademia dei Concordi, 5-7 marzo 1993), Padusa Quaderni, rovigo, pp. 9-11.
roberts C., Cox M., 2003, Health & Disease in Britain from Prehistory to the Present Day, Glouscestershire.
Saggioro F. (a cura di), 2011, Nogara. Archeologia e Storia di un villaggio medievale (scavi 20032008), roma.
Salamon et al. 2008 = Salamon M. Coppa A., McCormick M., rubini M., Vargiu r., tuross N., The consilience of historical and isotopic approaches in reconstructing the medieval Mediterranean diet, «Journal of Archeological Science» 35, pp. 1667-1672.
Salvatori F., 2003, Archeozoologia e Medioevo: lo stato degli studi, in Fiorillo r., Peduto P. (a cura di), III Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Salerno 2003), Firenze, pp. 176-181.
Salvatori F., 2004, I reperti osteologici animali, in G. Bianchi (a cura di), La Rocca di Campiglia Marittima, II. Indagine archeologica, Firenze, pp. 477-496.
Salvatori F., 2008, Desarrollos recientes de la investigación arqueozoológica medieval en Italia, in J.M. Martín Civantos (ed.), Medio Ambiente y Arqueología Medieval, Granada, pp. 43-69.
Salvatori F., 2009, Indicatori archezoologici nell’età della transizione, in G. Volpe, P. Favia (a cura di), V Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (ManfredoniaFoggia), Firenze, pp. 40-43.
Salvatori F., 2010, Campioni archeozoologici italiani di età tardoantica e medievale. Tra schedatura di laboratorio e censimento dell’edito, tesi di dottorato inedita, università di Siena.
Salvatori F., 2011, Zooarchaeologia e controllo delle risorse economiche locali nel medioevo, «PCA» 1, pp. 195-244.
Shackley M., 1981, Environmental Archaeology, London.Squatriti P., 2010, The floods of 589 and climate change at the begin
ning of the Middle Ages: an Italian microhistory, «Speculum» 85, pp. 799-826.
Sykes N., 2007, The Norman Conquest: A Zooarchaeological perspective, BAr IS 1656, oxford.
Sykes N., 2010, Deer, land, knives and halls: social change in early medieval England, «the Antiquaries Journal» 90, pp. 175-193.
terrenato M., 1998, Fra tradizione e trend. L’ultimo ventennio (19751997), in M. Barbanera, L’archeologia degli italiani. Sto ria, metodi e orientamenti dell’archeologia classica in Italia, roma, pp. 175-192.
tozzi C., 1981, L’alimentazione nella Maremma medievale, «Archeo-logia Medievale», VIII, pp. 299-304.
tozzi C., 1990, L’archeozoologia: problemi e prospettive, in t. Man-noni, A. Molinari (a cura di), Scienze in Archeologia, Firenze, pp. 209-232.
Valenti M. (a cura di), 2008, Miranduolo in Val di Merse (Chiusdino – SI), Firenze.
Valenti M., Salvadori F., 2003, Il periodo altomedievale di Poggio Imperiale (Poggibonsi, SI): dal villaggio all’azienda curtense, in r. Fiorillo, P. Peduto (a cura di), III Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Salerno 2003), Firenze, pp. 325-330.
Vigil-escalera Guirado A., 2003, Los poblados de época visigoda del Sur de Madrid: algunos aspectos económicos y sociales, I Congreso del Instituto de estudios Históricos del Sur de Madrid, Madrid, pp. 51-68.
Volpe G., turchiano M., 2010, Faragola 1. Un insediamento rurale nella Valle del Carapelle. Ricerche e Studi, Bari.
62
J.A. QUIRÓS CASTILLO
Wickham C., 1999, Early medieval archaeology in Italy: the last twenty years, «Archeologia Medievale», XXVI, pp. 7-20.
Wickham C., 2001, Una valutazione sull’archeologia medieval italiana, «Quaderni Storici» CVI, pp. 295-301.
Wickham C., 2005, Framing the early middle ages, oxford.Wilkinson K., Stevens C., 2003, Environmental Archaeology. Appro
aches, Techniques and Applications, Sutton.zanini e., 2007, Archeologia dello status sociale nell’Italia bizantina:
tracce, segni e modelli interpretativi, in G.P. Brogiolo, A. Cha-varría Arnau, Archeologia e società tra tardo antico e alto medioevo, Mantova, pp. 23-46.
SummaryArchaeobiology and Archeologia Medievale. From Archaeometry
to Environmental Archaeology.the systematic analysis of bioarchaeological records is one of the
most important innovations to have taken place within Medieval Archaeology in Southern europe in the last few years. unlike in other european research areas, such as British Medieval Archaeology, Mediterranean Historical Archaeology did not develop an academic, theoretical and methodological background that encouraged the study of the biofact. Indeed, ecofacts were often considered of only secondary importance in archaeological research, compared to artefacts. the oc-casion of the 40-year anniversary of the journal Archeologia Medievale. Cultura Materiale Insediamenti, Territorio provides the opportunity for a brief discussion of the role of bioarchaeological analysis in the study of Italian, and more generally southern european, medieval societies over the last few decades. this paper discusses the bibliometric impact of the journal Archeologia Medievale and of the conference proceedings of the Society of Italian Medieval Archaeologists in relation to the study of biofacts and ecofacts. the analysis of the late development of these research areas takes into account theoretical approaches, historical paradigms and the organization of universities and research institutes. the paper concludes with the recommendation of a number of topics that would benefit from further study.
Riassuntouna delle innovazioni più rilevanti che ha avuto luogo negli ultimi
anni nell’archeologia medievale del Sud d’europa è stata l’inserimento sistematico dei record archeobiologici nella costruzione del discorso archeologico. L’archeologia di età storica realizzata in quest’area non ha,
a differenza di altre tradizioni come quella anglosassone, un retroterra accademico, concettuale e metodologico articolato intorno allo studio degli ecofatti, considerati spesso come una specializzazione secondaria o periferica rispetto all’analisi dei manufatti, fondamentali invece all’in-terno dell’indagine archeologica. In occasione della celebrazione dei 40 anni della rivista Archeologia Medievale. Cultura Materiale, Insediamenti, Territorio si intende realizzare una breve riflessione sull’archeobiologia e sullo studio archeologico delle società medievali in Italia e, più in generale, nell’europa meridionale, negli ultimi decenni. oltre a fare una rassegna basata sull’analisi bibliometrica della rivista stessa e dei convegni nazionali organizzati dalla Società degli Archeologi Medievisti Italiani, si sono volute considerare le ragioni alla base dello sviluppo tardivo di questi orientamenti di ricerca nell’indagine archeologica e le conseguenze che ne sono derivate, ponendo l’accento sugli approcci teorici, i quadri storici e le strutture accademiche e di ricerca. Infine, si propongono alcune tematiche di studio per il futuro.
ResumenArqueobiologías y arqueología medieval. De la arqueometría a la
arqueología ambiental.una de las principales innovaciones que han tenido lugar en la
Arqueología Medieval del Sur de la europa ha sido la incorporación sis-temática de la bioarqueología en el proceso de construcción del registro arqueológico. A diferencia de otras tradiciones como la Anglosajona, la arqueología de época histórica mediterránea no cuenta con un marco académico, conceptual y metodológico que haya favorecido el estudio de los ecofactos, considerados con frecuencia como una temática secun-daria o periférica respecto al análisis de las manufacturas. en ocasión de la celebración de los cuarenta años de la revista Archeologia Medievale se presentan algunas reflexiones sobre la potencialidad que tiene la arqueobiología en el estudio de las sociedades medievales italianas y, más en general, de la europa meridional en los últimos decenios. en este trabajo se realiza un balance crítico de carácter bibliométrico de los estudios bioarqueológicos que han sido publicados en la revista y en los congresos nacionales organizados por la Sociedad de Arqueólogos Medievales Italianas, se analizan las razones que pueden explicar el desarrollo tardío de estas temáticas de investigación y las consecuen-cias de este retraso, poniendo el acento sobre los aspectos teóricos, los cuadros históricos y la organización de las estructuras académicas y de investigación. Por último se proponen algunas temáticas para el desarrollo futuro de estos trabajos.





















![I resti faunistici [Il villaggio medievale di Geridu (Sorso, SS)]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6321608b0c12e1161503c46b/i-resti-faunistici-il-villaggio-medievale-di-geridu-sorso-ss.jpg)