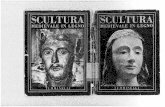Cooperação Sul-Sul brasileira - Brazilian South-South Cooperation - Cooperación Sur-Sur brasileña
Riflessioni sul cronotopo medievale
Transcript of Riflessioni sul cronotopo medievale
3
Gioia Zaganelli Riflessioni sul cronotopo medievale
La «formidabile teoria del cronotopo»1 elaborata da Michail Bachtin negli
anni venti del secolo scorso e nota al pubblico occidentale a partire dagli anni settanta, ha trovato limitatissime applicazioni all’ambito della letteratura medievale. L’indicazione fornita dallo studioso russo a considerare le categorie di tempo e spazio come strettamente interdipendenti e in quanto tali generatrici di intreccio 2 è stata infatti raccolta in un numero estremamente esiguo di saggi, e sia pur di grande impegno ermeneutico. Non solo. Dei tre lavori noti a chi scrive ben due sono dedicati alla Chanson de Roland,3 testo fondativo della tradizione epica romanza ma in qualche modo eccentrico rispetto ad essa, mentre il terzo pone domande alla tradizione romanzesca, 4 il cui cronotopo è stato suggestivamente riassunto da Bachtin nella formula «il mondo prodigioso nel tempo d’avventura».5
Il primo problema che vorrei porre in apertura di queste mie riflessioni riguarda dunque le ragioni di questa sostanziale indifferenza, che curiosamente caratterizza anche autori che conoscono e citano la teoria bachtiniana, ma che non le assegnano alcuna reale funzione operativa nello svolgimento delle proprie argomentazioni.6
Una possibile risposta potrebbe essere data chiamando in causa la conoscenza quanto mai limitata che Bachtin aveva della letteratura medievale, di cui mostra di fatto di conoscere una versione del Romanzo di Tristano e il Parzival di Wolfram von Eschenbach. Ma questa risposta lascia ovviamente il tempo che trova, e potrebbe semmai dare ragione di un interesse per l’ambito medievale tanto più forte quanto più vasto è il campo da dissodare, per verificare l’efficacia euristica e cognitiva del cronotopo su una testualità più ampia di quella nota a Bachtin. 1 Maxia 2007, 12. 2 Bachtin 1979, 231. «Chiameremo cronotopo (il che significa letteralmente “tempospazio”) l’interconnessione sostanziale dei rapporti temporali e spaziali dei quali la letteratura si è impadronita artisticamente». 3 Eckard 1996 e Segre 2001b. 4 Pioletti 2004. 5 Bachtin 1979, 301. 6 È questo ad esempio il caso dell’importante riflessione di Walter 1989 sul tempo nella narrativa romanza e della corposa analisi dell’erranza arturiana elaborata da Chênerie 1986.
Gioia Zaganelli
4
Provo dunque a cercare altrove la risposta, notando come la teoria bachtiniana ponga con grande forza l’interconnessione sostanziale di tempo e spazio, ma assegni un ruolo fondamentale e trainante al primo dei due vettori. Conferme di questo si trovano ad ogni passo nel lavoro dello studioso, e non solo nelle sue parti applicative: «Si può dire senza ambagi che il genere letterario e le sue varietà sono determinati proprio dal cronotopo, con la precisazione che il principio guida del cronotopo letterario è il tempo»,7 «In tutte le nostre analisi concentreremo l’attenzione sul problema del tempo (che è il principio guida del cronotopo) e soltanto con tutto ciò che con tale problema ha un diretto e immediato rapporto».8 Ma il tempo, o meglio la concezione del tempo, è un elemento variabile e fortemente condizionato sul piano socio-culturale, e la concezione che di esso ha Bachtin appartiene a un registro modernista, che vede il tempo come «slancio in avanti», come forza unidirezionale, lineare, progressiva, aperta verso il futuro. Questo da un lato, come è stato notato, rende il cronotopo bachtiniano inadatto alle poetiche del postmoderno, segnate da un indebolimento della concezione lineare e irreversibile del tempo a favore di visioni cicliche e puntiformi, frammentate, parcellizzate.9 Ma questo lo rende inadatto anche alle poetiche medievali, che con le poetiche postmoderne mostrano, almeno da questo punto di vista, singolari punti di affinità. E non solo per quanto riguarda la concezione del tempo. Non v’è infatti dubbio sul fatto che il mondo del romanzo medievale sia costruito su tempi e spazi privi di continuità, su momenti privilegiati e selezionati le cui relazioni prescindono da contiguità spazio-temporali. E non v’è dubbio sul fatto che i suoi protagonisti si muovano a balzi nello spazio e nel tempo, come figure su una scacchiera.10
Ecco. Questa è una prima possibile risposta al problema che ho posto più sopra, risposta il cui senso coincide con l’esigenza di ripensare, ampliare, modificare la categoria del cronotopo in relazione a concezioni del tempo e 7 Bachtin 1979, 232. 8 Ibid., 233. 9 Cfr. Maxia 2007, 10-13. 10 Questa caratteristica del romanzo medievale è stata colta in modo straordinario da Eric Rohmer nel suo Perceval le Gallois e commentata con grande efficacia da Toni 1995. Rohmer ha infatti trasferito in immagini la monodimensionalità del romanzo arturiano, facendo muovere i protagonisti del suo testo fonte, il Perceval di Chrétien de Troyes, in uno spazio-tempo bloccato e costruito da sfondi privi di qualunque impostazione prospettica. E ben dice Sandro Toni quando osserva che «il romanzo medievale contrae invece di sciogliere, preferisce fare a meno delle mediazioni e dispone sulla stessa linea gli elementi narrativi. E nei romanzi di Chrétien […] i tempi sono funzionali alla scena, non alla logica narrativa». Toni 1995, 43. Sottolineatura mia.
Riflessioni sul cronotopo medievale
5
dello spazio non sempre coincidenti con quelle utilizzate dallo studioso russo. Indicazioni in tal senso sono d’altronde fornite dallo stesso Bachtin, che a più riprese invita a non perdere mai di vista il cronotopo del «mondo raffigurante», mentre si va alla ricerca del cronotopo del mondo, o di un mondo, raffigurato.11 E indicazioni in tal senso sono fornite anche da chi, avendo colto le straordinarie potenzialità della teoria bachtiniana, ha ben precisato che la tipologia dei cronotopi fornita da Bachtin va considerata «una tassonomia aperta (per fortuna)».12
È in questa direzione che mi muoverò nelle pagine che seguono, nel tentativo di segnalare aspetti del «mondo raffigurante» medievale forse utili a definire, in chiave cronotopica, alcuni livelli del suo «mondo raffigurato». Devo però precisare che, in armonia col titolo di questo mio intervento, mi terrò sul piano di riflessioni che prescindono da finalità operative e sollecitate invece, diciamo così in astratto, da una serie di letture, o controllate in alcune letture.
E inizio da un lavoro che fornisce un’indicazione a mio parere di grande rilievo. Nelle note, brevi ma dense di suggestioni, dedicate a Il cronotopo, Cesare Segre afferma che il concetto di cronotopo va molto al di là dei rapporti, ovvii, tra tempo e spazio. Esso è infatti: criticamente produttivo quando esamina le implicazioni e gli scambi, specialmente soggettivi, tra spazio e tempo […]. Solo in questo caso il tempo e lo spazio diventano elementi costitutivi del nostro vissuto, e sono elaborati letterariamente in una grande varietà di tipi.13
Ciò che colgo in queste righe è un invito a considerare che tre, e non due,
sono i livelli coinvolti dal cronotopo. Perché se tempo e spazio vanno valutati come fascio di determinazioni riferite ad un io e dunque come specifiche attività percettive di un soggetto, quest’ultimo va portato in primo piano sulla scena dell’analisi. L’indicazione, quanto mai suggestiva, da un lato complica non poco le cose se riferita al modello medievale, in cui non solo, come già detto, la concezione del tempo è altra rispetto a quella moderna, ma radicalmente altra è anche la concezione dell’io. D’altro lato essa però in qualche modo spiana la strada, evocando un testo in cui il rapporto tra tempo, spazio e soggetto è posto, sul bagnasciuga tra mondo
11 Cfr. Bachtin 1979, in particolare 390-405. 12 Segre 2001b, 272. 13 Segre 2001a, 257. Sottolineatura mia.
Gioia Zaganelli
6
antico e mondo medievale, con efficacia insuperata. Si tratta delle Confessioni di sant’Agostino, punto nodale di una riflessione sulla storia interiore dell’io proiettata nei luoghi del tempo, recuperata nei «campi e vasti quartieri della memoria». 14 La riflessione agostiniana è ovviamente tutta segnata dal problema del rapporto tra tempo ed eternità, tra transeunte ed eterno.15 Ciò che dal nostro punto di vista possiamo però trarre da alcune pagine di Agostino è che per il soggetto, o come dice lui per lo spirito, tutto è presente ma nulla è presente, visto che il presente è solo un fragile intervallo tra ciò che non è più, o che non è ancora:
Cos’è dunque il tempo? Se nessuno mi interroga lo so; se volessi spiegarlo a chi mi interroga, non lo so. Questo però posso dire con fiducia di sapere: senza nulla che passi, non esisterebbe un tempo passato; senza nulla che venga non esisterebbe un tempo futuro; senza nulla che esista, non esisterebbe un tempo presente. Due, dunque, di questi tempi, il passato e il futuro, come esistono, dal momento che il primo non è più, il secondo non è ancora? E quanto al presente, se fosse sempre presente, senza tradursi in passato, non sarebbe più tempo, ma eternità. Se dunque il presente, per essere tempo, deve tradursi in passato, come possiamo dire anche di lui che esiste, se la ragione per cui esiste è che non esisterà?16
Eppure, continua Agostino, noi parliamo di presente, passato e futuro, li
misuriamo, ne percepiamo gli intervalli, li confrontiamo tra loro. Ma come è possibile questo, visto che i tempi passati sono inesistenti, e i futuri non ancora esistenti? È possibile, dice Agostino, perché il tempo esiste «in qualche modo nell’animo»17 e perché esso è dunque «un’estensione dello spirito stesso»,18 che non può mai impadronirsi del presente come di una zona autonoma del tempo, ma che con la memoria recupera nel presente il passato e con l’attesa anticipa nel presente il futuro:
14 Sant’Agostino, Le Confessioni, X, 8, 12. 15 Ibid., XI, 13, 16. «Non è nel tempo che tu precedi tutti i tempi. Altrimenti non li precederesti tutti. E tu precedi tutti i tempi passati dalla vetta della tua eternità sempre presente; superi tutti i futuri, perché ora sono futuri, e dopo giunti saranno passati. Tu invece sei sempre il medesimo, e i tuoi anni non finiranno mai (Sal. 101, 28 = Ebr. 1, 12). I tuoi anni non vanno né vengono; invece questi, i nostri, vanno e vengono, affinché tutti possano venire. I tuoi anni sono tutti insieme, perché sono stabili; non se ne vanno, eliminati dai venienti, perché non passano. Invece questi, i nostri, saranno tutti quando tutti non saranno più. I tuoi anni sono un giorno solo (2, Pt. 3, 8), e il tuo giorno non è ogni giorno, ma oggi, perché il tuo oggi non cede al domani, come non successe a ieri. Il tuo oggi è l’eternità». 16 Ibid., XI, 14, 17. 17 Ibid., XI, 20, 26. 18 Ibid., XI, 26, 33.
Riflessioni sul cronotopo medievale
7
Un fatto ora è limpido e chiaro: né futuro né passato esistono. È inesatto dire che i tempi sono tre: passato, presente e futuro. Forse sarebbe esatto dire che i tempi sono tre: presente del passato, presente del presente, presente del futuro. Queste tre specie di tempi esistono in qualche modo nell’animo, e non vedo altrove: il presente del passato è la memoria, il presente del presente la visione, il presente del futuro l’attesa.19
Questo collegamento del tempo, mai presente ma solo presente, alla coscienza, 20 consente di fare un passo avanti nella individuazione di modalità di percezione del tempo e del soggetto utili dal nostro punto di vista e quindi utilizzabili anche in ambiti non segnati, come nel caso di Agostino, dal mistero insondabile di Dio e dell’eterno. In questa direzione risulta di particolare interesse il commento che Arno Borst ha dato di un brano di Beda il Venerabile e di un brano di Petrarca.21 L’accostamento di un monaco anglosassone attivo all’inizio dell’VIII secolo e di un intellettuale e poeta italiano del secolo XIV può sembrare incongruo. Ma tale non è se si segue l’analisi sofisticata e sottile dello studioso, che fa notare come Beda e Petrarca condividano una stessa idea del soggetto e delle sue relazioni con il tempo. Entrambi collocano infatti il proprio punto di vista nel tempo concesso a ogni individuo, nel percorso obbligato tra nascita e morte, nel presente dunque, percepito però come caduco e transeunte e dal quale entrambi tentano di sfuggire trasferendosi in un altro livello temporale, che qui non è però quello dell’eterno bensì quello della costruzione di una tradizione, di un tempo cioè che gli uomini tutti insieme devono colmare:
Beda e Petrarca propongono una nuova continuità, tutta ancora da attuare, e danno rilievo a una tradizione che è ancora da acquisire. La storia per loro non è né unica e limitata come la vita umana, né ciclica e inscindibile come i processi naturali. Il tempo deve essere colmato da uomini che, tutti insieme, diano forma alla loro vita.22
Ma dar forma alla vita degli uomini da parte degli uomini «tutti insieme»
e vedere nelle forme di vita una tradizione da costruire, equivale a pensare il tempo come «margine delle azioni umane e in primo luogo di quelle sociali»,
19 Ibid., XI, 20, 26. 20 Nota Carlo Carena: «Così l’estensione del tempo, condizionato all’uomo e collegato con la creazione, in cui si manifesta Chi vive irraggiungibile nell’eterno, è una proiezione dell’anima, un elemento anch’esso psicologico». Carena 1984, 18-19. 21 Si tratta di un brano della Historia ecclesiastica gentis Anglorum di Beda e di un’epistola di Petrarca a Giovanni Colonna. Cfr. Borst 1988, 33-48. 22 Ibid., 48.
Gioia Zaganelli
8
come «orizzonte delle comunità storiche».23 E questo equivale a sua volta, se non fraintendo il senso dei testi e del loro commento, a pensare a una percezione collettiva, socializzata del tempo.
Conferme di questa particolare visione della temporalità si trovano in un ampio settore di studi storiografici. Jacques Le Goff e Aron Gurevič, per non citarne che alcuni, hanno in vari modi sottolineato non solo la compresenza, nel modello medievale, di tempi diversi – agrario, aristocratico, clericale, mercantile – ma anche e soprattutto il fatto che questi tempi sono, in essenza, tempi sociali.24 «Une multiplicité de temps, telle est la réalité temporelle pour l’esprit médiéval», dice ad esempio Le Goff, che poco più avanti precisa che questa molteplicità è l’immagine delle differenze sociali dell’epoca. 25 E, commentando le osservazioni dello storico francese, Gurevič nota come la specificità della temporalità medievale sia non solo o non tanto nell’assenza di un’idea unica del tempo e quindi nella pluralità dei tempi percepiti, quanto nel fatto che il tempo scorre in modo diverso non nella coscienza dei singoli individui ma in quella dei singoli gruppi, degli ordines al di fuori dei quali l’individuo non ha esistenza, né identità. Perché, dice Gurevič, il tempo dell’individuo non è un tempo individuale. O meglio, esso lo è solo nella misura in cui il tempo individuale è visto come punto di incontro e di relazione, nella coscienza, dei diversi tempi collettivi: «Il tempo dell’individuo non era il suo tempo individuale, non apparteneva a lui ma a una forza superiore al di sopra di lui».26
Ed è proprio qui che volevo arrivare, a questa constatazione importante nell’ottica delle mie pagine. Ciò che ne traggo è infatti la possibilità di pensare all’identità, o alla singolarità, di un’esistenza soggettiva nei termini di coesistenza, vale a dire di qualcosa che è inscritto non nella coscienza individuale ma nella rete delle sue relazioni. Se valutata dal punto di vista del cronotopo, questa ridefinizione di un soggetto plurale e relazionale
23 Ibid., 47. 24 Cfr. Le Goff 1964, 211-236, Le Goff 1977, Gurevič 1983, 97-162. 25 Le Goff 1964, 223, 225. «Una molteplicità di tempi, questa è la realtà temporale per lo spirito medievale». Ma si ascolti anche un letterato: «La littérature paraît attentive à cette diversité et semble présenter différents temps sociaux, différents “calendriers”, véritables traces de la réalité vécue par les hommes et les femmes du moyen âge». Walter 1989, 10. «La letteratura appare attenta a questa diversità e sembra presentare differenti tempi sociali, differenti “calendari”, vere e proprie tracce della realtà vissuta dagli uomini e dalle donne del medioevo». 26 Gurevič 1983, 148.
Riflessioni sul cronotopo medievale
9
consente di fare qualche piccolo passo in avanti nella direzione segnalata all’inizio, perché può aiutarci a rileggere, in chiave cronotopica, alcuni aspetti della testualità letteraria medievale, e dunque di un «mondo raffigurato» da valutare, come si è detto, in rapporto al suo «mondo raffigurante». Con la precisazione però che, anche in questa parte del mio lavoro, procederò con modalità deduttive più che induttive, per delineare un quadro di problemi come si vedrà interconnessi tra loro.
A tal fine chiamo di nuovo in causa uno studioso già più volte citato. Nel suo lavoro dedicato all’analisi del cronotopo della Chanson de Roland e finalizzato anche a riempire la casella dell’epica romanza, lasciata vuota da Bachtin, Segre dimostra come nel Roland la contrazione delle distanze abbia lo scopo di abbreviare i tempi, rendendo evidenti rapporti di causa ed effetto e contiguità improponibili sul piano della verosimiglianza spazio-temporale. Il tempo così accorciato, dice infatti Segre, non diventa «“breve” come la sua percezione», perché in questo caso si tratta di un tempo di ordine mitico e simbolico, in cui sono i rapporti reciproci tra i personaggi a contare e non «la disposizione su uno scacchiere verisimile».27
Anche la testualità romanzesca si presta a considerazioni che, almeno dal mio punto di vista, offrono risultati in linea con questi. Lo conferma un finissimo saggio di Peter Haidu dedicato all’analisi dei rapporti tra tempo, storia e soggettività, controllati anche in uno dei primi romanzi arturiani, l’Yvain di Chrétien de Troyes. Di quest’ultimo Haidu commenta tre momenti centrali dell’intreccio, vale a dire l’innamoramento di Yvain per Laudine, la sua denuncia pubblica da parte della damigella messaggera e il suo ritorno finale al feudo e alla sposa.28 E conclude:
Aux trois moments où notre hypothèse de travail nous suggérait qu’on était en droit de s’attendre à des développements textuels d’intériorité subjective individuelle axés sur l’isotopie de la temporalité, ils sont remarquables par leur absence. En fait, dans ce texte profondément marqué par la temporalité, celle-ci n’est pas «dans» l’individu, comme chez nous. L’isotopie de la temporalité n’est pas localisée dans un «for intérieur» supposé des individus: elle est au contraire localisée entre les individus, comme élément constitutif de leurs relations.29
27 Segre 2001b, 271. 28 Cfr. Chrétien de Troyes, Le chevalier au lion (Yvain), 1144-1544, 2640-2775, 6517-6808. 29 Haidu 1988, 119. «I tre momenti in cui la nostra ipotesi di lavoro ci suggeriva che si era in diritto di aspettarsi degli sviluppi testuali di interiorità soggettiva individuale imperniati sull’isotopia della temporalità sono da notare per la loro assenza. Infatti, in questo testo profondamente segnato dalla temporalità, questa non è “nell’”individuo come in noi.
Gioia Zaganelli
10
Ora, questa sottolineatura delle relazioni, che vengono qui fatte valere tra gli individui, o meglio tra i personaggi, mi conduce sulla soglia di un altro ordine di relazioni che valgono tra gli eventi, gli episodi, gli spazi, anche le date. Mi conduce cioè nel quadro di quel vasto sistema di echi, somiglianze e risonanze che è il quadro del pensiero analogico sul quale Antonio Pioletti ci ha invitati a riflettere nel suo saggio sul cronotopo,30 e con buona ragione data la rilevanza in epoca medievale di questo paradigma epistemologico di cui in modo tanto suggestivo ha parlato Michel Foucault. Si tratta, come è noto, di un modo di rappresentare, interpretare e conoscere basato sul riconoscimento delle somiglianze disseminate nelle cose, nel mondo e nelle parole e che l’interprete deve saper riconoscere e collegare, individuando i loro rapporti profondi a partire dalle tracce superficiali, dalle «segnature»:
Le somiglianze esigono una segnatura, poiché nessuna di esse potrebbe essere notata se non fosse contraddistinta leggibilmente. […] Ogni somiglianza riceve una segnatura; ma questa segnatura non è che una forma mediana della somiglianza stessa.31
Questa particolare modalità di rappresentazione e interpretazione ha
conseguenze anche sul piano della percezione dello spazio e del tempo. Gurevič nota non a caso come la specificità della percezione medievale del mondo e dello spazio possa essere colta solo se consideriamo con attenzione la relazione di analogia che esiste tra microcosmo e macrocosmo, visto che il microcosmo non è una piccola parte del tutto, ma «una sorta di sua replica ridotta» che con la struttura del cosmo ha una relazione di parentela, vale a dire analogica.32 Le Goff dal canto suo parla, per quanto riguarda la percezione del tempo, di «chronologie signifiante» e fa notare come per i medievali il quadro di riferimento di un episodio o di un evento non sia offerto dalla ‘cifra’, dalla data oggettiva collocata sulla linearità di un tempo divisibile e misurabile, ma dal significato della data, da decifrare all’interno di quella struttura fondamentale della mentalità medievale che è la «structure par analogie, par écho».33 Perché «n’existe vraiment que ce qui rappelle quelque chose ou quelqu’un, que ce qui a déjà existé».34
L’isotopia della temporalità non è situata in una “coscienza intima” degli individui: è situata invece tra gli individui, come elemento costitutivo delle loro relazioni». 30 Pioletti 2004. 31 Foucault 1980, 43. 32 Gurevič 1983, 59. 33 Le Goff 1964, 218. 34 Ibid. «esiste davvero solo ciò che ci ricorda qualcosa o qualcuno, ciò che è già esistito».
Riflessioni sul cronotopo medievale
11
La testualità letteraria non si sottrae a questo quadro di riferimento. Lo dimostra tra gli altri Douglas Kelly nel saggio, dal titolo quanto mai significativo nell’ottica di questa pagine, Le lieu du temps, le temps du lieu. Analizzando alcuni segmenti del Perceval di Chrétien de Troyes in cui il problema della temporalità e della cronologia è posto con particolare efficacia – cioè l’oblio del tempo di cui Perceval è attore e vittima nell’episodio delle tre gocce di sangue sulla neve, il suo successivo oblio di Dio e di nuovo del tempo nei cinque anni di inutile erranza e la riconquista del tempo nel giorno del venerdì santo – 35 Kelly spiega che questa riconquista nulla ha a che vedere con la cronologia. La domanda che Perceval rivolge ai cavalieri penitenti: «Quels jors est il dont hui?»36 è infatti pertinente solo in rapporto al significato che quel giorno contiene e cioè nel quadro di una percezione qualitativa, significante del tempo, e non quantitativa come sarebbe piuttosto la nostra.37
Le conseguenze di quanto esposto sin qui sono molteplici e non irrilevanti per la nostra riflessione sul cronotopo medievale. Ne segnalo brevemente alcune. La prima è che l’analogia, basata su echi e risonanze, su somiglianze che sono prova ed evidenza di relazioni, mette fuori gioco il principio di causalità. Tra un personaggio e l’altro, tra un episodio e l’altro, così come tra i tempi e gli spazi, non vale infatti un rapporto di causa ed effetto o di contiguità, ma una dialettica di prefigurazione e compimento, in cui si annida il significato.38 La seconda è una motivazione della struttura profondamente iterativa che caratterizza gran parte dei testi narrativi medievali. La forza del modello analogico fa infatti sì che la connessione tra scene consecutive sia subordinata a relazioni non sequenziali e Norris Lacy ha non a caso notato come il romanzo medievale solo «in the most literal sense» imprima all’azione uno sviluppo lineare e come esso richieda dunque all’ascoltatore di ieri e al lettore di oggi un movimento di andata e ritorno per collegare gli episodi in base a una logica strutturata non su contiguità spazio-temporali o su rapporti causali ma su relazioni di somiglianza.39 La terza è la rilevanza, nella narrativa medievale, della temporalità ciclica e mitica, ben segnalata tra gli altri da Philippe Walter nel suo volume sul calendario festivo.40 La quarta è la possibilità di ridisegnare, a partire di qui, 35 Chrétien de Troyes, Le roman de Perceval ou Le conte du Graal, 4144-4215, 6217-6513. 36 Ibid., 6264. «Che giorno è dunque oggi?» 37 Kelly 1988, 123. 38 Cfr. Vinaver 1988, 147-170. 39 Lacy 1974, 161. 40 Walter 1989.
Gioia Zaganelli
12
alcune frontiere di genere, come fa Friedrich Wolfzettel quando distingue i romanzi arturiani dai non arturiani proprio a partire dalla permanenza, nei primi, della visione iterativa e circolare tipica del pensiero analogico – «on dirait que le jeu romanesque est lié à l’abolition de la temporalité, trasformée en une temporalité cyclique» 41 – e dalla presenza di una temporalità lineare e irreversibile nei secondi. La quinta, e torno così al problema posto all’inizio, è che proprio modalità di rappresentazione così radicalmente altre rispetto a quelle moderne rendono forse non solo a volte inadeguate le nostre letture ma anche lievemente opaca la nozione di cronotopo così come l’ha definita Bachtin. Quanto esposto sin qui potrebbe infatti invitarci a concludere che l’alterità del modello medievale rende quel cronotopo non sufficientemente cognitivo e tale cioè da non consentire di trovare aspetti dei testi che analisi condotte su basi diverse non sono in grado di mettere in luce.
Ma quanto a questo, faccio due osservazioni conclusive, di segno opposto. Nella direzione accennata qui sopra, e quindi nella individuazione delle difficoltà che si incontrano quando si voglia utilizzare la teoria bachtiniana, un’altra ne va segnalata. Mi riferisco all’oralità di ricezione, che introduce nello spazio-tempo del testo lo spazio-tempo dell’esecuzione,42 con tutto ciò che esso comporta in termini di rapporto tra tempo della storia e tempo del racconto e tra spazi della storia e spazio pubblico in cui agisce il corpo dell’interprete. Su questo punto valgano le osservazioni definitive di Paul Zumthor: L’espace de l’œuvre vocale est public. L’œuvre est reçue comme une émanation du discours social […] Son lieu est donc ouvert, sinon à tous, du moins à une multiplicité d’auteurs-participants. Supposé que le texte soit ensuite noté par écrit et soumis à la lecture, il tend à basculer dans l’espace intellectuel et affectif du «for intérieur». Une oreille le saisissait, vibrant des bruits de la vie, sous les apparences de son lieu; maintenant, un œil décode une graphie à laquelle se réduit, durant la lecture, toute évidence.43
41 Wolfzettel 2002, 372. «si direbbe che il gioco romanzesco sia legato alla abolizione della temporalità, trasformata in una temporalità ciclica». 42 Jauss 1989, 11. «Il carattere orale della tradizione letteraria è senza dubbio un aspetto dell’alterità del Medioevo che oggi nessuno sforzo ermeneutico può pienamente ricostruire. L’invenzione della stampa è – per dirla con Paul Zumthor – l’evento che più di ogni altro ci ha precluso la cultura del Medioevo come “il tempo che sta prima”». 43 Zumthor 1993, 366. «Lo spazio dell’opera vocale è pubblico. L’opera è recepita come un’emanazione del discorso sociale […] Il suo luogo è dunque aperto, se non a tutti almeno a una molteplicità di autori-partecipanti. Supposto che il testo sia in seguito annotato per iscritto
Riflessioni sul cronotopo medievale
13
E ancora :
Romanciers et conteurs disent moins l’événement qu’ils ne le mettent en scène [et] cette extériorité propre au discours narratif médiéval (fût-ce le plus raffiné) le contraint à rendre perceptibles des rapports de temps et d’espace au moyen de symétries, d’échos, de correspondances évidentes.44
Nella direzione opposta sta da un lato il ragionamento fatto fin qui e
quindi l’invito, che rivolgo per prima a me stessa, ad approfondire l’analisi del cronotopo bachtiniano nel quadro di un peculiare modello del mondo, dello spazio e del tempo. Ma sta anche, dall’altro, la convinzione che la categoria del cronotopo possa aiutarci a dare una direzione alle analisi di tipo intertestuale, molto e molto giustamente diffuse viste le caratteristiche della scrittura medievale, ma la cui utilità sul piano interpretativo non è sempre cogente. Ed è lo stesso Bachtin che ci offre una chiave in tal senso, quando chiarisce ad esempio che tutti gli ingredienti con i quali vengono costruiti gli intrecci del romanzo greco costituitosi tra il II e il VI secolo provengono da altri generi della letteratura antica, chiarendo però al contempo come nel romanzo greco essi vengano rifusi in una nuova specifica unità romanzesca e in un cronotopo completamente nuovo, che in questo caso è quello del «mondo altrui nel tempo d’avventura».45
Ecco. Colgo in queste parole un’indicazione operativa efficace, utile ad ancorare ad un nucleo centrale e forse generatore quel processo di selezione e montaggio di temi e motivi derivati che fanno del testo medievale «le lieu de transformation d’énoncés venus d’ailleurs». 46 Nel cronotopo dei testi potremmo infatti cogliere il centro pulsante di una intertestualità non sempre facile da capire, perché impone al lettore di oggi di «negare il carattere di opera del singolo testo per attingere fino in fondo il fascino di un gioco iniziato già prima». 47 Ma in questo quadro la
e sottoposto alla lettura, esso tende a cadere nello spazio intellettuale e affettivo della “coscienza intima”. Un orecchio lo coglieva, vibrante dei rumori della vita, sotto le apparenze del suo luogo; ora, un occhio decodifica una grafia alla quale, nella lettura, si riduce ogni evidenza». 44Ibid., 380. «Romanzieri e narratori dicono meno l’evento di quanto non lo inscenino e questa esteriorità tipica del discorso narrativo medievale, anche il più raffinato, lo costringe a rendere percepibili i rapporti di tempo e di spazio per mezzo di simmetrie, echi, corrispondenze evidenti». 45 Bachtin 1979, 236. 46 Zumthor 1993, 376. «il luogo di trasformazione di enunciati venuti da altrove». 47 Jauss 1989, 12.
Gioia Zaganelli
14
riflessione sul cronotopo medievale potrebbe produrre anche altro. Perché il fascino di un «gioco iniziato già prima» informa anche le poetiche del postmoderno e la «réémergence, au seuil de notre postmodernité […] de tendances discursives, poétiques et peut-être mentales, caractéristiques, pour l’historien, de la civilisation du Moyen Age» 48 potrebbe aiutarci a ritrovare non solo conferme dell’alterità invalicabile tra Medioevo e modernità ma anche una parentela tutta da esplorare tra postmodernità – vale dire noi – e loro.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
FONTI PRIMARIE
CHRETIEN DE TROYES, Le chevalier au lion (Yvain), a cura di Mario Roques, Paris, Champion, 1960.
CHRETIEN DE TROYES, Le roman de Perceval ou Le Conte du graal, a cura di William Roach, Genève/Paris, Droz/Minard, 1959.
SANT’AGOSTINO, Le Confessioni, a cura di Carlo Carena, Milano, Mondadori, 1984. FONTI SECONDARIE
BACHTIN Michail (1979), Le forme del tempo e del cronotopo nel romanzo, in ID., Estetica e romanzo, a cura di Clara Strada Janovič, Torino, Einaudi, 231-405.
BORST Arno (1988), Forme di vita nel Medioevo, Napoli, Guida (ed. orig., Frankfurt/M-Berlin 1973).
CARENA Carlo (1984), Introduzione, in SANT’AGOSTINO, Le Confessioni, a cura di Carlo Carena, Milano, Mondadori, 7-21.
CHENERIE Marie-Luce (1986), Le chevalier errant, Genève, Droz. ECKARD Gilles (1996), Le chronotope de la «Chanson de Roland», in ROSSI Luciano (a cura
di), Ensi firent li ancessors. Mélanges de philologie médiévale offerts à Marc-René Jung, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 227-253.
FOUCAULT Michel (1980), Le parole e le cose, Milano, Rizzoli (ed. orig., Paris 1966). GUREVIĈ Aron Ja. (1983), Le categorie della cultura medievale, Torino, Einaudi (ed. orig.,
Moskva 1972). HAIDU Peter (1988), Temps, histoire, subjectivité aux XIe et XIIe siècles, in BAUMGARTNER
Emmanuèle et alia (a cura di), Le nombre du temps, en hommage à Paul Zumthor, Paris, Champion, 105-122.
JAUSS Hans Robert (1989), Alterità e modernità della letteratura medievale, Torino, Bollati 48 Zumthor 1993, 377. «riemergenza alle soglie della nostra postmodernità […] di tendenze discorsive, poetiche, e forse mentali, caratteristiche, per lo storico, della civiltà del Medio Evo».
Riflessioni sul cronotopo medievale
15
Boringhieri (ed. orig., München 1977). KELLY Douglas (1988), Le lieu du temps, le temps du lieu, in BAUMGARTNER Emmanuèle
et alia (a cura di), Le nombre du temps, en hommage à Paul Zumthor, Paris, Champion, 123-126.
LACY Norris J. (1974), Spatial Form in Medieval Romance, «Yale French Studies», LI, 160-169.
LE GOFF Jacques (1964), La civilisation de l’Occident médiéval, Paris, Arthaud. LE GOFF Jacques (1977), Nel Medioevo: tempo della Chiesa e tempo del mercante, in ID., Tempo della Chiesa e tempo del mercante, Torino, Einaudi, 3-23 (ed. orig., «Annales ESC» 1960).
MAXIA Sandro (2007), Letteratura e spazio. Introduzione, «Moderna», I, 9-17. PIOLETTI Antonio (2004), Del cronòtopo e dell’alterità nella narrativa romanza medievale, «La
Parola del Testo», VIII, 2, 305-316. SEGRE Cesare (2001a), Il cronòtopo, in ID., Ritorno alla critica, Torino, Einaudi, 253-257. SEGRE Cesare (2001b), Dal cronòtopo alla «Chanson de Roland», in ID., Ritorno alla critica,
Torino, Einaudi, 259-272. TONI Sandro (1995), Rohmer e il suo Perceval, in MARIANI Chiara (a cura di), Piccolo dizionario rohmeriano, «I Quaderni del Lumière», XII, 34-48.
VINAVER Eugène (1988), Il tessuto del racconto, Bologna, il Mulino (ed. orig., Oxford 1971).
WALTER Philippe (1989), La mémoire du temps. Fêtes et calendriers de Chrétien de Troyes à la «Mort Artu», Paris/Genève, Champion/Slatkine.
WOLFZETTEL Friedrich (2002), Temps et histoire dans la littérature arthurienne, «Bulletin Bibliographique de la Société Internationale Arthurienne», LIV, 362-384.
ZUMTHOR Paul (1993), La Mesure du monde, Paris, Seuil.