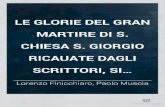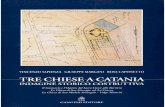La chiesa basso-medievale: il tramezzo di Ognissanti
Transcript of La chiesa basso-medievale: il tramezzo di Ognissanti
Maria Teresa Bartoli
DAL GOTICO, OLTRE LA MANIERAGli architetti di Ognissanti a Firenze
contributiStefano Giannetti e Nevena Radojevic
ediiredizioni firenze
© 2011 Ediir-Edizioni Firenze s.r.l.
Realizzazione editorialeEdiir-Edizioni Firenze
Via Fiume, 8 - 50123 FirenzeTel. 055289639 - Fax 055289478http://www.ediir.it - [email protected]
Responsabile del progetto editorialeSimone Gismondi
Responsabile editorialeElena Mariotti
Fotolito, impaginazione e stampaPacini Editore Industrie Graiche - Ospedaletto (Pisa)
Finito di stampare in Italia nel mese di dicembre 2011da Pacini Editore Industrie Graiche - Ospedaletto (Pisa)per conto di Ediir-Edizione Firenze
ISBN 978-88-7970-???-?
Fotocopie per uso personale del lettore possono essere efettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dall’accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, ConfArtigianato, CASA, CLAAI, ConfCommercio, ConfEsercenti il 18 dicembre 2000. Le riproduzioni per uso diferente da quello personale sopracitato potranno avvenire solo a seguito di speciica autorizzazione rilasciata dagli aventi diritto/dall’editore.Photocopies for reader’s personal use are limited to 15% of every book/issue of periodical and with payment to SIAE of the compensation foreseen in art. 68, codicil 4, of Law 22 April 1941 no. 633 and by the agreement of December 18, 2000 between SIAE, AIE, SNS and CNA, ConfArtigianato, CASA, CLAAI, ConfCommercio, ConfEsercenti. Reproductions for purposes diferent from the previously mentioned one may be made only after speciic authorization by those holding copyright/the Publisher.
Finanziato con fondi di ricerca Miur per progetti di ricerca scientiica d’Ateneo (ex quota 60%) e fondi residui da convenzioni con enti diversi.
INDICE
Natura, ars, logos. Epistemologia di una città medioevaleAlessandro Salucci pag. 00
Dal Gotico, oltre la maniera. Gli architetti di Ognissanti a FirenzeMaria Teresa Bartoli » 00
Rilievo, stimoli, sensazioni, conoscenza » 00L’origine di Ognissanti e il disegno di Firenze » 00Il disegno della chiesa tra Gotico e maniera » 00
Contributi
La chiesa basso-medievale: il tramezzo di OgnissantiStefano Giannetti » 00
La Quadratura di Ognissanti.Concezione dello spazio tra Barocco e IlluminismoNevena Radojevic » 00
Tavolea cura di Nevena Radojevic » 00
— 47 —
Il tramezzo nella liturgia basso-medioevale
In un celebre afresco di Giotto, conservato nella basilica superiore di Assisi, è rappresentato il presepe di Greccio. Sullo sfondo della raigurazione della nati-vità di Gesù si vede una folla assiepata dietro una pic-cola porta per assistere alla rappresentazione. La porta in questione è quella del tramezzo che distingueva la parte della chiesa destinata ai frati da quella destinata all’assemblea.
Con il termine “tramezzo” se ne deinisce la natura isica di separazione, ma, oltre a questo dato e a qualche afresco, poco si sa di questo elemento architettonico sistematicamente demolito nelle chiese medioevali dopo il Concilio di Trento. Sappiamo, per gli studi ef-fettuati, che il crociisso della “bottega di Giotto” (L’OF-
FICINA DI GIOTTO 2010) e probabilmente la Maestà dello stesso autore, poggiavano su un tramezzo anche nella chiesa di Ognissanti (Hueck 1992). L’opera del pittore ci invita ad un paragone con le chiese coeve iorenti-ne e in particolare con la vicina Santa Maria Novella, la quale, sul cosiddetto “ponte” (Borghigiani 1760; Hall 1974)
1 ospitava il più grande crociisso ligneo
mai realizzato, opera certa di Giotto (GIOTTO 2002; De Marchi 2009).
Per comprendere meglio la relazione del tramez-zo con la chiesa, è sicuramente di notevole interesse il disegno di progetto per la chiesa e il convento di San Francesco ad Arezzo 2
. La scelta di questo documen-to, per l’analisi della chiesa oggetto di questo studio, è stata incentivata da osservazioni di pari valore: la pros-simità territoriale e storica del progetto con la chiesa iorentina; la congruenza delle misure e della tipologia; la rarità di un disegno di progetto originale di una chie-sa basso-medioevale minuziosamente disegnato.
Per completare questa premessa è utile ricordare la funzione di questo elemento architettonico. Nel bas-so medioevo, da elemento divisorio partecipante alla scansione degli spazi della chiesa, dal sagrato all’altare maggiore, il tramezzo era divenuto sempre più il luo-
go intorno al quale gli ordini mendicanti, molto atten-ti all’evangelizzazione, svolgevano rappresentazioni di testi sacri. Oltre all’afresco di Giotto descritto in apertura di questo studio esistono altri documenti che testimoniano l’utilizzo teatrale del tramezzo. In parti-colare, anche se tarda, è interessante la descrizione di una sacra rappresentazione scritta dal Vescovo Abramo di Souzdal, il quale, giunto a Firenze nel 1439, descrive minuziosamente una rievocazione dell’Annunciazione alla quale assiste:
«[...] Nel mezzo poi della chiesa, centosettantacinque piedi dalla porta d’entrata, da una parete all’altra va un pon-te o tramezzo di pietra, su quattro colonne di pietra, alto ventun piedi e largo diciassette e mezzo, parato di stofe rosse: a sinistra v’è un letto di legno, ornato anch’esso di magniiche stofe, e a lato a guanciale un seggio riccamen-te coperto. Vi sedeva sopra un bel giovane, vestito di ricchi abiti femminili, con corona in capo e nelle mani un libro che
La chiesa basso-medioevale: il tramezzo di OgnissantiStefano Giannetti
1. Presepe di Greccio, affresco di Giotto, Basilica superiore di Assisi. Da notare il tramezzo sullo sfondo sul quale è collocata la Crux de
medio ecclesiae
— 48 —
Stefano Giannetti
leggeva in silenzio, e rassomigliava benissimo alla Vergine Maria. […] Da cotesto palco di pietra nel mezzo della chiesa vanno alla tribuna alta [endonartece, ndr] ch’è di fronte cin-que canapi ini ma forti. Due di essi sono attaccati non lungi dal giovane che fa da Vergine, ed è qua che per mezzo d’un terzo canapo inissimo, l’angelo inviato da Dio, discende e ritorna poi in alto giubilando, dopo l’Annunziazione. I tre altri canapi vanno appunto nel mezzo del palco.
Venuto il momento del grande e meraviglioso spettaco-lo, molta gente si raccoglie nella chiesa, silenziosa, cogli oc-chi issi al palco del tramezzo. Dopo poco cadono le cortine co’ drappi, e sul magniico seggio presso il lettuccio si vede colui che rappresenta la Vergine. Tutto ciò è bello, meravi-glioso, pieno di grazia» (Todarello 2006, p. 184).
La descrizione di questa rappresentazione, avvenu-ta nella chiesa della Santissima Annunziata a Firenze, è utile per capire come il tramezzo, ormai nel XV secolo, era divenuto il fulcro principale della chiesa e ormai lontano dalla funzione di divisorio si era trasformato in un vero e proprio palcoscenico.
Altra evidenza che ci perviene dai documenti è l’impegno profuso nell’allestimento e nella progetta-zione di questi luoghi liturgici, sempre più ricchi nel basso medioevo di opere d’arte.
«Grazie alle grandi tavole della seconda metà del Due-cento e del primo Trecento i tramezzi delle chiese centro-italiane, soprattutto di quelle degli ordini mendicanti, ma non solo, vennero qualiicati come una sorta di facciata in-terna, con la medesima organizzazione dogmatica e struttu-rale […]» (De Marchi 2009).
La ricchezza con la quale era ornato il tramezzo di Ognissanti induce ad ipotizzare che, anche nel caso de-gli Umiliati, le sacre rappresentazioni e molti momenti importanti della liturgia ruotassero attorno a questo elemento architettonico.
Il tramezzo in pianta: il disegno di progetto di San Francesco
ad Arezzo
Del tramezzo di Ognissanti non abbiamo molti do-cumenti che ne descrivano le dimensioni e la colloca-zione. Irene Hueck attraverso alcune osservazioni e la lettura di alcuni documenti descrittivi del manufatto, ricolloca il tramezzo in relazione alle due porte, or-mai tamponate, che dalla chiesa permettevano di uscire verso il convento ad est e verso il cimitero ad ovest:
Secondo il Tognocchi di Terrinca il tramezzo «doveva arrivare alla dirittura delle Porte di ianco» le quali, a suo parere, erano più o meno in mezzo alle pareti laterali. Nell’interpretazione del testo data dal Razzoli, il coro si sarebbe allungato ino all’odierno altare di Sant’An-tonio da Padova, visibile […] sulla parete sinistra prima dell’organo. L’argomento a sostegno di tale ipotesi è la collocazione ben documentata di tre opere trasferite dal transetto alle pareti laterali» (Hueck 1992).
Queste porte, seppur tamponate, sono tutt’oggi visibili e in occasione del recente rilievo del complesso di Ognissanti sono state inserite correttamente nella pianta della chiesa.
Come già accennato, per comprendere con mag-
2. Ricostruzione in pianta e in alzato del tramezzo di Ognissanti, con inserimento delle opere díarte (HUECK 1992)
— 49 —
La chiesa basso-medioevale: il tramezzo di Ognissanti
giore accuratezza il processo ideativo alla base del-la progettazione e del posizionamento del tramezzo all’interno della pianta della chiesa, questo studio si è avvalso del disegno di progetto del Convento di San Francesco di Arezzo.
In questa pergamena sono presenti molte misure dell’architettura, tuttavia gli studi precedenti efettuati sul documento hanno preso poco in considerazione tali numeri (Franchetti Pardo 1986). Infatti, analizzando il disegno 3
e confrontandolo con le misure delle chie-se aretine coeve a San Francesco, e quelle della chiesa stessa, si può afermare che l’unità di misura utilizzata in quel periodo ad Arezzo era il braccio iorentino 4. An-dando a ricostruire la pianta del convento, sulla base del-le misure riportate sulla pergamena, è possibile dedurre molte informazioni riguardo alla chiesa e il tramezzo. La chiesa è larga al lordo dei muri precisamente 29 brac-cia e 8/12 5
e il ilo del muro del tramezzo che guar-da la controfacciata dista dal ilo esterno della facciata 55 braccia e 8/12. L’area che si ottiene è precisamente di 1650 braccia quadre che equivalgono ad uno staioro (Bartoli 2007; Høyrup 1995). L’area destinata ai frati, invece, presa dallo stesso ilo del tramezzo ino al ilo esterno del muro della chiesa escluse le absidi, è di 1000 braccia esatte. Questo fa intendere che la posizione del
tramezzo crea due aree in rapporto di 1.65 tra loro. Le absidi coprono un’area, al lordo dei muri, di 650/2, ov-vero di 325 braccia quadre. Al netto dei muri la chiesa ha una supericie di 2500 braccia quadre totali, di cui 1400 braccia destinate all’assemblea, 850 al coro e 250 al pre-sbiterio. Non si possono trovare nella pergamena altre misure espresse con numeri interi che possano spiegare in modo migliore la collocazione del tramezzo.
Altro paragone che si può efettuare, al ine di com-prendere la posizione del tramezzo, è con la chiesa di Santa Maria Novella. Il “ponte” nella ricostruzione che ne fa la Hall si trovava all’altezza della seconda coppia di pilastri della navata a partire dall’altare, nei pressi degli scalini tuttora esistenti (Hall 1974). La Hall ri-costruisce questa posizione basandosi sul testo del Bor-ghigiani
6 che lo descrive così:
«Il ponte da petto a rene si stendeva per braccia 14 cir-ca, le di cui volte erano raccomandate ai due pilastroni ove adesso sono i quadri di san Pietro Martire e di san Giacinto. Sopra aveva da una parte e l’altra una sponda andante alta a mezz’uomo, per cui veniva a denominarsi ponte, e per es-sere da levante e ponente lungo, e da mezzodì a tramontana assai più stretto. Lungo era quanto è larga la chiesa, e stretto quanto è dagli scalini alla ine delle prime ile de’ sepolchri di marmo stesi sul suolo, cioè ino al principio del mattonato
3. Pianta della chiesa disegnata sulla pergamena di Arezzo. Si puÚ notare la posizione del tramezzo e le superici delle tre aree destinate al culto
4. Pianta della chiesa disegnata sulla pergamena di Arezzo sulla quale Ë stato aggiunto il transetto al ine di eguagliare líarea destinata allíassemblea a quella destinata ai consacrati
— 50 —
Stefano Giannetti
che non ha sepolture» (Borghigiani 1757-1761).Andando a sovrapporre la pianta della chiesa areti-
na, opportunamente ingrandita, con quella iorentina si nota come la posizione del tramezzo coincida perfet-tamente. Infatti a Santa Maria Novella, l’interasse della coppia di pilastri individuata come sede del ponte, dista dal ilo esterno della facciata 95 braccia 7
e dal muro di fondo, escluso l’abside e le cappelle, 59 braccia. Molti-plicando queste distanze per la larghezza della chiesa al lordo dei muri, che equivale a 50 braccia, si ottengono rispettivamente le misure di 4750 e di 2950 braccia quadre. Il rapporto fra le dimensioni in questo caso è di 1.61 circa 8
. Inoltre è interessante notare come, al netto dei
muri, le campate della «prima fase» di Santa Maria Novella (Bartoli 2009) coprono un’area di circa uno staioro. L’interasse di 18 braccia moltiplicato per la distanza, misurata tra le paraste, di 46 braccia e per il numero di campate (in questo caso due), da’ come risultato 1656 braccia quadre. Poiché l’attuale corpo
longitudinale della chiesa, anziché dalle sei diferenti campate dalle quali è costituito, potrebbe essere coper-to da sette campate equivalenti alle due più prossime all’altare (Bartoli 2009, pp. 25-28)
9, allora la misura
dell’area della chiesa ino al transetto equivale a 5800 braccia quadre esatte (18 x 46 x 7). A queste si aggiun-gono le 2450 braccia quadre del transetto portando l’intera misura alla cifra di 8250 braccia quadre: 5 sta-iora esatte. Il tramezzo, nella posizione descritta sopra, distando dalla controfacciata 91 braccia, divide quasi perfettamente a metà la supericie netta della chiesa: 8250/2 = 4125; 4125/46 = 90 circa.
Al lordo dei muri, invece, la parte presbiteriale della chiesa copre un’area di circa 1350 braccia qua-dre, che, sommata allo staioro del transetto e alle 1750 braccia quadre delle navate ino alla posizione del pon-te, portano l’area della chiesa destinata ai consacrati a 4750 braccia quadre compresi i muri. Questa, come calcolato in precedenza, è la stessa misura della super-icie della chiesa destinata all’assemblea.
5. Pianta della chiesa di Santa Maria Novella con evidenziata la posizione del tramezzo e le superici delle varie aree
6. Pianta della chiesa di Santa Maria Novella con sovrapposta la pianta modiicata della pergamena di Arezzo
— 51 —
La chiesa basso-medioevale: il tramezzo di Ognissanti
Tornando alla pergamena di Arezzo, sulla base delle osservazioni fatte sulla chiesa di Santa Maria Novella, è facile notare come, per eguagliare le due superici al lordo dei muri, è necessario aggiungere alla parte destinata ai consacrati le 325 braccia quadre mancanti per raggiungere lo staioro. Queste si possono ottenere creando un transetto che, raddoppiando le cappelle di fondo, ricalca precisamente il modello e i rapporti del-la chiesa di Santa Maria Novella.
Gli studi efettuati dalla Bartoli e pubblicati in que-sta monograia evidenziano che la supericie al lordo dei muri della chiesa di Ognissanti è di 2000 braccia quadre. Andando a cercare due numeri interi, il cui rapporto sia il più vicino possibile a 1.6, si è osservato che la distanza più congrua tra la facciata della chiesa e quella del tramezzo è quella di 47 braccia, le quali, moltiplicate per le 26.6 braccia della larghezza al lordo dei muri, individuano un’area destinata all’assemblea di 1250 braccia quadre e un’area destinata ai frati di 750 braccia quadre. Inoltre le superici nette create dal tra-
mezzo sarebbero rispettivamente di 1080 e 648 braccia quadre esatte. Questa posizione coincide, precisandone la misura, con la ricostruzione fatta dalla Hueck che colloca il tramezzo all’altezza circa dell’attuale pulpito (Hueck 1992). Va speciicato che l’attuale posizione del pulpito può essere stata inluenzata dal tramezzo, ma, sicuramente, la quota di questo non è confronta-bile con quella dell’originale; inoltre, la costruzione dell’attuale scala di accesso, poiché esterna alla chiesa, è da considerarsi sicuramente posteriore alla demoli-zione del tramezzo stesso.
L’alzato del tramezzo: il “ponte” di Santa Maria Novella
Per ricostruire l’alzato del “ponte” di Santa Maria Novella, come già visto per la pianta, un’ottima fonte è sicuramente il Borghigiani, il quale descrive accurata-mente la conformazione di questo prima della demoli-zione Vasariana:
«Sopra aveva da una parte e l’altra una sponda andante
7. Pianta della chiesa di Ognissanti nella probabile conigurazione medioevale con sovrapposto lo schema delle aree
8. Pianta della chiesa di Ognissanti nella probabile conigurazione medioevale sovrapposta alla pianta della chiesa attuale
— 52 —
Stefano Giannetti
alta a mezz’uomo, per cui veniva a denominarsi ponte, e per essere da levante e ponente lungo, e da mezzodì a tramon-tana assai più stretto. Lungo era quanto è larga la chiesa, e stretto quanto è dagli scalini alla ine delle prime ile de’ sepolchri di marmo stesi sul suolo, cioè ino al principio del mattonato che non ha sepolture; quali lapidi sepolcrali tor-navano sotto al ponte. Il piano di sopra era postato circa un braccio sopra la porta che scende nel chiostro verde, il di cui solare era tutto mattonato» (Borghigiani 1757-1761).
La Hall parla di un’altezza complessiva del ponte di 4,5 metri (Hall 1974). Ripercorrendo i suoi calcoli e le descrizioni del Borghigiani si possono descrivere più pre-cisamente le altezze in questo modo. A partire dalla quo-ta dell’architrave della porta dei frati che si apre verso il chiostro verde, misurata a partire dal livello inferiore della chiesa, si ha una misura di 5 braccia e mezzo: aggiungendo a questa misura quella di un braccio si ottiene l’imposta del solaio del ponte che si attesta all’altezza di 6 braccia e mezzo. Il Borghigiani descrive il parapetto alto mezz’uo-mo, quindi un braccio e mezzo, che, aggiunto al ponte, porta la sua altezza complessiva dal livello inferiore della chiesa a 8 braccia (4,4 metri dal livello superiore, 10 cen-timetri in meno dell’ipotesi formulata dalla Hall).
Sulla base del rilievo della chiesa, eseguito da questo gruppo di ricerca 10
, e seguendo la descrizio-
ne dell’autore, è stato possibile ricollocare il ponte in alzato e collocare su questo il crociisso. Si è potuto notare che il crociisso è in rapporto preciso con l’al-zato della chiesa. L’arco principale della chiesa, lar-ga 46 braccia al netto delle paraste, ha l’altezza della chiave pari all’altezza del triangolo equilatero di lato 46. Il crociisso di Giotto, sistemato sopra il ponte, si troverebbe circa all’altezza dell’attuale ricollocazione e avrebbe l’ombelico al centro dello stesso triangolo equilatero. Per calcolare la quota di questo punto basta moltiplicare 46 per √3 /6 ottenendo così la misura di 13 braccia e 3/12 circa.
Si è notato che in questo crociisso l’ombelico, oltre a giacere sull’asse mediano della tavola, è un elemen-to fondante della costruzione geometrica necessaria a descrivere le proporzioni del Cristo 11
. Questa, infatti, coincide con quella descritta da Vitruvio:
«Il centro del corpo è l’ombelico; infatti se si collocasse un uomo supino con le mani e i piedi aperti e si mettesse il centro del compasso nell’ombelico, descrivendo una cir-conferenza si toccherebbero tangenzialmente le dita delle mani e dei piedi. Ma non basta, oltre lo schema del cerchio nel corpo si troverà anche la igura del quadrato. Infatti se si misura dal piano di posa dei piedi al vertice del capo e poi si trasporta questa misura alle mani distese si troverà una
9. Genesi geometrica del crociisso di Giotto
10. Sezione della chiesa di Santa Maria Novella con sovrapposta la sagoma del tramezzo e il cro-ciisso di Giotto
— 53 —
La chiesa basso-medioevale: il tramezzo di Ognissanti
lunghezza uguale all’altezza come accade nel quadrato tirato a squadra» (Vitruvio).
Il centro del cerchio che passa per i tre chiodi è proprio l’ombelico e la larghezza delle braccia distese è pari all’altezza del corpo dalla testa ai piedi. Inoltre l’ombelico nello schema ad quadratum divide l’altezza del Cristo secondo il rapporto aureo 12
.Nel collocare il crociisso di Ognissanti
13 si è po-
tuto osservare che questo, escluso il trapezio di base, era alto 8 braccia (altezza equivalente al corrispettivo di Santa Maria Novella). Tuttavia, mentre la igura del Cristo di Ognissanti ha le stesse identiche proporzioni di quello di Santa Maria Novella 14
, il supporto ligneo cambia molto, ridimensionando il soggetto e collocan-dolo in un posizione inferiore della croce. Il supporto ligneo è stato ampiamente studiato in occasione del recente restauro: si è notato che la costruzione isica e geometrica è basata sulla ripetizione di un modulo quadrato di 50 cm (circa 10/12 di braccio), distribuito uniformemente lungo tutta la tavola e, in particolare, ripetuto in numeri uguali lungo le braccia e la testa della
croce (L’OFFICINA DI GIOTTO 2010). Da questa ripetizione deriva la possibilità di descrivere gran parte della croce come un quadrato il cui centro giace all’altezza della testa del Cristo. Collocando il crociisso sul tramezzo, si è osservato che la quota (13 braccia e 4/12) di que-sto punto, centro del quadrato del supporto ligneo, era molto simile a quella dell’ombelico del Cristo, centro dell’esagono, di Santa Maria Novella, e che, anche nel caso di Ognissanti, rappresentava il centro della costru-zione quadrata della sezione della chiesa nel quale era ospitata (lato di 26,5 braccia).
In medio Ecclesiae
Nella presente ricerca, l’utilizzo della misura, otte-nuta attraverso il rilievo architettonico dell’oggetto, ha permesso di precisare l’origine del processo creativo che colloca il tramezzo al centro della chiesa basso-me-dioevale. Sulla base degli studi già efettuati sul tema, è utile evidenziare il cambiamento di funzione e di posizione di questo elemento all’interno dell’ediicio basso-medioevale. Da muro di recinzione dello spazio sacro, presso l’altare maggiore delle chiese dell’alto medioevo, il tramezzo nel Trecento “scende” in medio
Ecclesiae e, al centro della Chiesa, tempio e comunità, sopra questo elemento architettonico viene collocato il Cristo: la Crux de medio ecclesiae (De Marchi 2009). Da elemento divisorio perciò diviene sempre più materia-lizzazione del legame della Chiesa, proporzionata nei suoi elementi costituenti secondo la natura isica del corpo. Come sintetizza ottimamente Alessandro Saluc-ci nella prefazione a questa monograia
Come noto, nel pensiero medioevale la ratio ten-deva a essere intesa anche nel senso di una virtù mo-rale che guidava al retto agire. La ragione pratica era insomma a servizio della giustizia, se la giustizia è in-tesa nell’accezione di “giusto rapporto”. Mentre questi mutamenti concettuali si consolidavano, l’uomo inizia-va a essere il centro prospettico dello spazio divino e sociale, come la pittura di Duccio e Giotto iniziavano a far intendere.
Perciò, porre il Cristo al centro della Chiesa, per il progettista medioevale non è un’intenzione vaga, ma un obiettivo da perseguire con strumenti scientiici, siano essi quelli classici delle lunghezze che quelli inno-vativi delle superici.
11. Sezione della chiesa di Ognissanti nella probabile conigurazione medioevale, con sovrapposta la costruzione geometrica basata sul quadrato
— 54 —
Stefano Giannetti
1 Nei casi delle due chiese maggiori iorentine non si trattava solo di una parete, ma di un vero e proprio ponte o jubè.
2 Il documento in questione si tratta di una pergamena con-servata presso l’Archivio Capitolare di Arezzo, fondo Ex Archivis Variis, capsa V, n°873. La datazione del XIV secolo è postuma e incerta, mentre l’attribuzione a Fra Giovanni da Pistoia e l’attri-buzione quale progetto di San Francesco ad Arezzo sono leggibili nel “verso” della pergamena.
3 Nel disegno, nello spessore del muro longitudinale della chiesa, l’unità di misura è deinita per esteso con il termine brachia (braccia in latino). Nelle altre misure invece l’unità di misura è riportata median-te una b. minuscola con una linea perpendicolare alla lettera.
4 Sono stati rilevati speditamente la chiesa di San Domenico e quella di San Francesco in Arezzo entrambe della ine del XIII secolo. La prima, più piccola della seconda, è larga esattamente 14,60 metri (25 braccia iorentine) e lunga 52,21 metri (89,5 braccia). La seconda invece è larga 16,93 metri (29 braccia) e lun-ga 53,4 metri (91,5 braccia).
5 La misura della larghezza della chiesa riportata è di 26,5 braccia al netto dei muri. Mettendo in scala il disegno sulla base di questa misura si è notato come tutte le altre quote coincidono perfettamente con le numerose misure. Inoltre è stato possibile osservare come il progetto della chiesa diferisca dalla chiesa re-alizzata, avvalorando la tesi di un progetto non realizzato, da col-locare, quindi, negli anni antecedenti la costruzione della chiesa: almeno negli ultimi del XIII secolo.
6 La ricchezza del documento risiede nelle fonti, oggi perdu-te, sulla base delle quali l’autore ricostruisce minuziosamente la chiesa pre-vasariana.
7 La facciata della chiesa di Santa Maria Novella, alla quota della pianta del rilievo, risale all’epoca medioevale ed è stata lasciata intat-ta dagli interventi di Leon Battista Alberti (Wittkower 1962).
8 Questo numero è molto simile al rapporto aureo che vale precisamente 1,618.
9 Nel testo l’autore ipotizza che sussistano per Santa Maria Novella due fasi di costruzione, individuabili da scelte progettuali diverse. In particolare, la Bartoli mette in evidenza come la dife-
renza di interasse che sussiste tra le prime due campate, uguali fra di loro, e le ultime quattro verso la facciata, irregolari in maniera non proporzionale, non sia imputabile ad una prematura volontà prospettica, ma piuttosto ad una variante del progetto nella fase di realizzazione. Tuttavia l’autore nota che moltiplicando per sette (numero di campate molto utilizzato nell’architettura gotica ita-liana) l’interasse delle prime due, la posizione della facciata non si modiicherebbe, ipotizzando, così, un primo progetto di chiesa costituita da campate tutte con le stesse dimensioni.
10 Il rilievo della chiesa e del convento di Santa Maria Novella è stato realizzato dal gruppo di ricerca di Maria Teresa Bartoli ed è pubblicato in Bartoli 2009.
11 Lo studio della sezione della chiesa di Santa Maria Novella e del crociisso di Giotto, si è avvalso, come base dati, della nuvola di punti ottenuta durante il rilievo della chiesa. Questa base dati, data la sua accuratezza, ha permesso un’analisi dettagliata dell’ar-chitettura, del dipinto e del supporto ligneo.
12 Le proporzioni così descritte coincidono perfettamente con l’interpretazione operata da Leonardo da Vinci sul testo vitruvia-no. La diferenza sta nell’utilizzo, da parte di Giotto, dei chiodi e dell’ombelico come punti nodali per il proporzionamento della igura. Giotto così, utilizzando gli strumenti della scuola di Giunta Pisano e di Cimabue, che ponevano i chiodi secondo lo schema del triangolo equilatero, innova il metodo, accentuando, in questo modo, la dimensione umana del Cristo su quella divina. In ultimo va notato come Giotto, per far questo, è costretto a porre in asse l’ombelico del Cristo forzando la igura umana nell’innaturale po-sizione già notata nella critica al crociisso.
13 In questo caso, a diferenza di Santa Maria Novella, le mi-sure del dipinto non sono state prese direttamente, ma lo studio si è avvalso della pubblicazione seguita al restauro del crociisso: L’OFFICINA DI GIOTTO 2010.
14 Le proporzioni si discostano solo nella posizione dell’om-belico. Infatti la quota di questo è la stessa di quello di Santa Maria Novella, ma per evitare la posizione innaturale di cui alla nota 12, è possibile che l’artista abbia ritenuto opportuno spostare il cen-tro del corpo fuori dall’asse della croce.
Bartoli 2007M.T. Bartoli «Musso e non quadro». La strana igura di Palazzo Vecchio dal suo rilievo, Firenze, Ediir
Bartoli 2009M.T. Bartoli, Santa Maria Novella a Firenze, Algoritmi della scolastica per l’architettura, Firenze, Ediir
Benvenuti 1992A. Benvenuti, Vangelo e tiratoi, in La ‘Madonna d’Ognissanti’ di Giot-to restaurata, in «Gli Uizi», 8, pp. 75-84
Borghigiani 1757V. Borghigiani, Cronica annalistica di SMN, 1757-61, in «ASMN I.A.30», III, pp. 330-341
GIOTTO 2002Giotto. La croce di Santa Maria Novella, a cura di M. Ciatti- M. Sei-del, Firenze, Ediir
L’OFFICINA DI GIOTTO 2010L’oicina di Giotto, il restauro della Croce di Ognissanti, a cura di M. Ciatti, Firenze, Ediir
NOTE
BIBLIOGRAFIA
— 55 —
La chiesa basso-medioevale: il tramezzo di Ognissanti
De Marchi 2009A. De Marchi, “Cum dictum opus si magnum”. Il documento pistoie-se del 1274 e l’allestimento trionfale dei tramezzi in Umbria e Toscana fra Due e Trecento, in Medioevo: immagine e memoria, a cura di A.C. Quintavalle, Milano, Electa
ARREDI LITURGICI 2007Arredi liturgici e architettura, a cura di A.C. Quintavalle, Milano, Electa
Franchetti Pardo 1986V. Franchetti Pardo, Arezzo, Bari, Laterza
Høyrup 1995J. Høyrup, Linee larghe, un’ambiguità geometrica dimenticata, in «Bol-lettino di Storia delle Scienze Matematiche» 15, pp. 3-14
Hall 1974M.B. Hall, The ponte in S. Maria Novella: the problem of the rood screen in Italy, in «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes» 37
Hueck 1992I. Hueck, Le opere di Giotto per la chiesa di Ognissanti, in La ‘Madon-na d’Ognissanti’ di Giotto restaurata, in «Gli Uizi», 8, pp. 37-49, Firenze, Centro Di
Todarello 2006N.L. Todarello, Le arti della scena: lo spettacolo teatrale in occidente da Eschilo al trionfo dell’opera, Latorre
Vitruvio 1997M.P. Vitruvio (orig. 25 a.C.), De architectura, Einaudi
Wittkower 1994R. Wittkower (orig. 1962), Principii architettonici nell’età dell’Uma-nesimo, Torino, Einaudi
Pergamena del progetto del convento di San Francesco ad Arez-zo, Archivio Capitolare di Arezzo, fondo Ex Archivis Variis, capsa V, n°873
















![Chiesa dell'Annunziatella [Roma]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631ebadf4c5c8fb3a00e5599/chiesa-dellannunziatella-roma.jpg)