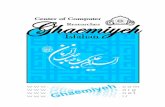Sul Canzoniere di Saba
Transcript of Sul Canzoniere di Saba
1
Il Canzoniere: Storia di un pellegrinaggio irrequieto
“Amai la verità che giace al fondo,
Quasi un sogno obliato, che il dolore
Ricopre amica. Con paura il cuore
Le si accosta, che più non l’abbandona”.
(Umberto Saba, Amai)
«L’artista- Bachtin osserva nel saggio intitolato in italiano
L’autore e l’eroe- che lotta per un’immagine determinata e stabile di un
eroe lotta, in larga misura, con se stesso».1 Una lotta che il Canzoniere,
l’opera che si presenta come la rappresentazione totale dell’esperienza
di un uomo, che sin dall’inizio della sua attività letteraria aveva
teorizzato la necessità di una poesia che fosse scrupolosa e spontanea
ricerca del vero, registra i suoi momenti essenziali. Saba, lacerato tra la
propria realtà e il proprio mito, senza staccarsi mai da se stesso, compie
un pellegrinaggio irrequieto, ora con scontento e amarezza che lo
spingono a desiderare di condurre la vita di tutti gli uomini, una vita
che non è più sua, ora con alto sentimento di pace infinita e fraterna
amicizia affermate in un ambiente plurietnico e pluriculturale.
L’intervento, cercando di afferrare una totalità stabile
dell’anima del poeta, proietta luce sulla tendenza a scoprire il mondo
affermata innanzitutto nei primi poemi, sulla nostalgia trascinante ai
volti e ai luoghi dell’infanzia del secondo volume, e sulla delusa sfiducia
dell’ultimo. Tre momenti che si scambiano il ruolo di protagonista, e
riassumono tutto un percorso di vita e di poesia in cui la liricità
dell’anima tinge la visione del mondo.
Una certa interdipendenza tra le singole parti del Canzoniere si
deve confessare. Un legame si deve cercare nell’identità poesia- vita,
caratteristica dell’ispirazione di Saba, nel continuo trapasso dal
bambino, che rimane, fino alla fine, nell’intimo del poeta, all’uomo
maturo. E Saba lo dichiara in parole ritrovate dalla figlia: «Il poeta è
l’amalgama di un bambino e di un uomo riuniti in una sola persona: è
un bambino che si meraviglia delle cose che accadono a lui stesso
diventato adulto».2
1 MICHEL BACHTIN, L’autore e l’eroe: teoria letteraria e scienza umana, Torino, Einaudi
1988, p. 6. 2 UMBERTO SABA, Prose, a cura di Linuccia Saba, prefazione di G. Piovene, nota critica di
A. Marcovecchio, Milano, 1964, p. 266.
2
1. La scoperta del mondo
Il primo volume del Canzoniere mostra i primi tratti del
rapporto che intercorrerà tra Saba e il mondo circondante; un
mondo che non si limita a presenze umane, ma accoglie pure
elementi di natura, animali e luoghi. Il «piccolo romanzo» è
testimone, sin dalle sue prime pagine, di una presenza intensa
della figura della madre triste, messa in relazione con la
coscienza del figlio di essere diverso dai suoi coetanei;
Mamma, non io così, mai. La mia culla
io la penso tagliata in strano legno.
Tese l’animo mio sempre ad un segno
cui non tesero i miei dolci compagni.
Mamma, è forse di questo che tu piangi
sempre là nella tua casa deserta?
Lacrimi ancora; e dalla non più aperta
finestra, con la sera
entra delle campane, entra il profondo
suono, il preludio della dolce notte,
d’un’insonne per te, gelida notte.3
( A mamma)
Un’angoscia acuta fa sì che Saba «solo e pensoso»,
anziché festeggiare la Pasqua, non vede nel suo spettacolo che
amarezza e morte;
Solo e pensoso dalla spiaggia i lenti
passi rivolgo alla casa lontana.
È la sera di Pasqua. Una campana
piange dal borgo sui passati eventi.
L’aure son miti, son tranquilli i venti
Crepuscolari; una dolcezza arcana
piove dal ciel sulla progenie umana,
le passioni sue fa meno ardenti.
Obliando, io penso alle leggende
di Fausto, che a quest’ora era inseguito
3 IDEM, Tutte le poesie, Il Canzoniere, introduzione di MARIO LAVAGETTO, Milano,
Mondadori, 1999 (5 ed.), p. 33.
3
dall’avversario in forma di barbone.
E mi par di vederlo, sbigottito
fra i campi, dove ombrosa umida scende
la notte, e lungi muore una canzone. 4
(Nella sera della domenica di Pasqua)
I versi, non privi di una forte eco di motivi petrarcheschi e
leopardiani, riflettono dolore e solitudine tanto profondi che non
trovano consolazione né negli affetti sinceri di Glauco, né nel
senso di fratellanza e di tolleranza con cui il giovane abbraccia
tutti gli esseri; «Ecco: qui tutto con i miei pensieri/ È fraterno;
ogni aspetto un nuovo lato/ del mio spirito adombra».
Gli anni di leva a Monte Oliveto ed a Salerno, rievocati nei
Versi militari, paiono riflettere momenti di appartenenza e di
solidarietà; E nessun dio la sua nuvola manda
A liberarci dal sol spaventoso.
Senza canti si va, senza riposo,
come pecore.5
Saba dichiara, in Storia e cronistoria del Canzoniere, di sentire
«con gioia (che pure attraverso i lamenti e le querele d’obblighi
nella vita militare di quelli anni) di non essere più solo, di
“appartenere a qualcosa e a qualcuno”».6 Nonostante tali
affermazioni, Il sogno di un coscritto, raccolto inizialmente nei
Versi militari, poi spostato in chiusura delle poesie
dell’adolescenza, indica un senso di estraneità al gruppo che
dissolve quello di appartenenza avvertito come un superamento
del limite soffocante della vita solitaria;
Ero là con i miei nuovi compagni;
là con essi seduto ad un’ingombra
tavola, quando un’ombra
scese in me, che la mia vita lontana
4 Ivi., p. 26.
5 Ivi., p. 46
6 UMBERTO SABA, Storia e cronistoria del Canzoniere, Milano, Mondatori, 1977, p. 49.
4
tenne, con la sua forza, con le sue
pene, da quel tumulto vespertino.
Centellinavo attonito i miei due
soldi di vino.7
In Casa e campagna La solitudine opprime una visione del
mondo caratterizzata di semplicità e spontaneità, e una profonda
partecipazione all’intimo pulsare della vita. A sua figlia si rivolge
Saba:
La mia vita, mia cara
bambina,
è l’erta solitaria, l’erta chiusa
dal muricciolo,
dove al tramonto solo
siedo, a celati miei pensieri in vista.8
(A mia figlia)
Nella medesima raccolta si introduce il personaggio di
Lina, destinato ad avere un ruolo primario nella vita e nell’opera
di Saba. La giovane moglie si presenta in un certo tipo di
preghiera o di «inno sacro» che accentua la sua funzione
salvatrice, come riferisce il poeta stesso in una delle più acute e
felici osservazioni della Storia e cronistoria; 9 «È come sono
tutte/ Le femmine di tutti/ i sereni animali/ che avvicinano a
Dio». Il ritratto della donna si arricchisce con nuove dimensioni
in Intermezzo a Lina, ove il poeta è preso dalla brama di
conoscere tutti i dettagli della sua vita da fanciulla. Dove andò la tua vita
di fanciulla? Le prime ore pensose?
Quelle baruffe quasi sanguinose
Con l’amata sorella?10
7 IDEM, Tutte le poesie, Il Canzoniere, op.cit., p. 39.
8 Ivi., p. 79.
9 Cfr. UMBERTO SABA, Storia e cronistoria del Canzoniere, op.cit., p. 59.
10 IDEM, Tutte le poesie, Il Canzoniere, op.cit., p. 83.
5
Lina, «la più pia rosa d’ogni bontà», presentata prima in modo
indefinito, si tratteggia ora con interesse e amore. Inizia una
nuova fase della vita del poeta che pare illudersi di aver trovato la
felicità, e di essere liberato dall’angoscia e dalla solitudine.
Una città e una donna si rivelano, con i loro aspetti
inconfondibili, due mondi miti ricchi di varietà, due personaggi
che hanno storie e fisionomie determinate. Trieste pare un ente
vivente che, in fondo del suo cuore molto vivo, dedica al figlio
un «cantuccio» che gli segna tutta la vita, e dove finisce il suo
muro pare finire il mondo. Tra Saba e la sua città intercorre una
relazione intima, basata su comprensione reciproca. Solo Trieste
può comprendere la solitudine, la sostanza immutabile dello
spirito del poeta, e la sollecita con piccole cose, luoghi mitici,
ricordi del passato, piccoli dettagli di vita, personaggi vari
nobilitati da un quieto e partecipe dolore; una prostituta, un
marinaio, «il vecchio che bestemmia, la femmina che bega, il
dragone che siede alla bottega del friggitorie, la tumultuante
giovane impazzita d’amore, tutte creature della vita e del dolore»,
in esse, come in lui, «si agita il Signore». Trieste gli è penetrata
fino in fondo il che non riesce a fare neanche la donna dal «rosso
scialle», che non può tollerare il silenzio orgoglioso del marito
come risposta alle sue domande sul perché del suo dolore
segreto;
«Quanto, quanto m’annoi»,
io le rispondo fra me stesso. E penso:
come farà il mio angelo a capire
che non v’ha cosa al mondo che partire
con essa io non vorrei, tranne quest’una,
questa muta tristezza; e che i miei mali
sono miei, sono all’anima mia sola;
non li cedo per moglie e per figliola,
non ne faccio ai miei cari parti uguali. 11
(La moglie)
11
Ivi., pp. 109- 10.
6
La liricità di Saba colora le stagioni, le ore, le creature.
Sorprendente risulta questa capacità del poeta di vedere in tutti
gli oggetti una parte di sé, di specchiarsi in essi; è la formula di
un suo realismo lirico che trova nelle cose più comuni una
propria presenza. Saba, tratteggiando delicatamente un proprio
ritratto, si riconosce nel fanciullo appassionato;
C’è un fanciullo che incontro nelle mie
passeggiate, un fanciullo un poco strano.
Ha qualcosa di me, di me lontano
nel tempo; un passo strascicato e molle
di bestia troppo in libertà lasciata;
la folle schiva entro le anguste vie,
ama le barche piene di cipolle
e di cappucci; tutto esplora, il nuovo
porto, la diga: ed oggi lo ritrovo,
fermo, la bella testina abbassata,
lo sguardo immobilmente a terra chino.12
I Nuovi versi di Lina sono un lungo monologo di
rimproveri, rimpianti ed accuse di ingratitudine e di tradimento
che il poeta rivolge ora alla moglie, ora a se stesso. Un’ultima
tenerezza vince il poeta solo pensando a Lina bambina. La «ben
piccola cosa» che non la vede, nell’apertura della raccolta, degna
né di amore né di interesse, diviene la buona e «povera Lina» che
gode «un’infinita attonita dolcezza». Saba, non trovando pace
accanto alla sua donna, si lascia commuovere dalla sua figura da
bambina.
Ne La serena disperazione, il poeta pare «soggetto a due
forze, concentrazione in se stesso e apertura verso gli altri e il
mondo».13
La raccolta, che si apre con la figura allegra e
consolatrice del garzone in tuta blu, rivela il timore che tormenta
12
Ivi., p. 115. 13
GNNARO SAVARESE, Umberto Saba. «continuità» della tradizione poetica: la soluzione
prosaico analogica dell’incontro affabile e dolente con l’uomo e con simboli del reale, in
Letteratura italiana. Novecento, Gli scrittori e la cultura letteraria nella società italiana,
introduzione di Gianni Grana, Milano, Marzorati, 1980, p. 3252.
7
l’anima del poeta. Il passar dell’età d’oro fa pensare al nulla e
alla morte. Dall’esperienza amara del vivere, e da «quel fare e
rifare, in un limitato ma consapevole pessimismo in ogni
momento»,14
esce Saba, ancora giovane, con il volto già vecchio
e l’anima ferita;
Io vivo… eppure sono un morto, sono
dentro un abisso; ed odo, ivi sepolto,
la vita che tra voi s’agita, il suono
della vita, ormai vano; ….
Io giaccio; ed ho solo un pensiero, godo
solo un pensiero: sono morto, ucciso
da me in sì strano, in sì felice modo,
che serbo ai cari miei la mia giornata,
anni più mossa, più fattiva ancora,
ad opere di buon fine ordinata;
ed a me la mia notte senz’aurora.15
(De profundis)
Saba, Nino e la loro città sono accomunati nelle sofferenze
e nel dolore, in Poesie scritte durante la guerra che rievocano lo
stato psicologico dei Versi militari. Nino Ribaldi, il giovane
soldato pacifico nonostante la divisa, va in guerra senza volerlo, e
non torna mai da quelli che lo aspettano. Saba, «vestito da
soldato italiano», vive «un sogno sanguinoso e strano», soffrendo
non solo la mancanza del compagno, ma pure della città
dell’amata Lina.
Profonda è la delusione che segue allo spegnere dell’amore
per Paolina, il raggio di sole entrato nella vita del poeta che non
riesce a portare a compimento nulla tranne la poesia ritenuta lo
specchio della sua anima. La malinconia di Saba verso la fine del
primo Canzoniere pare storica; una malinconia che riguarda tutta
un’epoca. Arrivato al «culmine» del dolore umano, il poeta si
14
GIANNI POZZI, La poesia italiana del Novecento, Torino, Einaudi, 1967, p. 53. 15UMBERTO SABA, Tutte le poesie, Il Canzoniere, op.cit., p. 166.
8
vergogna di non desiderare la morte, e di amare cose terrene che
illudono «col soave viso».
2. Nostalgia trascinante
Il secondo volume del Canzoniere (1921- 32) testimonia
una nostalgia trascinante. Ritornano alla vita tutte le figure
dell’infanzia, che prima erano materia di sogni e di adorabile
rimpianto. Saba torna nei momenti decisivi all’età dell’infanzia e
dell’adolescenza «come il salmone che, compiuto l’atto più
vitale, torna lentamente verso il mare dove trova il suo
indispensabile alimento».16
In effetti, il poeta costruisce dei suoi
sentimenti infantili una propria mitologia alla quale rimane fedele
in tutto il corso della sua vita. Il passar degli anni colora i ricordi
più cari con dolce serenità riflettendo la limpida visione che
Saba, avendo scoperto il mondo, ha acquisito di se stesso.
Preludio e canzonette si apre con una malinconia
sconsolata e struggente; passa la giovinezza, e alla vita mancano
l’amore e la presenza della donna adorata. Nei confronti
dell’eterno scorrere del tempo e del variare delle apparenze si
erge l’immortalità della poesia, l’unica cosa che Saba sa fare e
amare. Il Finale è un lungo lamento della provvisorietà dei casi
umani;
L’umana vita è oscura e dolorosa,
e non è ferma in lei nessuna cosa.
Solo il passo del Tempo è sempre uguale.17
L’Autobiografia, è un organizzato “flash-back” in cui il
poeta rivive intensamente gli episodi della sua infanzia, riprende i
momenti dolorosi della sua giovinezza che l’orgoglio dell’ anima
e la giocosità che dovrebbe essere della poesia gli impediscono di
16
GIACOMO DEBENEDETTI, Saggi critici, Milano, Mondatori, 1952, p. 142. 17
UMBERTO SABA, Tutte le poesie, Il Canzoniere, op.cit., p. 251.
9
esprimere. I primi versi rievocano la sofferenza cui si è già
accennato diverse volte;
Passò la giovinezza mia infelice,
che l’arte ad altri ha fatte dilettose,
come una verde tranquilla pendice.18
Dolore e sofferenze trovano giustificazione nelle vicende che si
susseguono. La vita inizia con i singhiozzi della madre;
Quando nacqui mia madre ne piangeva,
sola, la notte, nel deserto letto.19
Il figlio cresce portando sulle spalle il peso dell’immagine
negativa del padre «assassino», che si scopre straordinariamente
simile a lui, non soltanto nei tratti fisici, ma pure nella volubilità
dell’animo, da cui ha ereditato il «dono» della poesia. Senza
rimproveri, Saba ammette che il padre pellegrino è un tipo
totalmente diverso dalla madre; li staccano le differenze radicali
tra «due razze» totalmente diverse. Si accenna pure alla povertà
della famiglia ed ai pochi amici protagonisti di quell’età;
La mia famiglia fu povera e beata
Di pochi amici, di qualche animale;
con una zia benefica ed amata
come la madre, e in cielo Iddio mortale.20
Una nostalgia acuta si riflette ne Il Cuor morituro. Il
quadro della casa della nutrice indica il ritorno al mito infantile di
Saba.
O immaginata a lungo come un mito,
o quasi inesistente,
dove sei tu, ridente
casina, che dal primo verso addito?21
(La casa della mia nutrice)
18
Ivi., p. 255. 19
Ivi., p. 256. 20
Ivi., p. 258. 21
Ivi., p. 313.
10
Il ricordo, invece di provocare gioia ed affetti caldi, spinge al
pianto perché segna la perdita definitiva di tali sentimenti. Si
rivestono di carne le figure protagoniste dell’età d’oro; la balia,
Glauco e la casa della quale il poeta evidenzia una dimensione
tutta umana.
Dimensioni umane caratterizzano la vetrina, gli oggetti
esposti, e il Borgo che era al tempo dell’infanzia «un mucchio di
sparse casette», ed ora brulica di vita. Il poeta, vinto dalla
malattia, si commuove alla vista degli operai che, tornando dal
lavoro, camminano in lunghe file. Nei confronti di questo
spettacolo, Saba, tormentato da bambino dal sentirsi
disperatamente solo e diverso dagli altri, annuncia il suo
desiderio di essere come tutti gli uomini, e di vivere la gioia di
non essere più se stesso. Profondamente pietosa risulta questa
capacità di riconoscersi, in tono di fraterna malinconia,
nell’altrui.
La raccolta, che eleva la casa della balia al rango dei miti,
si conclude con una Preghiera alla madre. Saba ritorna con gioia
da sua madre rivolgendole versi di sinceri affetti. Con la madre
che ha fatto soffrire «come un buon figlio amoroso», solo
«l’anima fanciulla» può riprendere il discorso;
E il tuo soggiorno un verde
Giardino io penso, ove con te riprendere
Può a conversare l’anima fanciulla,
inebriarsi del tuo mesto viso,
sì che l’ali vi perda come al lume
una farfalla.22
Qui più di nostalgia si può parlare di un rivivere dell’età
adolescente.
Nel Piccolo Berto si ritessono perfettamente i ricordi e le
figure di infanzia. La raccolta si apre con una poesia in cui il 22
Ivi., p. 345.
11
recupero dell’età infantile prende avvio dall’immagine della
figlia di Saba, l’amata Linuccia, che facendogli vivere le
consolazioni della paternità condivisa, gli ripropone il rimpianto,
ormai addolcito, del passato con le sue gioie e i suoi dolori;
Mia figlia
mi tiene il braccio intorno al collo, ignudo;
ed io alla sua carezza m’addormento…
Al seno
approdo di colei che Berto ancora
mi chiama, al primo, all’amoroso seno,
ai verdi paradisi dell’infanzia.23
(Tre poesie alla mia balia)
La figlia, in un’immagine rovesciata rispetto alla tradizionale
consuetudine familiare, culla il padre assumendo il ruolo che
doveva essere del vero genitore, e che Saba è stato chiamato a
compiere nei confronti della madre abbandonata.
All’«eterna Peppa» si dedicano tre poesie; la figura rifatta
viva nella sua funzione di nutrice che dona il latte della vita e, più
tardi ancora, un simbolico caffelatte che segna l’approdo all’età
matura, incarna, per Saba, la vera maternità. Il ricordo fa pensare
alla lacerante scissione fra l’amore per la madre biologica, e
quello per la madre effettiva;
Mi accoglie come accoglieva il bambino
quando saliva beato alla povera
casa della sua balia. Paradiso
era al fanciullo, paradiso è ancora
all’uomo in lotta colla vita.
(la madre ormai amorosa)
da una madre amorosa a lei rubato,
dopo tre anni, all’improvviso.24
(Il figlio della Peppa)
23
Ivi., p. 406. 24
Ivi., p. 419.
12
In Berto Saba fugge a se stesso bambino ridando vita ad un
momento vissuto una volta dall’interno e lasciandosi
commuovere dalla timidezza e dall’innocenza del piccolo. I versi,
in cui l’anima di Saba si divide fra l’attuale vissuto e il passato,
rappresentano un discorso poetico straordinario che esce
adeguata allo spirito fanciullesco di Berto il quale chiede sulla
medaglia che doveva avere. Il bambino si rivela, in ultima
analisi, il punto di riferimento del poeta ormai vecchio;
Senza voce; «Berto
- gli dissi al fine- non sai quanto t’amo.
Io che me stesso oggi non amo, privo
Del tuo pensiero vivere non posso».25
Con il piccolo Berto si conclude la stagione della nostalgia
rivelata incapace ad alleviare i dolori e le sofferenze del poeta. La
voce di Berto si liquida, e la sua figura ricomparirà solo a tratti
nel resto del Canzoniere. In una lettera ad Alberto Carocci, Saba
scrive, il 24 ottobre 1930: «ho terminato il ciclo di poesie il
piccolo Berto. Lo so che è finito, perché il piccolo Berto è morto
una seconda volta e, almeno spero, definitivamente»26
.
3. Alienazione
Il terzo libro registra i momenti di crisi nella vita di Saba.
Il poeta, per metà ebreo, dovette subire rischi e difficoltà di ogni
natura fino al divieto di pubblicare scritti sia in giornali e in
riviste sia in volumi. Condizioni che improntano la visione
sabiana del mondo.
Ultime cose rappresenta un momento di rivelazione;
«adesso tu sai che tra i beati non è dimora per noi». La poesia
riflette la perdita della fiducia, la solitudine dei sette anni passati
sotto la minaccia razziale, e il distacco dalla realtà dolorosa;
25
Ivi., p. 409. 26
UMBERTO SABA, Prose, a cura di Linuccia Saba, op.cit., p. 310.
13
Sono solo. Nessuno ascolta dove
agli amici dispersi ogni richiamo
è vano. Brilla come un ghiacciolo l’odio, e penso
che vedrò questa sera te che amo.27
(Solo)
La solitudine fa riaccumulare i ricordi creduti sciolti in Parole, e
li riportano alla vita;
Quando si apriva il velario sul mondo
Della mia fanciullezza, accorsi come
Ad una festa promessa.28
(Quando si apriva il velario)
Il presente ridà vita al passato; il dolore fa pensare alla casa della
nutrice che «fumava per la cena». La bocca ora muta del poeta
richiama quella fanciullesca dolce e cara;
O bocca fanciullesca, bocca cara,
che dicevi parole ardite ed eri
così dolce a baciare.29
(Bocca)
Avevo raccoglie tutta l’esperienza di Saba superando i
limiti individuali ad un orizzonte universale in cui tutti piangono
la perdita di case, parenti e città. La totalità dell’anima del poeta
si esprime in questo lungo lamento poetico insicuro di trovare
conforto neanche nella morte. Saba ha passato anni e anni
raccogliendo e sistemando le singole parti di un quadro completo
di sé, e che gli viene distrutto durante gli anni dell’occupazione
nazista. La realtà dolorosa minacciante manda in frantumi tutta
una vita intensa: con quell’avevo si conclude un lungo e faticoso
viaggio. Le vane domande non trovano risposte in quel mondo
ove non si rispettano i valori umani. Saba che ha sempre espresso
posizioni chiare nei confronti degli ebrei respingendo la
circoncisione che praticano si trova perseguitato e minacciato
27
UMBERTO SABA, Tutte le poesie, Il Canzoniere, op.cit., p. 468. 28
Ivi., p. 469. 29
Ivi., p. 466.
14
dalla violenza del «fascista inetto» e del «tedesco lurco» che
trascina tutta l’Europa senza distinzioni.
La poesia si apre con una malinconia acuta che riflette le
sofferenze sotto la minaccia del razzismo;
Avevo il mondo per me; avevo luoghi
del mondo dove mi salvavo.30
La guerra ha distrutto una vita piena in cui i luoghi, superando il
senso vero e concreto della parola, erano cuori, occhi e bocche in
cui abitava Saba;
Ricordi,
tu dei miei giovani amici il più caro,
tu quasi un figlio per me, che non pure
so dove sei, né se più sei, che a volte
prigioniero ti penso nella terra
squallida, in mano al nemico?31
Aveva una bambina, diventata giovane che non gli rivolge più
sguardi affettuosi. Aveva una città ora rovinata. Pure Lina, la
«meravigliosa» Lina, protagonista del Canzoniere, è triste, esule
e invecchiata. Non si spera più conforto neanche nella morte.
È tornata la libertà di cantare senza divieti, ma non si può
mai cancellare il terrore e le rovine che la guerra ha lasciato
dietro. Fra i gridi di gioia la voce di Saba, esprimendo l’amarezza
e la tristezza che accompagnano il momento della vittoria, stenta
a ritrovare la sua serenità. La lirica riesce a comunicare il senso
umano e storico del momento della liberazione, un clima di
speranze ed entusiasmi, e di amarezza e delusione temuta. I versi
con cui si apre e si chiude il canto non segnano altro che dolore
profondo e pessimismo storico;
Falce martello e la stella d’Italia
30
Ivi., p. 509. 31
Ibidem,
15
ornano nuovi la sala. Ma quanto
dolore per quel segno su quel muro!...
Questo è il teatro degli Artigianelli,
quale lo vide il poeta nel mille
novecentoquarantaquattro, un giorno
di Settembre, che a tratti
rombava, ancora il cannone, e Firenze
taceva, assorta nelle sue rovine.32
(Teatro degli Artigianelli)
L’acutissima malinconia di Avevo, di quel viaggio mai
compiuto di dolori, castighi, e rimorsi porta quasi al delirio in
Mediterranee;
La casa è devastata
la casa è rovinata.
Mille e una notte non l’abita più.33
(Raccontino)
Saba pare ritrovare «una degna conclusione al suo
avventuroso poema»,34
cercando sollievo nelle antiche favole,
nelle vecchie poesie, nella figura di un ragazzo che ascolta il suo
cantare, e di una donna lontana. Quel sogno di felicità che balena
nelle immagini di un’adolescenza ormai lontana è «un prodigio»
che tiene il poeta attaccato alla vita.
Io sono come quella foglia- guarda-
sul nudo ramo, che un prodigio ancora
tiene attaccata.35
(Foglia)
Ormai abbandonato da tutti, non gli rimangono neanche le
immagini della «vita calda», della giovinezza. Questi ingrati e
crudeli, si allontanano dal loro vecchio adoratore; lo lasciano al
32
Ivi., p. 512. 33
Ivi., p. 544. 34
CARLO MUSCETTA, Pace e guerra nella poesia contemporanea, da Alfonso Gatto e
Umberto Saba, Roma, Bonacci, 1984, p. 124. 35
UMBERTO SABA, Tutte le poesie, Il Canzoniere, op.cit., p. 537.
16
«buio» che sta alle porte. Una estrema confessione di un destino
inevitabile rievoca le Parole che hanno aperto il terzo volume;
Antico mare perduto… Pur vuole
La Musa che da te nacque, ch’io dica
di te, col buio alle porte, parole.36
(Ebbri canti)
Uccelli e Quasi un racconto affermano il distacco del
poeta dalla realtà umana, da un mondo sconvolto dalle ambizioni
imperialistiche, e la sua aderenza al mondo delle altre creature di
cui è stato sempre l’interprete e il portavoce;
Da quando la mia bocca è quasi muta
Amo le vite che quasi non parlo.37
(Da quando)
36
Ivi., p. 543. 37
Ivi., p. 481.






























![Note sul territorio di Castiglion Fiorentino [RSA 1994-1]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6318fa62e9c87e0c090fe96c/note-sul-territorio-di-castiglion-fiorentino-rsa-1994-1.jpg)