La Regina di Saba, Salomone e la tradizione figurativa di ambito ebraico. Excursus iconografico in...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of La Regina di Saba, Salomone e la tradizione figurativa di ambito ebraico. Excursus iconografico in...
Le numerose leggende sul regno di Saba, la sua regina e il suc-cessivo suo incontro con Salomone, il loro amore, fiorite e in-trecciatesi l’una all’altra nella letteratura, nel corso dei secoli,trovano solo sporadicamente riscontro nelle rappresentazionifigurative sicuramente ascrivibili a contesti giudaici. È notoche complessi fattori culturali hanno ostacolato lo sviluppo diun’arte figurativa ebraica in maniera continuativa e che questasi sia concentrata solo in determinati ambiti cronologici e ter-ritoriali. Il mondo ebraico, infatti, non ha sempre aderito allostesso modo all’interdizione di rappresentazione secondoquanto prescritto in funzione anti idolatrica in Esodo 20, 4-5e in Deuteronomio 5, 8-9. In particolare, la raffigurazioneumana non è stata ritenuta in contrasto con tale precetto in queicontesti dove gli ebrei si sono sentiti più consapevoli della pro-pria identità e meno permeabili alle influenze esterne ma allostesso tempo capaci di relazionarsi in maniera costruttivaanche con il mondo circostante. La prima rappresentazione figurativa dell’episodio della reginadi Saba davanti al re Salomone sarebbe, in contesto ebraico,quella presente in una scena del registro superiore della pareteoccidentale nella sinagoga di Dura Europos. Il condizionale èd’obbligo in quanto la scena in questione non è interamenteconservata e pertanto gli studiosi non sono unanimemente con-cordi sulla sua interpretazione. Nel lacerto di tale dipinto mu-rario si vedono le parti inferiori di un trono con un re seduto,di due attendenti e, sulla parte anteriore, di due figure femmi-nili che gli si avvicinano. Gli studiosi più accreditati interpre-tano la scena proprio come quella della regina di Saba allapresenza del re Salomone (LEVINE 1981: 174), per altri si trat-terebbe del giudizio di re Salomone con le due prostitute o,altra ipotesi, le vedove davanti al Faraone (sintesi in GUTMANN1984: 1318). Secondo la descrizione biblica - narrata quasi con le stesse pa-role in 1 Re10 e in 2 Cronache 9 - su ognuno dei sei gradiniche portavano al trono del Re riposavano due leoni d’oro af-frontati; il pittore di Dura, però, si rifà ad una diversa fonte inquanto rappresenta la gradinata del podio con una decorazionecaratterizzata dall’alternanza di coppie di leoni e di aquile.
Una simile descrizione è giunta fino a noi in una più tarda tra-duzione aramaica della storia di Ester, il Targum Shenì in cuiviene fornita una narrazione haggadica che, andando ben oltrela semplice traduzione letterale, colora la versione biblica dinuovi particolari narrativi1. Questo testo, per quanto non siastato concordemente datato (dal III-IV al XI secolo), è autore-volmente ritenuto di epoca bizantina (GROSSFELD 1994 e FINE2005: 106), è quindi possibile che nel dipinto di Dura e in que-sto testo si faccia riferimento alla medesima fonte che non ciè stata tramandata.Non vi è dubbio che gli affreschi della sinagoga di Dura sianoispirati da testi postbiblici, mentre non sono certi i criteri allabase delle scelte tematiche e della loro disposizione all’internodell’aula. Se nel registro inferiore è stato possibile mettere inrelazione le scene poste ai due lati della nicchia centrale, menoagevole è trovare un legame fra le scene della parte superioredella composizione della parete: al di là di un’armonia com-positiva (entrambe le raffigurazioni conducono lo sguardoverso il centro della parte) non è rinvenibile una convincenterelazione ideologica (o teologica) tra la scena della Regina diSaba con Salomone e quella di Mosè che conduce gli Ebreifuori dall’Egitto. Risulta più comprensibile, invece, l’abbina-mento con la scena del registro inferiore dello stesso lato, cioècon la narrazione, in due momenti, che vede il trionfo di Mar-docheo e il re Assuero sul trono, con la regina Ester alle suespalle. I due troni su cui siedono Salomone (in alto) e Assuero(in basso) infatti sono rappresentati alla stessa maniera ma ciòin quanto, sempre secondo il Targum, quello di Assuero sa-rebbe lo stesso appartenuto a Salomone: entrambi poggianosu un piedestallo a sei gradini sui quali, come detto, riposanoalternativamente aquile e leoni. Il nesso sarebbe costituito dalla contrapposizione tra la cru-deltà del re straniero (Assuero), che senza l’intervento di Esteravrebbe ingiustamente messo a morte l’intera popolazioneebraica del suo regno, e la grandezza del saggio e sapiente reebreo Salomone, tale da attrarre le straniera regina di Saba. Sinoti che in entrambi i casi, l’abbigliamento degli ebrei è con-forme a quello della cultura greco-romana mentre quello dei
171
La Regina di Saba, Salomone e la tradizione figurativa di ambito ebraico:excursus iconografico in tre tappe
MICAELA VITALE
non ebrei è di tipo orientale. Il complesso decorativo quindicostituirebbe una visione auto celebrativa in cui il popoloebraico, seppure con le dovute differenze, risulta immedesi-mato nel gruppo in quel momento egemone nella città. (STEIN-LAUF 2004: 89)
La storia dell’arte figurativa di contesto ebraico, come detto, ècontraddistinta da notevole discontinuità nel tempo e nello spa-zio: con un grande balzo cronologico dopo gli affreschi di DuraEuropos, un successivo gruppo di rappresentazioni figurate sicolloca nella produzione di manoscritti miniati di epoca me-dievale, realizzata tanto in area sefardita quanto in quella aske-nazita. In particolare, fra quelli conservati fino ai giorni nostri,troviamo una scena tratta dall’epopea salomonica in una mi-niatura illustrata nel primo di tre volumi di un manoscritto rea-lizzato in area renana: il c.d. Mahazor Tripartito2. In esso,intorno alla parola iniziale del testo del Cantico dei Cantici,parte della liturgia della festa di Pesach, sono rappresentate duescene che si svolgono alla presenza di Salomone seduto sultrono. Salomone non rappresenta il tema della narrazione delCantico, ma a lui si attribuisce la scrittura del testo. (Fig. 1)Con una completa adesione ad un’ulteriore parte del citato Tar-gum shenì, le tre scene di questo cartiglio fissano alcuni mo-menti salienti della leggenda, evocandone i personaggiprincipali: i demoni convocati al banchetto che ballano in pre-senza del Re; la Regina che arriva in visita; la sua richiesta aSalomone di risolvere degli indovinelli. Anche la rappresen-tazione del trono è perfettamente aderente al seguito della de-scrizione narrativa del Targum, esso è raffigurato sul podiodecorato da coppie di animali aurei sui gradini: il bue con illeone, l’orso con l’agnello, la pantera con il gufo, l’aquila conil pavone, il gatto con la gallina, il falco con la colomba. È ri-scontrabile una ulteriore puntuale citazione dal testo letterario,un falco sul dorso di una colomba a sua volta sovrastante latesta coronata del re (GINZBERG 1913, 2007: 64-77). La caratteristica saliente delle illustrazioni di questo volume èla rappresentazione di figure femminili con testa di animale:uccelli non meglio identificabili e mammiferi vari (simili aorsi, gatti, asini o cavalli). Tali figure non simboleggiano le ca-ratteristiche peculiari dei corrispondenti personaggi biblici,piuttosto sembrano un espediente per non rappresentare ilvolto di quegli esseri umani. La motivazione è controversa: se-condo alcuni si tratterebbe dell’adesione al prescritto biblicoche vieta il culto idolatrico delle immagini (ma tale interpre-tazione non giustifica la limitazione ai soli volti delle donne);secondo altri gli esseri umani a volto zoomorfico rappresen-terebbe figure rette, celestiali, defunte, moralmente di gradopiù elevato (ma l’esclusione di Salomone contraddice tale ipo-tesi); infine, tali raffigurazioni sarebbero derisorie e di im-pronta antisemita (ma appare inverosimile che tale intento,posta la committenza ebraica, sia stato reiterato in tanti libri).Appare più convincente la spiegazione secondo cui i primi
committenti di tali beni di lusso, riflesso di uno status socioeconomico di rilievo, avrebbero aderito rigorosamente ai pre-scritti anti idolatrici mentre, nel corso del tempo, tali raffigu-razione zoomorfiche sarebbero diventate un modello non piùperfettamente compreso nella sua essenza originaria e dunqueimitato, anche solo parzialmente, spesso senza una reinven-zione semantica del tutto.
Anche questa scena, al pari di quella di Dura, sembra esserefinalizzata ad esaltare non tanto la figura della Regina, quantoad evidenziare la grandezza di Salomone. In epoca medievale,l’idea che un donna, ancorché regina, potesse mettere allaprova un uomo equivaleva ad una sfida all’ordine sociale per-tanto la letteratura coeva tese a snaturalizzare il genere sessualedella Regina per “demonizzarlo” e renderlo contro natura(LASSNER 1993: 1); d’altronde che la Regina di Saba fosse ildemone Lilith, è esplicitamente riportato in un altro Targum,quello riguardante il libro di Giobbe (GINZBERG 1999: 204). Secondo una certa tradizione, Salomone avrebbe appreso l’artedi sottomettere i demoni dal libro originariamente affidato daDio a Noè per istruirlo su come costruire l’arca, libro conte-nente anche i segreti e i misteri per apprendere i precetti disantità, purità modestia e umiltà, e che venne tramandato finoa Salomone (GINZBERG 1995: 151). Da questa stessa tradizionepuò derivare dunque l’episodio del disvelamento dell’ingannodella Regina di Saba: lo stratagemma del pavimento a specchiod’acqua obbliga la Regina a sollevare le vesti e quindi a mo-strare le estremità pelose, rivelatrici della sua natura nonumana.
La terza tappa nel viaggio della Regina di Saba attraversol’iconografia di ambito ebraico è da cercare nell’opera di unmaestro contemporaneo che si è sistematicamente cimentatocon le storie bibliche e la loro ricchezza narrativa: Marc Cha-gall. Chagall attinge al suo mondo ebraico, alla sua esperienzaculturale diretta ma non conosce o tiene conto di questi prece-denti iconografici.Un carnet da lavoro degli anni 1970-75 presenta una decinadi schizzi dedicati a questa Regina3. Due gli elementi caratte-rizzanti: il cammello che la conduce a Gerusalemme e l’in-contro con il Re Salomone. Quest’ultimo tema era già statoaffrontato dall’artista negli anni ’50 con un’incisione che ebbepiuttosto fortuna e larga diffusione (è presente in numerosecollezioni pubbliche) sia nella versione in bianco e nero cheacquerellata (Fig. 2): l’arrivo della Regina sul cammello e Sa-lomone che l’attende alle porte di Gerusalemme si pongonoin una sintesi iconografica illustrata con una serie di topoi lar-gamente condivisi. I leoni del trono salomonico vengono tra-slati a Gerusalemme – sede del palazzo reale - e disposti comequelli del portale della città di Micene e il cammello evocaterre lontane ed esotiche ad indicare la localizzazione di Saba.I leoni rappresentano un simbolo di forza e regalità ma sono
Micaela Vitale174
anche il simbolo della tribù di Giuda dalla quale discende ilpopolo d’Israele mentre tutta la tradizione pittorica occiden-tale indica con il cammello la provenienza orientale di perso-naggi come ad esempio i Re Magi; analogamente,nell’iconografia profana, il cammello costituisce l’attributodell’Asia nella rappresentazione dei quattro continenti. L’ade-sione alla narrazione biblica dell’episodio viene dunque raf-forzata da secoli di sovrapposizioni culturali che l’artistaassimila e reinterpreta. Nella serie degli schizzi, differentemente, l’incontro assume
un significato diverso: non è più un avvicinamento fra regnantiche si vogliono conoscere e stringere relazioni sociali ed eco-nomiche, diventa un’unione amorosa nella quale i due perso-naggi si fondono graficamente, così come la tradizione unificala promessa di Salomone di dare alla Regina tutto quanto ellapotesse desiderare (I Re 10,13) e l’offerta della sposa del Can-tico dei Cantici (1, 5), come detto attribuito a Salomone,quando si dichiara “nera io sono, eppure bella”. Finalmente, i due personaggi fin qui trattati raggiungono unequilibrio di forze su un piano egualitario.
Micaela Vitale176
1 Per un’estesa disamina della letteratura post biblica sulla Regina diSaba si vedano SILBERMAN 1974 e LASSNER 1993
2 Il manoscritto firmato e datato 1320, è conservato a Budapest, Hun-garian Academy of Sciences, Ms. A. 384, gli altri due volumi del trit-tico sono al British Museum, Add. Ms. 22413 e alla Bodleian Library
di Oxford, Ms. Mich. 619). Il Mahazor comprende il ciclo di cantiliturgici per i sabati e le varie festività annuali del calendario ebraico.
3 http://www.christies.com/lotfinder/drawings-watercolors/marc-cha-gall-la-reine-de-saba-a-5174031-details.aspx?pos=2&intObjec-tID=5174031&sid=&page=6








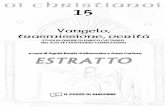















![Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6320d02c00d668140c0d32b3/asculum-cultura-architettonica-e-figurativa-di-eta-romana-in-g-paci-a-cura.jpg)


