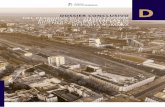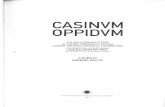Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di...
Transcript of Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di...
ASCULUM: CULTURA
ARCHITETTONICAE FIGURATIVA
DI ETÀ ROMANA
Sandro De MariaEnrico Giorgi
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:48 Pagina 171
Introduzione
Il destino delle città a continuità di vita si rivela spesso avaro neiconfronti degli edifici antichi, perché è frequente che lo sviluppourbano si imposti sulle rovine delle strutture precedenti o addiritturale usi per approvvigionarsi di materiali edilizi da reimpiegare percostruire altri complessi architettonici, più adatti alle rinnovateesigenze della vita cittadina. Un caso tipico del passaggio all’epoca medievale è quello dellafabbrica della Cattedrale, che anche ad Ascoli, come altrove,trasformò parte della città in una ‘cava di prestito’, termine usatoper definire vere e proprie imprese di recupero di materiali per l’edilizia (sottintendendo dunque che quel prestito assumeràcontorni definitivi). Basterà un rapido esame delle mura dellaCattedrale, del Battistero e dell’Episcopio, con lo sguardo rivolto ai muri perimetrali, per rendersi ben conto di quanto questa prassifosse consolidata, non solo nel Medioevo ma anche nelle epochesuccessive. Si consideri anche che quelli che riconosceremo sarannosoli i blocchi decorati, mentre ci sfuggiranno probabilmente gli altri,quelli scalpellati o messi in opera occultando le facce lavorate.Tuttavia questo esercizio può essere comunque utile per suggerire la ricchezza decorativa dell’abitato antico. Ovviamente il complessodella Cattedrale sarà solo l’inizio, perché da questo punto di vistaAscoli è una città particolarmente prodiga. Accade, infatti, chevestigia di antichi edifici siano ancora ben visibili e conservino inparte anche la loro originaria decorazione architettonica, inglobatanelle mura delle chiese medievali, come nel caso del tempio ioniconella chiesa di San Venanzo e di quello corinzio in quella di SanGregorio Magno.Vale la pena di riflettere su questi aspetti se vogliamo farci un’ideacompiuta della città antica, del suo aspetto, del gusto dei suoi abitantie dunque più in generale della cultura urbana in senso profondo.Un’esposizione intitolata I colori del bianco: mille anni di colori nellascultura antica, tenutasi nel 2004 presso i Musei Vaticani a Roma, fece
173
ASCULUM: CULTURA ARCHITETTONICAE FIGURATIVA DI ETÀ ROMANASandro De Maria - Enrico Giorgi
A SINISTRA
Ricostruzione della colonna ionicadel tempio romanooggi incorporatonella chiesa di San Venanzo.Ascoli Piceno,Museo ArcheologicoStatale (inv. K 4822,K 4823 e 64671)
PAGINA PRECEDENTE
Emblema centrale,con doppio volto,del mosaicopavimentale delladomus rinvenuta in occasione della costruzionedell’attuale Palazzodi Giustizia.Ascoli Piceno,Museo ArcheologicoStatale (inv. 64672)
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:48 Pagina 173
scoprire anche ai non addetti ai lavorila policromia delle statue dei Greci e dei Romani. Occorrerebbe qualcosadi simile per ricordare che una cittàromana non era una spogliasequenza di muri, strade e piazze, ma era spesso rivestita di apparatiarchitettonici e pareti dipinte cheoggi non possiamo più apprezzare.Un’idea parziale dell’aspettooriginario di questi elementiarchitettonici può trasparire anche
ad Ascoli se si pensa al noto “Rilievo dei frombolieri”, che conservatracce del fondo evanido ma che originariamente doveva essere di colore rosso acceso 1. In molti casi, specie negli edifici pubblici,questi elementi non erano affatto accessori, ma facevano parte di un programma decorativo preciso che poteva anche servire a veicolaresignificati importanti o a propagandare ideali e visioni politiche.L’architettura antica, a differenza di certi edifici razionalisti moderni,non era dunque spoglia ma parlava attraverso i suoi complessiapparati e le sue iscrizioni, come è ancora visibile in alcuni esempieccezionali di ambito romano e non solo. Casi emblematici in tal sensopossono essere, a titolo puramente esemplificativo, l’Ara Pacis o laColonna Traiana a Roma, oppure i fregi del tempio di Civitalba pressoSassoferrato, la porta di Augusto a Fano o l’arco di Traiano ad Ancona,per aggiungere anche qualche esempio di ambito marchigiano 2.Ad Ascoli, che pure abbiamo detto fortunata in terminiarcheologici, i resti della cultura architettonica e figurativa anticasono comunque abbastanza scarsi e poco rappresentatividell’originaria ricchezza monumentale della città romana.Ciononostante è possibile abbozzare una sintesi generale, se nonaltro per evitare che ciò che è giunto sino a noi venga dimenticato.Per raggiungere questo scopo faremo riferimento ai documenti che ci paiono più significativi, senza considerare quelli di ambitofunerario che sono trattati in un capitolo specifico.Il discorso si svilupperà soprattutto in riferimento alla decorazionearchitettonica e ai pochi resti di sculture, dato che una parte di questovolume è già dedicata all’urbanistica in senso stretto, e dunque a quelcapitolo viene riservata la trattazione dei singoli edifici inseriti nel lorocontesto urbano. Per completezza di trattazione non ci sottrarremocomunque al compito di tracciare, seppure brevemente, un quadro di sintesi dei principali complessi architettonici della città romana,limitandoci a quelli ancora ben visibili nel tessuto dell’abitato moderno.
174
Sandro DE MARIA - Enrico GIORGI
Fregi dorici reimpiegati nel Battistero di Ascoli Piceno
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:48 Pagina 174
1. Edilizia e architettura pubblica: la città romana e quella moderna
Il ponte di Borgo Solestà
Abbiamo già detto che, per quantoriguarda la conservazione dellearchitetture romane, Ascoli può essereconsiderato un caso abbastanzafortunato. Non è infatti usuale chel’accesso a una città moderna avvengaattraverso un ponte romano, comeaccade a chi si rechi verso il centrostorico scavalcando il fiume Tronto sulPonte di Borgo Solestà, detto anche di Porta Cappuccina 3. Questo percorsoaltro non è che una diramazionesettentrionale del tracciato urbanodella via Salaria, uno dei principali assistradali dell’antica colonia romana 4.Tutto il sistema itinerario collegato a quest’antica via consolare furistrutturato in età augustea e in quelmedesimo lasso di tempo si ritieneche sia stato costruito anche il grandeponte in opera quadrata di travertino,lungo sessantadue metri e largo seimetri e mezzo, che scavalca il corsod’acqua con un’unica arcata di oltre
ventidue metri 5. L’antico basolato stradale romano, ampio cinquemetri e mezzo e ancora parzialmente visibile sotto quello attuale,correva a venticinque metri di altezza ed è sottolineato all’esterno da una cornice marcapiano 6. L’estradosso si imposta su una cornicemodanata, sorretta da quattro lesene angolari di ordine dorico, che insistono su uno zoccolo inferiore, in blocchi rozzamente
sbozzati, coronato da un filare di conci in aggetto 7. L’arco è decorato lungo la fascia esterna(armilla) da un’alternanza di concimonolitici e di blocchi abbinati,sormontati da una cornice aggettante 8.L’osservazione dell’intradosso, sotto la
175
Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana
Prospetto del Pontedi Solestà, da B. Orsini, Descrizione della città di Ascoli,Perugia, 1790
Fregio doricoreimpiegato nel ponte romano
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:48 Pagina 175
cornice di imposta, permettedi ravvisare anche sette“buche pontaie”, che si reseronecessarie per l’alloggio dellacentina lignea approntata al momento della costruzione,per sorreggere i conci del grande fornice.Negli anni Trenta si resenecessario un restauro per quanto riguarda ilconsolidamento dei piloni,1929-30, e successivamentenel 1937-39 per l’interastruttura, ad operadell’impresa degli ing.
Cruciani e Catalini, che permise non solo il necessario consolidamento,ma diede anche la possibilità di operare un accurato studio scientificodel monumento. Il ponte in tale occasione fu svuotato del suoriempimento di malta e rinforzato con una costruzione armata sopral’intradosso, ma il vuoto delle parti laterali invece di essere sommersoda una colata di calcestruzzo fu sostituito da due archi di scarico che
176
Sandro DE MARIA - Enrico GIORGI
Giuseppe Vaccaj,Ponte di PortaCappuccina, Ascoli,giugno 1870. Pesaro, collezione privata
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:48 Pagina 176
formarono duestanze, ancora oggivisitabili, con lapossibilità di vederela struttura internadel ponte. Questa singolareprospettiva sarebbestata impossibileper gli antichiromani, corrispondea quella di vedereuna casa modernaall’interno dei piloni di cemento armato. Nel corso del restauro fu ritrovato il basolato della pavimentazioneromana, rimessa al suo posto dopo gli interventi di consolidamento, e di una successiva in opus spicatum posta ad un livello superiore, che è stata distaccata. I lavori sono documentati da numerose fotografie ma anche da unabella xilografia dell’artista Bruno da Osimo che esalta la complessaarmatura in legno posta a sostegno del ponte durante i lavori. 9
177
Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana
Bruno Marsili dettoBruno da Osimo,(Osimo 1888Ancona 1962) Ponte di BorgoSolestà in restauro,xilografia
Restauro del Pontedi Borgo Solestà nel 1937-39, foto di Bito Coppola,Archivio ASICAP
PAGINA PRECEDENTE
Giuseppe Viccei,ing. capo delComune.Progetto di operedi consolidamentodel Ponte di PortaCappuccina,26 Nov. 1938 - XVII.Archivio ASICAP
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:48 Pagina 177
Il ponte di Cecco
Anche l’uscita dalla città, per chi doveva discendere la valle,avveniva per mezzo di un ponte, ancora utilizzabile, costruito sul torrente Castellano al tempo dell’imperatore Augusto, forse reimpiegando anche i materiali di una struttura precedente. Si tratta del cosiddetto Ponte di Cecco, che oggi collega il ForteMalatesta a Campo Parignano con un percorso pedonale a schienad’asino, frazionato a metà dalla guardiola medievale 10. Nella tradizione locale il nome si collegherebbe alla diabolicaimpresa notturna del suo costruttore, l’erudito Francesco Stabili(noto come Cecco d’Ascoli) 11, mentre il suo aspetto attuale è ingran parte frutto della ‘ricostruzione filologica’ del 1960 curatadall’architetto Giuseppe Zander e promossa dalla Brigata Amicidell’Arte, dopo la distruzione nel 1944 ad opera delle truppetedesche in ritirata.Il ponte lungo oltre quarantatré metri, in opera quadrata ditravertino con assise alte due piedi e conci alterni per testa e pertaglio, presenta un’arcata maggiore di quattordici metri e mezzo e l’altra minore di metà grandezza. Le due arcate sono divise da una grossa pila centrale, di sette per cinque metri, protetta a monte da un rostro a profilo acuto, profondo cinque metri,
178
Sandro DE MARIA - Enrico GIORGI
Prospetto del Ponte di Cecco edel Ponte Maggiore,da B. Orsini,Descrizione della città di Ascoli,Perugia, 1790
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:48 Pagina 178
che frange la corrente alla base. Proprio sotto la fortezza lungo la riva sinistra, l’arcata maggioresi imposta su una robusta spalla,mentre quella minore, con unopportuno artificio costruttivo,sfrutta quasi per metà ampiezzauna sporgenza rocciosa sulla rivaopposta. La scelta di attraversareil torrente Castellano, menoimpegnativo del fiume Tronto,unita alla presenza di tale“imposta rocciosa”, favorì la
costruzione di questa notevole infrastruttura antica. L’arco è formato da conci monolitici bugnati alternati a conci condue blocchi abbinati. I due fornici si impostano, senza modanature,ad altezza differente, direttamente sulle pile sporgenti. Queste riseghe dovettero sostenere anche la centina lignea almomento della costruzione e verosimilmente anche quella successivadurante la ricostruzione 12.
179
Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana
Ponte di Cecco,foto di fineOttocento,Archivio ASICAP
Ponte di Ceccodopo ilbombardamentotedesco del 1944
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:48 Pagina 179
La Porta Romana
Com’è ben noto, la geografia del pianoro ascolano, naturalmentedifeso da due corsi d’acqua profondamente incisi e dall’altura del colledell’Annunziata, non rese necessarie altre protezioni se non appuntonello stretto corridoio occidentale, tra le pendici del colle e la riva delfiume Tronto. Per chi proveniva da Roma lungo la via Salaria, infatti,l’accesso privilegiato alla città avveniva proprio da questo lato,fiancheggiando i monumenti funerari della necropoli occidentale, checelebravano le glorie passate delle principali famiglie ascolane secondouna consuetudine tipica della romanità 13. In questo punto le mura, di cui restano ancora alcuni tratti, si interrompevano per inquadrarel’architettura monumentale a due fornici della Porta Gemina, meglionota anche semplicemente come Porta Romana 14. Anche questocomplesso architettonico fu costruito tra la tarda età repubblicana e l’inizio dell’epoca augustea, come sembra potersi evincere dal confronto con altre strutture analoghe 15.Nonostante varie vicissitudini intercorse nel tempo, la struttura èancora oggi ben visibile, anche se in forme che hanno reso necessarialcuni restauri, soprattutto nella parte superiore del fornicesettentrionale. Le mura medievali e il complesso della chiesa di San
182
Sandro DE MARIA - Enrico GIORGI
PAGINE PRECEDENTI
Il Forte Malatestae il Ponte di Cecco
Porta Romanain una foto d’inizioNovecento,Archivio ASICAP
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:48 Pagina 182
Leonardo, infatti, la incorporarono riducendolaa un unico fornice, fino a tempi recenti,quando furono demolite per consentire un accesso più agevole all’attuale via carraia 16. I due fornici, in bella opera quadrata di travertino, sono ampi quasi tre metri, altipoco meno di sei e sono divisi da un pilastroquadrato di un metro e ottanta centimetri 17. L’imposta degli archi è decorata con unamodanatura, mentre verso l’esterno i conciradiali sono stati scolpiti lungo l’estradossoper ricavarne una cornice modanata 18. I fornici in origine erano inquadrati da duetorrioni quadrati aggettanti, di cui resta in elevato solo quello meridionale, ancoraoggi inglobato in un caseggiato.
Non si conserva neppure il loggiato superiore, forse simile a quellodel cosiddetto Arco di Augusto a Fano, che potrebbe aver ispirato i primi stemmi comunali, dove il monumento era stato scelto comesimbolo della città. Nello spessore interno delle porte si conservano le scanalature per lo scorrimento delle cataractae che ne permettevano la chiusura.
183
Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana
Ricostruzione di Porta Romana,disegno di Giorgio Giorgi
Porta Romana
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:48 Pagina 183
Le sostruzioni dell’Annunziata
L’acropoli della città, oggi occupata dall’ex Convento rinascimentaledell’Annunziata, insiste su un pianoro soprelevato che probabilmenteospitava il maggiore tempio cittadino e che ancora oggi si affacciasulla città grazie a imponenti sostruzioni concamerate, ancoravisibili lungo i sentieri del Parco della Rimembranza. Si tratta di grandi camere, ampie oltre quattro metri e di diversaprofondità, che delimitano la terrazza per tutto il lato occidentale,proseguendo in parte anche verso nord e verso sud. Proprio lungoquesti due fianchi è probabile che corressero le rampe chepermettevano di accedere al livello superiore. Le strutture sono realizzate in opera cementizia con paramenti in vittatum di travertino e con le testate in opera quadrata. Dal punto di vista architettonico queste sostruzioni erano funzionalial contenimento di un complesso di notevole impattomonumentale, simile a certi esempi che in area laziale trovanocompimento già fra la fine del II e l’inizio del I secolo a.C., ad esempio nei santuari di Palestrina o di Tivoli. Il caso ascolano, con ampio uso dell’opera vittata, potrebbe esserepiù tardo di qualche decennio, forse di età triumvirale 19.
184
Sandro DE MARIA - Enrico GIORGI
Il complessodell’Annunziata da B. Orsini,Descrizione della città di Ascoli,Perugia, 1790
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:48 Pagina 184
Un recente scavo, condotto appenasotto le sostruzioni nell’area dell’ex-ospedale Mazzoni tra il 2009e il 2012, ha portato al rinvenimentodi contesti molto significativi, da uno dei quali provieneun’antefissa fittile frammentaria,che tuttavia permette di riconoscerela raffigurazione di una divinitàfemminile vista come signora deglianimali selvatici (Potnia theron),con un’iconografia che è comune
anche al culto di Artemide. Il frammento, di tradizione ellenistica (III-II sec. a.C.), dovrebbeappartenere alla decorazione architettonica del tetto di un edificiodi culto e non sembra fuori luogo pensare che esso fosse collocatopiù in alto rispetto al luogo di rinvenimento, verosimilmenteproprio nell’area dell’acropoli 20.
E.G.
185
Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana
Giulio Gabrielli, Grottedell’AnnunziataAscoli Piceno.Pinacoteca Civica
Sostruzionidell’Annunziata,foto di fine OttocentoArchivio ASICAP
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:48 Pagina 185
2. L’architettura sacra
Altri complessi edilizi di non trascurabile rilievo, come l’acquedottoe gli edifici per spettacolo, contribuivano a conferire pregioarchitettonico alla città romana. Tra questi però, limitandoci a quelli ancora sostanzialmenteapprezzabili in elevato, dobbiamo ricordare innanzi tutto il tempioionico inglobato dalla chiesa di San Venanzo e quello corinzioutilizzato per edificare la chiesa di San Gregorio Magno. Anche in questo caso lo stato di conservazione può essereconsiderato eccezionale e non sono molte le città che possonovantare tali vestigia di templi romani. È importante ricordare che questi edifici non erano isolati, madovevano essere inseriti nel contesto di una più ampia corniceurbanistica, e prospettare su piazze porticate, com’è stato appuratonel caso del tempio ionico, oppure nell’ambito di un sistema diterrazzamenti, come nel caso del tempio corinzio. Un’ipotesi recentepropone di ricostruire a piazza Bonfine, dove sorge il tempio ionico,un porticato che accoglieva due templi gemelli, di cui quelloconservato sarebbe il più meridionale 21.Gli edifici or ora menzionati sono importanti non solo per la loroarchitettura, peraltro non sempre di facile ricostruzione, ma ancheper gli elementi degli ordini classici di cui sono dotati, sullecaratteristiche dei quali ci soffermeremo in modo particolare. Basi modanate e parti del fusto di colonne lapidee, lisce e scanalate,sono state rinvenute anche in scavi recenti, ad esempio nell’area di piazza Arringo, ma erano deposti fuori dalla loro collocazioneoriginaria e comunque non offrono molti spunti per quantoriguarda la cultura architettonica della città romana, a parte l’ovvia
considerazione dell’esistenza di un colonnato nelle vicinanze. Di particolare importanza,invece, paiono i due templiionico e corinzio ai quali si è fatto cenno, proprio perchégli elementi degli ordinisuperstiti sono notevoli e laloro collocazione originaria è chiaramente identificabile.
186
Sandro DE MARIA - Enrico GIORGI
Capitello corinzio di epoca romanariutilizzato comeacquasantiera nella chiesa di San Tommaso
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:49 Pagina 186
Il tempio ionico di San Venanzo
Sorge nel cuore del centro storico a piazza Bonfine. Il tempio è unprostilo tetrastilo di oltre quattordici per sei metri, di ordine ionico,su podio alto circa un metro e mezzo 22. Si conserva quest’ultimo,rivestito di stucco, e la parete sud della cella, lunga quasi otto metrie mezzo. Il culto non è noto con certezza, anche se esiste unatradizione, basata sull’iscrizione reimpiegata nella fabbricaseicentesca proprio davanti al podio (CIL IX, 5178), che lo collega alladea Salus 23. L’edificio pagano fu inglobato, nella maniera ancoraoggi visibile, nella chiesa di San Venanzo, edificata nel XII secolo e ricostruita nel XVII ad opera dei Gesuiti. Nel 1790 Baldassarre Orsinidescrisse la parete meridionale della cella, le paraste, l’architrave, il fregio e un capitello angolare del pronao, oggi perduto 24. Dal 1954 ebbe inizio lo scavo archeologico di Luigi Leporini, chepermise di recuperare due rocchi di colonna, un capitello e una baseattica, tuttora visibili nell’atrio del Museo Archeologico, dove sonostati ricollocati per mezzo di una struttura metallica che permette di apprezzare il profilo della colonna nella sua interezza. La recente ripresa dei lavori, nel 1995, ha permesso di chiarire megliole caratteristiche dell’edificio e ha riportato in luce un tasselloimportante del tessuto urbano, ma non ha condotto al recupero di altri elementi architettonici di importanza rilevante 25.Il podio presenta una cornice inferiore piuttosto arretrata rispettoalla crepidine sottostante, scolpita in blocchetti di travertino di lunghezza variabile ma dello stesso spessore. La cornice inferioreè composta da un listello dritto, una gola dritta sormontata da unaltro listello dritto e da un cavetto a quarto di cerchio. La cornice superiore è analoga ma con la sequenza delle modanature
187
Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana
Ricostruzione del tempio ionico di San Venanzo,disegnodi Giorgio Giorgi
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:49 Pagina 187
invertita. La base attica, in travertino, è priva di plinto e si impostavadirettamente sul podio. Presenta un diametro inferiore di circasettantasette centimetri, è alta venti ed è scolpita in un blocco unicocon l’imoscapo della colonna, alto complessivamente trentatrécentimetri. Presenta un toro inferiore separato da quello superioreda un listello ortogonale e da una scozia a profilo diritto. Il torosuperiore, del diametro di settanta centimetri, è a filo con il primolistello ed è sormontato da un altro listello ortogonale rientrante e afilo con la scozia (sessantacinque centimetri di diametro) 26. Il fustodella colonna si imposta su un cavetto, sagomato a quarto di cerchio.Il capitello ionico del pronao è scolpito in un blocco unico ditravertino, che comprende anche il sommoscapo della colonna, ed era rivestito di stucco. La colonna ha un diametro di poco più di mezzo metro e venti scanalature semicircolari, che terminano con un bordo superiore orizzontale, separate dal collarino da una
fascia piatta. Il capitello esibisce duevolute a sezione leggermente concava,con margini sporgenti percorsi da duesolchi generati dai bottoni circolari posti al centro delle volute stesse. Nella parte superiore di ciascuna voluta si trova un calice con margini frastagliatidal quale nascono le semipalmette a trefoglie e a sezione concava. Le estremitàsuperiori sono rivolte verso l’alto mentre il corpo si sviluppa in basso, lungo il bordo delle volute, sino a coprire le lancette esterne del kyma ionico e inparte gli ovuli laterali. Il kyma è compostoda quattro lancette alternate a tre ovuliprofondamente incisi in gusci dai bordiingrossati. Una foglia d’acanto, analoga a quelle che decorano i pulvini laterali, si diparte dall’ovulo centrale e si sviluppain verticale per tutta l’altezza del canaledritto. Ai suoi lati si trovano due steli conun fiore a tre petali e due foglie. L’echino,infine, è sormontato dall’abaco quadrato,privo di decorazioni 27. Sui lati si osservauno stretto pulvino a profilo concavodecorato con due foglie d’acqua disposteorizzontalmente, lanceolate e alternate a tre foglie di acanto, che si staccano e si
188
Sandro DE MARIA - Enrico GIORGI
Il podio del tempioromano di ordineionico inglobatonella chiesa di SanVenanzo, rimesso in luce nel 1953,foto Perini, Archivio ASICAP
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:49 Pagina 188
sviluppano oltre i bordi del rocchetto stesso 28. Il rocchetto presenta una fascia larga ed è decoratocon fogliette alternate a file di due e di tre allavolta tra i margini convessi del balteo, decorato da astragali.Si tratta, dunque, di un capitello che, pur rientrandonel canone di derivazione ermogeniana, presentaalcune particolarità, come l’essere scolpito assiemeal sommoscapo della colonna e la presenza dellafoglia d’acanto verticale posta al centro della partefrontale, caratteri che rimandano ai tipi cosiddetti“ionico-italici”, ben documentati nel vicino santuariodi Monterinaldo 29. Dal punto di vista della ricchezzadecorativa, invece, i confronti più direttiprovengono dall’ambito ellenistico microasiatico 30.Questo lascia pensare che alcuni modelli ellenistici
siano stati rielaborati dalla bottega di scalpellini che lavorò ad Ascolinel cantiere di questo tempio, forse trasmessi su supporti deperibili in forma di disegni o di schizzi, e fusi con una più antica tradizionelegata alle soluzioni decorative di tipo “ionico-italico”.Nel complesso queste considerazioni permettono anche qualchepuntualizzazione di tipo cronologico, almeno in relazione alladecorazione architettonica, che rimanda a un periodo compreso tra la metà del I secolo a. C. e i primi anni dell’età augustea (50-30 circaa. C.). L’edifico rientrerebbe dunque nello sviluppo monumentaledella colonia dedotta ad Ascoli in età triumvirale-augustea epotrebbe anche essere legato, in maniera più o meno diretta, a unprogramma edilizio e decorativo promosso da Roma, con una chiaravalenza di armonizzazione culturale nell’ambito peninsulare.
189
Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana
Iscrizione con dedica alla dea Salus,reimpiegata nella chiesa di San Venanzo(CIL IX 5178)
Capitello ionicodalla chiesa di sanVenanzo 1950-1951.Fondo Leporini,Archivio ASICAP
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:49 Pagina 189
Il tempio corinzio di San Gregorio Magno
Un secondo tempio in travertino si trova inglobato nella chiesamedievale di S. Gregorio Magno, nella piazza omonima. Sulla base di quanto ne resta, si può ricostruire una forma prostilaprobabilmente tetrastila, di ordine corinzio, su podio. Il tempiomisura oltre ventidue per undici metri, con pronao profondo settemetri e mezzo e podio alto circa un metro e mezzo 31. Nonostantela tradizione erudita locale lo attribuisca al culto di Vesta, per via di un’iscrizione erratica trovata in una casa vicina (purtroppoperduta), la destinazione cultuale non è precisabile. L’ipotesi diattribuzione, avanzata nel Seicento dallo storico locale SebastianoAndreantonelli, infatti, non è sostenibile, poiché si basa suun’iscrizione mutila (CIL IX, 5197), che riportava il nome di Vesta,che probabilmente non va identificato con la divinità, tanto che lo stesso Mommsen nel CIL non la colloca tra le epigrafi a caratterereligioso. Un’altra ipotesi suggestiva, ma non accettabile concertezza, assegna il tempio a Iside, il cui culto è in effetti attestatoin città (CIL IX, 5179) 32.L’edificio sacro sorge sotto le sostruzioni romane, che ancora oggisorreggono il pianoro che ospitò il tempio capitolino ascolano, non lontano da piazza Arringo, ovvero dall’area del complessoepiscopale ma prima ancora di un porticato romano 33. La prima accurata descrizione si deve a Baldassarre Orsini e, oltrealle numerose pagine dedicate nel tempo dai principali storicidell’arte ascolani, si ebbero varie campagne di scavo che, a piùriprese nella prima metà del secolo scorso, interessarono l’areacircostante il podio 34. In queste occasioni furono riportati in lucesvariati resti di crustae marmoree: marmo bianco, fior di pesco egiallo antico, provenienti probabilmente dal rivestimento internodella cella, oltre a frammenti di sculture e altri resti architettonicilapidei e fittili 35.Il podio è oggi completamente interrato, ma ben visibile sul fiancosinistro e prosegue anche sul fondo della chiesa e sul lato destro. Gli elevati, pur con ovvi rimaneggiamenti messi in opera nel corsodei secoli, mostrano comunque un ottimo stato di conservazione. Si riesce facilmente a riconoscere la cella, alta quasi nove metri con i muri in opera reticolata visibili fino all’altezza della trabeazione.Alle estremità della cella si riconoscono i quattro pilastri angolari,con paraste e relativi capitelli. Sulla fronte svettano ancora,inglobate nell’apparato medievale, le due colonne di destra delpronao, con i relativi capitelli che sorreggono ancora un bloccodell’architrave. Esse sono alte m. 8,82, con un diametro variabile
191
Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana
Il tempio corinzioinglobato nellachiesa medievale di S. Gregorio Magno
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:49 Pagina 191
da m. 0,735 a 0,85, solcate da venti scanalature. La colonna di destraconserva ancora in buono stato la sua base attica, ricavata nelmedesimo blocco del rocchio inferiore. È alta circa un piede romano(cm. 33) e il suo diametro è di m. 1,10; mostra una decorazione ad astragali separati da due anelli a sezione angolare. Come le basiattiche dei pilastri angolari, anche queste insistevano direttamentesul podio senza alcun plinto. I pilastri angolari, larghi m. 0,87 e alticome le colonne, presentano ancora in vista il prospetto lateraleesterno, solcato da sei scanalature, e risultano anch’essi coronati da capitelli corinzi 36.I capitelli corinzi, anch’essi di travertino, sono lavorati in due blocchisovrapposti e misurano m. 1,02 di alt. e 0,79 di diametro inferiore. Il capitello di destra risulta in migliore stato di conservazione, anche se le foglie d’acanto sono comunque frammentarie allasommità e anche l’abaco è danneggiato. Il blocco inferiore presentale consuete due corone di otto foglie d’acanto ciascuna e caulicoliverticali costolati. Ogni foglia presenta cinque lobi, formati dafogliette ogivali, con una larga costola centrale. Tra le foglie dellaseconda corona si sviluppano i caulicoli da cui nascono le volute e
le helices spiraliformi, cheraggiungevano il margine superioredell’abaco. Tra le helices, sopra la foglia centrale, si alza lo stelo chedoveva sostenere il fiore dell’abaco.Quest’ultimo presenta modanatureconcave e convesse prive di decorazione.Per cercare di completare la fisionomia generale dei caratteriarchitettonici dell’edificio, restanopochissimi elementi della trabeazione.Si conserva, però, un grosso bloccomodanato della cornice orizzontalecon la sima a kyma rectum e protomia fauci di leone. Questi elementi zoomorfi lasciavanodefluire l’acqua raccolta dal canalesuperiore. L’architrave e la cornicesono lisci, non decorati.Dall’esame formale dei resti dellemembrature architettoniche deltempio e da alcune procedure dilavorazione possiamo trarre qualcheconsiderazione di ordine cronologico,
192
Sandro DE MARIA - Enrico GIORGI
Prospetto dell’antico tempio a S. Gregorio Magno,da B. Orsini,Descrizione della città di Ascoli,Perugia, 1790
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:49 Pagina 192
perfettamente coerenti con la tecnica costruttivaimpiegata nella cella, ovvero l’opera reticolata. La lavorazione in due parti separate dei capitelli 37
e quella della base unitamente, invece,all’imoscapo della colonna, sono ancora ditradizione tardorepubblicana. Gli elementiarchitettonici orizzontali dell’ordine corinzio, consobria decorazione o più spesso perfettamentelisci, sono un orientamento caratteristico dell’età di Augusto, particolarmente della fase iniziale. La resa delle foglie e le proporzioni generali deicapitelli, con le due corone che occupano metàdell’altezza complessiva, sono tipiche del periodocompreso tra l’età triumvirale e la prima etàaugustea. I caulicoli, con scanalature basse e largolabbro convesso, paiono anch’essi perfettamente
coerenti con la prima età augustea. Da questi dati emerge un quadro cronologico che con buonaprobabilità riporta agli anni 30-20 a.C., dunque al periodo nel corso del quale la città è soggetta a una profonda ristrutturazioneurbanistica e a un decollo monumentale particolarmentesignificativo.
193
Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana
Ricostruzione del tempio corinziodi San Gregorio,disegnodi Giorgio Giorgi
Chiesa di S. Gregorio, il fianco della celladel tempio romanoin opera reticolata
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:49 Pagina 193
I capitelli corinzi di Sant’Angelo Magno
I due templi appena descritti rappresentano i contesti architettonicidi ambito pubblico meglio noti ad Ascoli; essi svolgevano un ruoloimportante nella fisionomia urbana dell’abitato a partire dallaprimissima età imperiale. Abbiamo già fatto cenno alla presenza di altri documenti, spesso frammentari e mutili, rinvenuti fuori dal loro contesto originario, oppure reimpiegati per costruire edificisuccessivi, come nel caso della Cattedrale. A questo riguardo si devesegnalare almeno un’altra situazione degna di nota, che presenta
194
Sandro DE MARIA - Enrico GIORGI
Capitello Corintio a S. Angelo Magno,da B. Orsini,Descrizione della città di Ascoli,Perugia, 1790
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:49 Pagina 194
però un maggior grado di complessitàdal punto di vista di una possibilericostruzione architettonica. Si tratta didue colonne di granito grigio con basiattiche e capitelli corinzi di marmo afoglie lisce, reimpiegati per sorreggerel’ultima arcata della navata centraledella chiesa di Sant’Angelo Magno,nella parte alta del centro storico aipiedi delle sostruzioni del Capitolium 38.La provenienza di questi elementiarchitettonici è del tutto incerta.Secondo alcuni studiosi ascolani, comeGiulio Gabrielli, essi potrebbero esserestati prelevati da “una grandiosafabbrica antica nella collinasoprastante”, con evidente riferimentoai templi dell’arce capitolina. Secondoaltri, invece, sarebbero stati rinvenutisul posto. A sostegno dell’esistenza diun edificio antico precedente la chiesaattuale, ci sarebbero alcune struttureprobabilmente romane, come il lungomuraglione di travertino che delimita la piazza antistante, oltre ad alcuneiscrizioni reimpiegate nel complessoecclesiastico 39. Allo stato attuale la questione rimaneaperta, ma la qualità di questi elementi,sia che appartengano a un grandesantuario ascolano oggi perduto, sia cheil loro contesto originario vada cercatoaltrove, merita comunque qualche altraconsiderazione.
Occorre infatti rilevare che l’antichità stessa dei capitelli è stata messain dubbio negli studi più recenti 40. Una riconsiderazione dei materiali, invece, ci stimola ora ad analizzarlicon maggiore attenzione 41.Le due basi attiche, alte venti centimetri e con un diametro di ottantacentimetri, sono prive di decorazione e si impostano su un plintoalto dieci cm. Le colonne di granito grigio, separate dalle basi, sonoalte m. 3,68, con un diametro di m. 0,535/0,570. I capitelli di marmobianco sono monolitici e alti poco meno di settanta centimetri.
195
Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana
I capitelli corinzi della chiesa diSant’Angelo Magno
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:49 Pagina 195
La loro morfologia presenta due corone sovrapposte di dodici foglie d’acqua ciascuna, con costola centralerilevata e punta ricurva. I caulicoli sono scanalati, con bordo rigonfio e a petali rovesciati. Le volutepresentano un fiore a sei petali con bottone centrale e sono sostenute e parzialmente coperte da piccolefoglie di acanto. Al centro, tra le volute, è inserito un complessosistema di elementi vegetali affrontati, con due stelida cui nascono girali di foglie e infiorescenze.Sull’abaco si trova un grande fiore con lungo stelodecorato da elementi vegetali.La soluzione che qui riscontriamo del capitellocorinzio con foglie d’acqua, unita a una decisaricchezza decorativa nella parte superiore del kalathos, riporta a stilemi largamente diffusi al tempo dell’imperatore Adriano 42. In aggiuntasi deve segnalare una particolarità di questi capitelli
ascolani: entrambi presentano un’iscrizione compostada alcune lettere, di facile lettura e interpretazione.Sulla gola dell’abaco del capitello posto in opera a destra si trovano le lettere HYMN, incise capovolterispetto al capitello. Nella medesima posizione l’altrocapitello reca la sigla L. TR. L’alfabeto impiegato è certamente quello latino, mentre queste breviiscrizioni, ben note in diversi contesti d’Italia eprovinciali, si riferiscono certamente ai nomi degliscalpellini operanti nei cantieri, apposti perdistinguere i vari pezzi eseguiti da diversi operatori. Non deve stupire la loro posizione, perfettamentevisibile, perché le brevi iscrizioni potevano esserefacilmente occultate con una semplice stuccatura. È assai significativo che se ne trovino numerosiesempi fra il materiale architettonico di Villa Adriana,anche in lettere greche 43. I due capitelli di SanGregorio Magno, dunque, nonostante i molti aspettiancora da chiarire per quanto riguarda soprattutto la loro provenienza e il contesto di pertinenza,aprono prospettive interessantissime sulla diffusionedella cultura architettonica “urbana” ad Ascoli e più in generale nel Piceno in epoca medio-imperiale,alla quale sembrano appartenere.
S.D.M.
196
Sandro DE MARIA - Enrico GIORGI
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:49 Pagina 196
3. Gli elementi architettonici e figurativi del teatro
Il teatro romano si trova sulle pendici del colle dell’Annunziata, non lontano da Porta Romana, ed è realizzato in opera cementiziacon paramento in quasi reticolato 44. L’edificio, fortementedanneggiato dalle spogliazioni di età medievale 45, è stato riportatoin luce con scavi effettuati a più riprese nel secolo scorso, mentrealcune indagini più recenti hanno chiarito meglio la cronologia e la fisionomia architettonica dell’edificio scenico e in particolare delvano absidato posto sul margine occidentale della scena stessa 46. La cavea sfrutta la morfologia collinare, mentre la scena si adeguaall’isolato urbano, con un allineamento parallelo a uno deiprincipali assi est-ovest della città, appena a sud del tratto urbanodella via Salaria 47. Le gradinate si sviluppavano in due sezioniconcentriche, divise da una praecinctio larga due metri e settantacentimetri. Il meniano inferiore ha conservato numerose iscrizionisui sedili destinati ai magistrati municipali (subsellia) 48. Quello superiore insisteva su un poderoso ambulacro voltatosorretto dai muri radiali, interrotti dagli ingressi alla cavea(vomitoria). L’orchestra, ampia poco più di ventisette metri, conservaancora l’euripo, mentre il proscenio si innalzava su un podio altocirca un metro e mezzo. L’edificio scenico, saldato alla cavea com’ètipico dei teatri romani, era interrotto dai due ingressi (aditus), di cui è meglio noto quello occidentale. La scena è oggi conservatain maniera discontinua: l’attuale via Francesco Ricci la interrompe al centro, mentre lateralmente è coperta da un’ex-officina e dallachiesa medievale detta dei Templari o di Santa Croce.
197
Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana
A DESTRAE PAGINA SUCCESSIVAMuri radiali della caveadel Teatro Romanodi Ascoli
A SINISTRA
Riutilizzo di fusto di colonna romanacon il capitellocorinzio nella chiesa diSant’Angelo Magno
STORIA DI ASCOLI ok 14 23-04-2014 15:32 Pagina 197
Lo stesso ordine del colonnato nelfrontescena non è noto, anche seun’ipotesi ricostruttiva di LuigiLeporini lo vorrebbe corinzio, comeperaltro è assai probabile che fosse 49.Al suo margine occidentale siconserva un edificio absidato, che
ha subito interventi edilizi successivi,indagato in maniera approfondita negli
scavi del 1989. Questo edificio conservaancora parte dell’elevato, con zoccolo laterizio e alzatoin opera reticolata, della pavimentazione in lastrinequadrate di marmo e degli elementi architettonici, con
basi lapidee di colonnine scanalate.Dagli scavi del complesso teatrale provengono anche numerosiframmenti significativi, sia architettonici che scultorei. In particolaresi segnalano parti di una statua maschile e numerosi altri frammentidi sculture, fra cui dita e parti di mani pertinenti a statue colossali(certamente collocate nel frontescena) 50. Inoltre frammenti di unalastra fittile del tipo “Campana”, con la raffigurazione di una Nikeche sacrifica il toro, iconografia ben nota nelle lastre cosiddette“Campana” che potevano decorare portici, teatri e aree sacre, e chesi può attribuire, per ragioni di ordine stilistico, all’età di Augusto 51.In generale dai dati archeologici disponibili e dalle considerazionilegate alle tecniche, ai materiali edilizi e ai non molti frammentipertinenti al corredo figurativo si può concludere che il teatro siastato costruito al tempo della deduzione della colonia, con alcunesignificative riprese di età alto-imperiale 52.
199
Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana
Esedra del TeatroRomano, 1950-1951.Fondo Leporini,Archivio ASICAP
Frammenti di“Lastra Campana”,di età augustea,raffigurante Nikeche uccide un toro,proveniente dal Teatro Romanodi Ascoli.Ascoli Piceno,Museo ArcheologicoStatale
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:49 Pagina 199
4. Aspetti della cultura architettonica negli edifici pubblici della colonia romana
Come si è visto, la cultura architettonica degli ateliers cheoperarono nei cantieri pubblici della città, prevalentemente alla fine
del I sec. a.C. o poco dopo, può esseredefinita sulla base di una documentazionedisponibile assai limitata: sostanzialmentei due templi prostili di San Venanzo e diSan Gregorio e, in minima parte, ciò cheresta degli apparati del teatro.Diversamente stanno le cose per i capitellidi Sant’Angelo Magno, di cui si è anchemessa in dubbio l’antichità e per i quali è sempre plausibile una provenienzaextra-cittadina. I due templi prostili sembrano fra loro in qualche modo omogenei, sia per le
circostanze della loro conservazione, legata a riedificazioni che li hanno inglobati, ancora stabilmente collocate nel tessuto dellacittà attuale, sia per la cronologia, che in entrambi i casi – pur con un breve stacco temporale di pochi anni – rimanda alla fase di istituzione della colonia romana di età triumvirale-augustea,subito seguita dalle assegnazioni di terre ai veterani di Augusto 53. Dal punto di vita della storia urbana si tratta di un passaggio di eccezionale rilevanza, perché si collega a uno sviluppo che non fu solo politico e amministrativo, ma anche urbanistico emonumentale. In tali circostanze il decor urbano ebbe certamenteun ruolo rilevante nella diffusione della cultura romana, nel consenso che essa richiedeva e poi nel veicolare quei messaggipolitici e sociali che contraddistinguono tanti aspetti dell’ideologiadel Principato nascente. Non sembra inutile ricordare ancora unavolta che l’ideale della Pax Augusta promossa dal primo imperatorefu spesso veicolato anche attraverso la munificenza sua e dellefamiglie aristocratiche municipali che volevano aderirvi. Questo messaggio doveva trovare ulteriori interlocutori e anchesoggetti attivi nei veterani che in quel periodo vennero a popolareil territorio ascolano.La ristrutturazione del sistema itinerario della via Salaria, asseordinatore dell’impianto urbano, la Porta Gemina, il Ponte diSolestà e quello di Cecco, gli edifici per spettacolo (teatro eanfiteatro), sono tutti componenti di rilievo che rientrano in questogrande progetto di riqualificazione urbanistica.
200
Sandro DE MARIA - Enrico GIORGI
Carro trionfale nel bassorilievodella casa ruraledel conte PietroSaladini fuori PortaMaggiore,da G. Colucci,Monumenti antichidella città d’Ascoli,Fermo 1793, Tavola XVI
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:49 Pagina 200
Già da tempo è stato notato come, nel Piceno in particolare, lededuzioni coloniarie di età triumvirale-augustea siano strettamenteconnesse a un’accelerazione nei programmi edilizi, certamentedovuta alla volontà e ai programmi dello stesso imperatore 54.Pur rientrando entrambi in questa temperie storica e culturale,
tra i due templi prostili si puòforse individuare unaseriazione cronologica, comeabbiamo già osservato. Quello ionico sembrerebbe,seppur di poco, più antico e potrebbe anche precedere di qualche anno la deduzionedella colonia, o comunquepotrebbe essere stato costruitoproprio in coincidenza di quelcambiamento nellacostituzione della città. A questa fase di passaggio tral’età del municipio e quelladella colonia si devono riferireprobabilmente anche leimponenti sostruzionicapitoline dell’Annunziata, che rimandano a modelli giàampiamente diffusi da moltidecenni in area tirrenica 55. Il tempio corinzio, invece,sembra rientrare piùpienamente nei programmiche abbiamo indicato comepropri dell’età di Augusto.Assai diverso appare invece
quanto possiamo osservare, con tutte le cautele del caso, per i capitelli corinzi di Sant’Angelo Magno, per i quali si richiedecomunque uno studio più attento e puntuale, sia per la loro storia“esterna” (luogo di ritrovamento o provenienza, in prima istanza),sia per la particolare morfologia e per gli aspetti esecutivi.L’orizzonte culturale di riferimento è del tutto diverso e sembrapiuttosto rifarsi a esperienze “colte” di età medio-imperiale,probabilmente di area urbana, e avere piuttosto come riferimentoprogrammi monumentali promossi a Roma nell’età di Adriano.
E.G.
201
Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana
Capitelli dellachiesa diSan Gregorio Magno,da G. Colucci,Monumenti antichidella città d’Ascoli, Fermo 1793,Tavola XI
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:49 Pagina 201
5. Architettura e immagini degli edifici privati
Contrariamente a quanto possiamo constatare per altri importanticentri urbani della regione, Ascoli romana non ha conservatoconsistenti tracce dell’edilizia abitativa, che certamente caratterizzòmolti degli isolati dell’impianto urbano. Se pensiamo a Pesaro, Fano,Suasa, o, più a sud, Potentia/Porto Recanati e Ricina/Villa Potenza,dovremo concluderne che la documentazione ascolana diarchitettura domestica è molto più modesta. Ciononostante, restanole tracce rilevanti di almeno un isolato della città che era occupatoda domus della prima età imperiale, di impianto architettonico erivestimenti interni (pavimentali e parietali) di grande interesse. Si tratta di alcune (due o forse tre) domus rinvenute sotto l’attualePalazzo di Giustizia: da esse – da una in particolare – provengonomosaici, resti di pitture ed elementi scultorei e architettonici che neattestano l’importanza e anche la ricchezza. Sia i mosaici, sia i materiali più significativi sono ora conservati e in parte esposti nell’attuale collezione del Museo Archeologico 56.L’area sotto il Palazzo di Giustizia fu oggetto a più riprese di indaginiarcheologiche attorno alla metà del secolo scorso o poco prima,mentre scavi più recenti hanno riportato in luce le strutture chedelimitavano la parte estrema dell’isolato antico 57.Il complesso abitativo privato si affacciava sul ciglio meridionale di una via parallela al tratto urbano della Salaria, posta a due isolatidi distanza verso sud 58. Le case si estendevano sino al retrostantependio dell’Annunziata, dove sono da poco stati riportati in luceimponenti muraglioni di contenimento ancora ben conservati in elevato. Sulla base della planimetria disponibile, si possonodistinguere i resti di alcune abitazioni, con gli ambienti sistematiattorno a tre peristili. Si tratta di ampi giardini aperti, circondati da portici sorretti da colonne su tutti e quattro i lati, dietro ai qualisi aprivano vani di soggiorno, talora forniti di rivestimenti interni di particolare pregio. Anche il caso ascolano si allinea dunque asoluzioni già in uso, in Italia, dalla media età repubblicana e recepitidall’aristocrazia romana (successivamente anche dalle classi medie)dalla cultura abitativa ellenistica-orientale. Successivamente, in etàimperiale, l’uso perdura e anche si intensifica, in ogni parte dellapenisola. Data l’incompletezza degli scavi, non è stato possibilechiarire se tali strutture fossero riferibili a due o, più probabilmente,a tre diverse unità abitative.Un primo grande peristilio, di circa quindici per ventiquattro metri,con alcuni vani di soggiorno posti dietro i portici, si trova sotto l’ala orientale del Palazzo di Giustizia. L’area scoperta centrale era
202
Sandro DE MARIA - Enrico GIORGI
Rilievo dellestrutturearcheologicherinvenute nellazona del Palazzo di Giustizia durantegli scavi eseguiti dalComune negli anni1956-1957,disegno diPaolo Seghetti.Ascoli Piceno,Pinacoteca Civica
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:49 Pagina 202
bordata da quattro ali di portico, di sette per undici colonne,distanziate fra loro di poco più di due metri. Faceva eccezionel’intercolunnio centrale nel braccio meridionale, ampio oltre duemetri e mezzo, posto in corrispondenza dell’apertura della salacentrale di un gruppo di tre, che occupa questo lato del peristilio. Il gruppo di tre vani di soggiorno prospettante su un lato delperistilio rientra anch’esso in un uso di origine ellenistica, quandosovente si tratta dell’insieme dei vani destinati al padrone di casa e ai suoi ospiti maschi (andròn). Nella domus di Ascoli ai tre vani si aggiunge anche un corridoio di comunicazione con la partemeridionale dell’abitazione. Nella sala centrale si è riconosciuto il triclinio, dotato di un prezioso pavimento in lastre di marmo e a tessellato musivo. Le colonne in muratura dei portici, di circasessanta centimetri di diametro, erano rivestite di intonaco rosso(almeno nella parte inferiore, che si è conservata) e insistevanodirettamente sulle lastre di travertino che delimitavano il cortile. Il bordo di quest’ultimo era percorso da una canaletta scoperta, che raccoglieva e scaricava gli scoli delle acque di gronda dei portici. La parte meridionale del cortile, presso la sala tricliniare, accoglievauna vasca rettangolare absidata, con il pavimento in cotto a spina dipesce e il cordolo in cocciopesto. Gli angoli della vasca presentavanoquattro basamenti circolari in muratura che dovevano sorreggerealtrettante colonnine. Questo insieme doveva avere le forme
204
Sandro DE MARIA - Enrico GIORGI
Fasi di recupero deimosaici delle domusindividuati nell’areadel Palazzo di Giustizia durantegli scavi del 1957.Fondo Leporini,Archivio ASICAP
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:49 Pagina 204
architettoniche di un piccolo ninfeo all’aperto, probabilmentedotato di fontane e decorato con statue. La struttura era accessibile dal portico meridionale per mezzo di un ampio corridoio, pavimentato anch’esso a spina di pesce 59. Si tratta di un uso dell’acqua, come elemento decorativo e spessoanche di vera e propria modellazione architettonica dei giardini, che si ritrova frequentemente nelle dimore signorili fin dalla tardaetà repubblicana. Più a nord e verso il portico occidentale, si trovava anche un pozzocoronato da una vera monolitica di 70 cm. di diametro 60.L’ala meridionale del portico era profonda tre metri e mezzo circa e dava accesso a una serie di altri vani, come abbiamo ricordato.Quelli principali sono costituiti dal gruppo dei tre, perimetrati dagrossi muri rivestiti da uno spesso intonaco dipinto 61. La decorazione parietale di queste stanze, per quanto conservato,era normalmente caratterizzata da una zoccolatura scura separatada una banda bianca dalla parte superiore della parete, dipinta in rosso 62. Da ovest verso est, si susseguono un vano di soggiorno,un triclinio, un corridoio e un altro ambiente di soggiorno, forseanch’esso con funzione tricliniare. Il vano centrale corrisponde al triclinio affacciato verso il ninfeo del giardino. Esso è affiancato a ovest da un vano rettangolare, con pavimento in cocciopesto, chedava accesso a un piccolo ambiente triangolare di risulta, quasi un
205
Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:49 Pagina 205
ripostiglio posto sul fondo della casa, con pavimento in semplicebattuto di terra, posto a una quota sopraelevata di circa settantacentimetri. Dall’altro lato (a est), prima di un’altra stanza di soggiorno pavimentata con un cocciopesto delimitato da unacornice a mosaico nera, di piccole dimensioni, si trova un corridoioche metteva in comunicazione il portico con altri ambienti di servizio. Sui lati di questo corridoio, anch’esso con pavimento in cocciopesto, si osservano due soglie affrontate, che costituivanoaccessi secondari alle sale tricliniari. La planimetria dei vani posti sul fondo della casa è irregolare perché doveva adeguarsiall’andamento del pendio retrostante, quasi una scarpata che necondizionava lo sviluppo. Proprio gli ultimi scavi hanno mostratocome i muri perimetrali sul fondo dell’abitazione svolgessero anchela funzione di contenimento e regolarizzazione della collina.Il triclinio centrale era la sala principale di questo gruppo,pavimentata con un mosaico di cinque metri e mezzo per otto metrie mezzo circa. È preceduto da una soglia, verso il portico, in mosaicoe opus sectile di marmi policromi, costituita da una serie di losangheprofilate in tessellato bianco recanti, all’interno, dischi marmorei dimarmo bianco venato, che troviamo ancora, assieme ad altri marmipolicromi, in piccoli quadrati posti fra una losanga e l’altra, entrospazi triangolari campiti con tessere nere. L’intero pavimento dellastanza era profilato da una doppia linea nera separata all’internoda una banda bianca. La stesura musiva, nel suo complesso, ècomposta anteriormente da uno schema a esagoni bianchi profilatidi nero, delimitato da una banda nera. Nella zona centrale si trovaun’altra cornice quasi quadrata, di circa tre metri di lato, a tesserebianche e nere con un rosone centrale ed émblema policromo. Le due parti del pavimento, quella centrale con il motivo a rosone e quella anteriore con la decorazione geometrica, erano separate da una fascetta decorata con un tralcio d’edera stilizzato 63.La decorazione musiva centrale è naturalmente quella piùimportante e corrisponde allo spazio lasciato libero al centro edavanti ai letti tricliniari, come di norma si riscontra in questo tipodi vani. Dunque la sintassi decorativa del mosaico corrispondestrettamente alle funzioni e ai percorsi all’interno della stanza.Procedendo dall’esterno verso l’interno, essa presenta un bordo conil motivo della treccia a due capi, cui seguono, alternandosi, quattroprofilature bianche e nere. Più all’interno, quattro cespi vegetalimolto stilizzati, posti agli angoli del rettangolo, generano ciascunodue tralci, esili e quasi filiformi, che si sviluppano simmetricamente a destra e a sinistra, con pochissime brattee e infiorescenze,affrontate a girale al centro dei lati delle corniciature. Nel mezzo
206
Sandro DE MARIA - Enrico GIORGI
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:49 Pagina 206
del mosaico si trova un cerchio di poco meno di due metri e mezzodi diametro, bordato con il motivo a onde correnti e campito asquame ellittiche bicrome, bianche e nere, decrescenti verso il centro.L’effetto è naturalmente quello di uno “scudo” convesso, al centrodel quale, entro una cornice circolare ancora con una treccia a duecapi, si colloca un virtuosistico motivo figurato policromo. In luogo della testa della Gorgone, come molto spesso nel mosaicoromano si ritrova in questa stessa posizione, osserviamo qui unadoppia testa silenica o satiresca visibile da due lati. Da un lato(quello nord, dunque verso l’ingresso della sala) essa si percepiscecome quella di un personaggio anziano, calvo e con folta barbacadente, occhi volti verso l’alto e bocca socchiusa; dall’altro lato(quello sud) la testa appare invece come quella di un giovanescarmigliato, con le lunghe ciocche dei capelli rivolte verso l’alto,come mosse dal vento, con gli occhi sbarrati e la bocca aperta comein un grido. Si tratta di un gioco virtuosistico a “trompe l’oeil” ditradizione ellenistica, che tuttavia, in questo caso, potrebbe ancheavere un’altra chiave di lettura più di matrice filosofica, legata aiconcetti opposti di gioventù e vecchiaia, come qualcuno ha voluto
suggerire 64. Anche le altre soglie degliambienti affacciati sul portico
presentano piccoli tappetimusivi, con decorazioni
geometriche in bianco e nero: bordo a denti di
lupo e campo internoancora con il motivodegli esagoni, maallacciati; tappetinobordato da unasequenza ditriangoli sullepunte e campointerno a quadraticon doppia
profilatura, recantial centro una rosetta,
scudi incrociati, unalosanga 65.
Inoltre tutti i passaggipresentavano dei fori laterali
per l’alloggio delle impostelignee delle porte.
207
Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana
Emblema centrale,con doppio volto,del mosaicopavimentale delladomus rinvenuta in occasione della costruzionedell’attuale Palazzodi Giustizia.Ascoli Piceno,Museo ArcheologicoStatale (inv. 64672)
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:49 Pagina 207
In un’altra area di scavo, collocata a nord, ovvero dalla parteopposta rispetto al lato del peristilio occupato dai vani di cuiabbiamo appena trattato, è stato possibile individuare un secondomosaico bianco e nero, anch’esso dotato di una soglia musiva. Tale pavimentazione doveva appartenere a una stanza collocata inuna posizione intermedia tra l’atrio (non individuato) e il peristilio. La documentazione disponibile non permette neppure di chiarire da quale lato si trovasse la soglia d’ingresso al vano. Tuttavia, in considerazione della dislocazione dell’ambienteconfrontata con la comune sintassi dell’abitazione romana, della sua decorazione musiva e delle dimensioni, si dovrebbe trattare di un altro vano di soggiorno/passaggio, forse del tablino. A ovest di questo peristilio, infine, fu riportato in luce l’angolo di un secondo peristilio, probabilmente appartenente a un’abitazionediversa, per il resto del tutto ignota.Nella stessa direzione, ma ancora più a occidente, si trovano i resti diuna terza dimora, anch’essa dotata di un grande peristilio con alcuniambienti retrostanti. Il cortile coi suoi portici misura circa sedici perventi metri, con sei colonne su un lato e più di sette sull’altro; esso,di forma rettangolare, si disponeva con il suo asse maggiore in sensoortogonale a quello del primo peristilio. Dietro il porticomeridionale, profondo circa tre metri e mezzo, sono stati riportati in luce altri due vani, di cui quello più centrale era probabilmente un triclinio pavimentato a mosaico, il cui schema generale eraanalogo a quello dell’altro triclinio con il motivo a rosone. Infatti ladecorazione musiva in bianco e nero era anch’essa divisa in due partida una fascia, che sembra riproducesse le arcate di un acquedotto,mentre il settore più interno presentava un emblema centrale in tarsie marmoree. La presenza di frammenti di intonaci dipintinella tradizione del cosiddetto “quarto stile” pompeiano lasciapensare a rifacimenti delle pitture parietali anche in epoca imperialepost-augustea (seconda metà del I sec. d.C. – inizi del II).Se proviamo a ricomporre in un insieme coerente i lacerti dellaplanimetria generale di questo complesso edilizio, pur con qualcheapprossimazione si possono ricostruire probabilmente tre unitàabitative contigue, accessibili dalla via che le delimitava a nord e sviluppate sino alla incombente collina retrostante. Si tratta di abitazioni a peristilio dotate di un notevole apparato di finiture interne, rivestimenti sia pavimentali che parietali dinotevole qualità, il cui arco di vita non è ricostruibile con precisioneper la mancanza di documentazione probante.La domus orientale, ad angolo tra due assi viari ortogonali, è la meglio nota e si può tentare una ricostruzione un po’ più
208
Sandro DE MARIA - Enrico GIORGI
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:49 Pagina 208
dettagliata della sua planimetria, provvedendo anche a colmareidealmente qualche lacuna dovuta ad assenza di dati. Dal gruppo dei vani d’ingresso, certamente fauces e atrio, gravitantisulla strada che correva a nord, si doveva accedere al tablino e daqui al grande peristilio, sul quale si affacciavano la sala tricliniare egli altri attigui vani di soggiorno 66. Questi erano caratterizzati dallapresenza di grandi muraglioni di contenimento del pendio collinare,che ebbero anche lo scopo di rafforzare uno spazio probabilmentericavato dal parziale sbancamento della collina. I cubicula (stanze da letto e di sosta) potevano essere dislocati ai lati dell’atrio 67.
209
Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana
Fasi di recuperodelle domusindividuate nell’areadel Palazzo diGiustizia durantegli scavi del 1957.Fondo Leporini,Archivio ASICAP
PAGINE SUCCESSIVE
I mosaici esposti nel MuseoArcheologicoStataledi Ascoli Picenoa Palazzo Panichi
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:49 Pagina 209
Ai lati dell’ingresso sul fronte-strada a nord e lungo il fianco orientale dell’abitazione, affacciato su
una via ortogonale alla precedente, potevanotrovare spazio alcune tabernae o officine,
con accessi autonomi, come è ripetutamenteaccertato in tanti casi di città romane. Le stesure musive e i sectilia dei pavimenti
nei triclini principali mostrano alcuni elementidi omogeneità e risultano condizionati dalla
funzione di queste stanze, che dovevanoaccogliere i letti tricliniari disposti a ferro
di cavallo lungo le pareti laterali e su quella di fondo, lasciando in vista le parti centrali e
gli emblemata dei pavimenti.Forse più di una bottega ha lavorato alla stesura
dei rivestimenti pavimentali, mentre dal punto di vista cronologico essi sembrano conservare alcunielementi ancora nell’alveo della tradizione di epoca
repubblicana, come la commistione di parti rivestite a cocciopesto con altre a tessellato. Altri dettagli ancora, come i caratteri degli elementi vegetali presenti nel mosaico del primoperistilio e il rapporto fra tessere chiare e scure paiono piùesplicitamente riferibili all’età augustea. Questo suggerirebbe unadatazione dell’impianto tra il periodo del secondo triumvirato e laprima e media età di Augusto, in sostanza nei quattro decenni chevanno dagli anni Quaranta del I sec. a.C. fino al cambiamento d’era.Data la carenza della documentazione, non è possibile stabilire se questo lasso di tempo comprenda la successione di differenti fasi edilizie, com’è consueto nell’edilizia domestica, oppure dipenda dal variare degli orientamenti della committenza. Il tenore elevatoche si può cogliere sia nell’impianto architettonico delle costruzioniche nelle parti accessorie e decorative di pavimenti e pareti fa comunque intravvedere, dietro almeno alla fase originaria, una proprietà abbiente e abbastanza raffinata nella sua cultura e nei suoi “gusti”. Viene immediato pensare alla nuova classedirigente che dovette stabilirsi in città al momento della deduzionedella colonia triumvirale-augustea 68. Di fatto, comunque, è accertata una sequenza di fasi differenti, ad esempio nelle stesure degli affreschi parietali, oltre che in alcunealtre tracce archeologiche di cui diremo subito. Si tratta di unrinvenimento di eccezionale importanza effettuato nel 1939 inquesto stesso contesto, quando fu rinvenuto un ritratto marmoreodi Traiano di dimensioni molto vicine al vero (alt. cm. 32), pertinente
212
Sandro DE MARIA - Enrico GIORGI
Ritratto maschile diepoca giulio-claudia.Ascoli Piceno,Museo ArcheologicoStatale (inv. K 5691)
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:49 Pagina 212
a una statua per il resto perduta. I caratterifisionomici dell’optimus Princeps sono ben
riconoscibili: volto massiccio e sololeggermente ovale, naso pronunciato
(compromesso da una lacuna), labbrasottili e serrate, mento piccolo etondeggiante. Caratteristica è l’acconciatura, a breviciocche svirgolate verso destra ericadenti sulla fronte. Evidenti sono le rughe al centro della fronte stessa e i profondi solchi naso-labiali, qui indicati con decisione, seconda unatradizione che risale a età repubblicana
e che fu ripresa, qualche decennio prima,nel ritratto di Vespasiano. Le caratteristiche
dell’acconciatura avvicinano questo ritrattoal tipo cosiddetto “del sacrificio”, perchépresente appunto in una scena di sacrificioche compare sulla Colonna Traiana, creato
probabilmente poco prima del 113,dunque a pochi anni dalla mortedell’imperatore.
La testa era leggermente volta verso la sua sinistra, come mostrano le rughe sul
collo e la lieve articolazione della muscolatura.Se la pertinenza a una statua iconica è fuori discussione, data la conformazione della frattura alla base del collo, nulla possiamo dire dello schema iconografico della scultura nel suo insieme, ad esempio se del tipo loricato oppure togato 69. L’alta qualità e la stessa personalità rappresentata fanno pensare alla collocazionedella statua in un edificio pubblico, in contrasto con i dati sulrinvenimento. È però possibile che la scultura sia stata rinvenuta in giacitura secondaria, cioè fuori dal suo luogo originario, forsepronta per essere calcinata, come non di rado accade in etàtardoantica o anche nel corso del medioevo. Probabilmente èquesta la ragione per cui la bella testa di Augusto della prima etàclaudia, in marmo greco insulare, rinvenuta a Suasa fu ritrovata,assieme a una gamba della statua, in un ambiente di servizio delladomus dei Coiedii, un contesto indubitabilmente privato 70. In seconda istanza, si dovrebbe pensare a un’eventuale funzionesemi-pubblica di una delle abitazioni appena descritte: non è poicosì raro il ritrovamento di statue iconiche di imperatori in contesti
213
Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana
Ritrattodell’imperatoreTraiano (98-117 d.C.),rinvenuto nel 1939nell’area delPalazzo di Giustizia.Ascoli Piceno,Museo ArcheologicoStatale (SAM 64256)
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:49 Pagina 213
privati o semi-pubblici appunto, sia pure di particolarerango e significato. Si pensi soltanto alla provenienzadel celeberrimo “Augusto di Primaporta” dalla villaposseduta dalla moglie Livia. Inoltre, dallo stesso
contesto di scavo delle case proviene anche un’ala diNike di bronzo, di piccole dimensioni, che richiama
temi “trionfali” che ben si accompagnano al quadro ufficiale che prospetta anche la statua di Traiano 71.Si deve anche ricordare che dai pressi degliedifici privati di cui abbiamo trattato, più
esattamente da un vecchio rinvenimentosegnalato dal Gabrielli prima della costruzione
dell’attuale via Dino Angelini, proviene ancheun’altra significativa scultura di marmo, ancorchémolto frammentaria. Si tratta di una replica della cosiddetta ‘Afroditeaccovacciata’, raffigurata nell’atto di chinarsi per il bagno, oggi visibile presso il MuseoArcheologico, copia di un originale greco,
in bronzo, di età medio-ellenistica (seconda metà del III sec. a.C.) molto amato dalla committenza
romana, come ornamento di spazi domestici o anche di taluni edifici pubblici 72.
La cronologia della copia è probabilmente l’età medio-imperiale, mentre il soggetto si addice appunto sia a una
casa che, ad esempio, a un impianto termale, dunque restaimpossibile stabilirne il contesto di provenienza, se dagli edifici
privati di cui abbiamo ampiamente trattato oppure da unvicino impianto pubblico 73.In ogni caso, a prescindere da questa possibile commistione di funzioni, pubbliche e private, le dimore rinvenute sotto
il Palazzo di Giustizia attestano comunque, come abbiamo giàricordato, una committenza elevata e un’adeguata estrazionesociale dei proprietari. I possibili riferimenti iconograficiall’ufficialità del potere imperiale non fanno che confermare questaimpressione. Ancora una volta, come si è già notato a propositodell’architettura pubblica, il quadro cronologico della fase ediliziaprincipale rientra nello sviluppo urbano risalente al momento della deduzione della colonia. Il dato appare di notevole importanza,per definire sia gli assetti sociali che le fasi di sviluppo della città e della vita urbana nel suo insieme.
S.D.M.
214
Sandro DE MARIA - Enrico GIORGI
Afroditeaccovacciata,copia di un originalegreco di età medio-ellenistica,rinvenuta nei pressidel Palazzo di Giustizia, già viadel Gigante.Ascoli Piceno,Museo ArcheologicoStatale inv. K 5714)
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:49 Pagina 214
6. Le sculture fuori contesto conservate nel Museo Archeologico Statale
Sinora abbiamo segnalato e interpretato i principali resti scultoreidella città romana, riferendoli ai contesti urbani dai qualiprovengono, come nel caso della lastra Campana nel teatro, del ritratto di Traiano nella domus del Palazzo di Giustizia e della Afrodite accovacciata di via del Gigante. Per completare il panorama della cultura figurativa di Ascoli romana, tuttavia, pur limitandoci ai pezzi principali esposti nel Museo Archeologico e senza considerare quelli troppo frammentari oppure di ambitofunerario (che vengono trattati in un altro capitolo di questo stessovolume), occorre considerare ancora alcuni documenti scultorei diprovenienza ignota 74. La breve rassegna che segue è chiusa da unastatua proveniente dal territorio della colonia romana.Al ritratto di Traiano rinvenuto negli scavi delle domus del Palazzodi Giustizia si devono aggiungere due ritratti di età giulio-claudia,appunto privi di indicazioni precise in relazione al loro contesto di rinvenimento. Si tratta di un ritratto maschile in marmo bianco,alto circa 26 cm., con varie scheggiature, nel naso, ai lati della boccae sulla fronte. Il ritratto, con lieve torsione della testa e una resamolto compatta dei volumi, è riferibile a un personaggio della gensClaudia, forse Druso Minore, e presenta la tipica idealizzazione dei
215
Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana
Giulio GabrielliAntichità romane,tempera su cartoncino,Ascoli Piceno,Pinacoteca Civica
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:49 Pagina 215
lineamenti che caratterizza le statue postume,il che ne porterebbe la datazione a un periodoposteriore al 23 d.C. 75. Una seconda testa,femminile, di calcare bianco, alta circa 20 cm. e riferibile a una statua privata, ritrae il voltoovale con lineamenti minuti di una giovinetta.L’acconciatura è divisa dalla scriminaturacentrale in due bande che lasciano scoperte leorecchie e vengono poi raccolte in uno chignonsulla nuca. Si tratta di una semplificazione dello schema tipico di Agrippina (Maggiore o Minore), comune nella moda dei ritrattifemminili di età tiberiana e claudia 76.Per la coroplastica di età repubblicana 77
un pezzo assai significativo è costituito da unaformella frammentaria proveniente dall’areaurbana, precisamente dai pressi della chiesa di Sant’Agostino. Si tratta di una lastra di terracotta di trentunoper venticinque centimetri circa, priva dellaparte superiore, sulla quale è raffigurata unaprora di nave da guerra, attraccata a un molocon la scaletta per la discesa, rostro e torretta
sul ponte. A fianco, come completamento della simbologia militare,compaiono in alto una corazza, di tipo ancora ellenistico, e al disotto una coppia di schinieri incrociati. La lastra doveva essereaffissa a una travatura di legno o a una parete, come indica il foroper il fissaggio in alto a sinistra. Con ogni probabilità il contesto diappartenenza doveva essere domestico: è da escludere, per il luogodi ritrovamento, un edificio funerario, dove pure la tematica dellaraffigurazione troverebbe un altrettanto logico riferimento. È invece molto interessante la possibile appartenenza a un atrio (o a un tablino) di casa privata, cioè a un luogo che potevaaccogliere i segni della gloria militare del proprietario, come è bendocumentato sia dalle fonti che da altri ritrovamenti archeologici 78.La cronologia, certamente di età repubblicana, può risalire fino ai decenni centrali del I secolo a.C. e forse, ancora una volta,possiamo trovarci di fronte a un altro riferimento alle impresemilitari dei veterani, primi abitanti della colonia di Asculum 79. La documentazione della cosiddetta “arte plebea” 80 – ovveropertinente alle classi medie di municipi e colonie, fra I sec. a.C. e I d.C., caratterizzata da un linguaggio formale antinaturalistico,schematico e abbreviato, e da soggetti della sfera privata – ad Ascoli
216
Sandro DE MARIA - Enrico GIORGI
Statua di togato e fregio dorico con motivi floreali e sacrificali, dalla chiesa di San Leonardo,demolita nel 1824,presso Porta Romana,da G. Colucci,Monumenti antichidella città d’Ascoli,Fermo 1793, Tavola XII
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:49 Pagina 216
non appare particolarmente cospicua.Anche la produzione funeraria,solitamente legata a questa particolareforma di espressività figurativa, èscarsamente dotata di elementi iconici. A questa particolare categoria possiamoperò ascrivere una statua in travertinodi togato del Museo Archeologico dellacittà, parzialmente conservata. Essa misura un metro e sessanta dialtezza, dunque è corrispondente al vero,considerando che è mutila della testa, di una mano e dei piedi. Nonostantequeste lacune e la consunzione di varieparti, si distingue comunque bene unafigura maschile stante, con il peso chegrava sulla gamba destra, mentre lasinistra è lievemente flessa. Il bracciodestro doveva essere disteso sul fianco,a lato di una lunga piega della stoffadella toga che giunge fino al ginocchio(sinus), mentre la mano sinistra trattienesul petto il lembo della veste pendentedalla spalla (balteus), con uno schemaben noto nella statuaria romana. Il panneggio, con pieghe poco profondema abbastanza ampie sui fianchi e sullegambe, è piatto e sommario, poconaturalistico, come di norma si osservasu questa produzione scultorea,eseguita da scalpellini locali cheproducono spesso in serie, secondoschemi consolidati e capacità formalimodeste. La parte posteriore, lasciatagrezza, testimonia la collocazioneoriginaria della statua all’interno di una nicchia o a ridosso di una parete. La destinazione (sconosciuta, come
il luogo di ritrovamento) poteva essere onoraria e celebrativa, in un contesto pubblico o anche privato, oppure funeraria,all’interno di un monumento sepolcrale a edicola. Sulla base di queste considerazioni e dei molti confronti possibilicon altra analoga produzione, la scultura può essere riferita
217
Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana
Statua di togatoin travertino.Ascoli Piceno,Museo ArcheologicoStatale (inv. K 4401)
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:49 Pagina 217
ai decenni a cavallo del cambiamento d’era 81.Alla stessa sfera dell’“arte plebea” può essere ascritto il noto “Rilievo dei frombolieri”, come solitamenteviene definito un segmento di fregio lapideo anch’essoesposto nel Museo Archeologico della città,
di provenienza sconosciuta. Si tratta di una lastra frammentaria di pietra
calcarea mutila a sinistra, parzialmente abrasae con tracce di colore rosso sul fondo 82. La zona centrale, tra due fasce piatteaggettanti (quella inferiore è più alta),
presenta la raffigurazione a bassorilievo di ungruppo di cinque frombolieri (funditores),riconoscibili per le caratteristiche fionde che
tengono nelle mani. I personaggi, tre stanti e due in movimento verso sinistra, sono resi di prospettonel tronco e di scorcio o di profilo negli arti inferiori,disposti paratatticamente; comunicano un certodinamismo, presentano le medesime dimensioni e si susseguono con un ritmo costante. Indossanosolo una fascia di stoffa a cingere i fianchi come unperizoma (subligaculum) sorretto da un cinturone. Come abbiamo anticipato, sono armati di unafionda alla mano destra, mentre nella sinistrasembra custodiscano il proiettile, probabilmenteuna ghianda missile. La composizione è semplificata, anche se non del tutto antinaturalistica, certamente daattribuire a una bottega locale di scultori. È possibile la pertinenza a un monumentoonorario, legato agli eventi della guerra sociale
(91-89 a.C.), che per la prima volta videro la città picena sollevarsi al livello della grande storia peninsulare e durante la quale è ben attestato archeologicamente l’uso di ghiande missili. Ma piùprobabilmente si deve pensare a un monumento funerario, chepoteva ricordare gli stessi episodi storici oppure scene gladiatorie. La cronologia può essere fissata agli ultimi decenni del I secolo a.C. 83.Infine, tra i non molti materiali scultorei provenienti dal territorioascolano, si segnala una bella statuetta di età medio-imperiale di un giovane Dioniso, esempio caratteristico di “scultura d’arredo”propria della pars urbana delle ville rustiche di campagna. Fu rinvenuta occasionalmente nel 1879 e registrata come provenienteappunto da una villa rustica romana rintracciata in contrada La Macèra,
218
Sandro DE MARIA - Enrico GIORGI
Statua di Dionisogiovane in marmolunense(II secolo d.C.), da un originale greco del IV-III secolo a.C.Ascoli Piceno,Museo ArcheologicoStatale (inv. K 4402)
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:49 Pagina 218
a Piani Morti presso Maltignano 84. In realtà la provenienza esatta è piuttosto dubbia, tanto che lo stesso Giulio Gabrielli, quando riuscìa farla acquisire al Museo nel 1880, annotò che il venditore sostenevadi averla trovata invece al Passo di Civitella vicino al ponte nuovo sultorrente Vibrata. La scultura proverrebbe dunque da un’area postalungo la viabilità di collegamento tra Ascoli e Teramo. Comunque sia, il contesto di riferimento a una villa di campagnaappare sicuro. La piccola scultura, in marmo lunense, è alta cm. 53 e rappresenta Dioniso giovane (più che un satirello); è mutila degliavambracci e di parte degli arti inferiori, dal ginocchio in giù. Il giovinetto è quasi completamente nudo, indossa soltanto una pelledi capretto, che pende abbastanza morbidamente dalla spalla destrae copre il fianco sinistro. Il capo, volto a destra e lievementeabbassato, è circondato da una corona d’edera. I capelli sono folti e riccioluti, solo in parte raccolti sulla nuca, mentre scendonolateralmente a boccoli sulle spalle. Forse erano presenti altri elementidi coronamento metallici, sostenuti da perni che potevano trovarealloggio nei fori di trapano presenti sulla sommità del capo. Dietro la gamba destra si conservano i resti di un tronco che dovevafungere da sostegno. Il modello iconografico discende sicuramente da un prototipo alto-ellenistico, rielaborato nel pieno II secolo d.C.,come mostra il trattamento del modellato del corpo e soprattuttol’esecuzione, molto chiaroscurata e morbida, della capigliatura 85. Si tratta, come abbiamo anticipato, di una piccola scultura destinataa decorare giardini, fontane o ambienti domestici di particolareraffinatezza, dove la sfera dionisiaca trovava la più appropriatacollocazione, evocando paesaggi e atmosfere proprie del mondodella natura, del bosco e della selva.
E.G.
1 Del rilievo si tratterà in conclusione di questo saggio.2 Per una sintesi sulla regione si veda LUNI 2003; per gli archi onorari si rimanda invece
a DE MARIA 1988.3 La denominazione è dovuta alla presenza del vicino Convento dei frati francescani
che si spostarono nell’area di Borgo Solestà dal Convento di San Francesco, in pienocentro storico, dando così il nome alla Porta sorta dopo il ponte sulla spondameridionale del fiume Tronto.
4 CAMPAGNOLI-GIORGI 2002; GIORGI 2005. Si veda anche il capitolo sulle infrastrutture delterritorio in questo volume.
5 I blocchi di travertino hanno lunghezza variabile, ma le assise sono regolari e altedue piedi romani (circa cm 58).
6 Questa cornice è stata molto restaurata. Il basolato romano era coperto dalla stradamedievale ed era allettato su uno strato di riempimento che copriva l’intradosso. Da questo strato vengono alcuni frammenti di ceramica picena (PASQUINUCCI 1975,pp. 14-19).
219
Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:49 Pagina 219
7 La cornice modanata, grande quanto un piede romano (circa cm 29), presenta unlistello rettilineo sormontato da un kymation. Le lesene e le cornici orizzontali, chetripartiscono il fornice, accomunano il Ponte di Borgo Solestà al Ponte di Augusto aNarni. L’analisi generale suggerisce una datazione in età augustea non troppoavanzata, ossia anteriore al ponte di Narni e precedente a quello di Rimini(PASQUINUCCI 1975, pp. 14-15).
8 La cornice aggettante presenta un listello superiore, una modanatura rettilinea e unkymation inferiore.
9 GALLI - VICCEI 1942; AMADIO 1987; AMADIO 2000 pp. 96-97.10 La diversa imponenza della Porta Cappuccina rispetto a questa guardiola deve far
riflettere su quale fosse la via privilegiata di collegamento con la media valle delTronto (mentre l’ingresso da monte era ovviamente quello di Porta Romana). Il selciato attuale del Ponte di Cecco con il profilo a schiena d’asino è, ovviamente,quello della strada medievale.
11 Un’altra tradizione assegna la costruzione del ponte, voluta da Galeotto Malatesta, aCecco Aprutino (PASQUINUCCI 1975, p. 8, con bibliografia).
12 L’aspetto di un rozzo bugnato è dato dai conci dell’arco, che presentano anathyrosise sbozzatura grossolana della facciata. L’imposta degli archi, il bugnato, larobustezza della pila centrale trovano analogie con il ponte di Narni, della prima etàaugustea (PASQUINUCCI 1975, pp. 8-12, con bibliografia).
13 Si veda il contributo sulla viabilità romana in questo stesso volume.14 Le mura, conservate per alcuni tratti tra le pendici dell’Annunziata e la sponda destra
del fiume Tronto, presentano almeno due fasi principali (una pre-romana in blocchidi arenaria e una romana in opera reticolata). Tale sequenza di fasi è statarecentemente riscontrata anche nell’ambito di alcune indagini stratigrafiche condottenell’area di Porta Romana. A tal proposito si rimanda al contributo sull’urbanistica inquesto stesso volume. In generale per la descrizione e lo studio della Porta Gemina siveda PASQUINUCCI 1975, pp. 27-29, con bibliografia.
15 La porta si daterebbe nella seconda metà del I secolo a.C. I confronti più appropriatiche sono stati proposti sono costituiti dalle porte di Verona e Como e dalla PortaConsolare di Spello (PASQUINUCCI 1975, p. 29).
16 La chiesa di San Leonardo fu distrutta nel 1824, altri lavori di sistemazione dellastrada si ebbero nella prima metà del secolo scorso.
17 Nella muratura si conservano blocchi di reimpiego decorati (con spire di un mostromarino oppure con strumenti di mestiere, come una regula e una libella),probabilmente prelevati da monumenti funerari.
18 La modanatura sull’imposta degli archi presenta in alto una cornice rettilinea, unkymation, un listello piano e un kyma rectum. La modanatura sull’estradossopresenta una sequenza che alterna elementi rettilinei ad altri convessi (PASQUINUCCI
1975, p. 26). 19 PASQUINUCCI 1975, pp. 52-55; TORELLI 1977; GIORGI 2004; SALVO 2012.20 Lo scavo è stato condotto dalla società Archeologica di Ascoli Piceno.
Per una prima notizia si veda la scheda relativa di Nora Lucentini in:www.archeologia.beniculturali.it/index.php?it/142/scavi/scaviarcheologici.
21 Una situazione simile, ma di ordine corinzio, è attestata in numerosi altri casi per laprima età imperiale, ad esempio a Pola in Istria e ad Augusta PraetoriaSalassorum/Aosta. Sulla sostenibilità di questa ipotesi cfr. ALTINI 2007.
22 Il tempio è ampio m. 14,20 x 6,35 e il podio è alto m. 1,55, la parete sud della cellaè ampia m. 8,40. Per altre notizie su questo tempio si veda il capitolosull’urbanistica. Più in generale sullo sviluppo urbano della città romana: PASQUINUCCI
1975; GIORGI 2005; PROFUMO 2005; PROFUMO 2009.23 Nonostante sia attestato ad Ascoli il culto di numerose divinità, quali Giove, Vesta,
Fortuna (venerata con l’appellativo di Redux e Respiciens), Iside Vincitrice associata aGiunone (con un interessante fenomeno di sincretismo), Sol, oltre ai culti imperiali di
220
Sandro DE MARIA - Enrico GIORGI
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:49 Pagina 220
Augusto e Tiberio, nessuno di questi è riferibile con certezza al tempio (LAFFI 1975, pp.LIII-LV; PACI 1999a). Tuttavia la presenza di un’epigrafe dedicata appunto a Salus, forsedi età augustea, reimpiegata nell’edificio seicentesco e ancora visibile proprio davanti alpodio (seppure girata su un fianco), ha fatto supporre che il tempio potesse riferirsi aquesta divinità. L’ipotesi si deve a Pompilio Bonvicini, che tuttavia cadde probabilmentein errore ritenendo che si trattasse di un altare iscritto (PASQUINUCCI 1975, p. 38 conbibliografia relativa). Si tratta invece di un segnacolo con funzione di ex voto, a ricordodi un’offerta di doni alla dea Salus che ha permesso il lieto ritorno a casa del coniuge.Non è quindi del tutto da escludere che il tempio in questione possa essere statodedicato alla Fortuna Redux (cfr. VISANI 2007). A tal proposito si rimanda al contributosulla Vita religiosa di SILVIA MARENGO in questo volume.
24 ORSINI 1790; PASQUINUCCI 1975, pp. 38-42; VISANI 2007 (a cui si rimanda per ladescrizione generale).
25 Per questi scavi si veda il capitolo sull’urbanistica in questo stesso volume.26 Per le misure delle modanature vedi VISANI 2007.27 Cfr. nota precedente.28 Le foglie d’acqua sono lisce, con scanalature lungo la costola mediana e sui margini,
mentre quelle d’acanto hanno una nervatura profonda nelle costole centrali elaterali, con fogliette a tre lobi ogivali che si avvicinano formando occhielli dal profiloa goccia. Cfr. VISANI 2007.
29 Nel colonnato interno della stoà. Cfr. LANDOLFI 2005, pp. 8-19. Si veda, in generalesui tipi “ionico-italici”, BATINO 2010.
30 I confronti proposti sono costituiti da due capitelli provenienti dal tempio di Afroditead Afrodisia e tre da Efeso, due dal témenos del tempio di Cesare e Roma e unodalla Porta Occidentale dell’agorà tetragona: VISANI 2007.
31 Il tempio misura m. 22,12 x 11,14, il pronao è profondo esattamente m. 7,48 e ilpodio è alto m. 1,20/1,50.
32 Per una più esaustiva trattazione in merito al problema di questa dedica si veda LAFFI
1975, con bibliografia. Sul culto di Iside ad Ascoli: CAPRIOTTI VITTOZZI 1999, p. 64.33 Cfr., in questo stesso volume, il capitolo sull’urbanistica della città.34 Gli scavi permisero di verificare l’altezza del podio, sull’angolo nord-est, e
interessarono anche l’area antistante l’ingresso del pronao. Cfr. PASQUINUCCI 1975,pp. 30-38, con bibliografia.
35 Parrebbe presente, tra questi, anche una protome leonina fittile. In generale si vedaPASQUINUCCI 1975, pp. 32-33.
36 I capitelli corinzi a coronamento dei pilastri sono costituiti da due blocchi alti m. 0,85,larghi m. 0, 90 alla base e m. 1 alla sommità. Sul fondo della cella quello occidentale èquasi integro, l’altro ampiamente ricostruito dopo la demolizione della vecchiacanonica; erano lisci sul lato meridionale, PASQUINUCCI 1975, pp. 30-38).
37 Cfr. DE MARIA 1983, p. 36638 La chiesa di Sant’Angelo Magno parrebbe di antiche origini medievali, ma fu
ricostruita in epoca rinascimentale. Sull’importanza di quest’area nella topografiaaltomedievale della città si veda GIORGI 2004.
39 Per una sintesi del problema si veda PASQUINUCCI 1975, pp. 101-103, con bibliografiarelativa.
40 PASQUINUCCI 1975, p. 103.41 Dal 2012, infatti, sono in corso annuali campagne di analisi, studio e rilievo topografico
dei monumenti antichi della città romana, nell’ambito di un progetto della Sezione diArcheologia del Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna,condotto in accordo con la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche, con ilComune di Ascoli Piceno e con l’Ufficio Beni Culturali della Curia Vescovile.
42 In generale si veda FREYBERGER 1990. Per la decorazione architettonica della Piazzad’Oro a Villa Adriana: CONTI 1970.
221
Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:49 Pagina 221
43 Si veda ad es. MáRQUEZ 2010, pp. 100-101, figg. 12-17. Per confronti con Ostia:PENSABENE 2002.
44 PASQUINUCCI 1975, pp. 43-49; PROFUMO-LANDOLFI 2002.45 A partire dall’età tardoantica e altomedievale i cantieri per il recupero dei materiali
edilizi, destinati al riuso o alla produzione di calce, furono molto attivi in città ecertamente non trascurarono quest’edificio antico ormai in disuso, come dimostranole numerose calcare rinvenute in questa zona. Molti dei conci squadrati di travertinovisibili nella parte inferiore delle mura medievali, presso Porta Romana, potrebberoessere stati prelevati proprio dal vicino teatro (PASQUINUCCI 1975, p. 44; GIORGI 2005).
46 I primi scavi furono eseguiti tra il 1929 e il 1959. Nuove indagini si sono avute nel 1989 e nel 2009: PASQUINUCCI 1975, p. 43; LANDOLFI-PROFUMO in LUCENTINI 2002,pp. 85-86.
47 L’area scelta per edificare il teatro era interessata da una precedente frana. Per isolarlo dai rischi di infiltrazioni di acqua, probabilmente l’edificio fu isolatodalla collina per mezzo di un’intercapedine: PASQUINUCCI 1975, p. 44; LANDOLFI-PROFUMO in LUCENTINI 2002, pp. 85-86.
48 PACI 2002.49 PASQUINUCCI 1975, fig. 63.50 Cfr. PASQUINUCCI 1975, p. 48.51 LANDOLFI-PROFUMO in LUCENTINI 2002, p. 86, fig. 119.52 Più esattamente tra gli ultimi decenni del I secolo a.C. e la prima metà del I d.C.
(PROFUMO 2002). A conforto di questo orizzonte cronologico si pongono anche alcunimattoni bollati: PASQUINUCCI 1975, pp. 47-48; LANDOLFI-PROFUMO in LUCENTINI 2002.
53 Per l’inquadramento storico e per le assegnazioni di terre si rimanda a LAFFI 1975; cfr.anche CAMPAGNOLI-GIORGI 2004, oltre che ai capitoli appositi in questo stesso volume.
54 Vedi, ad es., PACI 1994-95.55 TORELLI 1977; GIORGI 2005.56 Cfr. la breve sintesi di PROFUMO 2002, pp. 81-84.57 Per le prime ricerche si rimanda a PASQUINUCCI 1975, p. 65, nota 197. I nuovi scavi
sono stati effettuati tra il 2011 e l’anno successivo per la realizzazione di unparcheggio previsto dal Comune di Ascoli Piceno, ma non sono ancora conclusi. In generale si veda PASQUINUCCI 1975, pp. 65-71.
58 Con una terminologia mutuata dall’agrimensura, impropria per l’urbanistica anticama ampiamente entrata nell’uso corrente, si tratterebbe del secondo decumano asud di quello massimo. Si veda anche il capitolo sull’urbanistica in questo stessovolume.
59 La vasca rettangolare misura m. 5,70 x 2,80. Per altri dettagli vedi PASQUINUCCI 1975,p. 66.
60 Ibid.61 I muri erano spessi circa mezzo metro, in opera cementizia con le testate in blocchi
di travertino, mentre la parete sud del vano principale era in opera vittata diblocchetti di travertino: PASQUINUCCI 1975, pp. 66-67.
62 Gli scavi più recenti hanno riportato in luce altri frammenti di decorazione parietale,ancora inediti. Si tratta di un insieme di resti di particolare importanza, di cui siattende ancora uno studio esaustivo.
63 PASQUINUCCI 1975, figg. 90-91.64 AMADIO 2000, p. 99; PURCARO 2005, pp. 287-88.65 PASQUINUCCI 1975, figg. 92-93.66 Sintassi degli spazi e articolazione dei percorsi interni che trovano naturalmente
molti paralleli pompeiani: si veda ad es. ANGUISSOLA 2012, pp. 31-47.67 Per la funzione dei cubicula non esclusivamente destinati al sonno e al riposo vedi la
documentazione proposta in CARUCCI 2012.
222
Sandro DE MARIA - Enrico GIORGI
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:49 Pagina 222
68 Cfr. GIORGI 2005, p. 218.69 Cfr. RINALDI TUFI 2005, con bibliografia precedente.70 Su questo ritrovamento: DE MARIA 1993.71 Cfr. PROFUMO 2002, p. 82, fig. 115.72 L’originale viene attribuito a uno scultore bitinio di nome Doidalsas, sulla base di una
controversa menzione, assai corrotta, di Plinio il Vecchio (nat. hist. 36.35). Per una replica famosa dell’età di Adriano (quella del Museo Nazionale Romano inv.108597) vedi O. VASORI in GIULIANO 1979, pp. 141-144 nr. 100.
73 La statua fu rinvenuta da Giulio Gabrielli presso Casa Stipa in via del Gigante,demolita negli anni Trenta del secolo scorso per l’apertura di via Adua, oggi via DinoAngelini. Via del Gigante, ancora visibile nel catasto del 1830, fu poi denominatarua del Crocefisso nel catasto del 1970. Entrambe le strade furono demolite e ogginon sono più esistenti (Archivio Storico Iconografico curato da Emidio Seghetti).Dobbiamo queste informazioni alla cortesia di Michele Massoni.
74 A rigore a questa documentazione andrebbe aggiunta anche la già citata copiadell’Afrodite accovacciata, di cui conosciamo la provenienza ma abbiamo comunqueormai perduto il preciso contesto d’origine.
75 Si riprendono qui, in sintesi, le conclusioni di VIRZì HäGGLUND 1981.76 Ibid. Anche se questa trattazione è limitata ai reperti esposti nel Museo cittadino,
per completezza possiamo ricordare che i resti molto abrasi di un ritratto romanosono stati riutilizzati nella muratura del campanile della chiesa medievale di SantaMaria Inter Vineas, mentre una statua femminile panneggiata si trova nel giardino di una casa privata in via Bonaccorsi nel Palazzo Carfratelli. Attualmente risulta priva della testa, che però è stata riconosciuta da Adele AnnaAmadio, alla quale dobbiamo la cortese informazione, tra le immagini conservatenell'archivio fotografico dell’Istituto Archeologico Germanico di Roma.
77 Occorre anche ricordare, fra i materiali del Museo Archeologico, un’antefissa con Potnia theron (Signora degli animali, divinità femminile ben nota in ambitomediterraneo e largamente diffusa in area italica) da un luogo imprecisato dell’area urbana, che potrebbe riferirsi a un contesto templare, peraltro ignoto,ancora di II sec. a.C.
78 Si veda ad es. PLINIO, nat. hist. 34.17; 35.7 (tabulina codicibus implebantur etmonimentis rerum in magistratu gestarum). La documentazione archeologica più significativa è costituita probabilmente dai fregi “storici” rinvenuti in ambitodomestico a Fregellae: COARELLI 1996 (specialmente pp. 256-257, per le fontiletterarie).
79 Su questa lastra fittile cfr. PROFUMO 2005a, pp. 58-59, con bibliografia precedente.80 Per questa definizione è ovvio il rimando a BIANCHI BANDINELLI 1978.81 MARIOTTI 1913, p. 26 (dove compare un’immagine della scultura con l’inserzione di
una testa non pertinente).82 La lastra è grande 45 x 122 x 10,5 centimetri.83 Cfr. CARDINALI 2005, pp. 54-55.84 Gabrielli prima disegna la statua e ne appunta la provenienza da Maltignano dove
l’aveva visionata (Taccuino 45, 1879, pp. 16-18), poi riferisce della compravenditadal contadino Stefano Marinelli con la ricostruzione della provenienza da Civitella(Taccuino 46, 1880, pp. 18-19). Per una sintesi si veda CONTA 1982, pp. 286-287.
85 Per i siti del territorio si veda il capitolo dedicato a questo tema in questo stessovolume. Per la scultura in questione cfr. anche CONTA 1982, p. 286, fig. 156;LUCENTINI 2002, p. 92, fig. 130.
223
Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana
STORIA DI ASCOLI ok 14 22-04-2014 14:49 Pagina 223
![Page 1: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/27.jpg)
![Page 28: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/28.jpg)
![Page 29: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/31.jpg)
![Page 32: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/32.jpg)
![Page 33: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/34.jpg)
![Page 35: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/35.jpg)
![Page 36: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/36.jpg)
![Page 37: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/37.jpg)
![Page 38: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/38.jpg)
![Page 39: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/39.jpg)
![Page 40: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/40.jpg)
![Page 41: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/41.jpg)
![Page 42: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/42.jpg)
![Page 43: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/43.jpg)
![Page 44: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/44.jpg)
![Page 45: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/45.jpg)
![Page 46: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/46.jpg)
![Page 47: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/47.jpg)
![Page 48: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/48.jpg)
![Page 49: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/49.jpg)
![Page 50: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/50.jpg)
![Page 51: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/51.jpg)
![Page 52: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/52.jpg)
![Page 53: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/53.jpg)
![Page 54: Asculum: cultura architettonica e figurativa di età romana, in G. Paci (a cura di), Storia di Ascoli. Dai Piceni all'epoca romana, Ascoli Piceno 2014, pp. 171-223 [con E. Giorgi]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022308/6320d02c00d668140c0d32b3/html5/thumbnails/54.jpg)