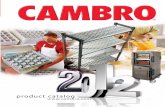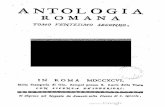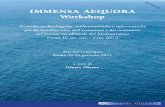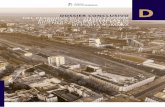L'iconografia di Cibele nella monetazione romana
Transcript of L'iconografia di Cibele nella monetazione romana
Bollettino di Archeologia on line I 2010/ Volume speciale D / D3 / 3 Reg. Tribunale Roma 05.08.2010 n. 330 ISSN 2039 - 0076 www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html
24
Patrizia Calabria, Francesco Di Jorio, Patrizio Pensabene
L’iconografia di Cibele nella monetazione romana
L’iconografia di Cibele sulle monete romane comincia fin dall’epoca repubblicana, su emissioni di bronzo, denari e aurei e testimonia la sempre maggiore importanza assunta dal suo culto nella compagine sociale e politica, oltre che religiosa, dell’epoca. È per questo che nel testo che segue si è tentato di collegare le emissioni monetali alle circostanze storiche che le hanno determinate, in ciò seguendo la traccia, e in parte aggiornandola in base ai nuovi studi, del “pio-neristico” lavoro di Robert Turcan, risalente al 19831, dove il linguaggio epigrafico e iconografico delle monete era proiet-tato al di là della disciplina numismatica per trarne le informa-zioni storiche atte a contribuire alla ricostruzione della storia del culto di Cibele a Roma. Ma nell’affrontare questo lavoro di revisione abbiamo rilevato l’indispensabilità di un contributo specialistico numismatico, perché una nuova lettura delle emissioni monetali già note ha consentito di trarre ulteriori informazioni che precisano ancora di più l’impatto che questa divinità ha avuto nella Roma repubblicana e continua ad avere, sotto forma diversa, in quella imperiale.
Patrizio Pensabene Età repubblicana
Le prime monete, di bronzo che la riguardano fanno parte della serie semilibrale, considerate emissioni romano-campane, battute nel 218-213 a.C. che hanno al D/ una testa femminile con corona turrita e al R/ un giovane cavaliere (fig. 1) e fanno parte di una serie dove appaiono il Sole, Ercole, Venere o Giunone.
1 TURCAN 1983.
Fig. 1 – Bronzi serie romano campana.
XVII International Congress of Classical Archaeology, Roma 22-26 Sept. 2008 Session: Oriental Cults at Rome
Bollettino di Archeologia on line I 2010/ Volume speciale D / D3 / 3 Reg. Tribunale Roma 05.08.2010 n. 330 ISSN 2039 - 0076 www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html
25
La testa femminile con corona turrita al D/ ricorda l’iconografia monetale delle città dell’Asia Minore dove la Tyche campeggia sul dritto delle emissioni locali. Ma nel caso di una emissione di bronzo, adatta a una circolazione limitata ed emessa sotto l’autorità di Roma, l’immagine di una testa femminile turrita non può essere automaticamente riconosciuta come Thyche. Non potendosi ritenere la personificazione della città che conia, in quanto è Roma l’autorità emittente che ha già una sua tipologia, si propone invece di riprendere l’ipotesi di Mattingly e Alföldi, riconoscendo nella testa la Grande Madre Cibele, identificazione invece negata da Turcan2. Infatti Cibele è divinità salutaris, cioè protettrice della fondazione e conservazione di Roma e questo spiega perché la sua testa è ornata come una Tyche. Inoltre si può pensare che l’iconografia della testa della dea si identifichi con quella della Tyche di Pessinunte, città dove sorgeva il maggior tempio del culto metroaco e dove già poteva esserne avvenuta l’assimilazione. Se apparentemente non vi è connessione con il giovane cavaliere in corsa sul R/, in realtà recenti studi hanno evidenziato come il desultor rappresenti la trasmissione del potere dal dictator al magister equitum3: si coglie, dunque, un collegamento con la divinità salutaris e la continuità del potere di Roma.
Ancora, le emissioni considerate romano-campane sono ritenute monete di imitazione, necessarie per essere accettate nei mercati limitrofi: a nord dagli Etruschi, popolo fondatore di città caratterizzate da numerose torri, a sud dalle colonie greche dell’Italia Meridionale, dove il rovescio con il tipo del cavallo e il cavaliere erano una costante. Questo confermerebbe la polivalenza che il cavaliere ha nella monetazione dell’epoca, che andrebbe di volta in volta decodificato.
Ora, da quanto detto e se è vero che la testa di Cibele turrita compare nelle emissioni del 218-213, ci troveremmo circa dieci anni prima rispetto all’introduzione ufficiale del culto a Roma, che avvenne nel 204 a.C., in seguito alle alterne vicende relative alla prima fase della seconda guerra punica (è nota la prospettiva di vittoria sui Cartaginesi, associata all’arrivo di Cibele a Roma, secondo il responso dei Libri Sibyllini riportato da Tito Livio4). Questa differenza di anni è stata utilizzata da Turcan per negare l’identificazione con Cibele, ma, al contrario, essa non stupisce perché ci aiuta a capire il clima politico in cui fu poi interpretato il prodigio che dette origine all’introduzione del culto e riflette in realtà un momento della propaganda romana sui miti di fondazione della città connessi alle leggende troiane5 (v. supra il contributo di P. Pensabene), che evidentemente precede la data ufficiale dell’insediarsi sul Palatino del tempio della Magna Mater.
Passa quindi in seconda linea il fatto che non ci siano giunte monete che ricordino l’arrivo della pietra nera aniconica, il 9 aprile del 204 a.C., o la fondazione del tempio di Cibele sul Palatino, nel 191 a.C.6, perché la divinità faceva già parte del pantheon romano.
Sempre da Livio sappiamo che uno dei censori che dette inizio alla costruzione dell’aedem Matris Magnae fu C. Claudius, esponente della gens Claudia7, insieme al collega M. Livius. In attesa del completa-
2 TURCAN 1983, 5–6. 3 Cf. CACCAMO CALTABIANO ET AL. 2004, 17–45 per tutta la problematica. 4 Liv., Hist., 29, 10, 4-7. Secondo quanto prescritto dai libri Sibillini e dalle ripetute consultazioni dell’oracolo delfico: Liv., Hist., 22, 57, 5-6 ; 29, 10, 4-7; 11, 2-5, 7-8; 14, 2-9; Val. Max., Fact. mem., 8, 15, 3; Plut., Fab. Max., 18, 3; Appian., Bell. Hann., 27, 116; 56, 233. Dell’ambasceria inviata presso re Attalo I di Pergamo per ottenerne la consegna faceva parte anche M. Cecilio Metello, pretore nel 206 a.C. 5 Il culto è connesso con i miti di fondazione di Roma perché Enea discende da Dardano, capostipite della dinastia troiana: Hom. Il., XX, 216. Questi veniva dall’isola di Samotracia (diversamente in Verg., Aen., III, 94 ss., 154 ss.; VII, 195-242; VIII, 596 ss., IX, 9 ss., Dardano giunge a Samotracia provenendo dalla città etrusca di Corito), dove si trova il Santuario dei Grandi Dei (da cui provengono la dea alata, Nike; i Cabiri, mitici fondatori dell’isola; e la Grande Madre, divinità femminile): cf. Enciclopedia dell’arte antica classica e orientale, VI, s.v. Samotracia, 1102-7. Cibele, dea “nazionale” frigia (Phrygia mater), è legata ai monti Cibelo, Ida, Dindimo, Berecyntus - tutti in Frigia (esiste anche il monte Ida, a Creta) - e dai quali derivano anche i vari appellativi con cui è conosciuta la divinità. Cf. PENSABENE 2004, 84–86. 6 Cf. VERMASEREN 1977, 45, n. 218 per il trasporto della statua da Pessinunte a Roma, nel 204 a.C., e per l’altare con dedica conservato ai Musei Capitolini cf. ZEVI 1997, 435–71; la rappresentazione di Cibele sulla nave si ritrova anche su delle terrecotte conservate al Museo Nazionale Romano, cf. PENSABENE ET AL. 1983, 310–12, cxliii-cxliv. Il nome con il quale la dea era ufficialmente venerata a Roma è: Magna Mater Deum Idaea: cf. ARRIGONI 1982, 7–68, in part. 46, n. 61. 7 LIV., Hist., 29, 37, 1-2. Emerge la stretta relazione che intercorre tra la gens dei Claudii e l’introduzione del culto della Magna Mater a Roma: anche la vestale Claudia Quinta (supra N. 6) apparteneva a questa gens.
P. Calabria, F. Di Jorio, P. Pensabene – L’iconografia di Cibele nella monetazione romana
Bollettino di Archeologia on line I 2010/ Volume speciale D / D3 / 3 Reg. Tribunale Roma 05.08.2010 n. 330 ISSN 2039 - 0076 www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html
26
Fig. 2 – Denario di Cecilio Metello Scipione Pio. mento dell’opera la statua fu ospitata nel vicino tempio della Vittoria e tale vicinanza rappresenta anche simbolicamente il rapporto tra Cibele protettrice di Roma e la Vittoria che ne accompagna il destino8 e che spiega la copresenza delle due divinità in emissioni monetali repubblicane, come in quelle di C. Fabius Hadrianus (v. infra).
In seguito, nel 111 a.C., un vasto incendio distrusse il tempio di Cibele sul Palatino9, e la ricostruzione si deve all’opera di Q. Metello Numidico10. A questo avvenimento è legata l’emissione d’argento, battuta a Roma, sulla quale al D/ è raffigurata una testa femminile turrita volta a d., fra spiga di grano e caduceo: in tale tipologia è possibile riconoscere Cibele, nell’accezione di divinità salutaris, cioè, come si è detto, protettrice della fondazione e conservazione di Roma11; sul R/ compare un trofeo tra lituus e sitella (o urceus) (fig. 2). Si tratta dei denarii12 coniati nel 47 a.C. da Q. Cecilio Metello Pio Scipione13: l’immagine del R/ ricorda con i simboli l’augurato del 100 a.C. di Metello Numidico14, e quindi si rifà alla commemorazione da parte di Metello Scipione, responsabile dell’emissione, della ricostruzione del tempio a opera del nonno adottivo: ricordandola aveva l’opportunità di tramandare ai posteri le imprese della sua famiglia e collegare così il suo ricordo al destino dell’Urbe15.
Le prime emissioni vere e proprie sono due denarii del 102 a.C.16 emessi sotto l’autorità di C. Fabius riconosciuto con il C. Fabius Hadrianus, pretore dell’84 a.C., governatore dell’Africa e seguace di Mario17:
8 TURCAN 1983, 8. 9 Obseq., 39; Val. Max., Fact. Mem., 1, 8, 11; Tac., Ann., 4, 64, 3. 10 Ov., Fast., 4, 347-348: templi non persistit auctor: Augustus nunc est, ante Metellus erat. È anche probabile che il Metello più famoso al tempo di Ovidio fosse il Numidico, di modo che la semplice menzione del gentilizio ne avrebbe evocato il ricordo presso il pubblico. Cecilio Metello Numidico apparteneva alla famiglia più potente della nobilitas plebea dell’epoca: tra il 123 e il 109 a.C. sei di loro ricoprirono il consolato, tra il 120 e il 102 a.C. quattro la censura, e da ultimo Q. Cecilio Metello Pio, figlio del Numidico e cugino di C. Mario, che rivesti la carica di pontifex maximus, conferitagli da Silla nell’83 a.C. 11 LAMBRECHTS 1951, 44–60; diversamente BOYANCÉ 1954, 337–42; ALTERI 1990, 103, n. 485. 12 SYDENHAM 1952, 1049; CRAWFORD 1983, 460/3; inoltre cf. BABELON 1885-1886, 1: 280, n. 52; BABELON 1885-1886, 2: 135, n. 22; GRÜBER 1910, 572, n. 6; CRAWFORD 1969, xiv. 13 MORGAN 1973, 215–45, non è d’accordo con questa impostazione. 14 ROSS TAYLOR 1944, 352–56 ; cf. BADIAN 1968, 26–46. 15 Per tutta la problematica relativa cf. D’ALESSIO in preparazione. Si ringrazia il dott. A. D’Alessio per avermi comunicato i risultati della sua ricerca prima della loro definitiva pubblicazione. 16 SYDENHAM 1952, 589–590; CRAWFORD 1983, 322/1a, 1b: le datazioni delle monete, dove non diversamente specificato, sono riprese da CRAWFORD 1983. 17 TURCAN 1983, 6.
XVII International Congress of Classical Archaeology, Roma 22-26 Sept. 2008 Session: Oriental Cults at Rome
Bollettino di Archeologia on line I 2010/ Volume speciale D / D3 / 3 Reg. Tribunale Roma 05.08.2010 n. 330 ISSN 2039 - 0076 www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html
27
essi riportano al D/ la testa di Cibele volta a d., velata e turrita, identificata come la Tyche della città di Pessinunte, sede del tempio più importante della Magna Mater18. Dietro, la leggenda EX A PV, sot-tolinea che l’argento utilizzato per questa emis-sione è pubblico, non proviene dalle fonti abituali di approvvigionamento e da questo si l’eccezionalità dell’emissione, fatta coniare da un questore; al R/ la Vittoria che guida la biga, verso d., sotto i cavalli un marchio di controllo, davanti una cicogna o tram-poliere. In esergo C. FABI. C. F. Il trampoliere o la cicogna sono forse un richiamo alla Pietas19 (fig. 3).
Si tratta di un’emissione che propaganda la forza della città e la sua vittoria. La comparsa del tipo di Cibele al D/ e la Vittoria al R/ sui questi denarii ricorda che Mario, eletto console nel 104 a.C., sconfisse prima i Teutoni nel 102 a.C. ad Aquae Sextiae e successivamente, nel 101 a.C., i Cimbri ai Campi Raudii, presso Vercellae, liberando così l’Italia e Roma20 dalla loro invasione.
Vi sono altre serie di denarii, non legati ai magistrati monetali, bensì agli ediles curules, pre-posti all’organizzazione, con autorizzazione del Se-nato, dei Ludi Megalenses21, celebrati dal 4 al 10 aprile per l’anniversario dell’arrivo della pietra aniconica di Cibele con l’inaugurazione del tempio, il 10 aprile del 191 a.C.
I denari degli edili Furius Crassipes22, 84 a.C. e M. Volteius23, del 78 a.C. ricordano questo evento, con la differenza che le emissioni di Volteius non hanno alcun riferimento, al R/, alla
carica da lui ricoperta. Questo sta a significare, da parte del magistrato, la volontà di voler celebrare il culto della dea eliminando ogni riferimento personale (fig. 4). Per l’iconografia, nei denari di Volteius abbiamo al D/ la testa di Cibele volta a d. con l’elmo frigio laureato, è la prima volta che sulle monete Cibele
18 Da ultimo cf. PENSABENE 2004, 83–137. 19 La leggenda EX A(rgento) PV(blico) sul D/ di alcuni di questi denarii, oltre ad alludere al fatto che si trattò di un’emissione straordinaria, potrebbe anche indicare che C. Fabius Hadrianus, era stato edile curule, come si riscontra nel caso delle successive coniazioni, sempre con l’effige della Magna Mater, come anche nei casi di P. Furius Crassipes, M. Pletorius Cestianus e A. Plautius: cf. ALTERI 1990, 79–81, nn. 398-401 (con bibl.). La cicogna (?) presente sul rovescio dei denarii può simboleggiare quella pietas…ciconia…pietaticultrix, come riportato in Petr., Sat., 55, 5-6., che Mario e il suo gruppo vantavano a garanzia della vittoria sugli invasori germani e in diretto rapporto con il culto della Magna Mater: cfr. TURCAN 1983, 6–9, ii, 1–3. Proprio la presenza della cicogna fa supporre la probabile appartenenza di C. Fabius Hadrianus allo schieramento di Mario. 20 CÀSSOLA 1985, 172–74. La vittoria di Mario era stata in un certo senso annunciata dal gran sacerdote di Cibele, Battakes, presente a Roma, ed è da mettere in relazione con il successivo viaggio di Mario in Asia Minore, nel 98-97 a.C., per compiere i sacrifici votati appunto alla Magna Mater dopo le vittorie militari. Impressionato dalla profezia il Senato decise di far costruire un naòs epiníkios in onore di Cibele: cfr. Plut., Mar., 17, 9. 21 È nota del resto l’attenzione degli edili curuli verso il culto di Cibele e la consuetudine di organizzare e presiedere i Ludi Megalenses in onore della dea: Liv., Hist., 34, 54, 3; Dion. Cass., 37, 8; Cic., De Har. resp., 5, 11-16; 13, 28-29: Cicerone mette in risalto come i giochi fossero stati da subito assimilati nella tradizione romana, nonostante il nome non certamente latino. 22 SYDENHAM 1952, 735, 735 a-b; CRAWFORD 1983, 356/1 a-d. 23 SYDENHAM 1952, 777; CRAWFORD 1983, 385/4.
Fig. 3 – Denarii di C. Fabius Hadrianus.
P. Calabria, F. Di Jorio, P. Pensabene – L’iconografia di Cibele nella monetazione romana
Bollettino di Archeologia on line I 2010/ Volume speciale D / D3 / 3 Reg. Tribunale Roma 05.08.2010 n. 330 ISSN 2039 - 0076 www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html
28
non è turrita ma porta l’elmo che la riconduce alla sua terra di origine; al R/ la dea guida il carro trainato da due leoni, verso d. (fig. 5)24.
I denari25 di Plaetorius Cestianus, datati al 67 a.C., hanno al D/ la testa di Cibele volta a d., con corona turrita; al R/ la sella curulis che si riferisce appunto alla carica ricoperta. Nelle emissioni di Cestianus la sfera davanti a Cibele ricorda la vittoria di Gn. Pompeo sui pirati in Cilicia, conseguita nel 67 a.C.26 (fig. 6).
Sempre nel contesto storico legato a Pompeo sono da riferire i denari27 dell’edile A. Plautius, emessi nel 55 a.C. Al D/ testa turrita di Cibele volta a d.; R/ un cammello rivolto a d. e un personaggio in ginocchio volto a d. che tiene nella mano d. un ramo d’olivo. All’esterno la leggenda IVDAEVS, in esergo BACCHIVS (fig. 7). Siamo sempre nell’ambito della celebrazione di Cibele e si può ipotizzare o una distribuzione straordinaria di grano organizzata da Pompeo, oppure, come ritenne il duca H. De Luynes (1802-1867) riportato da Turcan28, la leggenda è la traduzione in latino di un non meglio noto Aristobulo, gran sacerdote giudeo di una tribù nomade, che implora clemenza a Pompeo. Il riferimento è di nuovo legato alla vittoria e affermazione della potenza romana.
24 Anche dal confronto con la base di Sorrento, cf. Gérard 1980, 162, n. 1, l’iconografia di Cibele ricorda i versi di Lucrezio (Lucr., Rer. nat., 2, 601): sedibus in curru biiugos agitare leones. 25 SYDENHAM 1952, 808; CRAWFORD 1983, 409/2. 26 Cf. CÀSSOLA 1985, 222. 27 SYDENHAM 1952, 932; CRAWFORD 1983, 431/1. 28 DE LUYNES 1858, 384; TURCAN 1983, 12.
Fig. 4 – Denarii di C. Furius Crassipes. Fig. 5 – Denarii di M. Volteius.
XVII International Congress of Classical Archaeology, Roma 22-26 Sept. 2008 Session: Oriental Cults at Rome
Bollettino di Archeologia on line I 2010/ Volume speciale D / D3 / 3 Reg. Tribunale Roma 05.08.2010 n. 330 ISSN 2039 - 0076 www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html
29
Fig. 6 – Denarii di Plaetoruis Cestianus. Fig. 7 – Denarii di A. Plautius.
La tipologia degli aurei29, molto rari, emessi da L. Cestius e C. Norbanus, del 43 a.C., presenta al D/
testa femminile volta a d., con acconciatura molto complessa. In alto leggenda C NORBANVS, in basso, L CESTIVS, nel campo a d., P R. Al R/ Cibele che guida la biga trainata da due leoni, a s. e tiene il timpano e la patera (fig. 8). La figura femminile al D/ potrebbe essere interpretata sia come la Sibilla che Venere30. Tutto riferito probabilmente alla propaganda cesariana: infatti la Sibilla o Venere, secondo Dione Cassio31, sono legate alla Grande Madre che protegge la città dalle origini troiane, come Venere protegge i discendenti di Enea, i Giuli32.
Le emissioni di aurei e denarii33 di C. Clodius Vestalis, del 41 a.C., che hanno sul D/ una testa femminile, Flora, sul R/ una figura femminile seduta con leggenda VESTALIS (fig. 9), identificata con la statua esposta nell’atrio del tempio della Magna Mater, sono ritenute da molti come tipi legati a Cibele34;
29 SYDENHAM 1952, 1155; CRAWFORD 1983, 491/2. 30 TURCAN 1983, 15 e bibl. citata. 31 Dio Cass., XLVII, 35, 2-3; 36, 2-3. 32 Anche Virgilio, Aen., 6, 781-787; 10, 251-255, celebra la dea frigia e in particolare troiana: infatti la stretta connessione di Cibele con Enea, la sua famiglia, la città di Troia e la lode di Roma e della dea fatta da Anchise, e la successiva preghiera alla Mater Idaea costituiscono un complemento della politica estera romana, ma anche di quella religiosa. 33 SYDENHAM 1952, 1134, 1135; CRAWFORD 1983, 512/1-2; TURCAN 1983, 16–17. 34 TURCAN 1983, 16.
P. Calabria, F. Di Jorio, P. Pensabene – L’iconografia di Cibele nella monetazione romana
Bollettino di Archeologia on line I 2010/ Volume speciale D / D3 / 3 Reg. Tribunale Roma 05.08.2010 n. 330 ISSN 2039 - 0076 www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html
30
Fig. 8 – Aurei di Cestius e Norbanus. Fig. 9 – Aurei e denarii di C. Clodius Vestalis. potrebbe essere che questo sia stato solo il modello adottato dell’incisore monetale, perché non ne conosciamo altri. Tuttavia non si può escludere che queste facciano parte delle emissioni in onore dell’inizio della celebrazione dei Floralia, che si svolgevano appunto dopo i Ludi Megalenses, dal 28/30 aprile fino al 3 maggio: sono quindi parte di quelle emissioni “pubblicitarie” che i magistrati facevano coniare per ricordare i giochi da loro organizzati.
Riassumendo i dati che fin presentati che esauriscono la parte delle coniazioni di età repubblicana, dove è stata standardizzata l’iconografia di Cibele, rileviamo come uno dei principali risultati è l’aver potuto ribadire che l’emissione dove compare per la prima volta l’immagine della dea turrita è su monete di bronzo e risale a pochi anni prima della fondazione ufficiale del culto di Cibele sul Palatino; si continua ad avere la medesima iconografia del dritto per quelle d’argento, mentre solo su un denario di Volteius compare l’elmo frigio a ribadire l’”ambito territoriale” della divinità.
Sugli aurei le immagini di Cibele non rispondono a un preciso programma tipologico: data l’eccezionalità delle emissioni, spesso i magistrati erano diversi da quelli monetali.
L’immagine femminile turrita sul dritto è sempre utilizzata a sottolineare la potenza di Roma e le sue vittorie, con una valenza ben augurante, mentre le immagini del rovescio sono la spiegazione di un evento
XVII International Congress of Classical Archaeology, Roma 22-26 Sept. 2008 Session: Oriental Cults at Rome
Bollettino di Archeologia on line I 2010/ Volume speciale D / D3 / 3 Reg. Tribunale Roma 05.08.2010 n. 330 ISSN 2039 - 0076 www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html
31
fortunato. Questa “propaganda” è utilizzata da diverse fazioni politiche, come ad esempio emerge dagli avvenimenti occorsi durante la permanenza di Battakes a Roma.
Tuttavia è stato rilevato come da un punto di vista statistico la Magna Mater non sia tra le divinità più ricorrenti35, ed è per questo che la sua presenza risalta e ne ha permesso il collegamento con precisi avvenimenti storici oppure in chiave di esaltazione della fama degli edili che organizzavano i Ludi Megalensi.
Patrizia Calabria
Fig. 10 – Denario di Domiziano. Età imperiale
A partire da Augusto il culto diventa ufficiale e pubblico, e la dea viene inserita tra le divinità tutelari
della casa imperiale. Lo stesso imperatore fece ricostruire il tempio36, dopo un incendio nel 3 d.C. Tuttavia il tipo con Cibele non è presente sulla sua monetazione, né apparentemente in quella del periodo giulio-claudio, nonostante il fatto che l’imperatore Claudio ebbe un grande ruolo nella riorganizzazione del culto sul Palatino, in quanto ne ampliò il santuario e istituì le nuove festività degli Hilaria, che presto, dato il grande favore popolare, presero il sopravvento sulle più tradizionali festività di primavera legate all’anniversario dell’introduzione del culto metroaco. L’assenza di Cibele sulle monete sembra continuare anche sotto i Flavi. Tuttavia su un denario37 di Domiziano, datato tra l’88 e il 96 d.C., compare al D/ DOMITIANVS AVG GERM, testa dell’imperatore volta a d., mentre al R/ IMP CAES e una sorta di propileo tetrastilo, con portale tra le colonne al centro, in cui si distingue una divinità femminile stante con animali ai lati; inoltre il tetrastilo è sormontato da una trabeazione orizzontale sopra la quale vi è un’altra divinità femminile seduta su un leone (fig. 10). Mattingly ha pensato di riconoscere un tempio tetrastilo con all’interno Cibele stante con due leoni ai lati e con Cibele seduta su un leone, sul fastigio del tempio. L’ipotesi è negata da Turcan38 che non riconosce la Magna Mater, in quanto dalle fonti antiche non si hanno testimonianze di una ricostruzione del tempio da parte di Domiziano, mentre invece propone di riconoscervi una Iside con sistro in mano, nel portale; mentre una figura di Iside-Sothis nella divinità cavalcante il leone, in alto. Si può tuttavia attenuare la critica di Turcan, ricordando che proprio in età domizianea è menzionata, da Marziale, una tholus di Cibele
35 TURCAN 1983, 65. 36 Res gestae, 19, 2: aedem Matris Magnae in Palatio feci. 37 MATTINGLY ET AL. 1926, 2: n. 205. 38 TURCAN 1983, 25.
P. Calabria, F. Di Jorio, P. Pensabene – L’iconografia di Cibele nella monetazione romana
Bollettino di Archeologia on line I 2010/ Volume speciale D / D3 / 3 Reg. Tribunale Roma 05.08.2010 n. 330 ISSN 2039 - 0076 www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html
32
Fig. 11 – Rilievo degli Haterii.
sul Palatino39, che non corrisponde al grande Tempio della Magna Mater. Inoltre nel rilievo degli Haterii40 (fig. 11), della fine del I sec. d.C., com-pare una Cibele su trono, al-l’interno di un arco e se, come si è affermato, gli edifici ri-prodotti nei rilievi sono quelli appaltati dagli Haterii, si a-vrebbe un indizio di una qual-
che attività edilizia connessa con un luogo di culto di Cibele. La dea, seppure come un elemento accessorio, ricompare su se-
sterzi di Traiano, datati al 103 d.C., che ricordano interventi edilizi nel Circo Massimo. Su queste emissioni abbiamo al D/ IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC PM TR P COS V PP, busto laureato dell’imperatore volto a d.; sul R/ S P.Q.R. OPTIMO PRINCIPI, ed è rappresentato il Circo Massimo con le metae e l’obelisco al centro; in esergo S C41 (fig. 12). Sulla spina del circo è possibile riconoscere la figura di Cibele su un leone: tuttavia ancora non si è certi se il gruppo scultoreo già esistesse in precedenza oppure facesse parte del programma ricostruttivo e di ampliamento promosso dal-l’imperatore. Nel caso specifico tali emissioni mettono in risalto la mu-nificenza e liberalità di Traiano. Da questo momento Cibele scompare dalle
monete propriamente dette, per ritornare a essere rappresentata come, ha rilevato a suo tempo anche Turcan42, solo dopo la morte di Faustina Maggiore (141 d.C.).
In seguito Cibele ricompare, ma solo su alcuni medaglioni43 di Adriano e Sabina. La troviamo raffigurata con i consueti attributi come la corona turrita, il tympanum, lo scettro, ramo d’olivo e l’albero con i cymbala. Con Adriano compare il tipo con al D/ il busto dell’imperatore a d., con leggenda ADRIANVS AVGVSTVS, al R/ Cibele velata che guida una quadriga trainata da quattro leoni, volta a d.; un altro presenta all’esergo COS III: questo si data al 120 d.C., anno in cui l’imperatore ricoprì il terzo consolato44
39 Mart., Epigr., I, 70, 1-13: […]inde sacro veneranda petes Palatia clivo[…]et Cybeles picto stat Corybante tholus. 40 L’arco, probabilmente di Domiziano, riporta sull’attico l’epigrafe arcus in sacra via summa, mentre, vista attraverso il fornice, si trova una piccola tholos con la dea seduta tra due leoni. Cf. CASTAGNOLI 1941, 60, tav. iii; per gli ultimi studi cf. PENSABENE 2008, 29. 41 MATTINGLY ET AL. 1926, 2: n. 571. 42 TURCAN 1983, 24–25. 43 TOYNBEE 1986, 142. 44 COHEN 1880-1892, n. 284; GNECCHI 1912, 2: 3, n. 5; 1912, 3: 16, n. 60.
Fig. 12 – Sesterzio di Traiano.
Fig. 13 – Medaglione di Adriano.
XVII International Congress of Classical Archaeology, Roma 22-26 Sept. 2008 Session: Oriental Cults at Rome
Bollettino di Archeologia on line I 2010/ Volume speciale D / D3 / 3 Reg. Tribunale Roma 05.08.2010 n. 330 ISSN 2039 - 0076 www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html
33
(fig. 13). Nei tipi per Vibia Sabina45 (85-138 d.C.) al D/ il busto dell’imperatrice laureato e drappeggiato, volto a d., con leggenda SABINA AVGVSTA; al R/ la dea è rappresentata con la testa turrita e seduta, secondo il tipo amazzonico, su un leone volto a d. (fig. 14). Tuttavia Turcan mette il rilievo come la raffigurazione di Cibele su questo medaglione sia simile al gruppo scultoreo che si già trovava sulla spina del Circo Massimo, e ipotizza di datare il medaglione al 139 d.C., quando – in un clima più favorevole ad
Adriano e Sabina – proprio Antonino Pio decretò l’apoteosi per la coppia imperiale, durante lo svolgimento dei Ludi Megalenses46. Infatti nella pompa circensis le immagini degli imperatori divinizzati e dei membri defunti della casa imperiale sfilavano dietro il ferculum sul quale era trasportata la dea. Inoltre esistono anche cistofori emessi da zecche orientali con la medesima iconografia del medaglione esaminato47 (fig. 00).
In età antonina, in un clima di rievocazione delle antiche leggende legate alla fondazione della città e dei culti arcaici, la Magna Mater e Attis ebbero un nuovo impulso sulla rappresentazione monetale, evidentemente su direttive che provenivano proprio dello stesso Antonino Pio e dalla moglie Faustina (105-141 d.C.). Dopo la morte di quest’ultima e la sua conseguente apoteosi, sulla monetazione propriamente detta ritroviamo il tipo con Cibele. Le raffigurazioni della dea sono molteplici, per questo motivo si ritiene opportuno dividere tra le monete vere e proprie, i medaglioni e contorniati. Per quanto concerne la rappresentazione dell’augusta sui sesterzi, abbiamo al D/ le leggende48 DIVA FAVSTINA oppure DIVA AVGVSTA FAVSTINA, con la testa dell’imperatrice velata volta a d. e il busto drappeggiato; mentre al R/ le leggende sono AETERNITAS49, AVGVSTA o MATRI DEVM SALVTARI50, ed è raffigurata Cibele con corona
45 COHEN 1880-1892, n. 88; GNECCHI 1912, 2: 9, n. 1. 46 Il problema è affrontato in TURCAN 1983, 25–26. 47 MATTINGLY ET AL. 1926, 2: n. 463, 488, 533. 48 MATTINGLY ET AL. 1930, 3: n. 1123, n. 1150; COHEN 1880-1892, 2: 422, n. 126; 434, n. 267. 49 MATTINGLY ET AL. 1930, 3: n. 1114; p. 167, n. 1167; COHEN 1880-1892, 2: 417, nn. 55-56.
Fig. 14 – Medaglione di Vibia Sabina.
Fig. 15 – Sesterzii di Faustina Madre.
P. Calabria, F. Di Jorio, P. Pensabene – L’iconografia di Cibele nella monetazione romana
Bollettino di Archeologia on line I 2010/ Volume speciale D / D3 / 3 Reg. Tribunale Roma 05.08.2010 n. 330 ISSN 2039 - 0076 www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html
34
turrita, seduta su una biga, che tiene nelle mani gli strumenti del culto; ai suoi piedi seduti, due leoni, ma in altri casi è raffigurata anche senza gli animali (fig. 15). Le prime due leggende del rovescio alludono alla divinizzazione dell’imperatrice (v. infra), mentre l’ultima mette in risalto il ruolo di madre di tutti gli imperatori e i membri della famiglia imperiale divinizzati, in quanto Cibele stessa è anche madre degli dei (matri deum), e poi si sottolinea la protezione (salutari) nei confronti di Roma e della casa imperiale51.
Per i medaglioni uno, datato al 141 d.C., subito dopo la morte dell’imperatrice, ha al D/ la leggenda FAVSTINA AVG ANTONII PII P P, con il busto drappeggiato e volto a d., mentre al R/ Cibele turrita seduta su un leone che corre verso d52. (fig. 16). Turcan pensa di riconoscere in esso una sorta di allusione ai futuri onori divini che le verranno concessi53. Gli altri medaglioni presentano al D/ le leggende DIVA FAVSTINA o DIVA AVGVSTA FAVSTINA, con la testa dell’imperatrice velata volta a d. e il busto drappeggiato; al R/ le rappresentazioni della dea sono molteplici: Cibele turrita che tiene uno scettro, seduta su un leone che avanza verso s., con dietro il pino e gli strumenti del culto (fig. 17); frontale tra due leoni insieme ad Attis, mentre tiene in mano il sistro invece del timpano (fig. 18); l’arrivo della nave con la statua della Magna Mater (fig. 19); rappresentazione del corteo metroaco54 con sullo sfondo il tempio di Vesta, e sul carro Antonio Pio e Faustina (fig. 20).………………………………………………………………………………………………………
50 MATTINGLY ET AL. 1930, 3: 1145; COHEN 1880-1892, 2, 431, nn. 229-230. 51 TURCAN 1983, 27–30. 52 COHEN 1880-1892, 2: nn. 304-305; GNECCHI 1912, 2: 25, nn. 10-11; GNECCHI 1912, 3: 31, n. 34. 53 TURCAN 1983, 27. 54 Rappresentazione simile sul coperchio di un sarcofago conservato nel chiostro della basilica di San Lorenzo f.l.m., a Roma. La scena è suddivisa in due parti: da sinistra si riconosce un carro trainato da elefanti, ma a causa di una lacuna non si può capire cosa fosse trasportato; davanti al carro due personaggi togati, presumibilmente magistrati, e più oltre due fercula, portati a spalla da otto uomini
Fig. 16 – Medaglione Faustina Madre. Fig. 17 – Medaglione Faustina Madre. Fig. 18 – Medaglione Faustina Madre.
XVII International Congress of Classical Archaeology, Roma 22-26 Sept. 2008 Session: Oriental Cults at Rome
Bollettino di Archeologia on line I 2010/ Volume speciale D / D3 / 3 Reg. Tribunale Roma 05.08.2010 n. 330 ISSN 2039 - 0076 www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html
35
Un altro medaglione55 forse riferibile ad Antonio Pio, datato al 158 d.C., presenta al D/ ANTONINVS AVG PIVS PP IMP, II testa e busto nudo dell’imperatore, volto a d.; una complessa icono-grafia al R/ TRIB POT XXI COS IIII,
Roma con la testa elmata, volta a s., seduta su una roccia e con dietro un pino (?), una figura maschile stante volta a d., in abiti militari che tiene una lancia nella mano d. (forse l’imperatore); e dietro due figure: una femminile velata che tiene in mano offerte rituali e strumenti di culto, e un’altra – di dimensioni più piccole. (fig. 21). L’unica interpretazione che, a nostro parere, rimane convincente è quella proposta da Graillot, dove si riconosce nelle due figure Cibele e Attis, ipotesi invece rifiutata da Turcan56.
Durante il regno di Marco Aurelio il culto della Magna Mater continuò ad affermarsi come in epoca precedente, con la differenza che sui sesterzi, denarii e aurei57, datati tra il 171 e il 176 d.C. emessi per la moglie Faustina Minore (125/130?-175 d.C.) sul R/, il tipo di Cibele è sempre lo stesso: con la corona turrita, i due leoni ai lati e gli strumenti del culto. La leggenda del R/ MATRI MAGNAE (fig. 22 a, b). La novità, rispetto all’epoca precedente, sta nel fatto che tutte le emissioni si riferiscono a Faustina ancora in vita. Stessa considerazione e medesima tipologia si ritrova anche sui sesterzi e medaglioni58 di Lucilla (149-182 d.C.), figlia di Marco Aurelio e moglie di Lucio Vero. Al R/ la leggenda MATRI MAGNAE (fig. 23).
Riassumendo, dunque, i dati fin qui raccolti per Sabina e Faustina Maggiore, possiamo notare, come in precedenza rilevato anche da Turcan, che le monete e medaglioni celebrano non solo il culto metrocao,
ciascuno, che avanzano al suono della tuba. Sul primo è trasportata una statua della Vittoria, sull’altro Cibele preceduta da due leoni. Il sarcofago è datato al IV sec. d.C. ca.: cf. KOCH-SICHTERMANN 1982, 115, fig. 131. Cf. TURCAN 1983, 28. 55 COHEN 1880-1892, 2: 150, n. 1029. 56 GRAILLOT 1912, 152; TURCAN 1983, 32–34. 57 MATTINGLY ET AL. 1930, 3: nn. 704-706; nn. 1663, 1664; COHEN 1880-1892, 3: 150, nn. 169-172. 58 MATTINGLY ET AL. 1930, 3: nn. 1753, 1754; COHEN 1880-1892, 3: 218–219, nn. 47, 48.
Fig. 19 – Medaglione Faustina Madre. Fig. 20 – Medaglione Faustina Madre.
Fig. 21 – Medaglione Antonino Pio.
P. Calabria, F. Di Jorio, P. Pensabene – L’iconografia di Cibele nella monetazione romana
Bollettino di Archeologia on line I 2010/ Volume speciale D / D3 / 3 Reg. Tribunale Roma 05.08.2010 n. 330 ISSN 2039 - 0076 www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html
36
ma sono strettamente connessi al rito di “consacrazione” riservato alle imperatrici divinizzate o che lo saranno in seguito. L’indizio è dato dalla presenza, nella leggenda del dritto, del titolo DIVA, e si assiste di fatto anche a una sorta di analogia o parallelismo tra la dea e le auguste.
Sulle sporadiche emissioni di Commodo59, datate al 191-192 d.C., abbiamo al R/ Cibele che indossa il polos, seduta frontalmente e che cavalca un leone che corre verso d. Al R/ la leggenda MATRI DEVM (oppure DEV) CONSERV AVG (fig. 24). In realtà l’epiclesi non ha nulla di soteriologico, ma si riferisce a Cibele considerata come protettrice dell’im-peratore (conservator Augusti), dopo i diversi attentati dai quali Commodo era sopravvissuto60. Assistiamo però a un altro cambiamento: non riscontriamo nelle monete l’asso-ciazione – come rilevato in precedenza – tra Cibele e la mo-glie dell’imperatore, Bruttia Crispina (161-187 d.C.).
Concluso il periodo degli antonini, l’unico sesterzio61 non attribuibile con certezza a Pertinace, presenta al R/ Cibele frontale, stante, con la corona turrita sul capo, che sacrifica davanti a un altare, a d. un fanciullo con le braccia alzate seduto su un globo, con leggenda DIS GENITORIBVS, nel campo SC (fig. 25). L’interpretazione di questa emissione sporadica è comunque problematica e non aggiunge nulla di nuovo alle conoscenze fin qui acquisite62. 59 MATTINGLY ET AL. 1930, 3: n. 258; n. 599; COHEN 1880-1892, 3: 274, n. 354-355. 60 TURCAN 1983, 37–38. 61 MATTINGLY ET AL. 1936, 4,1: n. 16; COHEN 1880-1892, 3: 392, n. 16. 62 TURCAN 1983, 38–39.
Fig. 22 a – Sesterzio di Faustina Minore. Fig. 22b – Aurei, sesterzi e denarii di Faustina Minore
Fig. 23 – Medaglione di Lucilla.
Fig. 24 – Sesterzi e denarii di Commodo.
XVII International Congress of Classical Archaeology, Roma 22-26 Sept. 2008 Session: Oriental Cults at Rome
Bollettino di Archeologia on line I 2010/ Volume speciale D / D3 / 3 Reg. Tribunale Roma 05.08.2010 n. 330 ISSN 2039 - 0076 www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html
37
Rinnovano le tradizioni delle impe-ratrici antonine, per propiziarsi il favore della Magna Mater, le emissioni63 di Giulia Domna (170-217 d.C.) madre di Caracalla e Geta, datate tra il 193 e il 211 d.C. I tipi sono simili a quelli presenti sulle monete di Faustina Minore. Le leggende del R/ sono: MATRI DEVM, MATRI MAGNAE e MATER AVGVSTRORVM (fig. 26 a, b). La differenza con le emissioni precedenti è che in questo caso non entra solo in gioco la propaganda imperiale, dove l’imperatrice è considerata,
con il favore di Cibele, madre universale e dell’impero, ma assistiamo a una sorta di identificazione con la divinità stessa, come evidenzia anche Turcan64.
Cibele non compare nei tipi di Elagabalo, poiché questi era, per diritto ereditario, l’alto sacerdote del dio Sole (Sol Invictus) di Emesa. Si ritrova, invece, su sesterzi65 di Giulia Soemia (m. 222 d.C.), madre dell’imperatore. Essi presentano al R/ il tipo di Cibele, simile ai tipi di Giulia Domna, con la leggenda MATER DEVM. Anche qui ritorna il riferimento alla maternità, segno del favore divino (fig. 27).
Il tipo di Cibele, dopo il 222 d.C., non è più presente nella monetazione imperiale, sostituita da altre tipologie come Hilaritas. Questa divinità, nota soltanto attraverso tipi monetali66, comincia ad apparire già su alcune emissioni di Adriano (fig. 28). Potrebbe essere messa in relazione con le Hilaria, feste primaverili che celebravano Attis risorto e dunque legate sempre al culto di Cibele.
Fig. 26a – Sesterzi e denarii di Giulia Domna. Fig. 26b – Aurei e denarii di Giulia Domna
63 MATTINGLY ET AL. 1936, 4,1: n. 562; nn. 564-566, 570; n. 841; n. 858; nn. 859, 861; nn. 382-383; COHEN 1880-1892, 4: 114–117, nn. 116-119, 122–126, 128–129, 138–141. 64 TURCAN 1983, 39–42. 65 MATTINGLY ET AL. 1936, 4,2: nn. 400-401; COHEN 1880-1892, 4: 338, nn. 4-5. 66 Il problema è solo accennato in TURCAN 1983, 44. Cf. GRANT 1954, 215, 261.
Fig. 25 – Sesterzio di Pertinace.
P. Calabria, F. Di Jorio, P. Pensabene – L’iconografia di Cibele nella monetazione romana
Bollettino di Archeologia on line I 2010/ Volume speciale D / D3 / 3 Reg. Tribunale Roma 05.08.2010 n. 330 ISSN 2039 - 0076 www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html
38
Un discorso a parte occorre fare per i contorniati, pseudo-monete emesse tra la metà del IV e gli ultimi trenta anni del V sec. d.C. Per quanto riguarda le raf-figurazioni riferibili al culto metroaco in generale, si pos-sono riscontrare quattro tipologie. Su tre tipi al D/ tro-viamo i ritratti di Alessandro Magno, Nerone, Vespa-siano, Traiano e Antonino Pio, e una variante con le
maschere teatrali. Per il tipo con le maschere sce-niche l’attribuzione al culto metroaco è ancora dubbia. inoltre su alcuni è presente anche il mo-nogramma PE, da intendersi verosimilmente co-me una contromarca. Al R/ sono presenti varie raffigurazioni con Cibele, Attis e tutta la classica tipologia relativa al culto metroaco; su un altro anche i miti di fondazione della città (fig. 29 a-g).
Tra essi spiccano una serie di contorniati con al D/ il busto di Faustina Maggiore velato e diademato, volto a s. con leggenda DIVA AVGVSTA FAVSTINA, mentre al R/ la raffigu-razione di un tempio con all’interno la statua della Magna Mater e la leggenda MATRI DEVM SALVTARI67 (fig. 30 a, b, c). In esso si è cercato di riconoscere un altro edificio di culto, con la fac-ciata caratterizzata da due colonne corinzie e tra-beazione ad arco di cerchio, e ai lati una corte porticata dello stesso ordine architettonico. Inoltre, altri contorniati dello stesso tipo presentano anche un foro, a dimostrazione che era portato come ornamento e denotano ancora la diffusione del culto tra i membri dell’élite senatoria e imperiale.
Francesco Di Jorio
67 GRAILLOT 1912, 335; ALFÖLDI 1990, 3, 10–11; 113, 10; 180, 11–12; 181, 1–2, 182, 1; TURCAN 1983, 52–57.
Fig. 27 – Sesterzio di Giulia Soemia.
Fig. 28 – Sesterzio di Adriano – Hilaritas.
Fig. 29 a-g – Contorniati con culto metroaco e miti di fondazione di Roma.
XVII International Congress of Classical Archaeology, Roma 22-26 Sept. 2008 Session: Oriental Cults at Rome
Bollettino di Archeologia on line I 2010/ Volume speciale D / D3 / 3 Reg. Tribunale Roma 05.08.2010 n. 330 ISSN 2039 - 0076 www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html
39
Fig. 30 a-c. – Contorniato di Faustina Maggiore. Conclusioni
Riassumendo tutti i dati fin qui raccolti possiamo mettere in evidenza una serie di novità. Abbiamo identificato che la prima emissione con il tipo di Cibele è su bronzo; l’autorità emittente è, come sempre, Roma, il Senato romano, ma non attraverso i magistrati monetali.
Successivamente Cibele compare, a partire dal 102 a.C., su denarii e aurei. In questo caso la differenza sostanziale si nota sulle diverse tipologie dei denarii. Infatti su alcuni si mette in evidenza il ruolo svolto della dea come divinità salutaris, protettrice di Roma, perché collegata ai miti di fondazione; su altri è invece l’affermazione della forza e potenza romana. In seguito, nelle emissioni degli edili curuli, si ritrova la celebrazione dei giochi a lei dedicati con il tentativo di auto-celebrazione dei magistrati stessi: tutto questo rientra nei precisi canoni della monetazione repubblicana, dove le monete erano impiegate anche per la propaganda familiare e personale. Con gli aurei è presente l’accostamento Sibilla/Venere-Magna Mater, protettrici delle città di origine troiana, legata quindi, ancora una volta alle origini di Roma. Tuttavia sugli aurei sembra non essere seguito un vero e proprio programma tipologico, data l’eccezionalità della loro emissione.
Da ultimo, almeno per il periodo repubblicano, Cibele è rappresentata con la corona turrita; solo in un’occasione ha l’elmo frigio laureato, che si riconnette di nuovo alle sue origini geografiche.
In età imperiale la propaganda sulle monete è decisa dall’imperatore e il tipo con Cibele è dunque slegato da ogni riferimento storico. Il suo culto è stato ormai assimilato, tuttavia non ne abbiamo attestazioni nelle tipologie monetali di età augustea e giulio-caudia. Per l’età flavia il sesterzio di Domiziano – supportato anche dal rilievo degli Haterii – potrebbe indicare un inizio di ripresa del culto metroaco.
Tuttavia, tra il II e il III sec. d.C. l’iconografia diventerà, come abbiamo potuto constatare, sempre più complessa e legata soprattutto alle imperatrici, “grandi madri” dell’impero, fino a giungere anche a una specie di identificazione tra le auguste e la dea.
P. Calabria, F. Di Jorio, P. Pensabene – L’iconografia di Cibele nella monetazione romana
Bollettino di Archeologia on line I 2010/ Volume speciale D / D3 / 3 Reg. Tribunale Roma 05.08.2010 n. 330 ISSN 2039 - 0076 www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html
40
Sui contorniati68, che rappresentano le ultime attestazioni con l’immagine di Cibele, sono riproposti i miti di fondazione e dunque la tipologia della testa ornata dalla corona turrita è legata ancora all’idea della personificazione delle città dove sorgeva il suo tempio maggiore; ma ritorna anche la relazione tra il culto della dea e i giochi offerti alla plebe romana.
Il fatto poi che si concluda la presenza di Cibele, facendo posto all’Hilaritas, conferma le valenze fortunate e di rinnovamento che ha questa divinità.
Prof.ssa Patrizia Calabria “La Sapienza”. Università di Roma
E-mail: [email protected]
Dott. Francesco Di Jorio “La Sapienza”. Università di Roma
E-mail: [email protected]
Prof. Patrizio Pensabene “La Sapienza”. Università di Roma
E-mail: [email protected]; [email protected] Bibliografia ALFÖLDI A., ALFÖLDI E., 1990. Die Kontorniat-Medaillons in neuer Bearbeitung. Berlin. ALTERI G., 1990. Tipologia delle monete della Repubblica di Roma (con particolare riferimento al denario).
Catalogo della mostra. Città del Vaticano. ARRIGONI G., 1982. Camilla amazzone e sacerdotessa di Diana. Milano. BABELON E., 1885-1886. Description historique et chronologique des monnaies de la République romaine
vulgairement appelées monnaies consulaires, 1–2. Paris. BADIAN E., 1968. Sulla’s Augurate. Arethusa, 1, 26–46. BOYANCÉ P., 1954. Cybèle aux Mégalénsies. Latomus, 13, 337–42. CACCAMO CALTABIANO M., 2004. Il tipo monetale del cavaliere nell’ottica del Lessico Iconografico
Numismatico. In M. CACCAMO CALTABIANO, D. CASTRIZIO, M. PUGLISI (eds), La tradizione iconica come fonte storica. Il ruolo della numismatica negli studi di iconografia. Atti del I Incontro di Studio del Lexicon Iconographicum Numismaticae (Messina 6-8 marzo 2003), 17-47. Reggio Calabria.
CASTAGNOLI F., 1941. Gli edifici rappresentati in un rilievo del sepolcro degli Haterii. BCAR, 69, 62–5. CÀSSOLA F., 1985. Storia di Roma. Dalle origini a Cesare. Roma. COHEN H., 1880-1892. Description historique des monnaies frappées sous l'Empire romain: communément
appellées médailles imperials. Paris. CRAWFORD M. H., 1969. Roman Republican Coin Hoards. London. CRAWFORD M. H., 1983. Roman Republican Coinage. London. D’ALESSIO A., in preparazione. Il rifacimento del santuario della Magna Mater a Roma alla fine del II secolo
a.C. Impianto architettonico, cronologia e tecniche edilizie. In Criteri di datazione dei contesti repubblicani: ceramica, tecniche edilizie, monetazione. In V. JOLIVET, C. PAVOLINI, M. A. TOMEI, R. VOLPE (a cura di), Suburbium 2. Il suburbio di Roma dalla fine dell’età monarchica alla nascita del
68 Cf. N. 66.
XVII International Congress of Classical Archaeology, Roma 22-26 Sept. 2008 Session: Oriental Cults at Rome
Bollettino di Archeologia on line I 2010/ Volume speciale D / D3 / 3 Reg. Tribunale Roma 05.08.2010 n. 330 ISSN 2039 - 0076 www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html
41
sistema delle ville (V-II sec. a.C.). Atti del Convegno Internazionale di Roma (École Française de Rome). Roma, 227–240.
DE LUYNES H., 1858. Monnaies des Nabatéens. RN, 362–85. GÉRARD H., 1980. Lègende et politique autour de la Mère dex dieux. REL, 58, 153–75. GNECCHI F., 1912. I medaglioni romani descritti e illustrati da Francesco Gnecchi, 2. Milano. GRAILLOT H., 1912. Le culte de Cybèle Mère des dieux, à Rome et dans l’Empire Romain. Paris. GRANT M., 1954. Roman Imperial Money. London. GRÜBER H. A., 1910. Coins of the Roman Republic in the British Museum, 2. London. KOCH G., SICHTERMANN H., 1982. Römische Sarkophage. München. LAMBRECHTS P., 1951. Cybèle, divinité étrangère ou nationale? Bulletin de la Société Royale Belge
d’Antropologie et de Préhistoire, 62 (1952), 44–60. MATTINGLY H., SYDENHAM E. A, 1926. The Roiman Imperial Coinage. Vespasian to Hadrian, 2. London. MATTINGLY H., SYDENHAM E. A, 1930. The Roiman Imperial Coinage. Antoninus Pius to Commodus, 3.
London. MATTINGLY H., SYDENHAM E. A, 1936. The Roiman Imperial Coinage. Pertinax to Geta, 4,1. London. MATTINGLY H., SYDENHAM E. A, 1938. The Roiman Imperial Coinage. London. MORGAN M. G. 1973. Villa Publica and Magna Mater. Klio, 55, 231–245. PENSABENE P., SANZI DI MINO M., 1983. Museo Nazionale Romano. Le terrecotte, III, 1–2. Roma. PENSABENE P., 2004. Non stelle, ma il sole. Il contributo della planimetria e della decorazione architettonica
alla definizione del santuario di Cibele a Pessinunte. ArchClass, 55, 83–143. PENSABENE P., 2008. Il culto di Cibele e la topografia del sacro a Roma. In B. PALMA VENETUCCI (ed), Culti
orientali tra scavo e collezionismo. Roma, 21–39. ROSS TAYLOR L., 1944. Symbols of the Augurate on Coins of Caecilii Metelli. AJA, 48, 352–6. SYDENHAM E. A., 1952. The Coinage of the Roman Republic. London. TOYNBEE J. M. C., 1986. Roman Medallions. New York. TURCAN R., 1983. Numismatique romaine du culte mètroaque. Leiden. WERMASEREN M. J., 1977. Corpus Cultus Cybelae Attidisque (CCCA). Leiden. ZEVI F., 1997. Culti Claudi a Ostia e a Roma: qualche osservazione. ArchClass, 49, 435–71. Abbreviazioni periodici (Année Philologique): AJA American Journal of Archaeology. The Journal of the Archaeological Institute of America ArchClass Archeologia Classica Arethusa Arethusa. A Journal of the Wellsprings of Western Man BCAR Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma Klio Klio. Beiträge zur Alten Geschichte Latomus Collection Latomus REL Revue des études latines RN Revue numismatique