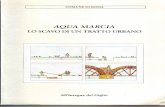I monumenti di Olympis e di C. Claudio Marcello a Taormina, in «Rendiconti della Pontificia...
-
Upload
beniculturali -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of I monumenti di Olympis e di C. Claudio Marcello a Taormina, in «Rendiconti della Pontificia...
I MONUMENTI DI OLYMPISE DI C. CLAUDIO MARCELLO A TAORMINA*
DI
FRANCESCO MUSCOLINO
Antoninooptimo patri
septuagenario
LA SCOPERTA
Nel marzo del 1770, durante lavori di ampliamento del Monastero fem-minile di Santa Maria di Valverde a Taormina, si rinvengono due basi dimonumenti onorari, una con dedica a Olympis figlio di Olympis, vincitorenella corsa con il cavallo adulto nei giochi Pitici (IG XIV 434),1 l’altra con il
Rend. Pont. Acc. Rom. Arch., LXXXII 2009-2010, pp. 131-181
* Nota presentata dal socio effettivo Marco Buonocore.Ringrazio sentitamente tutti coloro che hanno reso possibile questo lavoro, in partico-
lare, presso la Soprintendenza di Messina, il soprintendente arch. Rocco Scimone e ladott.ssa Gabriella Tigano, direttore del Servizio Beni Archeologici, per aver autorizzato lostudio e la pubblicazione dei due monumenti (autorizzazione nr. 4496 del 20 novembre2009), nonché l’archeologa dott.ssa Maria Grazia Vanaria, per aver cortesemente agevolatoil mio lavoro presso l’Antiquarium del Teatro Antico di Taormina. Ringrazio, inoltre, Gae-tano Castorina, per le fotografie alle figg. 16 e 17; il geom. Francesco Rosselli, per la fig. 19;mons. Giuseppe Greco, per aver autorizzato le mie ricerche presso la Biblioteca Arcivesco-vile Alagoniana di Siracusa, e Giovanni Sudano per averle pazientemente favorite; ringrazioancora la dott.ssa Rosalba Guarneri e Giovanni Galioto della Biblioteca Comunale diPalermo. Al dott. Marco Buonocore va la mia gratitudine per essersi interessato a questericerche e per aver proposto di pubblicarle in una sede così prestigiosa.
Per le riviste, si usano le abbreviazioni de L’Année Philologique, integrate da quelle dellaArchäologische Bibliographie; per gli autori greci e latini quelle della Kleine Pauly. Si usano, inol-tre, le seguenti abbreviazioni: AE per l’Année Épigraphique della RA e BE per il Bulletin Épi-graphique della REG. Le foto e i disegni delle figg. 1-15 sono stati eseguiti da chi scrive e sonopubblicati su concessione dell’Assessorato per i Beni Culturali e Ambientali della RegioneSicilia; per tale motivo ne è vietata la riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.
1 Taormina, Antiquarium del Teatro Antico, inv. 1 (ex inv. 24): `O d©moj tîn Tauro-
menit©n | ”Olumpin 'OlÚmpioj MESTON | nik£santa PÚqia k≤lhti | tele…wi (figg. 1-6).
408 REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D’ARCH. – VOL. LXXXII
nome di un C. Claudio M. f. Marcello (IG XIV 435).2 Solo il testo delle iscri-zioni, pubblicato pochi mesi dopo la scoperta, ha ricevuto adeguata atten-zione, mentre sono state quasi del tutto trascurate sia la contestualizzazionedelle due basi sia, soprattutto, la loro conformazione.3 Si cercherà dunque diaffrontare uno studio complessivo dei due monumenti, anche alla luce dialcuni documenti inediti o poco noti sul loro ritrovamento.
Subito dopo la loro scoperta, le due epigrafi sono oggetto di un ampio scam-bio di informazioni e opinioni che coinvolge alcuni dei più illustri rappresen-tanti dell’antichistica siciliana del tempo, oltre a Bertrand Capmartin deChaupy4 che passa da Taormina nel maggio del 1770.5 Questa intensa attivitàesegetica si svolge soprattutto attraverso scambi epistolari, secondo una prassi difondamentale importanza nella cultura settecentesca. Nel caso in esame, è pos-sibile ricostruire parzialmente gli scambi intercorsi grazie alla Raccolta di lettere diuomini illustri a Cesare Gaetani della Torre, custodita presso la Biblioteca Arcive-scovile Alagoniana di Siracusa, e alla Raccolta di varie scritture sulla città di Taor-mina, conservata presso la Biblioteca Comunale di Palermo (ms. Qq H 272).Alcuni cittadini di cui non è specificato il nome inviano le trascrizioni delle epi-grafi al messinese Giuseppe Vinci6 e al palermitano Domenico Schiavo.7 Le loro
2 Taormina, Antiquarium del Teatro Antico, inv. 2 (ex inv. 22): G£ioj KlaÚdioj |
Ma£rkou uƒÕj Ma£rkelloj | G (?) (figg. 7-15).3 Gaetano Rizzo fornisce le misure della sola faccia con l’iscrizione (RIZZO 1893, p. 32,
nt. 1 e ID. 1904, p. 111 per IG XIV 434, e ID. 1893, p. 34, nt. 1 per IG XIV 435). Le unichefotografie edite delle due iscrizioni sono, per quanto consta, la fig. 79 in C. CIPOLLA, C’erauna volta Taormina ed il suo territorio, Palermo 1984, che mostra la disposizione delle duebasi nella vecchia sistemazione dell’Antiquarium e le figg. 6-7 in P. PELAGATTI, La secolare sto-ria del Museo di Taormina, in Kalos XI n° 1 1999, p. 8.
4 Il nome di Bertrand Capmartin de Chaupy (1720-1798), in campo archeologico, èlegato soprattutto alla Découverte de la maison de campagne d’Horace, Rome 1767-1769; su que-sto studioso, v. soprattutto E. GALLETIER, L’abbé Capmartin de Chaupy et la découverte de la villad’Horace, in LEC IV 1935, pp. 74-92 e N. MATHIEU, Capmartin de Chaupy, découvreur de la mai-son de campagne d’Horace, ou petite promenade archéologique au sujet du domaine d’Horace enSabine, au XVIIIe siècle, in Caesarodunum XXIII bis 1988, pp. 177-198.
5 Chaupy è a Taormina il 20 maggio (v. docc. 5 e 7); il 18 maggio era stato presente allascoperta della dedica al Genio di Catania (CIL X 7014) nel Teatro romano di quest’ultimacittà, secondo la testimonianza del principe di Biscari (I. PATERNÒ DI BISCARI, Discorso accademicosopra un’antica iscrizione trovata nel Teatro della Città di Catania, Catania 1771, p. XVI, nt. 10).
6 Su Giuseppe Vinci (1701-1772), protopapa dei cattolici di rito greco e prefetto dellabiblioteca pubblica di Messina, v. D. SCINÀ, Prospetto della storia letteraria di Sicilia nel secolodecimottavo, Palermo 1824-1827, II, pp. 112, 115-116, 133, 370; G. M. MIRA, Bibliografia sici-liana, Palermo 1875-1881, II, pp. 462-463, s.v.
7 Su Domenico Schiavo (1718-1773) v. G. BERTINI in G.E. ORTOLANI (ed.), Biografia degliuomini illustri della Sicilia, Napoli 1817-1821, III, s.v.; SCINÀ, Prospetto cit. (nota 6), I, in par-ticolare pp. 10-11, 49-50; per i suoi rapporti con Ignazio Cartella, v. MUSCOLINO 2007,pp. 583-584, 592-596.
interpretazioni, però, non soddisfano l’erudito taorminese Ignazio Cartella, che,il 30 maggio 1770, scrive al conte siracusano Cesare Gaetani della Torre8 (doc. 1),chiedendogli il suo parere e inviandogli, a sua volta, le trascrizioni (doc. 2). Ilconte fornisce la sua interpretazione (docc. 3-4) e Cartella, il 4 luglio dello stessoanno, gli invia, con altre osservazioni e richieste di chiarimento, anche la tradu-zione di Capmartin de Chaupy (doc. 5). Gaetani, secondo la sua abitudine,informa della scoperta anche il palermitano Gabriele Lancillotto Castelli prin-cipe di Torremuzza,9 che aveva appena pubblicato la prima edizione della suaCollectio epigrafica.10 Torremuzza risponde a Gaetani il 10 luglio (doc. 6), comu-nicandogli di aver già ricevuto il testo da un’altra fonte che non precisa,11 oltreche da Ignazio Cartella.12 Una “ sintesi ” delle principali interpretazioni delle dueiscrizioni è offerta, forse non oltre il 1777, da un breve scritto di un anonimo eru-dito taorminese (doc. 7).13
LE EDIZIONI
Risultato di questo stretti contatti tra gli studiosi è la pubblicazione intempi molto rapidi: nel fascicolo del 10 agosto 1770, le Novelle Letterarie di
F. MUSCOLINO - I MONUMENTI DI OLYMPIS E DI C. CLAUDIO MARCELLO A TAORMINA 409
8 Su Cesare Gaetani conte della Torre (1718-1805) e i suoi studi epigrafici v. soprat-tutto SGARLATA 1993 e anche EAD., Un manoscritto di epigrafia siracusana, in Kokalos XXXIX-XL I.2 1993-1994, pp. 669-694 e K. KORHONEN, Erudite Forgeries or Families seeking Distinction?Cesare Gaetani’s Inscriptions from Syracuse, in ZPE CLXI 2007, pp. 292-298.
9 Su Gabriele Lancillotto Castelli principe di Torremuzza (1727-1792) v., almeno, lasua postuma autobiografia (Memorie della vita letteraria di Gabriele Lancillotto Castello principedi Torremuzza scritte da lui stesso con annotazioni di Giovanni D’Angelo, Palermo 1804),G. ORTOLANI DI BORDONARO, G.L. Castelli di Torremuzza e gli studi d’antiquaria siciliana nel sec.XVIII, in ASS VII 1941, pp. 223-250 e Palermo 19802 e, tra gli studi più recenti, G. PAGNANO,Le Antichità del Regno di Sicilia. I plani di Biscari e Torremuzza per la Regia Custodia 1779, Sira-cusa-Palermo 2001 e A. CRISÀ, G. L. Castelli, principe di Torremuzza, numismatico ed antichistaad Halaesa Archonidea, in Lanx II 2009, pp. 116-149; per i suoi rapporti con Ignazio Cartella,v. MUSCOLINO 2007, pp. 584-589, 596-605.
10 G. L. CASTELLI DI TORREMUZZA, Siciliae et objacentium insularum veterum inscriptionumnova collectio, Panormi 1769.
11 Torremuzza sembra aver ricevuto la notizia sia da Cartella, come precisa nella Collectio(v. nota 17), sia da un altro mittente non specificato che erroneamente considera le due iscri-zioni come parte di un unico testo, secondo quanto lo stesso principe afferma in doc. 6.
12 V. nota 17.13 Palermo, Biblioteca Comunale, ms. Qq H 272, nr. 43, ff. 1123-1124. La miscellanea,
in corso di studio da parte di chi scrive, sembra essere stata assemblata da Domenico LaCamiola (1702-1777), anche se la grafia del breve testo dedicato alle due iscrizioni non èla sua. La grafia non è neanche di Ignazio Cartella, come dimostrato dal confronto conscritti autografi (le lettere a Gaetani pubblicate in questo lavoro e quelle a Torremuzza inMUSCOLINO 2007, pp. 596-604).
Firenze offrono l’editio princeps delle due epigrafi14 appena sei mesi dopo laloro scoperta. Cartella pubblica due volte le iscrizioni, nel 177415 e nel 1777,16
e ne manda la trascrizione a Torremuzza, che le inserisce nella seconda edi-zione della sua Collectio.17 Le epigrafi sono pubblicate – in trascrizioni più omeno corrette – anche da vari « Letterati viaggiatori »,18 da Cantini,19 dall’ar-
410 REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D’ARCH. – VOL. LXXXII
14 Novelle letterarie pubblicate in Firenze l’anno MDCCLXX, I, Firenze 1770, fasc. XXXII,coll. 500-501. Le due iscrizioni sono considerate come formanti un unico testo, forse per-ché la notizia fu inviata a Firenze da Torremuzza o dalla sua fonte: il principe, nella letteraa Gaetani del 10 luglio 1770 (doc. 6), afferma, infatti, di essere già stato informato della sco-perta « coll’avviso però che la Iscriz(ion)e è unica, venuta di sotterra in due pezzi ». Nellostesso fascicolo delle Novelle letterarie (col. 502) è pubblicata l’iscrizione CIL X 7014, sco-perta a Catania nel maggio del 1770 (v. nota 5).
15 I. CARTELLA, Lettera intorno a’ pregi dell’antica città di Taormina, in Opuscoli di Autori Sici-liani XV 1774, p. 149.
16 I. CARTELLA, Discorso istorico-critico intorno all’origine della città di Taormina, in Opuscoli diAutori Siciliani XVIII 1777, p. 224.
17 G. L. CASTELLI DI TORREMUZZA, Siciliae et obiacentium insularum veterum inscriptionum novacollectio, Panormi 1784, p. 108, nr. 9 (iscrizione di Olympis, con la precisazione «Misit Igna-tius Cartella J(uris) U(triusque) D(octor) Regius Tauromenitanarum Antiquitatum Cura-tor ») e nr. 10 (iscrizione di C. Claudio Marcello). Nei due volumi contenenti il carteggio diTorremuzza (Biblioteca Comunale di Palermo, mss. Qq E 136 e Qq H 178) sono conservatesei lettere di Cartella a Torremuzza, edite in MUSCOLINO 2007, pp. 596-604, nrr. 4, 5, 7, 9, 13,14, ma non vi è traccia di missive relative a queste epigrafi, sia perché le lettere conservatesi datano in un arco di tempo (1777-1791) posteriore alla scoperta, sia perché i due volumidel carteggio torremuzziano hanno un carattere ‘selettivo’ (MUSCOLINO 2007, p. 582). La tra-duzione in latino di Torremuzza è accolta da Cartella nella Breve relazione de’ più rimarchevoliantichi monumenti esistenti nella città di Taormina … e particolarmente del Conservatojo d’acqua, chesi trova intero, in Nuova Raccolta di Opuscoli di Autori Siciliani, IV 1791, p. 14. Torremuzzaafferma che le due iscrizioni furono trovate «prope Hippodromum», mostrando di con-nettere i due monumenti con la cd. ‘Naumachia’, interpretata, appunto, anche come Ippo-dromo nella letteratura antiquaria (valga per tutti J. P. D’ORVILLE, Sicula, Amstelaedami1764, pp. 266-267). Di avviso simile anche le Novelle letterarie cit. (nota 14) che, come si èvisto, dipendono da Torremuzza o dalla sua fonte: « vicino a quel magnifico avanzo di anticafabbrica da taluni creduta una Naumachia, e da altri un Ippodromo». Sebbene la cd. ‘Nau-machia’ sia piuttosto vicina al luogo di rinvenimento, è da escludere un legame tra questomonumento e le due basi: tale legame, infatti, sembra creato ‘a tavolino’ per connettere lavittoria equestre di Olympis con un presunto ‘Ippodromo’.
18 Tra i quali D. SESTINI, Lettere dalla Sicilia e dalla Turchia a diversi suoi amici in Toscana,II, Firenze 1780, pp. 55-56, che trascrive entrambe le iscrizioni, mentre D. V. DENON, Voyagepittoresque ou description des Royaumes de Naples et de Sicile, IV, Paris 1785, p. 45, L. N. P. A. DEFORBIN, Souvenirs de la Sicile, Paris 1823, pp. 193 e 305, nt. 38, R. ROCHETTE, Lettre à M. le Ducde Luynes sur les Graveurs des monnaies grecques, Paris 1831, pp. 34-35 si limitano all’iscrizionedi Olympis. Tutti costoro vedono le epigrafi all’interno della Chiesa del Monastero di Val-verde.
19 L. CANTINI, Iscrizioni che si trovano negli Atti dell’Accademia Colombaria di Firenze, Firenze1800-1801, I, pp. 76-86 pubblica, in modo scorretto e basandosi sull’edito, la sola iscrizione
ciprete Castorina;20 il testo è poi fissato dal Corpus Inscriptionum Graecarum21 edalle Inscriptiones Graecae.22
Dopo essere state esposte, sin dal loro ritrovamento, nella oggi non piùesistente chiesa del Monastero di Santa Maria di Valverde,23 le due basi sonostate trasportate, forse dopo la soppressione del Monastero nel 1866, nel-l’Antiquarium (già casa del custode) del Teatro Antico.24
IL MONUMENTO DI OLYMPIS
La base del monumento di Olympis (IG XIV 434) è realizzata in pietra rossadi Taormina, ha una larghezza di cm 69,5, una profondità di cm 66, un’altezzadi cm 28/29, ed è levigata, oltre che sul lato frontale, che ospita l’iscrizione (figg.1 e 6), anche sul lato a destra di chi guarda e nella parte superiore (figg. 2, 3 e5), dove sono ben visibili gli incavi per i piedi della statua, verosimilmente bron-zea, del vincitore e, lungo il margine destro, un incavo destinato forse a ospitareuna grappa. Il lato sinistro, quello posteriore (fig. 4) e quello inferiore, invece,sono solo sbozzati. Ammettendo che la lavorazione del blocco non sia incom-pleta per motivi che ci sfuggono e che la grappa sia contemporanea del monu-mento, si potrebbe ipotizzare che la base, lungo il lato destro, fosse in contattocon un altro blocco, forse perché inserita in una struttura muraria.25
Le lettere (figg. 1 e 6), apicate e accuratamente incise, hanno un’altezzamedia di cm 2,5; le parole sono disposte in maniera da occupare armoniosa-mente lo spazio disponibile. Il testo,26 in dialetto dorico, non offre particolari
F. MUSCOLINO - I MONUMENTI DI OLYMPIS E DI C. CLAUDIO MARCELLO A TAORMINA 411
di Olympis, considerando (ibidem, pp. 85-86) il personaggio onorato come un probabileantenato (!) dell’Olimpio magister officiorum e praefectus praetorio di Onorio o dell’omonimoesarca di Ravenna del VII secolo.
20 R. CASTORINA, Dello Ippodromo di Taormina, in Giornale di scienze, lettere e arti per la Sici-lia LXX 1840, pp. 148-150; ID., Sopra una lettera scritta in latino del chiarissimo professore Cav.Canonico Alessi … riguardante una Medaglia non ha guari trovata, che l’illustre autore crede appar-tenere a Taormina, in Giornale di scienze, lettere e arti per la Sicilia LXXI 1840, pp. 53-54.
21 A cura di I. Franz in CIG III 5638 (anche dalle schede di T. Panofka e O. Müller) eCIG III 5644 (anche dalle schede di O. Müller).
22 IG XIV, 434 e 435, nella trascrizione, rispettivamente di G. Kaibel ed E. Bormann edel solo Kaibel. Per altre indicazioni bibliografiche, v. infra note 26 e 37.
23 SESTINI, Lettere cit. (nota 18), p. 55 precisa che le due iscrizioni erano conservate den-tro la chiesa «presso la Porta ».
24 In IG XIV, edito nel 1890, le due epigrafi sono « apud custodem theatri ».25 Un esempio di basi di statue inserite in una struttura muraria è offerto dal monu-
mento ai due amphipoloi nell’agorà di Solunto (V. TUSA, L’anfipolia di Solunto, in Kokalos VIII1962, pp. 185-188, tav. 60).
26 Oltre alla bibliografia citata supra, su IG XIV 434 v. anche SGDI III.2 5232; RIZZO 1893,pp. 32-34; ID. 1904, p. 111; ID., I monumenti epigrafici di Taormina. Nuovi studi ed integrazioni, in
412 REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D’ARCH. – VOL. LXXXII
Fig. 1. Base di Olympis: faccia anteriore
Fig. 2. Base di Olympis: faccia superiore (foto) Fig. 3. Base di Olympis: faccia superiore(disegno)
F. MUSCOLINO - I MONUMENTI DI OLYMPIS E DI C. CLAUDIO MARCELLO A TAORMINA 413
Fig. 6. Apografo dell’iscrizione di Olympis
Fig. 5. Base di Olympis: facce anteriore e destra
Fig. 4. Base di Olympis: faccesinistra e posteriore
414 REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D’ARCH. – VOL. LXXXII
problemi interpretativi, dato il buono stato di conservazione27 e la chiarezzadelle lettere, a parte la parola Meston che potrebbe essere una delle sigle fre-quenti nell’epigrafia tauromenitana28 o un terzo nome del personaggio.29 A
ASM VI 1905, p. 113; M. SANTANGELO, Taormina e dintorni, Roma 1950, p. 80, nr. 1; CIPOLLA,C’era una volta Taormina cit. (nota 3), pp. 99, 205, J. R. W. PRAG, Auxilia and Gymnasia. A Sici-lian Model of Roman Imperialism, in JRS XCVII 2007, p. 94, e soprattutto GENTILE 2002.
27 Solo la seconda asta verticale del N finale della prima linea è scomparsa a causa diuna scheggiatura del blocco.
28 L’ipotesi è avanzata da RIZZO 1893, p. 33; ID., La tavola degli Strategi a Tauromenio. Con-tributi alla storia dell’elemento dorico in Sicilia, parte II, Catania 1893, p. 15 e GENTILE 2002,p. 229. Su tali sigle, di controversa interpretazione (etnici? demotici? filetici?), v. I. FRANZ,Iscrizioni taormitane, in AdI X 1838, p. 79; ID., Elementa epigraphices graecae, Berolini 1840,p. 230; CIG III, p. 644; G. LAFAYE, Inscription de Tauromenion, inMEFR I 1881, pp. 16-17; RIZZO
1893, pp. 12-15; MANGANARO 1964, p. 60; ID., Città di Sicilia e santuari panellenici nel III e II sec.a.C., in Historia XIII 1964, p. 429, nt. 79; G. PUGLIESE CARRATELLI, La dedica di Kleombrotos e lesigle preposte a nomi in epigrafi italiote, in ASMG n.s. VI-VII 1965-1966, pp. 211-212; M. GUAR-DUCCI, Epigrafia greca, II, Epigrafi di carattere pubblico, Roma 1970, p. 292; G. MANGANARO, Peruna storia della Sicilia romana, in ANRW, I.1 1972, p. 451, nt. 44; ID., Tavolette di piomboinscritte della Sicilia greca, in ASNP, s. III, VII 1977, p. 1346; ID. 1979, p. 433; BACCI 1980-1981,pp. 739-741; C. ANTONETTI, Sigle epigrafiche greche di Tauromenio (Memorie dell’Istituto Veneto diScienze, Lettere e Arti. Classe di Scienze morali, Lettere ed Arti, XXXIX.3), Venezia 1985 (BE 1987,nr. 756); N. F. JONES, Public Organization in Ancient Greece: A Documentary Study (Memoirs of theAmerican Philosophical Society, 176), Philadelphia 1987, p. 176; C. ANTONETTI, Le sigle delle iscri-zioni greche di Tauromenio: loro simbolo e funzione nella storia sociale della città e nei suoi risvoltigiuridici, in Praktik≠ toà h/ Dieqnoàj Sunedr…ou `EllhnikÁj kaˆ LatinikÁj 'EpigrafikÁj
('Aq»na, 3-9 'Oktwbr…ou 1982), Athina 1987, pp. 11-15; MANGANARO 1988, pp. 159-164 (BE1989, nr. 854); A. BRUGNONE, Epigrafia greca, in Kokalos XXXIX-XL I.2 1993-1994, pp. 499-500 (SEG LIV 872); F. GHINATTI, Le organizzazioni civiche siceliote, in Kokalos XLVI 2000,pp. 63-64, 66-68, 71-72; L. DEL MONACO, Le istituzioni di Tauromenio ellenistico-romana, inM.L. LAZZARINI - P. LOMBARDI (edd.), L’Italia centro meridionale tra Repubblica e Primo Impero.Alcuni aspetti culturali e istituzionali, (Giornata di studio, Roma 13 dicembre 2002) (Opuscula epi-graphica, 11), Roma 2003, pp. 36-39.
29 Sembra questa l’interpretazione preferita da IG XIV che, nell’indice dei Nomina etCognomina, a p. 723, distingue tra ”Olumpij 'OlÚmpioj MestÒj di IG XIV 434 e ”Olumpij
'OlÚmpioj di IG XIV 421, inserendo, a p. 722, MestÒj come nome a sé stante; la stessadistinzione è operata da M. B. HATZOPOULOS, `O `EllhnismÕj tÁj Sikel…aj kat≠ t»n
Rwmaiokrat…a (per…odoj 264-44 p.C.), Athina 1976, p. 285, nrr. 442-443. Già Franz (CIG III5638) aveva annotato «Est potius cognomen MestÒj sive M≤stoj», con rimando alle iscri-zioni di Alesa CIG III 5595 e 5596 (= IG XIV 353 e 354). Più esplicitamente, F. CORDANO,Considerazioni sull’uso greco del terzo nome in Sicilia, in Seconde giornate internazionali di studi sul-l’area elima (Gibellina, 22-26 ottobre 1994), Atti, I, Pisa-Gibellina 1997, pp. 411-412, nt. 2, defi-nisce MestÒj in IG XIV 434 «un esempio di terzo nome non abbreviato », seguita da GHI-NATTI, Le organizzazioni cit. (nota 28), p. 64. ANTONETTI, Sigle cit. (nota 28), p. 61, nt. 150,elenca MestÒn tra i « nomi di famiglia », espungendolo, in tal modo, dal corpus delle sigle.Anche HATZOPOULOS, `O `EllhnismÕj cit., pp. 207 e 285, e PRAG, Auxilia cit. (nota 26), p. 94mostrano di interpretare MestÒj come nome.
favore della prima ipotesi, il parallelismo con la posizione della sigla nellealtre due iscrizioni onorarie (SEG XXXII 936 e 937) provenienti dalla stessaarea;30 a favore della seconda, oltre ai casi simili,31 il fatto che Meston siafinora un hapax tra le sigle tauromenitane.32
La partecipazione di Olympis ai giochi Pitici si inserisce nel contesto deiben attestati rapporti tra Tauromenio e il santuario di Delfi: un suo cittadinoè nella lista dei theorodokoi 33 e un altro, Agatharchos di Menon, è nominatoproxenos nel 168/167 a.C.34 Non ha invece avuto seguito l’ipotesi, avanzata daTorremuzza e da Manganaro,35 che i Pythia fossero giochi celebrati a Tauro-menio.36
F. MUSCOLINO - I MONUMENTI DI OLYMPIS E DI C. CLAUDIO MARCELLO A TAORMINA 415
30 Su queste due iscrizioni e sulla loro relazione con IG XIV 434 e 435 v. infra.31 Per i quali v., in particolare, CORDANO, Considerazioni cit. (nota 29).32 All’eventualità che Meston sia una sigla osta la sua lunghezza: le sigle sicuramente
considerabili come tali sono composte da due/cinque lettere. L’unico esempio di sigla disei lettere sarebbe Sippok (ANTONETTI, Sigle cit. (nota 28), p. 12, nr. 20).
33 SGDI II 2580, col. IV, ll. 94-95: «™n Tauro[men…wi --] | dèrou Ai[s -]» (lettura di G.Manganaro). La bibliografia su questa epigrafe è molto vasta; v., almeno, A. PLASSART,Inscriptions de Delphes. La liste des Théorodoques, in BCH XLV 1921, pp. 1-85; G. DAUX, Listesdelphiques de Théarodoques, in REG LXII 1949, pp. 1-30; GUARDUCCI, Epigrafia cit. (nota 28),p. 352; la parte della lista relativa alla Sicilia è discussa in MANGANARO, Città cit. (nota 28),pp. 419-438 (BE 1965, nr. 497); E. MANNI, Note siceliote, II, Sull’itinerario siciliano dei « thearo-dokoi » delfici, in Kokalos XII 1966, pp. 171-178 (BE 1968, nr. 606); G. MANGANARO, La mone-tazione a Siracusa tra Canne e la vittoria di Marcello (216-212 a.C.), in ASSO LXV 1969, pp. 282-296 (BE 1971, nr. 359); MANGANARO 1979, pp. 419-421; G. ROUGEMONT, Delphes et les cités grec-ques d’Italie du Sud et de Sicile, in Atti del XXXI convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto,4-8 ottobre 1991), Taranto 1992, pp. 189-190; G. MANGANARO, Alla ricerca di poleis mikrai dellaSicilia centro-orientale, in Orbis Terrarum, II 1996, pp. 129-144. Dibattuta è anche la datazionedella lista: PLASSART, Inscriptions cit., p. 41 propone il primo quarto del II sec. a.C.; DAUX,Listes cit., pp. 21-27, ID., Notes de lecture, in BCH, LXXXI 1957, pp. 393-394, sostiene, invece,una datazione intorno al 235-221 a.C. (v. le obiezioni di J. e L. ROBERT, in BE 1950, nr. 127e di L. ROBERT,Hellenica XI-XII, pp. 167-168); questa datazione, o comunque una datazioneagli ultimi decenni del III sec. a.C., sembra oggi la più condivisa: ROUGEMONT, Delphes cit.(con riferimento alla tesi di dottorato di J. OUHLEN, Les Théarodoques de Delphes, Universitéde Paris X, 1992); M. HATZOPULOS, in BE 1994, nr. 432.
34 C. WESCHER – P. FOUCART, Inscriptions recueillies à Delphes, Paris 1863, p. 18, nr. 11; SGDIII 2619; v. anche SIG3 II 585, 123c; G. DAUX, Chronologie Delphique (Fouilles de Delphes, 3 horssérie), Paris 1943, p. 52, L31; BE 1955, nrr. 130 e 306; F. P. RIZZO, La Sicilia e le potenze elleni-stiche al tempo delle guerre puniche (Indagine storico-prosopografica), I, Rapporti con Cos, l’Egitto el’Etolia (Suppl. a Kokalos, 3), Palermo 1970, pp. 90-93, 112; MANGANARO 1988, p. 179; ROU-GEMONT, Delphes cit. (nota 33), p. 184.
35 TORREMUZZA, Siciliae cit. (nota 17), p. 108, nr. 9 (contra FRANZ in CIG III 5638 e RIZZO
1893, p. 34); CANTINI, Iscrizioni cit. (nota 19), p. 84; MANGANARO, Città cit. (nota 28), p. 427;ID., La Sicilia da Sesto Pompeo a Diocleziano, in ANRW, II.11.1 1988, p. 58.
36 La partecipazione di un tauromenitano ai Pythia di Delfi ben si inserisce, del resto,sia nei citati rapporti tra Tauromenio e Delfi, sia in quelli tra la città e altri santuari greci:
416 REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D’ARCH. – VOL. LXXXII
IL MONUMENTO DI C. CLAUDIO MARCELLO
La seconda epigrafe (IG XIV 435)37 onora, invece, un C. Claudio M. f.Marcello, identificabile con il proconsole della Sicilia del 79 a.C.,38 giunto,secondo Cicerone, dopo le malversazioni di M. Emilio Lepido, ut bis ex eademfamilia salus Siciliae constitueretur.39 Egli, infatti, è un discendente del M. Clau-
i Tauromenitani offrono a Delos, tra il 366 e il 364 a. C., tre phialai argentee (I. Délos 103,ll. 59-60 e 104, ll. 116-117; dubbia la menzione in I. Délos 101, ll. 40-41; v. commento diARENA, La fondazione cit. [nota 110], pp. 98-99) e dedicano a Olimpia una statua in onoredi Ierone II di Siracusa, opera del siracusano Mikion di Niker[at]os (F. ECKSTEIN in E.KUNZE, VI. Olympiabericht 1953/1954 und 1954/1955, Berlin 1958, pp. 205-209; G. KLAFFEN-BACH in P. R. FRANKE, Historisch-numismatische Probleme der Zeit Hierons II. von Syrakus, in JNGIX 1958, p. 83, nt. 175a; SEG XVII 196; BE 1960, nrr. 174 e 467; SEG XIX 332; L. MORETTI,Iscrizioni storiche ellenistiche, I. Attica, Peloponneso, Beozia (Biblioteca di Studi Superiori, 53),Firenze 1967, pp. 145-146, nr. 58; M. A. LEVI, Zeus Olimpico e le statue di Ierone II a Olimpia,in Acme XXIII 1970, pp. 153-156; SEG XXV 461; G. DE SENSI SESTITO, Gerone II. Un monarcaellenistico in Sicilia, Palermo 1977, pp. 114-115); Tauromenitani, inoltre, sono vincitori aOlimpia e a Cos (v. nota 127). Sarebbe molto suggestivo connettere con l’Amphiaraion lapresenza a Oropos, nel III sec. a.C., del tauromenitano Posidis di Glaukos, onorato da unlacunoso epigramma funerario (B. Ch. PETRAKOS, Oƒ ™pigraf≥j toà 'Wropoà (BAAH, 170),Athine 1997, p. 465, nr. 675, tav. 96; SEG XLVII 503), ma non vi sono elementi per pro-porre un tale collegamento.
37 Oltre alla bibliografia citata supra, su IG XIV 435 v. anche FRANZ, Elementa cit. (nota28), p. 248; IGRRP I 489; RIZZO 1893, pp. 34-37; ID. 1904, pp. 111-112; SANTANGELO, Taorminacit. (nota 26), p. 80, nr. 2; CIPOLLA, C’era una volta Taormina cit. (nota 3), pp. 99, 206; W.SCHULZE, Zur Geschichte Lateinischer Eigennamen, Berlin 19662, p. 177, nt. 3.
38 L’identificazione con C. Claudio Marcello, pretore nell’80 a.C. e proconsole in Sici-lia nel 79 a.C., avanzata in CIG III, p. 1250, è stata poi comunemente accettata (v., in parti-colare, MÜNZER 1899, col. 2733; IGRRP I 489; BROUGHTON 1951-1952, II, p. 84; M. CADARIO, IClaudi Marcelli: strategie di propaganda in monumenti onorari e dediche votive tra III e I sec. a.C., inOstraka XIV 2005, p. 170; J. R. W. PRAG, Ciceronian Sicily: The Epigraphic Dimension, in La Sicilede Cicéron 2007, pp. 252, nt. 27, 255, nt. 46, 258, nt. 57, 304); ancora Franz (CIG III 5638)pensava a un C. Claudio Marcello presunto figlio del M. Claudio Marcello espugnatore diSiracusa. È curioso notare come nessuno degli studiosi settecenteschi, che naturalmenteconoscevano le Verrine ciceroniane, pensi all’identificazione più semplice, proponendoaltre soluzioni (v. Appendice). Ancora RIZZO 1893, pp. 35-37, identifica il personaggio con ilC. Claudio Marcello console nel 50 a.C. (MÜNZER 1899, nr. 216), figlio del proconsole del79 a.C. (dunque C. f., non M. f. come il personaggio onorato nell’epigrafe) per poi ade-guarsi (ID. 1904, pp. 111-112) all’opinione espressa in IG XIV. L’unico altro C. ClaudioM. f. Marcello noto è il console del 49 a.C. (MÜNZER 1899, nr. 217) che, in mancanza di rap-porti noti con la Sicilia, è un candidato da escludere per il monumento di Tauromenio.
39 CIC., In Verrem, II, 2, 8. Sulla carriera di C. Claudio Marcello, v. MÜNZER 1899, col.2733, nr. 214; BROUGHTON 1951-1952, II, pp. 47, 55, 79, 84, 255, 314, 524, 545-546; T. C.BRENNAN, The Praetorship of the Roman Republic, Oxford-New York 2000, II, p. 484; LAZZERETTI
2006, pp. 67, 319; J. R. W. PRAG, Roman Magistrates in Sicily, 227-49 BC, in La Sicile de Cicéron2007, p. 304. Egli è anche augure e muore prima del 44 a.C., perché nel de Divinatione II,
dio Marcello40 conquistatore di Siracusa e Siculae victor telluris,41 ma ancheiniziatore di un secolare patronatus della sua famiglia nei confronti dellaSicilia.42 Proprio in nome di questo rapporto, i Siciliani si rivolgonoad Marcellos, antiquissimos Siciliae patronos 43 per avere aiuto contro Verre.44
C. Claudio Marcello è un governatore che in Sicilia lascia un ottimo ricordo
F. MUSCOLINO - I MONUMENTI DI OLYMPIS E DI C. CLAUDIO MARCELLO A TAORMINA 417
35, 75, composto in quell’anno, Cicerone parla al passato (ambo mei collegae fuerunt) sia dilui sia di Ap. Claudio Pulcher, morto a Farsalo nel 48 a.C. (F. MÜNZER in RE, III,2 1899, col.2853). BROUGHTON 1951-1952, I, pp. 534, 536; II, p. 55 propone di collegare a C. ClaudioMarcello un C. Aarcellus (<M>arcellus?), proquestore (in Macedonia?) nel 114-113 a.C.menzionato in un’iscrizione di Samotracia, nota solo dalla trascrizione di Ciriaco diAncona, contenente forse l’intestazione di una lista di iniziati datata al 113 a.C.: «· C · Cae-cilio | · Cn. · Papirio | cos | C · <M>arcello | proq »; il testo dell’epigrafe è in CIL III suppl.I.1 7367; Ephemeris epigraphica V, nr. 222; IG XII.8, p. 38; CIL I.22 662 a-b; N. M. DIMITROVA,Theoroi and Initiates in Samothrace. The Epigraphical Evidence (Hesperia suppl. 37), Athens2008, p. 151, nr. 65; v. anche O. KERN, Aus Samothrake, in MDAI(A) XVIII 1893, p. 375, nr.23; S. G. COLE, Theoi Megaloi: The Cult of the Great Gods at Samothrace (Études préliminaires auxreligions orientales dans l’Empire Romain, 96), Leiden 1984, p. 93. L’ipotesi della Dimitrova,secondo cui il proquestore citato nell’iscrizione di Samotracia sarebbe il padre del C. Clau-dio Marcello pretore nell’80 a.C. non è sostenibile, perché quest’ultimo è M. f., non C. f.Anche l’identificazione tra il C. Marcello proquestore nel 113 a.C. e il C. Claudio Marcellopretore nell’80 a.C. proposta – peraltro molto cautamente – da Broughton è difficilmenteaccettabile, per il notevole lasso di tempo intercorrente tra la proquestura e la pretura. Seil personaggio citato nell’iscrizione è davvero uno dei Claudii Marcelli, il suo legame con ilKabeirion di Samotracia potrebbe rientrare nelle sue tradizioni familiari: Plutarco (Marcel-lus, 30) ricorda l’offerta a questo santuario, da parte di M. Claudio Marcello, di statue equadri del bottino siracusano («¢ndri£ntej… kaˆ p…nakej tîn ™k Surakousîn»).
40 Secondo la ricostruzione proposta da MÜNZER 1899, coll. 2731-2732, M. Claudio Mar-cello sarebbe il trisnonno di C. Claudio Marcello.
41 PROP., III, 18, v. 33.42 CIC., In Verrem, divinatio in Caecilium, 13: omnino Marcellorum nomini tota illa provincia
adiuncta est.43 CIC., In Verrem, II, 3, 45.44 Sui rapporti di clientela dei Siciliani nei confronti dei Claudii Marcelli, v., oltre ai citati
passi ciceroniani, PS.-ASCON., In Divinationem, 2 (p. 187 ed. Stangl); LIV. XXVI, 32; VAL. MAX.IV, 1, 7; PLUT., Marcellus, 23; CASS. DIO XV, 57, 46; ZON. IX, 6, 8-9; v. anche E. ALBERTINI, LaClièntele des Claudii, in MEFR XXIV 1904, pp. 251-253; E. BADIAN, Foreign Clientelae (264-70B.C.), Oxford 1958, pp. 7, 155, nt. 1, 157; P. A. BRUNT, Patronage and Politics in the «Verrines »,in Chiron X 1980, pp. 274, 277-278; J. NICOLS, The Caecilii Metelli, patroni Siciliae?, in HistoriaXXX 1981, pp. 238-240; E. S. GRUEN, The Hellenistic World and the Coming of Rome, Berkeley-Los Angeles 1984, p. 163; A. M. ECKSTEIN, Senate and General. Individual Decision Making andRoman Foreign Relations, 264-194 B.C., Berkeley-Los Angeles-London 1987, pp. 169-177; J.-M.DAVID, Le patronat judiciaire au dernier siècle de la République romaine (BEFAR, 277), Rome 1992,pp. 72-73; É. DENIAUX, Clientèles et pouvoir à l’époque de Cicèron (CEFR, 182), Roma 1992, p. 317;J. B. RIVES, Marcellus and the Syracusans, in CPh LXXXIII 1993, pp. 32-35; F. CANALI DE ROSSI,Le ambascerie del mondo greco a Roma in età repubblicana (Studi pubblicati dall’Istituto italiano perla storia antica, 63), Roma 1997, pp. 642-645, nr. 704; ID., Il ruolo dei patroni nelle relazioni poli-
418 REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D’ARCH. – VOL. LXXXII
di sé,45 tanto da essere celebrato nei Marcellia, festa con cui annualmente iSiracusani cum recentibus beneficiis C. Marcelli debitum reddebant, tum generi,nomini, familiae Marcellorum maxima voluntate tribuebant.46 C. Claudio Marcelloha rapporti di ospitalità con Stenio di Terme47 ed è tutor di Eio di Lilibeo,48
entrambi vittime di Verre. Egli ha dunque parecchi titoli per essere tra imembri del consilium quaestionis nel processo contro Verre;49 Cicerone, oltreche nelle Verrine,50 lo menziona, sempre con grande rispetto, anche in altresue opere.51
tiche fra il mondo greco e Roma in età repubblicana e augustea, Roma 2000, pp. 8-12; C. EILERS,Roman Patrons of Greek Cities, Oxford 2002, pp. 51-56, 156; LAZZERETTI 2006, pp. 85, 169, 257,427-428; E. DENIAUX, Liens d’hospitalité, liens de clientèle et protection des notables de Sicile à l’épo-que du gouvernement de Verrès, in La Sicile de Cicéron 2007, pp. 231-232; PRAG, Auxilia cit. (nota26), p. 94. Altri Claudii Marcelli legati alla Sicilia, oltre a M. Claudio Marcello e C. ClaudioMarcello, sono M. Claudio Marcello, figlio del conquistatore di Siracusa, pretore in Sicilianel 198 a.C. (MÜNZER 1899, coll. 2755-2757, nr. 222; BROUGHTON 1951-1952, I, p. 330 e II,p. 546; PRAG, Roman Magistrates cit. [nota 39], p. 294) e forseM. (Claudius) Mar(cellus?), que-store in Sicilia ante 50 a.C. (BROUGHTON 1951-1952, II, pp. 478 e 546).
45 CIC., In Verrem, II, 3, 212: alia sunt tua facta atque consilia summa laude digna, quibusillam tu provinciam adflictam et perditam erexisti atque recreasti.
46 CIC., In Verrem, II, 2, 51; deiMarcellia Cicerone parla anche in II, 2, 154 e in II, 4, 151.PLUT., Marcellus, 23, 11, afferma che, per i benefici concessi da Marcello ai Siracusani, que-sti « fecero una legge in base alla quale, quando Marcello o qualche suo discendente avessemesso piede in Sicilia, i Siracusani si sarebbero incoronati di fiori e avrebbero offerto sacri-fici agli dèi » (trad. di P. Fabrini). Sui Marcellia e gli altri onori siracusani, v. in particolareL. CERFAUX - J. TONDRIAU, Un concurrent du Christianisme: le culte des souverains dans la civilisa-tion gréco-romaine (Bibliothèque de Théologie, s. III, 5), Tournai 1957, pp. 280-281; BADIAN,Foreign Clientelae cit. (nota 44), p. 296, nt. P; A. LIPPOLD, Consules. Untersuchungen zur Geschi-chte des römischen Konsulates von 264 bis 201 v. Chr. (Antiquitas, 1, Abhandlungen zur altenGeschichte, 8), Bonn 1963, pp. 267-268; MANGANARO 1979, p. 416; D. FISHWICK, The ImperialCult in the Latin West. Studies in the Ruler Cult of the Western Provinces of Roman Empire (Étudespréliminaires aux religions orientales dans l’Empire Romain, 108), I,1, Leiden 1987, p. 46; RIVES,Marcellus cit. (nota 44); J.-L. FERRARY, De l’évergétisme hellénistique à l’évergétisme romain, in Actesdu Xe Congrès International d’Épigraphie Grecque et Latine, Nîmes, 4-9 octobre 1992, Paris 1997,pp. 207, 217; F. BERNSTEIN, Ludi Publici. Untersuchungen zur Entstehung und Entwicklung deröffentlichen Spiele im republikanischer Rom (Historia Einzelschriften, 119), Stuttgart 1998,pp. 325-326; CADARIO, I Claudi Marcelli cit. (nota 38), pp. 156-157; LAZZERETTI 2006, pp. 403-404, 427-428; C. BERRENDONNER, Verrès, les cités, les statues, et l’argent, in La Sicile de Cicéron2007, pp. 216-217.
47 CIC., In Verrem, II, 2, 110; su questo passo, v. E. DENIAUX, Les hôtes des Romains en Sicile,in Sociabilité, pouvoirs et société. Actes du colloque de Rouen 24/26 novembre 1983 (Publications del’Université de Rouen, 110), Rouen 1987, pp. 339-340.
48 CIC., In Verrem, II, 4, 37; inoltre i Marcelli in generale sono patroni di Eraclio di Sira-cusa (ibidem, II, 2, 36).
49 CIC., In Verrem, divinatio in Caecilium, 13; II, 4, 90; v. anche W. C. MCDERMOTT, The Ver-rine Jury, in RhM, n.s. CXX 1977, pp. 66-67, 73 («Both Marcellus and Peducaeus were
Alla luce di questi elementi, non sorprende, nelle Verrine, l’attestazionedi statue dei Claudii Marcelli, e di C. Claudio Marcello in particolare, nel forodi Tindari e in altre città siciliane (ceteris in oppidis Siciliae).52 Il monumentodi Tauromenio rientra chiaramente tra i monumenti onorifici menzionati daCicerone e non è da escludere che i Tauromenitani abbiano onorato C. Clau-dio Marcello non solo come governatore in carica e patronus, ma anche comediscendente del M. Claudio Marcello che aveva concesso (o rinnovato?) allaloro città il foedus con Roma.53 Se quest’identificazione è corretta, dunque, il
F. MUSCOLINO - I MONUMENTI DI OLYMPIS E DI C. CLAUDIO MARCELLO A TAORMINA 419
named as former governors of Sicily, but Marcellus was named also because of the ance-stral connection with the Sicilian expedition in the second Punic war »); BRUNT, Patronagecit. (nota 44), pp. 277-278; M. C. ALEXANDER, Trials in the Late Roman Republic. 149 BC. to 50BC (Phoenix, Supplementary Volume 26), Toronto 1990, p. 88, nr. 177; F. FONTANELLA, Il senatonelle Verrine ciceroniane fra teoria e prassi politica, in Athenaeum, XCII 2004, p. 21; LAZZERETTI
2006, pp. 66-68.50 CIC., In Verrem, divinatio in Caecilium, 13; II, 2, 8; II, 2, 51; II, 2, 110; II, 3, 42; II, 3, 212;
II, 4, 37 e 86-90.51 Nell’orazione Pro Sulla, 19, Cicerone dice che apud me parentis gravitatem … obtinebat
(v. commento in DAVID, Le patronat cit. [nota 44], p. 230); nel de Legibus (II, 13, 32-33) e nelde Divinatione (II, 35, 75) lo ricorda come augure e autore di un testo sulla scienza augu-rale. Nel 51 a.C., inoltre, Cicerone, proconsole in Cilicia, scrive una lettera a C. ClaudioMarcello per congratularsi della designazione del figlio per il consolato del 50 a.C. (adFamiliares, XV, 8, v. commento in DENIAUX, Clientèles cit. [nota 44], pp. 90 e 98); nella stessacircostanza, scrive una lettera di congratulazioni anche a C. Claudio Marcello iunior (adFamiliares, XV, 7). Nel 50 a.C. Cicerone invia dalla Cilicia altre due epistole a C. ClaudioMarcello iunior, sempre con espressioni elogiative (ad Familiares, XV, 10 e 11).
52 Equestres sunt medio in foro Marcellorum statuae, sicut fere ceteris in oppidis Siciliae. Ex qui-bus iste (Verres) Gai Marcelli statuam delegit (CIC., In Verrem, II, 4, 86); sulle statuae Marcellorumin Sicilia, v. in particolare G. A. MANSUELLI, Pagine di storia artistica della Sicilia: osservazioni alde signis ciceroniano, in M. L. GUALANDI - L. MASSEI - S. SETTIS (edd.), in APARCAI. Nuovericerche e studi sulla Magna Grecia e la Sicilia antica in onore di Paolo Enrico Arias, II, Pisa 1982,pp. 620-621; G. LAHUSEN, Goldene und vergoldete römische Ehrenstatuen und Bildnisse, inMDAI(R), LXXXV 1978, p. 385; ID., Untersuchungen zur Ehrenstatue in Rom. Literarische undepigraphische Zeugnisse (Archaeologica, 35), Roma 1983, p. 88; N. BONACASA, Le arti figurativenella Sicilia romana imperiale, in ANRW, II.11.1 1988, p. 310; J. BERGEMANN, Römische Reitersta-tuen. Ehrendenkmäler im öffentlichen Bereich (Beiträge zur Erschließung hellenistischer und kaiser-zeitlicher Skulptur und Architektur, 11), Mainz am Rhein 1990, p. 168, cat. L42; M. SEHLMEYER,Stadtrömische Ehrenstatuen der republikanischen Zeit. Historizität und Kontext von Symbolen nobi-litären Standesbewusstseins (Historia Einzelschriften, 130), Stuttgart 1990, p. 121; D. ERKELENZ,Optimo Praesidi. Untersuchungen zu den Ehrenmonumenten für Amtsträger der römischen Provinzenin Republik und Kaiserzeit (Antiquitas, 1, Abhandlungen zur alten Geschichte, 52), Bonn 2003,pp. 331-332, 336-338; CADARIO, I Claudi Marcelli cit. (nota 38), pp. 169-170; M. PAPINI, Anti-chi volti della Repubblica. La ritrattistica in Italia Centrale tra IV e II secolo a.C. (BCAR, suppl. 13),Roma 2004, pp. 364-365.
53 La concessione del foedus a Tauromenio è ricondotta a M. Claudio Marcello soprat-tutto sulla base di App., Sic., fr. 5. Vi è invece disaccordo sull’anno della concessione (pro-
420 REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D’ARCH. – VOL. LXXXII
monumento a C. Claudio Marcello può essere datato al 79 a.C., anno in cuiil personaggio fu proconsole in Sicilia.
Le Verrine ciceroniane, di poco posteriori a questa data, sono ricche dinotizie sulla prassi di erigere statue al governatore: sono menzionate variestatue erette a Verre mentre questi era in carica54 e spesso demolite al termine
babilmente il 212, o comunque un anno compreso tra il 214 e il 211 a.C.), a seconda chesi consideri il foedus concesso prima dell’espugnazione di Siracusa, per assicurarsi unimportante punto strategico, o dopo, per premiare Tauromenio di non aver contrastato iRomani e di non aver aiutato i Cartaginesi; v. E. PAIS, Alcune osservazioni sulla storia e sullaamministrazione della Sicilia durante il dominio romano, in ASS n.s. XIII 1888, pp. 135-136 e164-165; B. NIESE, Geschichte der griechischen und makedonischen Staaten seit der Schlacht bei Chae-ronea (Handbücher der alten Geschichte, 2), Gotha 1893 (rist. anast. Darmstadt 1963), II,p. 539; G. DE SANCTIS, Storia dei Romani, III.2, Torino 1916, pp. 308-310; H. HORN, Foederati.Untersuchungen zur Geschichte ihrer Rechtsstellung im Zeitalter der römisches Republik und desfrühen Principats, Frankfurt am Main 1930, p. 42, nt. 25; K. ZIEGLER, Tauromenion, in RE, V A1 1934, col. 30; L. PARETI, Storia di Roma e del mondo romano, II, La Repubblica dalla guerra conPirro ai prodromi di quella con Perseo (280-170 a.C.), Torino 1952, pp. 411-412; SARTORI 1954,p. 380; BADIAN, Foreign Clientelae cit. (nota 44), p. 37, nt. 3; S. N. CONSOLO LANGHER, Il sike-likon talanton nella storia economica e finanziaria della Sicilia antica, in Helikon III 1963, p. 414,nt. 114; G. MANGANARO, Tauromenitana, in ArchClass XV 1963, p. 25; S. CALDERONE, Problemidell’organizzazione della provincia di Sicilia, in Kokalos X-XI 1964-1965, pp. 88-90; A. J. TOYN-BEE, Hannibal’s Legacy. The Hannibalic War’s Effects on Roman Life, London 1965, II, p. 220;T. ARDIZZONE, Proagori in città siceliote, in Kokalos XIII 1967, p. 166, nt. 47; H. H. SCHMITT, DieStaatsverträge des Altertums, III, Die Verträge der griechisch-römischen Welt von 338 bis 200 v. Chr.,München 1969, pp. 256-257, nr. 534; M. GOLDSBERRY, Sicily and its Cities in Hellenistic andRoman Times, Ann Arbor 1973, pp. 234-235, 288-289, 636-637; DE SENSI SESTITO, Gerone II cit.(nota 36), p. 415; ECKSTEIN, Senate cit. (nota 44), pp. 106, 108-109; R. MARINO, La Sicilia dal241 al 210 a.C. (Testimonia Siciliae antiqua, I, 12; Suppl. a Kokalos, 7), Roma 1988, pp. 16,170; LAZZERETTI 2006, pp. 18-19, 127. Secondo A. PINZONE, Sulle civitates foederatae di Sicilia:problemi di storia e cronologia, in ID., Provincia Sicilia. Ricerche di storia della Sicilia romana daGaio Flaminio a Gregorio Magno (Testi e studi di storia antica, 7), Catania 1999 (già in ASM,s. III, XXIX 1978, pp. 353-379), pp. 75-77, Marcello avrebbe solo rinnovato un foedus giàstabilito tra Roma e Tauromenio in quanto alleata di Ierone II. W. DAHLHEIM, Gewalt undHerrschaft. Das provinziale Herrschaftssystem der römischen Republik, Berlin-New York 1977,pp. 175-176 pensa invece che Appiano non si riferisca al foedus, ma alla deditio di Tauromenio.
54 In varie città siciliane e a Roma (CIC., In Verrem, II, 2, 50, 141-145, 150, 154, 157-168;ibidem, II, 4, 138-139). Sui monumenti a Verre v., in particolare, LAHUSEN, Untersuchungencit. (nota 52), pp. 84-87; J. P. ROLLIN, Untersuchungen zu Rechtsfragen römischer Bildnisse(Habelts Dissertationsdrucke, Reihe klassische Archäologie, 11), Bonn 1979, pp. 5-6; LTUR, II1995, s.v. Equus: C. Verres, p. 232 (E. Papi); BERGEMANN, Römische Reiterstatuen cit. (nota 52),p. 158, cat. L15; p. 168, cat. L41 e L43; SEHLMEYER, Stadtrömische Ehrenstatuen cit. (nota 52),pp. 175 e 213; V. FARINELLA, «Memoria damnata »: la distruzione delle immagini, del nome e delricordo, in S. SETTIS (ed.), Civiltà dei Romani. Il potere e l’esercito, Milano 1991, p. 184; J. TAN-NER, Portraits, Power and Patronage in the Late Roman Republic, in JRS XC 2000, pp. 32-35, 48-49; ERKELENZ, Optimo Praesidi cit. (nota 52), pp. 338-340; LAZZERETTI 2006, pp. 257-258, 409-410; BERRENDONNER, Verrès cit. (nota 46).
del suo mandato, tanto che, se L. Cecilio Metello, successore di Verre,55 nonlo avesse proibito, vestigium statuarum istius in tota Sicilia nullum esset relictum.56
Proprio a Tauromenio, in foro, quindi forse a poca distanza dal monumentoa C. Claudio Marcello, era stata eretta a Verre una statua che fu abbattuta,lasciando però al suo posto la base quod gravius in istum fore putabant si scirenthomines statuam eius a Tauromenitanis esse deiectam quam si nullam umquam posi-tam esse arbitrarentur.57
Anche l’epigrafe del monumento a C. Claudio Marcello (fig. 7 e 10),le cui lettere hanno un’altezza media di cm 3/3,5 e sono accuratamenteincise con solchi profondi, non presenta particolari problemi interpreta-tivi, se si eccettua il G (figg. 8-9) che, secondo la maggior parte delle tra-scrizioni, sarebbe l’unica lettera dell’ultima riga ma che, a un’analisi accu-rata, si rivela di incerta lettura.58 Solo il tratto orizzontale, lungo cm 4,5, è,infatti, ben inciso; il tratto verticale ha una lunghezza di circa cm 6,5, maè meno profondo e non è facile distinguerlo, nella sua parte terminale, dauna solcatura della pietra; proprio per la sua evanescenza, non è neanchepossibile indicarne la lunghezza precisa. Quello orizzontale, dunque,potrebbe essere semplicemente un tratto posto più o meno al centro dellaseconda riga dell’iscrizione o la parte superiore di una lettera incom-piuta,59 all’inizio di una parola mai scritta.60 Sin dagli eruditi settecente-
F. MUSCOLINO - I MONUMENTI DI OLYMPIS E DI C. CLAUDIO MARCELLO A TAORMINA 421
55 BROUGHTON 1951-1952, II; p. 538.56 CIC., In Verrem, II, 2, 160; sull’abbattimento delle statue di Verre in Sicilia, v. anche ibi-
dem, 158: De quo hoc homine auditum est umquam, quod tibi accidit, ut eius in provincia statuae inlocis publicis positae, partim etiam in aedibus sacris, per vim et per universam multitudinem deiceren-tur? ... Non crederem hoc de statuis nisi iacentis revulsasque vidissem.
57 CIC., In Verrem, II, 2, 160. Oltre che a Tauromenio, statue di Verre sono abbattute aTindari (II, 2, 160 e II, 4, 90), Lentini (II, 2, 160), Siracusa (II, 2, 160).
58 Il ricalco eseguito con la carta velina e il carboncino è fuorviante, perché restituiscela sagoma di un gamma (fig. 9) con una chiarezza che l’osservazione a occhio nudo e lafotografia (fig. 8) rivelano ingannevole.
59 Le lettere possibili sono G E Z X P S T. Ammettendo che il solco verticale sia dav-vero antico, le possibilità si ridurrebbero a G, E e P. All’interpretazione del tratto orizzon-tale come parte di una lettera ostano la sua lunghezza e il fatto che la nuova riga inizie-rebbe in una posizione piuttosto sfalsata rispetto alle due righe superiori.
60 Tale presunta lettera è stata, forse non casualmente, omessa da Müller, ma inseritada Franz in CIG III 5644, con l’osservazione: «Ea quid sibi velit, non liquet. Videndum nefuerit P (p£trwn) », dato che i Claudii Marcelli erano patroni della Sicilia. Proposta sugge-stiva, ma non dimostrabile per le difficoltà di lettura evidenziate. Kaibel in IG XIV 435 silimita a trascrivere il segno come G, rinunziando alle ipotesi (« quid significet mihi obscu-rum est ») e precisando: «notavi describens, MAARKELLOS nomen et G litteram sub-scriptam ab alia manu addita esse ». Molto cautamente, si potrebbe suggerire che il trattoverticale del presunto gamma sia un’ingenua “ falsificazione ” moderna (settecentesca?),per corroborare la lettura g(umn£siarcoj).
422 REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D’ARCH. – VOL. LXXXII
Fig. 7. Apografo dell’iscrizione di C. Claudio Marcello
Fig. 8. Particolare dell’iscrizione di C. ClaudioMarcello (fotografia)
Fig. 9. Particolare dell’iscrizione di C. ClaudioMarcello (ricalco)
Fig. 10. Base di C. Claudio Marcello (faccia anteriore)
schi,61 il presunto G è stato spesso considerato come iniziale della parolagumn£siarcoj:62 la stranezza di questa interpretazione non deve sorpren-dere, dato che il primo importante documento noto dell’epigrafia tauro-menitana è la tavola dei ginnasiarchi (IG XIV 422).63 Tra gli studiosimoderni, l’unico ad aver proposto, seppure implicitamente, un’interpre-tazione del presunto G è Manganaro, che lo considera un numerale.64
Un’altra particolarità dell’iscrizione, la dittografia aa per © (Ma£rkou
per M£rkou e Ma£rkelloj per M£rkelloj), è comune, soprattutto tra il IIe la metà del I sec. a.C., specialmente nella traslitterazione in greco di nomilatini.65 In Sicilia, la grafia M£arkoj compare nel decreto sulla sugg≤neia traCenturipe e Lanuvio66 e in un’iscrizione di Siracusa67 con cui i technitai diAfrodite onorano M. Acilio M. f. Canino, proconsole in Sicilia nel 46-45 a.C.68
Molto numerosi sono gli esempi nelle epigrafi greche69 e latine.70
F. MUSCOLINO - I MONUMENTI DI OLYMPIS E DI C. CLAUDIO MARCELLO A TAORMINA 423
61 V. i documenti citati in Appendice e, soprattutto, CARTELLA, Lettera cit. (nota 15),p. 149; CARTELLA, Discorso cit. (nota 16), pp. 223-224; SESTINI, Lettere cit. (nota 18), p. 56 e,in via ipotetica, TORREMUZZA, Siciliae cit. (nota 17), p. 108, nr. 9.
62 C. Claudio Marcello è ancora considerato come ginnasiarca da RIZZO 1893, pp. 26, 35-37 (che rivede la sua interpretazione alla luce di IGXIV in RIZZO 1904, pp. 111-112), e da varistudiosi taorminesi, quali E. STRAZZERI, Uomini illustri di Taormina. Bozzetti storici, Giarre 18962,pp. 76-77; P. RIZZO, Tauromenion (Taormina). Storia, topografia, monumenti, monete, Riposto 1928(rist. anast. Caltanissetta-Roma 1983), pp. 88, 153; CIPOLLA, C’era una volta Taormina cit. (nota3), pp. 99, 263; ID., Toponomastica tauromenitana, Catania 1988, p. 314.
63 Sull’editio princeps di quest’iscrizione, v. F. MUSCOLINO, Giovanni di Giovanni, le epigrafi gre-che di Taormina e il carteggio con Ludovico Antonio Muratori, in ZPE CLXVII 2008, pp. 119-134.
64 MANGANARO 1979, p. 443, scrivendo che «Tauromenium innalzò una serie di almenotre basi inscritte » a Claudio Marcello, sembra considerare il presunto G come un numerale.
65 Su tale fenomeno v. almeno FRANZ, Elementa cit. (nota 28), p. 248 (che cita tra gli esempiproprio questa iscrizione); T. ECKINGER, Die Orthographie lateinischer Wörter in griechischen Insch-riften, München [1893], pp. 8-11; M. LEUMANN, Lateinische Laut- und Formenlehre (Handbuch derAltertumswissenschaft, II.2.1), München 19772, pp. 12-13, § 12; SCHULZE, Zur Geschichte cit. (nota37), p. 464, nt. 6; R. L. LAZZERONI, Contatti di lingue e di culture nell’Italia antica: il patronimico nellaformula onomastica, in SSL XIV 1974, pp. 295-297; B. VINE, Studies in Archaic Latin Inscriptions(Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, 75), Innsbruck 1993, p. 277.
66 V., con bibl. prec., L. DUBOIS, Inscriptions grecques dialectales de Sicile. Contribution à l’é-tude du vocabulaire grec colonial (CEFR, 119), Rome 1989, p. 225, nr. 185 e SEG LII 888, l. 9:LeÚkioj K£ptioj Ma£rkou uƒÕj, I sec. a.C.; ibidem anche Ma£rkioj Ko…ntou uƒÕj.
67 G. V. GENTILI, Nuovi elementi di epigrafia siracusana, in ArchStorSir VII 1961, pp. 11-15,nr. 1, fig. 4 e L. MORETTI, I technitai di Siracusa, in RFIC XCI 1963, p. 41, ll. 3-4: Ma£rkwi
'Aki[l…wi M(a£rkou)] | uƒîi Kan…[nwi] e ll. 9-10: [M£arkoj] | 'Ak…lioj Ma£rkou [uƒÕj
Kan‹noj].68 BROUGHTON 1951-1952, II, pp. 296, 308.69 Tra le attestazioni non siciliane, v., ad es., SEG LII 575, l. 1, da Apollonia in Illiria,
« Late Hellenistic period »; SEG LII 501 = P. PERDRIZET, Inscriptions d’Acræphiæ, in BCH XXIII1899, p. 93, l. 26, da Akraiphia, II sec. a.C.; SEG LV 743 = L. D. LOUKOPOULOU - M. G. PARIS-
424 REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D’ARCH. – VOL. LXXXII
L’autopsia della base onoraria ha permesso di notare che il blocco dipietra rossa di Taormina, largo cm 92,5, profondo cm 74/78, alto cm 33, èincompleto, perché il lato opposto a quello con l’iscrizione presenta chiarisegni di una frattura, mentre gli altri tre lati sono levigati. Sono presenti,inoltre, incavi sia sulla faccia superiore, sia su quella inferiore, entrambelevigate. È chiaro, dunque, che il blocco è stato impiegato due volte, anchese, non conoscendo le modalità esatte del ritrovamento, non è possibileprecisare se la base sia stata dedicata prima a C. Claudio Marcello e poi,capovolta, sia stata utilizzata per un’altra dedica, o viceversa. Al di sotto del-l’iscrizione non è possibile individuare alcuna traccia di un testo prece-dente: o esso è stato abraso, levigando tutta la faccia del blocco, oppure sitrovava sulla faccia opposta, perduta a causa della frattura; non vi è alcunatraccia di iscrizione né sul lato sinistro né su quello destro. La faccia infe-
SAKI - S. PSOMA - A. ZOURNATZI, Inscriptiones antiquae partis Thraciae quae ad ora maris Aegaeisita est (praefecturae Xanthes, Rhodopes et Hebri), Athenis 2005, p. 353, cat. E178, ll. 3-4, daMaronea, II sec. a.C.; SEG XLV 607, ll. 7-8, da Kierion, inizi II sec. a.C.; SEG XXXIV 909, l.14, da Istiea, seconda metà del II-inizi del I sec. a.C.; SEG XXXVIII 487, II, l. 48, daButrinto, ca. 220-170/160 a.C.?; SEG XXXVI 555, l. 8, da Kassope, poco dopo il 129 a.C.;SEG XXIX 806, ll. 18-19, da Calcide, 120-100 a.C.; SEG XXI 477, III, l. 94, da Atene, 119/8a.C.; SEG XLI 516, l. 1, da Delfi, ca. 110 a.C.; SEG L 572, ll. 3-4, da Apollonia (Mygdonia),106 a.C.; SEG L 663 = A. ŁAJTAR, Die Inschriften von Byzantion (Inschriften griechischer Städte ausKleinasien, 58), I, p. 104, nr. 98, da Bisanzio, ca. 100 a.C.; SGDI III.1 3527, l.3 = SEG LIII1223, da Cnido, I sec. a.C.; SEG XXV 584, l. 29, da Delfi, 98/7 a.C.; SEG LII 1059, l. 22, daLagina, 81 a.C.; SEG XLVII 1137, l. 4, da Mesambria Pontica, ca. 72/71 a.C.; SEG XLII 575,l. 2, da Europos, ca. 40-31 a.C. Molto numerose le attestazioni a Delos, v. ad es. I. Délos 1427= SEG XXXVII 694, l. 3, ante 150 a.C.; 1732, l. 7, 150-125 a.C.; 1731, l. 5, ca. 140 a.C.; 1730,ll. 2 e 5, ca. 125 a.C.; 1733, ll. 8-9, ca. 125 a.C.; 1753, ll. 3-4, 6, 8, 113 a.C.; 1754, l. 13, fineII sec. a.C.; 1741, fine II sec. a.C.; 1771 = CIL I.22 2235, ll. 1, 4-5, fine II sec. a.C.; 1688, l. 1,ca. 100 a.C.; 1769, l. 4, ca. 100 a.C.; 1755, ll. 2 e 8, ca. 100 a.C.; 1766, ll. 3-4, 5-6, ca. 100a.C.; 1700, ll. 1-2, inizi del I sec. a.C.; 1764, ll. 6 e 15, 93 a.C.; 1758, ll. 1 e 11, 74 a.C. La gra-fia ricorre anche nel dossier epigrafico dei Cossutii, databile tra II e I sec. a.C. (v. E. RAWSON,Architecture and Sculpture: the Activities of the Cossutii, in PBSR XLIII 1975, pp. 36-47 e M.TORELLI, Industria estrattiva, lavoro artigianale, interessi economici: qualche appunto, in MAARXXXVI 1980, pp. 313-323): IG III.2 2873 = IG II-III2 10154, ad Atene, ca. 150 a.C. (Torelli);I. Délos 1739, l. 4, ca. 125 a.C.; IG XIV 1249 a, ll. 1-4, da Lanuvio; IG XIV 1249 b, ll. 1-4, daLanuvio; IG XIV 1250, ll. 1-3, a Roma; IG XII.5 1049, a Paros, età tardo-repubblicana(Torelli). È curioso osservare come in un’iscrizione di Eretria (IG XII suppl. 557), secondametà del II-inizi del I sec. a.C. (Torelli), coesistano M£rkoj KossoÚtioj (r. 25) e M£arkoj
Korn»lioj (r. 56).70 Un esempio dubbio di dittografia è proprio CIL I.22 662 a-b (v. supra nota 39), in cui
Aarcello potrebbe essere corretto in <M>aarcello, anche se la correzione <M>arcello sembrapreferibile (VINE, Studies cit. [nota 65], p. 277, nt. 31). Tra le epigrafi latine o bilingui, v.,ad es., CIL I.22 747, l. 1: Q · Maarcium; l. 3 Ko…nton Ma£rkio[n], da Delos, 68 a.C.; CIL I 1006= CIL I.22 1202, l. 2: Maarco · Caicilio (da Roma).
F. MUSCOLINO - I MONUMENTI DI OLYMPIS E DI C. CLAUDIO MARCELLO A TAORMINA 425
riore (figg. 11-13)71 presenta invece due incavi in posizione sfalsata (quello adestra più arretrato, l’altro più avanzato), di forma pressappoco rettangolare,con la parte destra più profonda di quella sinistra (fig. 14). Data la dimen-sione, la profondità e la reciproca distanza, i due incavi difficilmente possonoaver sostenuto una statua umana, tranne che questa non abbia avuto pro-porzioni colossali. Un’altra ricostruzione, altamente ipotetica data la fram-mentarietà delle nostre informazioni, merita comunque di essere proposta.In base all’interpretazione sopra avanzata, la faccia inferiore potrebbe esserela parte posteriore di un monumento; in tal caso, sarebbe suggestivo ipotiz-zare che i due incavi abbiano ospitato le zampe posteriori di un cavallo e chela faccia inferiore sia quanto rimane del piano d’appoggio di un monumentoequestre, presumibilmente bronzeo.72 Dall’età ellenistica in poi, il cavallo neimonumenti equestri può essere raffigurato o impennato, o stante, o, più fre-quentemente, al passo con una zampa anteriore alzata.73 La prima posizionesembra da escludere per l’ipotetico monumento tauromenitano: nelle raffi-gurazioni di cavalli impennati, le zampe posteriori sono in genere quasi sullastessa linea, o comunque ravvicinate,74 mentre la posizione sfalsata meglio siadatta per una raffigurazione al passo. Il confronto con i monumenti eque-stri conservati o con i loro basamenti permette di constatare che i cavalli sonoraffigurati costantemente con la zampa posteriore sinistra avanzata rispetto a
71 Nella descrizione si indica, convenzionalmente, come ‘superiore’ la faccia su cuipoggiava il monumento a C. Claudio Marcello, come ‘inferiore’ la faccia opposta. Attual-mente (2010) l’iscrizione è capovolta perché al momento della sua collocazione si è fattaattenzione alla parte con gli incavi più vistosi, che non è quella in fase con la dedica a C.Claudio Marcello. Le macchie in basso a sinistra (figg. 11-12), sono dovute all’impropriouso della base come piano di appoggio per lavori di verniciatura. Lo studio dell’altra fac-cia è stato possibile perché il blocco è sollevato dal pavimento mediante due assi, chehanno permesso una parziale visione, sulla quale si basano la descrizione proposta neltesto e il disegno schematico (fig. 15). Dato il notevole peso, non è stato possibile capo-volgere il blocco; sarà dunque necessario attendere il riordino dell’Antiquarium, attual-mente chiuso al pubblico e trasformato in deposito.
72 La conformazione irregolare degli incavi, in particolare, fa propendere per unmonumento di bronzo. Del resto, tale materiale è il più attestato per i monumenti eque-stri; v., almeno, SIEDENTOPF 1968, in particolare pp. 65, 83-88; F. CHAMOUX, I monumenti eque-stri in Grecia, in A. MELUCCO VACCARO - A. MURA SOMMELLA (edd.), Marco Aurelio. Storia di unmonumento e del suo restauro, Milano 1989, p. 57; BERGEMANN, Römische Reiterstatuen cit. (nota52), pp. 20-22.
73 SIEDENTOPF 1968, in particolare pp. 65-72; CHAMOUX, I monumenti equestri cit. (nota72), p. 57; G. CALCANI in EAA, secondo supplemento, III, 1995, pp. 769-774, s.v.Monumentoequestre.
74 SIEDENTOPF 1968, in particolare pp. 65-68, e anche H. VON ROQUES DE MAUMONT, AntikeReiterstandbilder, Berlin 1958, figg. 11, 15, 20, 23, 30, 33, 50.
426 REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D’ARCH. – VOL. LXXXII
Fig. 11. Base di C. Claudio Marcello: facce anteriore e ‘inferiore’
Fig. 12. Base di C. Claudio Marcello: faccia‘inferiore’ (foto)
Fig. 13. Base di C. Claudio Marcello: faccia‘inferiore’ (disegno)
F. MUSCOLINO - I MONUMENTI DI OLYMPIS E DI C. CLAUDIO MARCELLO A TAORMINA 427
Fig. 14. Base di C. Claudio Marcello: sezione degli incavi della faccia‘inferiore’
Fig. 15. Base di C. Claudio Marcello: faccia ‘superiore’(disegno schematico)
quella posteriore destra,75 proprio come lasciano supporre i due incavi sullabase in esame.76 L’iscrizione, inoltre, è in genere collocata sul lato breve fron-tale,77 il che spiegherebbe l’assenza di tracce di un’iscrizione relativa al pre-sunto monumento equestre: poiché, secondo la ricostruzione proposta, si èconservata la parte posteriore del monumento, l’iscrizione era sul lato oppo-sto, andato perduto. La peculiare conformazione dell’incavo sarebbe dovutaalla necessità di ospitare il perno o la staffa per fissare lo zoccolo del cavalloalla base.78
Non è possibile precisare se il basamento fosse composto da un unicoblocco rettangolare, spezzatosi all’incirca a metà, oppure da due blocchi, deiquali uno scomparso, l’altro giuntoci mutilo, anche se la presenza della frat-tura fa propendere per la prima ipotesi;79 non vi sono, invece, elementi néper proporre una ricostruzione della lunghezza del basamento,80 né per rico-struirne l’aspetto, anche se è probabile che la porzione di blocco conservatafosse il coronamento di una struttura più alta.81
Se è corretta l’interpretazione sopra avanzata, anche quello a C. ClaudioMarcello potrebbe essere stato un monumento equestre. Tale proposta nondeve sorprendere, alla luce del passo ciceroniano già ricordato: a Tindariequestres sunt medio in foro Marcellorum statuae, sicut fere ceteris in oppidis Siciliae, ein questa Reitergalerie era inclusa una statua equestre dello stesso personaggio
428 REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D’ARCH. – VOL. LXXXII
75 Tale posizione delle zampe posteriori si ripete su monumenti equestri, sia di pietrasia di bronzo, come si ricava dalle principali opere complessive sull’argomento, tra cui VON
ROQUES DE MAUMONT, Antike Reiterstandbilder cit. (nota 74); SIEDENTOPF 1968; BERGEMANN,Römische Reiterstatuen cit. (nota 52).
76 Numerosi i confronti in SIEDENTOPF 1968; v., in particolare, pp. 68-72, fig. 18.77 V. almeno SIEDENTOPF 1968, kat. II, nrr. 29, 36 (fig. 12), 43 (fig. 13), 45a-45b (fig. 10),
46-54, 65, 67 (fig. 14), 69, 70 (fig. 16), 71, 74-75, 76 (fig. 15), 77-82, 85, 100, 125-128, 130,132-134, 136, 175-176, 183, 185, 190.
78 Un esempio di zoccolo con un tassello sottostante è in BERGEMANN, Römische Reiter-statuen cit. (nota 52), cat. P67, tav. 87d. Come si evince dalla sezione (fig. 14), gli incavisembrano essere stati realizzati in due fasi: entrambi, infatti, hanno la parte sinistra menoprofonda di quella destra. Sembra, cioè, che sia stata realizzata prima la parte sinistra diciascun incavo, poi allargata verso destra. Tale allargamento potrebbe essere la traccia didue fasi successive di utilizzo, oppure potrebbe essere dovuto alla necessità di ampliare gliincavi in corso d’opera per meglio ospitare i perni della statua, poi fissati all’interno delblocco con materiale cementizio.
79 Gli esempi di monumenti poggianti su un unico blocco sembrerebbero i più nume-rosi, a giudicare dal catalogo in SIEDENTOPF 1968, anche se non mancano basamenti com-posti da due blocchi a volte tra loro connessi mediante grappe, come ad es. SIEDENTOPF
1968, kat. II, nrr. 71 (fig. 17c); 76 (fig. 15); 85 (fig. 18c).80 Le proporzioni dei monumenti conservati per intero sono, infatti, piuttosto variabili,
pur essendo costante la forma rettangolare (SIEDENTOPF 1968, p. 71).81 V., ad es., SIEDENTOPF 1968, kat. II, nrr. 45a (fig. 10); 67 (fig. 14); 76, (fig. 15).
F. MUSCOLINO - I MONUMENTI DI OLYMPIS E DI C. CLAUDIO MARCELLO A TAORMINA 429
onorato a Tauromenio.82 Un incavo, parzialmente conservato in prossimitàdella frattura, a una notevole distanza dal lato con l’iscrizione, potrebbe averospitato la zampa anteriore sinistra del cavallo, poggiata al suolo, mentre ladestra era alzata.83 Di interpretazione più incerta un altro incavo lungo uno deilati, in prossimità della frattura, mentre sono ben leggibili le tracce di incaviper due grappe sui lati,84 anche se non è possibile precisare se esse siano in fasecon l’utilizzo del blocco come monumento a C. Claudio Marcello, o se sianoattribuibili a un reimpiego. Qualora le grappe fossero contemporanee delmonumento, si potrebbe ipotizzare che il blocco fosse inserito in una strutturamuraria, come, forse, il monumento di Olympis.
IL LUOGO DI RINVENIMENTO
Dati utili per una più precisa collocazione del luogo in cui nel 1770furono rinvenute le due basi sono offerti dalle scarne ma precise notizie deicontemporanei, mentre gli scavi compiuti nell’area dagli anni ’60 del secoloscorso hanno fornito indizi per una migliore comprensione del contesto ori-ginario. Per cercare di individuare l’area interessata dai lavori edilizi che, nel1770, portano alla scoperta delle due epigrafi, è necessario riconsiderarel’antica conformazione del Monastero o Badia di Valverde. Tale complessobordava, sui lati nord ed est, una piazza che, sebbene oggi intitolata ufficial-mente a Vittorio Emanuele II, è ancora conosciuta come “piazza Badia ”. Lachiesa occupava l’estremità meridionale del lato est, mentre la restante partedel lato orientale e tutto il lato settentrionale erano occupati dal Monastero(fig. 16). Poiché il nucleo più antico, risalente a quanto pare al XIII secolo,85
doveva essere quello più vicino alla chiesa, si può dedurre che l’ampliamento
82 CIC., In Verrem, II, 4, 86; v. nota 52.83 Per le impronte di statue equestri con la zampa anteriore sinistra poggiata e la destra
sollevata o appena poggiata, v., ad es., SIEDENTOPF 1968, kat. II, 67 (fig. 14), 125 (fig. 18a),135 (fig. 18b), 183 (fig. 18d); tra le statue conservate, v., ad es., BERGEMANN, Römische Reiter-statuen cit. (nota 52), cat. P4, tavv. 2a, 5a, 12a, (monumento da Melos al Museo Nazionaledi Atene, marmo, fine II-I sec. a.C.); cat. P35, tav. 68 (monumento da Pompei al MuseoNazionale di Napoli, bronzo, prima età augustea); cat. P12, tavv. 20, 21 (monumento diCastel Gandolfo, marmo, età traianea o adrianea); cat. P27, tavv. 50-51 (monumento daRoma al British Museum, marmo, età traianea o adrianea); cat. P51, tav. 78 (Marco Aure-lio del Campidoglio, bronzo, post 162 d.C., forse età di Commodo).
84 Nella fig. 15 la parte di questi due incavi indicata con il tratteggio non è visibile per-ché coperta dalle assi utilizzate per sollevare il blocco da terra.
85 G. DI GIOVANNI - P. GRIMA, Storia ecclesiastica di Taormina, Palermo 1870, pp. 242-243;l’archivio del Monastero, conservato presso l’Archivio di Stato di Messina, Corporazioni Reli-giose Soppresse, è composto da 92 unità datate tra il 1455 e il 1866.
430 REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D’ARCH. – VOL. LXXXII
settecentesco abbia portato alla costruzione o al prolungamento verso Ovestdell’ala settentrionale dell’edificio, forse fino all’altezza dell’odierno corsoUmberto. Allo stato attuale della ricerca non è possibile escludere nessunadelle ipotesi.86 Poter ricostruire con più precisione le fasi edilizie del mona-stero porterebbe a una più esatta definizione del luogo di rinvenimento delledue basi perché, secondo un contemporaneo, esse furono rinvenute «nelcavarsi il pidamento pell’ampliazione del nostro Monastero … nel luogo oveal presente si ritrova situato il nuovo Portone di d(ett)o M(on)astero ».87 Acausa della nostra lacunosa conoscenza, è possibile formulare solo ipotesi sulluogo di rinvenimento, riconsiderando le tormentate vicende edilizie delcomplesso monumentale.
Dopo l’eversione dell’asse ecclesiastico nel 1866-1867,88 il Monastero futrasformato in Caserma dei Carabinieri, destinazione che mantiene tuttora,mentre la chiesa divenne un Teatro dedicato a Margherita di Savoia; lungo ilfianco nord dell’ex chiesa fu realizzato un mercato coperto, che cancellò lacontinuità tra la Chiesa e l’ala settentrionale dell’edificio. Tale situazione,che probabilmente conserva ancora vari elementi della fase settecentesca89
ed è documentata da una fotografia del 1959 (fig. 16),90 si mantiene fino aquell’anno, quando inizia la demolizione dell’ex chiesa, del mercato e del-
86 Il Monastero doveva essere stato ingrandito già in precedenza, perché una partedelle rendite del soppresso Collegio Gesuitico è assegnata, nel 1669, « alla fabbrica delVenerabile Monastero di donne … sotto il titolo di S. Maria di Valverde » (DI GIOVANNI -GRIMA, Storia ecclesiastica cit. [nota 85], p. 242). Esso, inoltre, già prima dell’ampliamentodel 1770, è così ampio da ospitare « la maggior parte delle Donne, e gentildonne » di Taor-mina il 25 giugno 1719 quando, dopo la battaglia di Francavilla, si temeva l’assedio daparte degli Imperiali (v. F. MUSCOLINO, Taormina, 1713-1720: la « relazione istorica » di VincenzoCartella e altre testimonianze inedite, edizione elettronica a cura della redazione di “Mediter-ranea. Ricerche storiche ”, on line su www.mediterranearicerchestoriche.it, Palermo 2009,p. 19).
87 V. Appendice, doc. 7.88 Regio decreto 7 luglio 1866, nr. 3036 per la soppressione degli ordini e delle cor-
porazioni religiose e legge 15 agosto 1867, nr. 3848 per la liquidazione dell’asse ecclesia-stico.
89 Il balcone al centro della facciata, difficilmente ammissibile per un convento di clau-sura, sembra una modifica posteriore; la porta che dà sul balcone sembra una finestraopportunamente ampliata; le finestre al piano terra, collocate molto in alto rispetto allapiazza, potrebbero essere ancora quelle del Monastero. Il balcone a sinistra e il locale pub-blico sottostante sono evidentemente modifiche successive al cambio d’uso dell’edificio.La facciata del Teatro Margherita, anche se quasi interamente moderna, ha però mante-nuto il portale della chiesa.
90 La fotografia si data con notevole precisione, perché a sinistra del portone del Tea-tro Margherita è visibile un manifesto con il programma del XVI Congresso EucaristicoNazionale, tenutosi a Catania dal 6 al 16 settembre 1959.
F. MUSCOLINO - I MONUMENTI DI OLYMPIS E DI C. CLAUDIO MARCELLO A TAORMINA 431
l’estremità Est dell’ala settentrionale dell’edificio (fig. 17)91 per costruire ilPalazzo dei Congressi (fig. 18).
Nella foto del 1959 (fig. 16), l’ala settentrionale ha due portoni: unodecentrato verso est, l’altro al centro, in posizione simmetrica rispetto allefinestre del primo e del secondo piano e alle due paraste che scandisconola facciata. Entrambi i portoni sono identici, ma la loro conformazione adarco a sesto ribassato ha un aspetto “ neo-medievale ” attribuibile a un inter-vento otto/novecentesco. Poiché è improbabile che un convento di mona-che di clausura abbia avuto due portoni ravvicinati prospicienti una pub-blica piazza, uno solo dei portoni può essere attribuito al Monastero; tra idue, è più verosimile che il portone originario sia quello al centro, ancoraoggi esistente.92 Secondo questa ricostruzione, le due basi onorarie sareb-bero state trovate in corrispondenza del punto dove sorge l’attuale portonedell’edificio su piazza Vittorio Emanuele II (fig. 20, nr. 1), pochi metri piùa sud del luogo in cui nel 1978 furono rinvenute le basi di altri due monu-menti onorari.93
Ammettendo, però, che solo l’estremità ovest 94 dell’ala settentrionaledel Monastero sia frutto dell’ampliamento settecentesco, il « nuovo por-tone », e di conseguenza il punto di rinvenimento, andrebbero spostatiqualche metro più a ovest, in corrispondenza della facciata dell’edificio sul-l’attuale corso Umberto (fig. 20, nr. 2) o presso l’estremità occidentaledella facciata sulla piazza (fig. 20, nr. 3). La radicale trasformazione subitadall’edificio in questo punto, con l’inserimento di locali pubblici e la rea-lizzazione di diverse nuove aperture sul corso Umberto, ha però cancellatotracce di eventuali portoni preesistenti. A titolo di semplice ipotesi, è piùprobabile che un eventuale « nuovo portone » fosse sul corso Umberto (fig.20, nr. 2), piuttosto che sulla piazza (fig. 20, nr. 3), perché in quest’ultimocaso sarebbe stato in una posizione fortemente decentrata e asimmetricarispetto alla facciata.
Una terza ala del Monastero, visibile in uno stralcio catastale anteriorealla demolizione del 1959 (fig. 19), sorgeva a nord della Chiesa. Sebbene non
91 Una fotografia molto simile a questa, con la demolizione in corso ma senza camione operai al lavoro, è pubblicata da S. LO RE, Le tre perle. I Palazzi Medioevali Corvaia – Duchidi Santo Stefano – Badia Vecchia, Taormina 2004, p. 47.
92 Il portone decentrato potrebbe essere stato realizzato in occasione di un rimaneg-giamento otto/novecentesco che alterò l’aspetto dell’altro portone, quello originario,senza però modificarne la posizione.
93 V. infra.94 Tale ipotetico ampliamento potrebbe iniziare dalla più occidentale tra le due para-
ste che scandiscono la facciata sulla piazza.
432 REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D’ARCH. – VOL. LXXXII
Fig. 16. Piazza Vittorio Emanuele II o “ piazza Badia ” nel 1959
Fig. 17. I lavori di demolizione del Teatro Margherita, già Chiesa di Santa Maria di Valverde, e delmercato coperto
F. MUSCOLINO - I MONUMENTI DI OLYMPIS E DI C. CLAUDIO MARCELLO A TAORMINA 433
Fig. 18. Piazza Vittorio Emanuele II o “ piazza Badia ” nel 2009
Fig. 19. Stralcio catastale ante 1959(70 e 73. Ex monastero di Valverde; 74. Mercato coperto; 76. Teatro Margherita)
434 REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D’ARCH. – VOL. LXXXII
Fig. 20. L’edificio pubblico (bouleuterion?) con le basi dei due Nymphodoros (da BACCI 1980-1981,tav. 169) e i probabili luoghi di rinvenimento delle basi di Olympis e C. Claudio Marcello
(nrr. 1, 2 e 3)
sia stato possibile trovare altre testimonianze sull’aspetto di quest’ala, sembrada escludere che sia frutto dell’ampliamento del 1770, soprattutto perché inessa sarebbe difficile immaginare un «nuovo portone »: a ovest, infatti, l’alaprospettava su un’area cortilizia interna al Monastero, a est era sovrastatadalle pendici di una collinetta, per cui la scelta di ubicare il nuovo ingressoda questo lato sarebbe piuttosto insolita.95
Per completare il quadro dei fortuiti ritrovamenti settecenteschi, si deveaggiungere che, secondo un anonimo contemporaneo, oltre alle due basi,« nell’anno 1770. nel cavarsi il pidamento delli muri laterali del nuovo por-tone del Monastero si scoprì un pavimento netto a mosaico, di pietre bian-che, ed un gran striscio di grosse pietre poste una sull’altra, senza calcina chedimostravano essere stato un grande edificio ».96 Ignazio Cartella, inoltre,dopo aver trascritto l’iscrizione di Olympis e quella di C. Claudio Marcello,afferma polemicamente che «quai fussero quest’Olimpio, e Cajo ClaudioMarcello … non è qui luogo di ricercarlo; ma se mai si fosse continuato loscavo, e tirati fuori altri consimili sassi, che in quel luogo cominciavano adiscoprirsi, e che per dappocaggine di chi sovrastava al lavoro furon lasciatisotterra, si sarebbero senza meno trovate altre Iscrizioni, che avrebber forserischiarate le precedenti, e maggior lume, e gloria recato avrebbero alla miaPatria ».97
Il desiderio di Cartella è parzialmente esaudito, più di duecento annidopo, in occasione degli scavi archeologici preventivi all’ampliamento versonord della Caserma dei Carabinieri, ormai ridottasi, dopo le demolizioni ini-ziate nel 1959, alla sola ala settentrionale dell’antico Monastero.98 Tali lavori
F. MUSCOLINO - I MONUMENTI DI OLYMPIS E DI C. CLAUDIO MARCELLO A TAORMINA 435
95 In questo punto si conserva ancora, tra l’altro, un muro di contenimento che, a giu-dicare dalla tecnica, sembra piuttosto antico: non è da escludere che esso fungesse ancheda muro di cinta del Monastero.
96 Le parole citate sono una postilla alla «Difesa della città di Taormina che non siagiammai appartenuta al distretto di Messina » (Palermo, Biblioteca Comunale, ms. Qq H272, nr. 3, f. 113), versione manoscritta e più ampia di CARTELLA, Discorso cit. (nota 16). Laredazione manoscritta, trascritta da Domenico la Camiola, può datarsi, in base a riferi-menti interni, verso il 1740-1750 (mi riservo di approfondire l’argomento in uno studiospecifico sul ms. Qq H 272). Ciò spiega perché la notizia sugli scavi del 1770 sia stataaggiunta per mano di uno studioso non identificato che, a giudicare dalla scrittura, non èné Cartella né La Camiola.
97 CARTELLA, Discorso cit. (nota 16), p. 224.98 Si prevedeva anche la demolizione di quest’ala dell’edificio, con la ricostruzione
della Caserma più a nord, nell’area dell’antico giardino del Monastero, per ampliarepiazza Vittorio Emanuele II. Durante lo scavo delle fondazioni del nuovo edificio, nel1962, vengono però alla luce i resti di un complesso termale romano, che inducono l’Am-ministrazione Comunale, guidata da Eugenio Longo, a desistere dal progetto, su propostadel soprintendente Luigi Bernabò Brea. Il complesso termale è poi esplorato da Paola
436 REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D’ARCH. – VOL. LXXXII
di ampliamento sono stati preceduti da indagini archeologiche condotte nel197899 in un’area compresa tra la Caserma e le terme romane individuate nel1962100 (fig. 20). Secondo la relazione di Giovanna Bacci, « al di sotto dimuretti a secco assai lacunosi e probabilmente pertinenti ad abitazioni di etàaltomedievale si sono rinvenuti: 1) resti di ambienti con pavimento in opussigninum di età repubblicana in gran parte tagliati dai muretti tardi e dabuche di età medievale e bizantina; 2) una spessa pavimentazione bianca incalce e schegge di calcare che si accosta ad un filare est-ovest di blocchi in cal-care bianco di Taormina posati su una preparazione di pietre a secco. Il pavi-mento bianco si data all’età augustea: al di sotto vi erano due livelli di battutodi età ellenistica che costituivano l’originaria pavimentazione del filare diblocchi. Nel filare erano inserite, lievemente sfalsate, due basi di statue, chedobbiamo immaginare in bronzo, con una iscrizione sulla faccia rivolta asud »101 (fig. 21). Il testo delle due iscrizioni è il seguente: `O d©moj tîn Tau-
romenit©n | NumfÒdwron EÙkle…da 'Areq | eÙno…aj ›neken102 (fig. 22) e `O
d©moj tîn Tauromenit©n | NumfÒdwron Filist…wnoj Spar | eÙno…aj kaˆ
Pelagatti nel 1964-1966 (P. PELAGATTI, Scoperta di un edificio termale a Taormina, in CASA III1964, pp. 25-37; EAD. in FA XVII 1962, nr. 4924 e XX 1967, nr. 2968; EAD., Luigi BernabòBrea e la Soprintendenza alle Antichità di Siracusa, in P. PELAGATTI - G. SPADEA (edd.), Dalle AreneCandide a Lipari. Scritti in onore di Luigi Bernabò Brea. Atti del convegno di Genova, 3-5 febbraio2001 (BA, volume speciale), Roma 2004, pp. 6, 27-28) e da Giovanna Bacci nel 1984(G. BACCI, Taormina [1984] – Scavi e restauri presso le Terme Romane, in Kokalos XXX-XXXI II.21984-1985, pp. 722-725). Sulla demolizione della Chiesa di Valverde e di parte del Mona-stero v. anche CIPOLLA, C’era una volta Taormina cit. (nota 3), pp. 525-526.
99 Sugli scavi del 1978 v., in particolare, BACCI 1980-1981, pp. 738-744 e anche EAD.,Taormina 1. – Ricerche archeologiche nell’area urbana, in ASM s. III, XXXI 1980, pp. 335-340;EAD., Taormina: 1977-1981, in BCASic III 1982, p. 165; R. J. A. WILSON, Archaeology in Sicily,1977-1981, in AR XXVIII 1981-1982, p. 93.
100 Su quest’ultimo complesso, v. nota 98.101 BACCI 1980-1981, p. 739.102 SEG XXXII 937; apografo in BACCI 1980-1981, p. 740, fig. 1a; ibidem, p. 739, nt. 5,
è data la seguente descrizione: « Inv. 82534. Base di statua in calcare biancastro locale, diforma quadrangolare. Sulla faccia superiore resta nitida l’impronta per l’allogamentodei piedi della statua, probabilmente di bronzo e di grandezza pressoché naturale. Suuno dei lati dedica di carattere onorario su tre righe. Lettere non molto regolari alte inmedia cm. 2,5, con leggeri apici. Cm. 66 × 66; h. cm. 26 ». Per limitarsi alla sola Sicilia,altri esempi di epigrafi onorarie con la formula «eÙno…aj ›neken» sono IG XIV 288 II (dalteatro di Segesta; v. anche T. MANNI PIRAINO, Iscrizioni greche lapidarie del Museo di Palermo(Sikelika, 6), Palermo 1973, pp. 72-73, nr. 47, tav. 28, II sec. a.C.; DUBOIS, Inscriptions cit.(nota 66), pp. 272-273, nr. 214; S. DE VIDO, in AA.VV., Segesta, in ASNP s. III, XX.3-4 1991,p. 972; L. CAMPAGNA, Architettura pubblica ed evergetismo nella Sicilia di età repubblicana, inC. MICCICHÈ - S. MODEO - L. SANTAGATI, La Sicilia romana tra Repubblica e Alto Impero, Atti delconvegno di studi, Caltanissetta 20-21 maggio 2006, Caltanissetta 2007, pp. 121-125); IG XIV
G.L. GREGORI - LE ISCRIZIONI, II 437
Fig. 21. Le basi dei monumenti ai due Nymphodoros in situ(da LENTINI, Tauromenion cit. [nota 103], p. 322, fig. 11)
Fig. 22. Apografo dell’iscrizione di Nymphodoros di Eukleidas (da BACCI 1980-1981, p. 740, fig. 1a)
Fig. 23. Apografo dell’iscrizione di Nymphodoros di Philistion (da BACCI 1980-1981, p. 740, fig. 2a)
438 REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D’ARCH. – VOL. LXXXII
eÙerges…aj ›neken | t©j e„j aÙtÕn qeo‹j p©si103 (fig. 23). La studiosa prose-gue precisando che « la struttura est-ovest in cui erano inserite le basi si col-lega a un complesso già individuato dalla dott. Pelagatti sotto le termeromane104 che vi si sovrappongono e che può essere interpretato come ungrande cortile o peristilio che si accosta verso ovest ad un ambiente rettan-golare assai allungato pavimentato in cocciopesto e delimitato da grandiblocchi ben squadrati. Questo ambiente sembra costituire una sorta di vesti-bolo tra il cortile o peristilio (sul quale si affaccia con almeno due portesituate verso le estremità) e un altro grande ambiente o sala di cui resta solouna piccolissima porzione della fronte in grandi blocchi squadrati (con trac-cia di un ingresso?), situato sotto le case moderne ».105 La Bacci, seppur conle dovute cautele, propone di considerare questo edificio come un bouleute-
356 (Alesa); IG XIV 366 (da Alunzio, v. anche MANNI PIRAINO, Iscrizioni cit., pp. 67-68, nr.43, tav. 26, I sec. a.C.); SEG XXXVII 760, dal portico occidentale dell’agorà di Alesa (G.SCIBONA, Epigraphica Halaesina I (Schede 1970), in Kokalos XVII 1971, pp. 5-11, nr. 1, tav. 2;AE 1973, nr. 267); con «eÙno…aj [›neka]», IG XIV 367 (da Alunzio, v. anche MANNI
PIRAINO, Iscrizioni cit., pp. 68-69, nr. 44, tav. 27, prima metà del II sec. a.C.); con «eÙno…a[j]
›nek[en]», IG XIV 311 (dal ginnasio di Solunto, v. anche MANNI PIRAINO, Iscrizioni cit.,pp. 144-147, nr. 114, tav. 67); con «eÙno…aj [›neka]», IG XIV 317 (dall’agorà di TerminiImerese; v. anche A. BRUGNONE, Iscrizioni greche del Museo Civico di Termini Imerese, in KokalosXX 1974, pp. 221-223, nr. 2, tav. 32, fig. 2; DUBOIS, Inscriptions cit. (nota 66), pp. 251-252,nr. 202; O. BELVEDERE, Elementi per la forma urbana, in O. BELVEDERE - A. BURGIO - R. MACA-LUSO - M. S. RIZZO, Termini Imerese. Ricerche di topografia e archeologia urbana, Palermo 1993,p. 26). Un caso molto dubbio è, a Tauromenio, IG XIV 436, oggi dispersa, che secondoBormann (seguito da RIZZO 1904, p. 112) potrebbe essere un’epigrafe in onore di unSiracusano «eÙno[…]a[j ›neka]».
103 SEG XXXII 936; apografo in BACCI 1980-1981, p. 740, fig. 2a; ibidem, p. 739, nt. 5, èdata la seguente descrizione: « Inv. 82535. Base quasi identica alla precedente per mate-riale e dimensioni. Sulla faccia superiore impronta dei piedi della statua. Iscrizione di quat-tro righe in lettere abbastanza regolari alte in media cm. 2,5 ed apicate. Piccole lacune eabrasioni. Cm. 66 × 56; h. cm. 26 ». Per limitarsi alla sola Sicilia, altri esempi di epigrafi ono-rarie con la formula «eÙerges…aj ›neken», sono IG XIV 353 (ad Alesa, v. anche MANNI
PIRAINO, Iscrizioni cit. [nota 102], pp. 162-163, nr. 127, tav. 75, prima metà del II sec. a.C.)e IG XIV 359 (a San Fratello, forse da Alunzio). Un probabile esempio della formula«[eÙno…aj] kaˆ eÙerges…aj ›nek(en)» è l’iscrizione SEG XXXVII 759 dall’agorà di Alesapubblicata da SCIBONA, Epigraphica cit. (nota 102), pp. 11-13, nr. 2, tav. 3, fig. 1, per la qualel’editore propone anche l’integrazione [¢ret©j]. Sulle due basi scoperte nel 1978, v., oltrealla bibliografia cit. supra (nota 99), anche BACCI, Taormina 1 cit. (nota 99), pp. 337-339, fig.1; ANTONETTI, Sigle cit. (nota 28), p. 10, nt. 5, p. 12, nt. 41, p. 14; R. J. A. WILSON, Sicily underthe Roman Empire. The Archaeology of a Roman Province 36 BC-AD 535, Warmister 1990, p. 50;M. C. LENTINI, Tauromenion, in F. GHEDINI - J. BONETTO - A. R. GHIOTTO - F. RINALDI, Lo Strettodi Messina nell’antichità, Roma 2005, p. 322, fig. 11 (qui fig. 21).
104 P. PELAGATTI in FA XX 1967, nr. 2968.105 BACCI 1980-1981, p. 741.
rion,106 poi obliterato dal complesso termale. Si potrebbe collegare all’edificiopubblico anche lo stilobate (?) con andamento nord-ovest/sud-est visto nel1918 «dentro la Caserma dei RR. Carabinieri ».107 In occasione di un altrosaggio di scavo condotto nel 1994 « immediatamente a nord della facciatainterna della caserma», dunque immediatamente a Nord dell’ala settentrio-nale del Monastero, è stato rinvenuto «un muro in blocchi regolari di pietrabianca di Taormina » che la Bacci propone di riferire alla sistemazione del-l’area nord dell’agorà verso la fine del I sec. a.C.108 Difficile non collegare il« pavimento netto a mosaico, di pietre bianche » e il « gran striscio di grossepietre poste una sull’altra, senza calcina » visti nel 1770 durante gli scavi perl’ampliamento del Monastero con la « spessa pavimentazione bianca in calcee schegge di calcare che si accosta ad un filare est-ovest di blocchi in calcarebianco di Taormina » scoperti nel 1978 oppure con il «muro in blocchi dipietra bianca di Taormina » individuato nel 1994, anche se la laconicità dellanotizia settecentesca e la lacunosità dell’area indagata in anni più recentisconsigliano conclusioni più precise.
L’elemento che maggiormente collega lo scavo settecentesco con quellomoderno è, comunque, il rinvenimento delle basi onorarie: se per le due basiscoperte nel 1978 la provenienza dall’edificio pubblico è certa, pochi dubbi,
F. MUSCOLINO - I MONUMENTI DI OLYMPIS E DI C. CLAUDIO MARCELLO A TAORMINA 439
106 L’ipotesi è avanzata in BACCI 1980-1981, p. 741 e accolta da A. IANNELLO, I bouleuteriain Sicilia. Fonti e monumenti, in QuadMess IX 1994, pp. 75-76. Riserve su questa identifica-zione, data l’esiguità della porzione nota dell’edificio, sono espresse da WILSON, Sicily cit.(nota 103), p. 50; LENTINI, Tauromenion cit. (nota 103), p. 322; L. CAMPAGNA, L’architettura dietà ellenistica in Sicilia: per una rilettura del quadro generale, in M. OSANNA - M. TORELLI (edd.),Sicilia ellenistica, consuetudo italica. Alle origini dell’architettura ellenistica d’Occidente (Spoleto,5-7 novembre 2004) (Biblioteca di « Sicilia antiqua », 1), Roma 2006, p. 26; G. F. LA TORRE in L.CAMPAGNA - G. F. LA TORRE, Ricerche sui monumenti e sulla topografia di Tauromenion: una stoàellenistica nell’area della Naumachia, in Sicilia Antiqua V 2008, pp. 134 e 136, nt. 7 e L. CAM-PAGNA, Urbanistica dei centri siciliani d’altura in età ellenistica: il caso di Tauromenion, in M. CON-GIU - C. MICCICHÈ - S. MODEO, E„j ¥kra. Insediamenti d’altura in Sicilia dalla Preistoria al III sec.a.C, Atti del V Convegno di studi, Caltanissetta, 10-11 maggio 2008, Caltanissetta-Roma 2009,p. 206. Tale edificio non è considerato da H. P. ISLER, Bouleuteria di Sicilia, in G. FIORENTINI –M. CALTABIANO - A. CALDERONE (edd.), Archeologia del Mediterraneo. Studi in onore di Ernesto DeMiro (Bibliotheca Archaeologica, 35), Roma 2003, pp. 429-433.
107 Paolo Orsi, taccuino 110, 8 aprile 1918, in PELAGATTI, Scoperta cit. (nota 98), p. 36,nt. 18: «Dentro la caserma dei RR. Carabinieri si è trovata una bella base dorica … che, sedice esatto Lo Gioco, sarebbe indizio di uno stilobate, che correrebbe da NO-SE. Il LoGioco raccomanda scavi nell’orto dei Carabinieri e nel contiguo orto Attanasio ». Lo stessoOrsi, ibidem, 11 aprile 1918, si mostra cosciente delle potenzialità archeologiche dell’area:« Sulla piazzetta Vittorio Emanuele, davanti la caserma dei RR. Carabinieri il suolo è pienodi ruderi ».
108 G. BACCI - C. RIZZO, Taormina. Interventi nell’area urbana, in Kokalos XLIII-XLIV II.11997-1998, pp. 358-361, p. 359, fig. 1 e tav. 88, fig. 1.
440 REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D’ARCH. – VOL. LXXXII
a prescindere da quelli sull’esatta collocazione, possono sussistere sulla per-tinenza delle basi di Olympis e di C. Claudio Marcello alla stessa area, o addi-rittura allo stesso edificio.109
LA DATAZIONE
Il monumento di C. Claudio Marcello, come già detto, va collocato nelperiodo in cui il personaggio fu proconsole in Sicilia (79 a.C.). Più com-plessa, invece, la datazione delle altre tre epigrafi. Dando per scontato che ilterminus post quem è la fondazione di Tauromenio nella prima metà del IV sec.a.C.110 e il terminus ante quem è la deduzione della colonia (36 o 21 a.C.),111 itentativi di datazione si sono finora basati sull’identificazione tra gli onoratie omonimi personaggi attestati nella tavola degli strateghi (IG XIV 421) e inquella dei ginnasiarchi (IG XIV 422), con una generale propensione per il IIsec. a.C.112
Un Olympis di Olympis (senza Meston) è citato come eponimo nellatavola degli strateghi (IG XIV 421)113 e un Nymphodoros di Eukleidas è pre-
109 Come già sostenuto da BACCI 1980-1981, pp. 741-742. La Pelagatti, quando ancoranon erano stati individuati i resti del grande edificio ellenistico, aveva intuito che le duebasi scoperte nel 1770 «potrebbero risalire ad epoca precedente alle Terme e apparteneread un diverso complesso monumentale forse collegato al foro stesso, il foro nel quale Cice-rone vide la statua rovesciata di Verre » (PELAGATTI, Scoperta cit. [nota 98], pp. 36-37); ancheOrsi, in maniera però speculativa, dato che non condusse mai scavi nell’area, propone dicollegare le due basi con un «grande edificio pubblico » i cui resti, parzialmente conser-vati in alzato, egli vide «dentro la sede della Società Operaia, attigua al Teatro (Marghe-rita) » (P. Orsi, Taccuino 110, 11 aprile 1918, in PELAGATTI, Scoperta cit. (nota 98), p. 36,nt. 18). È impossibile, allo stato attuale della ricerca, precisare l’ubicazione di questi ruderivisti da Orsi (lato Est della piazza, a fianco del Teatro Margherita?); non è da escludere cheessi siano stati coinvolti nelle demolizioni del 1959 o, ancor prima, nella realizzazione delMercato coperto.
110 Il complesso problema della fondazione della città è riconsiderato da E. ARENA, Lafondazione di Tauromenion fra i Dionisi e Andromaco, in Sicilia Antiqua V 2008, pp. 93-113.
111 Altrimenti sarebbe difficile spiegare la menzione del damos, che implica un regimedemocratico; v. DEL MONACO, Le istituzioni cit. (nota 28), pp. 35-36: «Quanto agli organi isti-tuzionali, tre iscrizioni onorarie databili alla seconda metà del II sec. a.C. menzionano π
d©moj tîn Tauromenit©n, nel quale si deve chiaramente riconoscere l’assemblea popolaredi Tauromenio, che in questi documenti figura come dedicante di tre statue a cittadini chesi sono ricoperti di particolari meriti ». Sulla deduzione della colonia, forse preceduta dauna trasformazione della città in municipium intorno al 46-42 a.C., v., in particolare, SARTORI
1954, pp. 381-383; CONSOLO LANGHER, Il sikelikon talanton cit. (nota 53), p. 396; MANGANARO
1988, pp. 177 e 182.112 V. la bibliografia citata supra.113 Olympis di Olympis è citato come eponimo sul lato destro dell’epigrafe (IG XIV
421, II l. 5: [™pˆ] 'OlÚmpioj toà 'OlÚmpioj).
sente (senza 'Areq)114 sia tra gli strateghi115 sia tra i ginnasiarchi.116 Non èinvece altrimenti noto Nymphodoros di Philistion.117 Ammesso che i perso-naggi onorati siano gli stessi menzionati in IG XIV 421 e 422, e non lorononni, nipoti o semplici omonimi, si potrebbe tentare di precisare la crono-logia dei monumenti onorari con l’aiuto delle liste annuali degli strateghi edei ginnasiarchi. A questo punto, però, si presenta un ben noto problemadell’epigrafia tauromenitana: l’incertezza sull’anno di inizio del computocronologico su cui si basa la lista degli strateghi, alla quale si “ aggancia ”quella dei ginnasiarchi. L’inizio della lista, che è fatto coincidere, comune-mente, con la cd. “ era tauromenitana ”, è fissato tra il 270 e il 241 circa,118
F. MUSCOLINO - I MONUMENTI DI OLYMPIS E DI C. CLAUDIO MARCELLO A TAORMINA 441
114 I nomi di altri membri di questa famiglia sono accompagnati, oltre che dalla sigla'Areq, anche da 'As e O„n: v. ANTONETTI, Sigle cit. (nota 28), p. 19, nt. 68, seguita da MAN-GANARO 1988, p. 162.
115 IG XIV 421 I a. 68, a. 82, a. 97. La connessione tra il Nymphodoros di Eukleidasdella base onoraria e l’omonimo personaggio di IG XIV 421 e 422 è ipotizzata, in partico-lare, da BACCI 1980-1981, p. 740; WILSON, Archaeology cit. (nota 99), p. 93; ANTONETTI, Siglecit. (nota 28), p. 15; MANGANARO 1988, p. 189, nt. 82. Forse è suo figlio l’Eukleidas diNymphodoros (senza sigla), eponimo nel quinto anno della lista D di IG XIV 421, tre annidopo Olympis di Olympis (ANTONETTI, Sigle cit. [nota 28], p. 19, nt. 68).
116 IG XIV 422 II a. 70. La sua famiglia è forse collegata con il sitonion di Eukleidas atte-stato nelle tavole finanziarie; MANGANARO 1988, p. 189, nt. 82, in particolare, ipotizza unaconnessione tra il padre di Nymphodoros e il proprietario del sitonion di Eukleidas citatoin IG XIV 423, 425-430 e nell’iscrizione MANGANARO 1964, p. 43. Sui sitonia di Tauromeniov., in particolare, L. MIGEOTTE, Le pain quotidien dans les cités hellénistiques. À propos des fondspermanents pour l’approvisionnement en grain, in CCG II 1991, pp. 38-40 e U. FANTASIA, ISitofÚlakej e i Sitènia di Tauromenio, in M. I. GULLETTA (ed.), Sicilia Epigraphica. Atti delconvegno internazionale (Erice, 15-18 ottobre 1998) (ASNP s. IV, Quaderni, 1), Pisa 1999, pp. 251-279 (BE 2001, nr. 592).
117 La sigla Spar accompagna Philistion di Philistion (IG XIV 421 I a. 94), Philistiondi Ageas (IG XIV 429), […] di Philistion (IG XIV 430); la sigla Spart Philistion di Ageas(IG XIV 421 D a. 13).
118 Le ipotesi possono essere così riassunte: verso il 270 a.C. (dopo la caduta di Tyn-darion: SARTORI 1954, pp. 365, 368, 376, seguito da CONSOLO LANGHER, Il sikelikon talan-ton cit. [nota 53], pp. 406-407, 409; C. ANTONETTI, Ancora sull’iscrizione dei ginnasiarchi diTauromenio. Riflessioni sulla base di nuove letture, in BCASic IV 1983, p. 16; EAD., Sigle cit.[nota 28], p. 15, nt. 46; DEL MONACO, Le istituzioni cit. [nota 28], p. 34), 263 a.C. (trat-tato tra Ierone II e Roma: E. BORMANN, Fastorum civitatis Tauromenitanae reliquiae, inIndex Lectionum Academiae Marburgensis, Marburg 1881, p. 22 e A. HOLM in Bursian’s Jah-resbericht IX, 3, 1881, p. 158) (non vidi); RIZZO 1893, p. 12; G. RIZZO, Sul di≠ p≤nte ™t≤wn
della Tavola degli Strategi, in Rivista di storia antica II.1 1896, p. 72, nonostante il parerecontrario espresso per lettera da Beloch), 253 a.C. (vittoria romana su Panormos:W. SCHWAHN, Strategos, in RE, suppl. VI 1937, col. 1133), 241 a.C. (fine della primaguerra punica e inizio del dominio romano su parte della Sicilia: MANGANARO, Tauro-menitana cit. [nota 53], pp. 21-25; DE SENSI SESTITO, Gerone II cit. [nota 36], pp. 130-131).
anche se non mancano tentativi di abbassare119 o di innalzare la data.120
Nymphodoros di Eukleidas è stratego negli anni 68, 82, 97 e ginnasiarca nel-l’anno 70. Considerando le due date di inizio “ estreme ” più probabili, cioèil 270 e il 241 a.C., la carriera politica del personaggio si collocherebbe,rispettivamente, tra il 202 e il 173 circa a.C.121 o tra il 173 e il 144 circa a.C.;122
in base a tale ricostruzione, una datazione tra la prima metà e i decenni cen-trali del II sec. a.C. sarebbe la più probabile per la base onoraria. Anche labase di Nymphodoros di Philistion, date le notevoli somiglianze nella confor-mazione e nella paleografia e la contiguità topografica, deve essere collocatain questo stesso periodo.
Più complessa, invece, la collocazione di Olympis di Olympis nellatavola degli strateghi; il personaggio compare, infatti, al secondo posto diuna lista di quattordici anni (lista D in IG XIV 421) nella parte alta di unafaccia della stele, seguita da uno spazio non iscritto.123 Il problema consistenel definire il rapporto tra questo gruppo di quattordici anni e la succes-sione cronologica delle altre facce della stele, rispetto alle quali, a causadelle lacune, si pone in una posizione di discontinuità. Senza addentrarsinel problema, basti osservare che, secondo una ricostruzione, tale partedella lista inizierebbe dopo la fine della prima guerra servile, quindi Olym-pis sarebbe stato eponimo intorno al 130 a.C.;124 secondo una diversa inter-pretazione nella successione delle liste sull’epigrafe, invece, Olympissarebbe stato eponimo nell’anno 182 della lista degli strateghi.125 Conside-
442 REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D’ARCH. – VOL. LXXXII
119 MANGANARO 1964, p. 67, propone il 235-233 a.C.; in un altro contributo (Una epistoladi Gerone II ai Siracusani (IG, XIV, 7), in Athenaeum LIII 1965, p. 319), colloca tra il 241 e il230 a.C. il riconoscimento dell’autonomia di Tauromenio da parte di Ierone II e l’iniziodella lista degli strateghi.
120 B. CARROCCIO, Roma in Sicilia. I cambi tra valute. Per una cronologia numismatica delleTavole di Tauromenio, inMinEpigrP XI, fasc. XIII 2008, pp. 29-43 propone di far cominciarel’era tauromenitana con la fondazione della città da parte di Andromaco nel 358/357 a.C.
121 270 a.C. - 68 = 202 a.C.; 270 a.C. - 82 = 188 a.C.; 270 a.C. - 97 = 173 a.C.122 241 a.C. - 68 = 173 a.C.; 241 a.C. - 82 = 159 a.C.; 241 a.C. - 97 = 144 a.C.123 MANGANARO 1988, pp. 167-168 e fig. 7.124 La lista, secondo BORMANN, Fastorum cit. (nota 118), p. 23; RIZZO 1893, p. 16; SCHWAHN,
Strategos cit. (nota 118), col. 1133; SARTORI 1954, pp. 359-360, inizierebbe con la fine dellaprima guerra servile nel 132 a.C. Dato che il primo anno della nuova lista sarebbe il132/131 (Bormann e Rizzo) o il 131/130 a.C. (Schwahn), Olympis sarebbe stato eponimonel 131/130 o nel 130/129 a.C. Di parere contrario CONSOLO LANGHER, Il sikelikon talantoncit. (nota 53), pp. 402 e 420-421, che tende a datare tutte le liste degli strateghi in IG XIV421 prima dell’inizio della guerra servile (136 a.C.).
125 MANGANARO 1988, pp. 169-170, 179-180, seguito da FANTASIA, I SitofÚlakej cit. (nota116), pp. 262-263, 279, propone di considerare la lista di quattordici anni in cui compareil nome di Olympis di Olympis come la sezione finale della tavola degli strateghi, che ini-
rando le due date di inizio “ estreme ” più probabili, cioè il 270 e il 241 a.C.,si otterrebbe per l’eponimia di Olympis, rispettivamente, l’88 o il 59 a.C.Nella prima ipotesi, e sempre ammettendo che i due Olympis (il vincitorenei Pitici e l’eponimo) siano la stessa persona, il monumento onorario puòessere collocato tra i decenni centrali e la seconda metà del II secolo a.C.;126
nella seconda ipotesi, il monumento risalirebbe alla prima metà del Isecolo a.C. È interessante notare che, accettando quest’ultima cronologia,la vittoria di Olympis nei giochi Pitici si collocherebbe a pochi anni didistanza dalla vittoria olimpica di Lamachos di Tauromenio, vincitore nellostadio durante la 181a Olimpiade (56 a.C.).127
Anche la paleografia delle iscrizioni, pur con le dovute cautele,128 può
F. MUSCOLINO - I MONUMENTI DI OLYMPIS E DI C. CLAUDIO MARCELLO A TAORMINA 443
zierebbe intorno al 62-61 a.C. e terminerebbe con la trasformazione di Tauromenio inmunicipio. L’eponimia di Olympis di Olympis andrebbe dunque collocata nell’anno 182,secondo quanto si deduce da MANGANARO 1988, p. 170 (Olympis di Olympis è eponimo nelsecondo anno della lista di 14 anni che sarebbe successiva ai 180 anni delle liste prece-denti, dunque 180 + 2 = 182) e p. 179 (lo stratego Phrynis di Phrynis, in carica nell’annoprecedente l’eponimia di Olympis di Olympis, è da Manganaro collocato nell’anno 181,dunque 181 + 1 = 182).
126 La vittoria celebrata dal monumento sarà stata conseguita in età giovanile, quindi,verosimilmente, diversi anni prima dell’eponimia: è questo il motivo che induce a pro-porre una cronologia lievemente più ampia di quella proposta da GENTILE 2002, p. 225(« seconda metà del II secolo a.C.»).
127 Iulius Africanus in EUS., Chronica (ed. Schoene), Berolini 1875, I, coll. 211-212, r. 32= IULIUS AFRICANUS, Chronographiae. The Extant Fragments (GCS, n. F., 15) (ed. Wallraff), Ber-lin-New York 2007, F65, p. 212, r. 300; v. anche H. FÖRSTER, Die Sieger in den olympischen Spie-len (II. Teil) (Wissenschaftliche Beilage zum Programm des Gymnasiums zu Zwickau, Ostern 1892),Zwickau 1892, p. 13, nr. 576 e L. MORETTI, Olympianikai, i vincitori negli antichi agoni olimpici,in MAL s. VIII, VIII.2 1957, p. 150, nr. 706. La partecipazione di Lamachos è significativaperché dal III sec. a.C. il numero di olimpionici sicelioti e italioti è in diminuzione, comesi ricava dalla lista di Moretti e dalla mappa con le provenienze degli atleti dal 296 a.C. al369 d.C. presentata da H. A. HARRIS, Greek Athletes and Athletics, Westport 1964, pp. 224-225,map 3 e ripresa da O. VAN NIJF, Athletics, Festivals and Greek Identity in the Roman East, inPCPhS XLV 1999, p. 179, fig. 2 (solo Tauromenio e Siracusa sono attestate). Anche se nonha un carattere ‘sportivo’, merita comunque di essere citata, come altra attestazione deirapporti tra Tauromenio e le competizioni legate ai santuari greci, un’epigrafe di Cos, delIII sec. a.C., che menziona la vittoria dell’attore Protarchos di Tauromenio nei Dionysialocali (W. R. PATON - E. L. HICKS, The Inscriptions of Cos, Oxford 1891, pp. 101-103, nr. 45;M. SEGRE, Iscrizioni di Cos, I (Monografie della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Ita-liane in Oriente, 6), Roma 1993, pp. 46-47, cat. ED 52, tav. 16, ll. 11-13: [Øpo|krit≠j]
kwmwid…aj Prètarc[oj | - - - Taur]omen…thj.128 Valga, per tutti, l’avvertimento di M. GUARDUCCI, Epigrafia greca, I, Roma 1967, p. 368:
« Se è difficile datare le iscrizioni arcaiche in base ai soli caratteri epigrafici, le difficoltàcrescono, di solito, per i testi dell’età ellenistica e dell’età imperiale romana. Bisogneràdunque, in questi casi, esprimere il proprio giudizio con la massima prudenza, anche acosto di dover datare, come spesso accade, per secoli o addirittura per coppie di secoli ».
contribuire alla datazione. Le basi dei due Nymphodoros hanno tra loro unanotevole affinità paleografica.129 La base di Olympis, pur avendo alcuniaspetti in comune,130 si differenzia per altri;131 l’omega romboidale, comune inSicilia tra il II e il I sec. a.C.,132 è un probabile indizio della seriorità di questabase rispetto alle altre due. Tra le iscrizioni datate, mostra somiglianze paleo-grafiche con quella di Olympis il già citato decreto dei technitai di Siracusa inonore di M. Acilio M. f. Canino, proconsole in Sicilia nel 46-45 a.C.133 Unadatazione tra la prima metà e la metà del I sec. a.C., dunque, può essere pro-posta per la base di Olympis anche su base paleografica.
444 REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D’ARCH. – VOL. LXXXII
129 V., in particolare, l’omega tondeggiante, l’alpha a barra spezzata, il theta con trattocentrale.
130 V., in particolare, l’alpha a barra spezzata; altre lettere mostrano una genericasomiglianza, anche se, a giudicare dal confronto con l’apografo delle due iscrizioni inBACCI 1980-1981, p. 740, figg. 1a e 2a, l’iscrizione di Olympis mostra una tendenza a unmaggior allungamento dei tratti orizzontali di alcune lettere, in particolare sigma edepsilon.
131 V., in particolare, il theta tondeggiante con tratto centrale prolungato fino a costi-tuire il diametro, il pi con tratto orizzontale che prosegue oltre l’incontro con i due trattiverticali, l’omega romboidale.
132 V., in particolare, G. NENCI, Varia Elyma: novità epigrafiche, numismatiche, toponomasti-che e cultuali dall’area elima, in Terze giornate internazionali di studi sull’area elima (Gibellina,23-26 ottobre 1997), Atti, II, Pisa-Gibellina 2000, p. 811 (già attestato in Sicilia nel III secolo,« l’omega romboidale … diverrà corrente nel II-I sec. a.C.»). L’omega romboidale compare,con l’alpha a barra spezzata, nell’iscrizione del Ginnasio di Agrigento che L. MORETTI, Epi-graphica, 14, in RFIC CIV 1976, pp. 182-186 datava, su base paleografica, alla prima metàdel I sec. a.C., ma che, dopo il ritrovamento di altri frammenti, si è rivelata di età augustea,con una datazione compresa tra il 2 a.C. e 14 d.C. (G. FIORENTINI, Il ginnasio di Agrigento, inKokalos XLII 1996, pp. 9-13, tavv. 3-5; SEG XLVI 1252).
133 GENTILI, Nuovi elementi cit. (nota 67); v., in particolare, la forma di pi, omega, theta;l’alpha, invece, è a barra dritta. Somiglianze vi sono anche con un’altra epigrafe siracusana(ibidem, pp. 15-18, fig. 5) che l’editore, per motivi paleografici, considera sostanzialmentecoeva con l’iscrizione di M. Acilio Canino. Alcuni dei caratteri dell’iscrizione di Olympissono generalmente considerati elementi per una datazione delle epigrafi siciliane a par-tire dalla metà del II sec. a.C. Ad es., M. T. MANNI PIRAINO, Due iscrizioni inedite di Marsala,in Kokalos IX 1963, p. 161 osserva, a proposito dell’iscrizione pubblicata ibidem, pp. 159-162, tav. 52, fig. 2, che « lo strano omega a spigoli vivi e chiuso da una linea che ne con-giunge i piedini inclinati verso il basso, non sembra … giustificabile prima della fine delII secolo (a.C.); né il sigma a tratti paralleli è anteriore al 150 (a.C.). … anche l’alpha conla barra centrale spezzata è certamente tardo »; un’iscrizione di Lipari è datata al 50 ca. a.C.da G. MANGANARO, Tra epigrafia e numismatica, in Chiron XXII 1992, p. 390, tav. 12,1, per lapresenza di lettere quadrate e un’iscrizione funeraria di Mineo, con theta, omega quadrato,alpha a barra spezzata e pi simili a quelli dell’iscrizione di Olympis è datata « alla prima etàimperiale » da F. CORDANO, Iscrizioni dal territorio di Palagonia e Mineo (Catania), in KokalosXLIII-XLIV II.1 1997-1998, p. 170, nr. 1, tav. 60, fig. 1.
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
Data l’estrema lacunosità dell’edificio pubblico (bouleuterion?) obliteratodalle terme romane, i monumenti di Olympis, di C. Claudio Marcello e deidue Nymphodoros sono, finora, la migliore testimonianza sul lato settentrio-nale dell’agorà di Tauromenio134 tra II e I sec. a.C., prima della sua probabilerisistemazione augustea.135 I monumenti di Nymphodoros di Philistion eNymphodoros di Eukleidas sono stati eretti, probabilmente tra la prima metàe i decenni centrali del II sec. a.C., nel cortile o peristilio dell’edificio pub-blico, con l’iscrizione verso sud,136 rivolta quindi verso chi entrava dallapiazza. A poca distanza, forse in posizione più vicina alla piazza137 sono col-locati, negli ultimi decenni del II secolo, o, più verosimilmente, nella primametà del I sec. a.C., il monumento a Olympis e, con ogni probabilità nel 79a.C., il monumento a C. Claudio Marcello, anche se sfugge l’esatta colloca-zione, e dunque anche il rapporto con l’edificio pubblico: erano anch’essinel cortile/peristilio, oppure sorgevano all’esterno, lungo i margini dellapiazza? A questi monumenti attestati archeologicamente deve essereaggiunto il monumento a Verre, eretto in un punto imprecisato del forodurante il governo del propretore (73-71 a.C.) e abbattuto subito dopo,secondo l’eccezionale testimonianza di Cicerone138 già ricordata.
F. MUSCOLINO - I MONUMENTI DI OLYMPIS E DI C. CLAUDIO MARCELLO A TAORMINA 445
134 L’identificazione di Piazza Vittorio Emanuele II o Badia con l’agorà è uno dei pochipunti generalmente condivisi della topografia di Tauromenio; v. almeno RIZZO 1893, pp. 40-41;P. ORSI, taccuino 110, 11 aprile 1918, in PELAGATTI, Scoperta cit. (nota 98), p. 36, nt. 18; RIZZO,Tauromenion cit. (nota 62), pp. 371-373; SANTANGELO, Taormina cit. (nota 26), p. 62; PELA-GATTI, Scoperta cit. (nota 98), p. 28; BACCI 1980-1981, pp. 738-742; F. COARELLI in F. COARELLI
- M. TORELLI, Sicilia (Guide archeologiche Laterza), Roma-Bari 1984, pp. 357-358, 361-362;WILSON, Archaeology cit. (nota 99), p. 50; G. M. BACCI, in EAA secondo supplemento, V 1997,pp. 526-527, s.v. Taormina; LENTINI, Tauromenion cit. (nota 103), pp. 321-324; L. CAMPAGNA, Archi-tettura e archeologia della basileia a Siracusa nell’età di Ierone II, in M. CACCAMO CALTABIANO -L. CAMPAGNA - A. PINZONE, Nuove prospettive della ricerca sulla Sicilia del III sec. a.C. Archeologia,Numismatica, Storia, Atti dell’Incontro di Studio (Messina 4-5 luglio 2002) (Pelorias, 11), Messina2004, pp. 163-164; F. BUSCEMI, Odei e romanizzazione nella Sicilia di età imperiale. Questioni ditopografia e tecniche edilizie, in La forma della città e del territorio, 3 (ATTA, 15), Roma 2006,p. 166; CAMPAGNA, Urbanistica cit. (nota 106), pp. 206-207. G. F. LA TORRE in CAMPAGNA -LA TORRE, Ricerche cit. (nota 106), pp. 132-140 propone di includere nell’area dell’agorà,oltre alla zona corrispondente a piazza Vittorio Emanuele II, anche quella prospiciente lacd. Naumachia.
135 BACCI 1980-1981, pp. 740-741.136 BACCI 1980-1981, p. 739.137 Le due basi furono trovate presso il nuovo portone del Monastero (v. supra), quindi
in un punto che, a prescindere dalla sua esatta collocazione, è più esterno rispetto al luogodi rinvenimento delle basi dei due Nymphodoros.
138 CIC., In Verrem, II, 2, 160.
Nonostante la frammentarietà delle nostre conoscenze, il lato settentrio-nale appare come un punto importante dell’agorà nel II-I secolo a.C.: in essosi concentrano le statue di Nymphodoros di Eukleidas, evergete e forseanche stratego e ginnasiarca, di Nymphodoros di Philistion, anch’egli ever-gete, di Olympis di Olympis, vincitore nei giochi pitici e forse anche epo-nimo, e del proconsole C. Claudio Marcello. L’importanza di quest’area,inoltre, è confermata dal rinvenimento di altre epigrafi di carattere pubblico,databili sia prima sia dopo la probabile risistemazione augustea.139
446 REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D’ARCH. – VOL. LXXXII
139 Una dedica frammentaria a Caracalla (CIL X 6991) è ritrovata « in monasterio » nel1867 (durante i lavori di trasformazione dell’edificio in Caserma dei Carabinieri?). Dall’a-rea delle terme romane provengono, inoltre, una tavola finanziaria (MANGANARO 1964,p. 43; BE 1965, nr. 512), i frammenti di un calendario romano e di Fasti consulares («FastiTauromenitani») (MANGANARO, Tauromenitana cit. (nota 53), pp. 14-19; II, XIII, 2, p. 547;MANGANARO 1964, p. 38, nr. 1 e p. 39, nr. 2; G. BARBIERI, Rassegna di epigrafia latina. Sui gover-natori della Sicilia in età imperiale e sugli ultimi rinvenimenti epigrafici, in Kokalos XIV-XV 1968-1969, pp. 192-193; G. M. BACCI, Taormina cit. (nota 98), pp. 724-725, tavv. 158, fig. 4 e 159;AE 1988, nrr. 625-626; O. SALOMIES, Zu den Fasti consulares von Tauromenium, in Arctos XXII1988, pp. 130-132 e in ZPE LXXXVI 1991, pp. 187-192; AE 1991, nrr. 894-895; J. RÜPKE,Kalendar und Öffentlichkeit. Die Geschichte der Repräsentation und religiösen Qualifikation von Zeitin Rom (Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten, 40), Berlin-New York 1995, pp. 102,133-138, 170, 172, 389; B. RUCK, Die Fasten von Taormina, in ZPE CXI 1996, pp. 271-280; AE1996, nr. 788; R. WILSON, Archaeology in Sicily, 1988-1995, in AR XLII 1994-1996, p. 80), ealtre iscrizioni di carattere pubblico (MANGANARO 1964, p. 42), tra cui una probabile dedicaa Domizia Longina, moglie di Domiziano (MANGANARO 1964, pp. 41-42, tav. 16; sull’altrafaccia di questa iscrizione opistografa, Manganaro legge una dedica all’Augusta Lucilla,figlia di Marco Aurelio e moglie di Lucio Vero, ma tale lettura è rifiutata da BARBIERI, Ras-segna cit., p. 193).
APPENDICE140
Doc. 1. Lettera di Ignazio Cartella a Cesare Gaetani della Torre, Taormina, 30 mag-gio 1770 141
[107]Taormina 30. Mag(gio) del 70
Se v’incommodo con questa mia, n’è causa la v(ost)ra gentilezza, e letteratura,mentre piu che ad ogni altro conviene che a voi scrivessi in materia di Lettere, emolto piu in trattandosi di Lingua greca, che perfettamente possedete; onde perciòvi acchiudo la Copia di due Iscrizioni greche, ritrovate di fresco qui, nell’occasione diampliarsi il Monistero di Donne di S. Maria di Valverde.
Giorni sono io l’osservai, seriamente colà portandomi, perche nel loro rinveni-mento mi ritrovava fuori di Citta, ove ancora sono, e ne feci esatta, e diligente Copia,essendo le Lettere chiare e lampanti, e tutte majuscole, ed ambe le Iscrizioni intiere,e finite e non tronche; e sono incise in due gran Lastroni di sasso nostrale rosso, dellagrandezza che osservarete nell’annessa Copia.142
I miei Concittadini, tosto ne inviarono copia (sebbene con poca esattezza) inMessina al Sig(no)r Protopapa Vinci, ed in Palermo al Sig(no)r Can(oni)co Schiavo:Il p(rim)o tradusse la grande Iscrizione [108] [come] siegue
Populus Tauromeniensiu(m) Olimpio-nicen, me qui vici in CertaminePythio Celetem (idest Equitem) per=fecit
Il Sig(no)r Schiavo però inviò la seguente versione:
Populus TauromenitanusOlympum Olimpij filiu(m) Messenium
F. MUSCOLINO - I MONUMENTI DI OLYMPIS E DI C. CLAUDIO MARCELLO A TAORMINA 447
140 La trascrizione dei docc. 1-6 è stata condotta su una scansione digitale, poiché il car-teggio originale non è attualmente consultabile. Lo scioglimento delle abbreviazioni è traparentesi tonde, mentre tra parentesi quadre sono i numeri di foglio e le poche parolenon visibili nella scansione perché coperte dal pulsante di scorrimento o perché danneg-giate. Le parole sono trascritte fedelmente, rispettando tutte le particolarità dell’ortogra-fia e dell’accentazione e cercando di rispettare l’uso delle iniziali maiuscole, non semprefacilmente distinguibili dalle minuscole.
141 Siracusa, Biblioteca Arcivescovile Alagoniana, Raccolta di lettere di uomini illustridirette al signor conte D(on) Cesare Gaetani compilata da Francesco di Paola Avolio (d’ora inpoi Carteggio Gaetani), raccoglitore 1, ff. 107-110. Inedita. La parte iniziale della lettera(da « Se v’incommodo » a « possedete ») è trascritta da SGARLATA 1993, p. 82, nt. 218come riprova della stima che Gaetani godeva, come grecista, da parte dei contempo-ranei. Un brano più esteso (da « Se v’incommodo » a «Valverde ») è trascritto ibidem,p. 224, doc. 15.
142 V. infra, doc. 2.
448 REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D’ARCH. – VOL. LXXXII
Victorem in Pythia cum Celiti (idestcum veloci equo). . . . . anno 10.
Egli però si dichiara non intendere l’ultima parola dell’istessa Iscrizione, e cio amio credere, perché non gli fu trascritta con esattezza, come io feci nell’annessaCopia.
Due cose non comprendo in questa sua versione, l’una come il termine MESTON,potesse traducersi per Messenium; e l’altra che non intendo è quell’anno 10.
In forza dunque di questa Iscrizione abbiamo la cognizione di un Vincitore nelCorso a Cavallo ne’ Giochi Pittj, come lo fu il v(ost)ro vecchio Gerone, e tuttochePrincipe di si illustre grande Citta, pure ricercò tal’Onore.143
[109] La piccola Iscrizione il med(esi)mo Sig(no)r Schiavo la tradusse cosi. =
Cajus ClaudiusMarci filius Marcellus.
E la lettera G ch’è sola, la vuole che fosse iniziale di Gymnasiarcha; cosichea[mbe]due144 Iscrizioni vuole che appartenessero al nostro antico Ginnasio, di cui,come ben sapete, largamente ne discorre il celebre Sig(no)r Jacopo Filippo D’OrvilleOlandese, traducendo, e commentando l’altre due nostre Iscrizioni greche, che aquesto nostro antico Ginnasio appartengono.145
Il sasso in cui è incisa l’accennata Iscrizione di Marcello, ha al di sopra nel piano,due cavita lunghe un palmo, e da quattro dita profonde, ne’ quali mi figuro che vifossero stati perni, e vi posavano i piedi, per sicuro sostegno della Statua, che m’im-magino fosse stata collocata nel Foro; di cui, sebbene oggi non ne sapessimo il sito,ne fa parola dallo stesso Cicerone nelle Verrine,146 ove narra la coraggiosa, ed insiemeingegnosa maniera con cui i Taorminesi prostrarono la Statua dell’iniquo Verre chenel Foro gli avevano collocato.
Io mi figuro che questo Cajo Marcello fosse figlio di quel M. Claudio Marcello,147
che fu l’Espugnatore della v(ost)ra Siracusa, e che ridusse in Provin[110][cia il]Regno del v(ost)ro Re Gerone; e non già un’altro Cajo Claudio Marcello,148 che negli
143 Ierone I.144 Le lettere tra parentesi quadre sono scomparse per una lacuna del foglio.145 Si tratta dei due frammenti della tavola dei ginnasiarchi (IG XIV 422), trascritta e
commentata da J. P. D’ORVILLE, Sicula (cit. nota 17), p. 268 e ibidem, pp. 526-559, nell’ap-pendice a cura di Petrus Burmannus Secundus (Pieter Burman(n) il Giovane).
146 CIC., In Verrem, II, 2, 160.147 In realtà il figlio di M. Claudio Marcello (console nel 196 a.C.) ha lo stesso praeno-
men del padre (MÜNZER 1899, coll. 2755-2757, nr. 222; BROUGHTON 1951-1952, I, p. 335 e II,p. 546).
148 C. Claudio C. f. Marcello, console nel 50 a.C. (704 a.u.c.), figlio del C. Claudio Mar-cello dell’epigrafe tauromenitana (MÜNZER 1899, coll. 2734-2736, nr. 216; BROUGHTON 1951-1952, II, pp. 247 e 546; R. SYME, The Augustan Aristocracy, Oxford 1986, pp. 141-144;E. BADIAN, The Consuls, 179-49 BC, in Chiron XX 1990, p. 397); suo cugino C. Claudio M. f.
F. MUSCOLINO - I MONUMENTI DI OLYMPIS E DI C. CLAUDIO MARCELLO A TAORMINA 449
anni di Roma 704. era uno de’ Consoli, rapportato dall’Abate di Vertot nella sua Sto-ria della rivol(uzione) della Rep(ubblica) Rom(ana),149 mentre questi visse 165 annii[nci]rca150 dopo del v(ost)ro Espugnatore; ed è molto verisimile che i nostri Antichiin quei frangenti di guerra per benevolarsi il Vincitore, essendo Taormina perdecreto degli stessi Romani, fra le Citta del Regno di Gerone avessero alzato nel Forouna Statua al figlio di Costui, e non gia al posteriore Marcello, per cui avrebberoposto nell’Iscrizione il titolo di Console. Siche vi priego illuminarmi non solo collav(ost)ra erudizione intorno a tutto l’anzid(ett)o ma inoltre degnatevi rimettermi lavera traduzione Latina delle accennate due Iscrizioni; giacche si è disposto collocarsiin un luogo proprio le due Lapidi in unione della versione Latina per commodo de’Letterati viaggiatori. Quindi anzioso dell’onore de’ v(ost)ri cari comandi, al solito miripeto essere
V(ost)ro Serv(ito)re ed amicoIgnazio Cartella
Doc. 2. Trascrizione delle due iscrizioni 151
[112-113]ODAMOS TWN TAUROMENITAN
OLUMPIN OLUMPIOS MESTON
NIKASANTA PUQIA KELHTI
TELEIWI
L’altra inscrizioneGAIOS KLAUDIOS
MAARKOUUIOS MAARKELLOS
G
La Lapide della inscrizione prima, è lunga due palmi, e mezo, e oncie quattro,alta di fronte dove è l’inscrizione un palmo, ed oncie s[…]152 larga due palmi, e mezo,e oncia una. L’altra lapide, in cui è la piccola inscrizione, è lunga tre palmi, ed oncie
Marcello è console l’anno successivo (MÜNZER 1899, coll. 2736-2737, nr. 217; BROUGHTON
1951-1952, II, pp. 256 e 546).149 R.-A. VERTOT, Histoire des révolutions arrivées dans le gouvernement de la République
Romaine, Paris 1719 (con numerose edizioni italiane).150 Le lettere tra parentesi quadre sono scomparse per una lacuna del foglio (la stessa
che ha danneggiato, nella pagina precedente, la parola « a[mbe]due »).151 Siracusa, Biblioteca Arcivescovile Alagoniana, Carteggio Gaetani, raccoglitore 1, ff. 112-
114. Non si tratta di un vero e proprio apografo, ma di una trascrizione, perché le lettere,a eccezione dei due omega dell’iscrizione di Olympis, non sono riprodotte in maniera rea-listica. Il particolare dei due omega rende sicuro che la trascrizione è opera di chi ha vistol’epigrafe: dovrebbe trattarsi della copia inviata da Cartella, anche se le annotazioni nonsono di suo pugno.
152 Parola illeggibile.
450 REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D’ARCH. – VOL. LXXXII
sei, alta di fronte ove è incis[a …] [114] […] un palmo[, onci]e sei, e larga trepalmi153
Cartella154
Doc. 3. Traduzione delle epigrafi e annotazioni 155
[116-117]
Populus Tauromenii Olympum Olympi Filium Perfectum Victorem In Ludis Pythiis SuperEquum Desultorium Perfecit.
Cajus Claudius Marcus Marcellus. Trium Pedum.
D©moj Doricè pro dÁmoj, ou populusTauromen…tan Doricè pro Tauromen…twn gen. plur.Nik£santa Doricè pro nik»santa aor. 1. partic. act. a nik£w vincoTeleiîi Doricè, et Atticè pro teleio‹ pers. 3. sing. ind. act. a teleiÒw perficio
Doc. 4. Traduzione delle epigrafi e annotazioni 156
[119]Populus Tauromenii Olympum OlympiFilium Plenum Victorem In Pythiis
Equo Veloci Perficit=
Cajus Claudius Marci Marcellus Tertiussivè Trium Pedum
sivè Senatus (subaud. posuit)=
Mi sembra in miglior forma tradotta la voce Tauromenitan in latino Tauromenii geni-tivo plurale di nome di Città secondo il dialetto Dorico, come Syracusae, arum; e nongià Tauromenitanorum, o Tauromeniensium genitivo sostantivo, o adjettivo: dovendosi intal caso piuttosto dire Populus Tauromeniensis.
153 In CARTELLA, Discorso cit. (nota 16), pp. 223-224, per l’iscrizione di Olympis si parla di«un lastrone lungo due palmi, ed oncie dieci, largo due, ed oncie tre, ed alto di fronte, oveè incisa, palmo uno, e tre oncie », per quella di C. Claudio Marcello di «un consimile sassolungo tre palmi, e mez<z>o, largo tre, ed alto di fronte, ove è incisa, un palmo, e mezzo».
154 La ripetizione del cognome alla fine del testo sembra indicare che la trascrizione ele annotazioni sono di Cartella, ma scritte da un’altra mano.
155 Siracusa, Biblioteca Arcivescovile Alagoniana, Carteggio Gaetani, raccoglitore 1, ff. 116-117. Il testo è, molto probabilmente, di mano del Gaetani; la grafia è, infatti, simile a quelladei testi autografi riprodotti in SGARLATA 1993, tavv. 5-8.
156 Siracusa, Biblioteca Arcivescovile Alagoniana, Carteggio Gaetani, raccoglitore 1, ff. 119-121. Il testo è scritto con la stessa grafia del documento precedente, dunque è anch’esso,probabilmente, di mano del Gaetani.
F. MUSCOLINO - I MONUMENTI DI OLYMPIS E DI C. CLAUDIO MARCELLO A TAORMINA 451
La spiegazione di Olympionicen sulle voci olumpin olumpioj non è adequata,quando per altro nella medesima Iscrizione più sotto vi è Victorem in Pythiis, che è l’i-stesso che dire Olympionicem; onde si replicarebbe la medesima cosa sotto diversi sino-nimi. La più verisimile è quella di Olympum Olympi Filium.
Che la voce Meston sia un sopranome bastantemente non si pruova; megliosarebbe spiegarlo come lo divisa il calapino greco in significato di plenus, refertus. Lainterpetrazione Messenium dal greco Messhnioj sembra arbitraria primo, perché laparola è scritta intera-[120]mente senza cifra di abbreviature, e secondariamentenella voce Messenioj non entra la lettera t della parola Meston.
Il dire Equo veloci, equo desultorio, celiti son la medesima cosa sotto diversi sinonimi;senonché il celiti spiega meno degli altri due vocaboli, mentre quello spesse volte siadopra in significato di semplice cavallo. Ma quì la voce Kelhti secondo il dizionariogreco equivale157 al Latino158 equo veloci, sivè desultorio.
Teleioi si è tradotto perficit per essere questo il vero significato di teleiw, o telew,o teleiow perficio.
Nella 2.a iscrizione mi sottometto al parere di quei, che la voce Markouuioj
Maarkelloj spiegano Marci Marcellus, cioè Cajus Claudius Marcellus Filius Marci sem-brandomi quel Markouuioj un genitivo singolare delle Imparisillabe; tuttavia perònon ho possuto ritrovare la vera Inflessione ne’ casi di questa voce, sebbene il grecoMarkoj, ou significhi un nome proprio di Marco differente nella inflessione dalsudetto.
Finalmente studiando seriamente la lettera G termine della seconda Iscrizione,la spiegherei meglio in significato di tertius, mosso dall’autorità di Grutero pag.210., di Sponio Popul. Att. pag. 166, e di Donio Cl. II. n. 73. pag. 88. che così tra-ducono il G nelle antiche lapidi greche, come li cita il P(adre) Corsini nel suo NotæGræcorum, sive Vocum Compendia: 159 ed è conseguente alla Storia de’ molti Marcelli.In significato di tres, trium si trova spiegato dal d(ett)o [121] Grutero pag. 730. n. 6.presso il mentovato Corsini; epperciò la misura della Lapide, ove è scolpita la pre-sente Iscrizione, mi animò ad interpetrare pure il G per trium pedum. Il Muratoriopag. 467 n. 7.160 e Cl. Maffejo presso il sud(ett)o Corsini lo spiegò in alcune mar-moree Lapidi sotto il nome di Gerous…a, scilicet Senatus; onde in questa potrebbeanche aver luogo questa terza spiegazione sottintendendosi qualche verbo, comeposuit, fecit etc. La d(ett)a lettera G interpetrata per Gymnasiarcha non si comprovada’ altri monumenti, o da Storia.
157 Parola aggiunta nell’interlinea superiore.158 Parola aggiunta nell’interlinea superiore.159 E. CORSINI, Notae graecorum sive vocum et numerorum compendia, Florentiae 1749,
pp. 13-14, da cui Gaetani ricava le citazioni delle opere di J. Gruter o Gruytere, I. Spon,G. B. Doni, S. Maffei.
160 L. A. MURATORI, Novus thesaurus veterum inscriptionum, Mediolani 1739-1742, I, p. 467,nr. 7.
452 REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D’ARCH. – VOL. LXXXII
Doc. 5. Lettera di Ignazio Cartella a Cesare Gaetani della Torre, Taormina, 4 luglio 1770 161
[123]Taormina 4 Luglio del 70
A(mico) C(arissimo)Ritrovandomi, come vi dissi, fuori di Citta, ho attrassato rispondervi; giacche biso-
gnai Colà scrivere per avere Copia della versione Latina fece delle sapute due Iscri-zioni il Sig(no)r Abate Francese, ed il mio amico, mi ritardò pure la risposta; ondequi adesso vi acchiudo la di Lui traduzione.162
Egli è vero che le Versioni fatte della grande Iscrizione, in sostanza dicono lostesso, variano pero in alcuni termini, e specialmente la parola MESTON, che ilSig(no)r Schiavo, non restò persuaso che si spiegasseMestum: A me però, che non hodiscernimento, sembra che in cio nessuno de’ due abbia dato nel segno; parendomimolto piu propria, e plausibile la v(ost)ra versione; cosiche da canto mio, consultoche s’incidesse la vostra.
Desidererei però che colla v(ost)ra erudizione m’illuminassivo su due particola-rità; L’una donde mai nasce la varietà, non degli altri termini, che posson dirsi sino-nimi, ma pella d(ett)a parola, che la spiega dell’uno, è si differente dall’altra, in unaIscrizi-[124][one nell’i]stessa Lingua, ch’è intiera, colle lettere chiare, e lampanti,senz’abbreviature, e senza diversita d’accenti?
L’altra particolarità si è, che voi mi avvisaste che la lettera G in fine della piccolaIscrizione significasse tre piedi: Onde voi che siete versato a fondo in questa materia,vi priego illuminarmi, per qual fine e motivo si notasse nelle Iscrizioni la misura dellaLapida; e che necessità v’era quando il sasso si vedea, e da ogniuno poteasi franca-mente misurare, qualora si fosse avuto il piacere, e l’impegno di saperlo?
Ben vi accorgete pure che il Maarkouuioj, entrambi lo spiegano Marci f. ed io,replico, donde mai nasce che un termine della stessa Lingua, ch’è con chiarezzascritto, diversamente si traduce?
Per corrobborarsi dunque la v(ost)ra Versione della piccola Iscrizzione, sipotrebbe, forse, congetturare, che fosse dedicata a due Soggetti della stessa Gente, eFamiglia; cioe a Cajo, e Marco Claudio Marcello; opure ad un solo, e questi avesse inuso di portare due Pronomi; cioe Cajo, e Marco Claudio Marcello; So che era forsecostume praticarsi da qualched’uno de’ Romani; come ne abbiamo l’esempio del-l’Imperatore Geta, che avea i Prenomi di Lucio, e [125] Publio, sebbene questi vissein tempi posteriori del Soggetto della nostra Iscrizione; ma chi fosse stato, è da indo-vinarsi. Io leggo che un Cajo Marcello,163 fu figlio di M. Marcello, e di Ottavia sorella
161 Siracusa, Biblioteca Arcivescovile Alagoniana, Carteggio Gaetani, raccoglitore 1, ff. 123-126. Inedita.
162 Nel post scriptum a questa stessa lettera.163 Cartella in realtà inverte i praenomina: C. Claudio Marcello, figlio del C. Claudio Mar-
cello onorato nell’epigrafe tauromenitana, è il padre del M. Claudio Marcello (42-23 a.C.)nipote e genero di Augusto (v., in particolare A. GAHEIS in RE, III,2 1899, s.v.M. Claudius Mar-cellus, coll. 2764-2770, nr. 230 e SYME, The Augustan Aristocracy cit. [nota 148], pp. 141-144).
F. MUSCOLINO - I MONUMENTI DI OLYMPIS E DI C. CLAUDIO MARCELLO A TAORMINA 453
d’Augusto, che poi fu Genero dello stesso, avendo sposata sua figlia Giulia, che p(rim)oloco fu moglie di questo Cajo Marcello, poi di M. Agrippa, e finalmente dell’Impera-tor Tiberio: Onde se la nostra Iscrizione fosse stata fatta a Costui, ò a qualche altropiu prossimo discendente del v(ost)ro Espugnatore, io non basto divisarlo: Commu-nicatemi dunque intorno a quanto vi ho pregato il v(ost)ro erudito parere per miaistruzione; e frattanto comandatemi, e sempre più credetemi
V(ost)ro Serv(ito)re ed amicoIgnazio Cartella, e Rocco
P.S.Il Sig(no)r Abate D(on) Beltrando Chaupi Francese nel passaggio fece da questaCitta a 20 Maggio 1770, tradusse dal greco in Lati=[126][no l’is]crizione dellap(rim)a Lapida come siegue
Populus TauromenitanorumCelebrat Olimpum Filiu(m) Olympij Meston*
Victorem Pythicorum Equo veloci.
Della 2.aCajus Claudius Marci filius Marcellus
Gymnasiarcha.
* Lo considerò per Prenome di Olimpum
Doc. 6. Lettera di Gabriele Lancillotto Castelli di Torremuzza a Cesare Gaetani dellaTorre, Palermo, 10 luglio 1770 164
[127]
Eccellenza
Non mi avanza altro da riscontrar V(ostra) E(ccellenza) in risposta del gentilis-simo suo Foglio, ed in cui mi acchiuse la Lett(er)a p(er) Roma, che di aver questa giàdirizzato Colà con commodo di Barca, e con persona assai sicura, la quale al suoimmediato arrivo la consegnerà a mani proprie del P(rio)re165 Ambrosini,166 ondep(er) ciò resta servita l’E(ccellenza) V(ostra).
164 Siracusa, Biblioteca Arcivescovile Alagoniana, Carteggio Gaetani, raccoglitore 1, ff. 127-128. Inedita. Le uniche parole autografe sono «Divot(issi)mo ed Obl(igatissi)mo Se(rvito)ree cug(i)no Gab(riel)e Lanc(illott)o Castello »; il resto della lettera è scritto con altra grafia.A questa missiva di Torremuzza fa riferimento Francesco di Paola Avolio nella sua lettera aGiovanni D’Angelo « intorno alla pubblicazione del commercio epistolare di Gabriello Lan-cillotto Castelli Principe di Torremuzza » (Siracusa, 25 dicembre 1799), pubblicata in calce(pp. 129-141) alle postume Memorie cit. (nota 9) del Torremuzza; alle pp. 139-140, Avolio,citando una delle lettere torremuzziane che Gaetani non aveva smarrito, scrive, infatti: « Inuna lettera de’ 10. Luglio 1770. si parla di certa Iscrizione di Tavormina».
165 O «P(ad)re », che però è normalmente abbreviato in «P(adre) ».166 Forse Andrea Ambrosini, autore dell’opera Delle memorie storico critiche del cimiterio di
Nola, Napoli 1792.
454 REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D’ARCH. – VOL. LXXXII
La Cassa poi che pervenne quì da Roma, e che a V(ostra) E(ccellenza) era diriz-zata, mi figuro che l’abbia a quest’ora capitata, mentre la Feci consegnare sulla Barcadi P(adro)n Giuseppe Nirè, che partiva p(er) cod(est)a
Al Sig(no)r D(on) Ignazio di lei Fratello167 anche mandai le sapute (onze) dieciquali mi sono state qui pagate da questo Sig(no)r B(aro)ne di S(ant’)Anna.168
La Iscriz(ion)e di Tavormina già l’avevo preventivam(en)te avuta coll’avviso peròche la Iscriz(ion)e è unica, venuta [128] [di] sotterra in due pezzi; la versione, che neho fatto è la seguente:
Populus Tauromenitanorum(Honorat) Olympum Olympij F: Mestonem
Victorem Pythicorum Equo Veloci: : : : : :
Cajo ClaudioMarci filio MarcelloGymnasiarcha.
In Catania se n’è scoverta un’altra, e me la mandò Biscari.169 In Siracusa mi pare cheda qualche tempo in quà siano diseccate le vene dei Tesori sotterranej.170
La riv(erisc)o infine di vero cuore la priego de suoi a me graditi comandi, ed alsolito mi confermo.
Di V(ostra) E(ccellenza) Palermo 10. Luglio 1770
S(ua) E(ccellenza) Sig(no)r Conte della TorreSiracusa
Divot(issi)mo ed Obl(igatissi)mo Se(rvito)ree cug(i)no
Gab(riel)e Lanc(illott)o Castello
167 Citato anche in una lettera di Torremuzza a Gaetani del 1785 (SGARLATA 1993,pp. 252-253, doc. 64) e in una del 1786 di Gaetani a Torremuzza (ibidem, pp. 254-255, doc. 66).
168 Michele Asmundo Landolina (F. SAN MARTINO DE SPUCCHES, La storia dei feudi e deititoli nobiliari di Sicilia dalla loro origine ai nostri giorni, Palermo 1924-1941, IV, pp. 111-112,115) oppure Ambrogio Alberto Riccio (ibidem, VI, pp. 444-445). Il Barone di Sant’Anna,sempre a proposito di un pagamento, è citato anche in una lettera di Schiavo a Gaetani del1769 (SGARLATA 1993, pp. 221-222, doc. 20).
169 CIL X 7014; su questa iscrizione, alla quale il Principe di Biscari dedica il Discorsoaccademico cit. (nota 5), v. K. KORHONEN, Le iscrizioni del Museo Civico di Catania. Storia dellecollezioni - cultura epigrafica - edizione (Commentationes Humanarum Litterarum, 121), Helsinki2004, pp. 149-151, nr. 7 (con bibl. prec.).
170 Gaetani è il “ fornitore ” ufficiale di epigrafi siracusane per le due edizioni della Col-lectio torremuzziana (1769 e 1784); tale ruolo del conte siracusano è ampiamente indagatoda SGARLATA 1993, pp. 57-88 e passim, è testimoniato dal carteggio tra i due studiosi (ibidem,pp. 243-246, docc. 48, 50-51; p. 250, doc. 59; pp. 251-256, docc. 63-68; p. 258, doc. 77;pp. 260-262, docc. 82-83) ed è costantemente riconosciuto da Torremuzza (ibidem, pp. 77-78).
F. MUSCOLINO - I MONUMENTI DI OLYMPIS E DI C. CLAUDIO MARCELLO A TAORMINA 455
Doc. 7. Annotazioni sulle iscrizioni di Olympis e C. Claudio Marcello 171
[1123]
L’Anno 1770. nel Mese di Marzo nel cavarsi il pidamento172 pell’ampliazione delnostro Monastero, si ritrovarono le due seguenti Iscrizioni, nel luogo ove al presentesi ritrova situato il nuovo Portone di d(ett)o M(on)astero.
O DAMOS TWN TAUROMENITAN
OLUMPIN OLUMPIOS MESTON
NIKASANTA PUQIA KELHTI
TELEIWI173
Il Sasso di questa Iscrizione è di Pietra rossa nostrale, ed è lungo palmi due, e mezzo,ed oncie quattro; Alto di fronte dove è l’iscrizione palmo uno, ed oncie tre; largopalmi due e mezzo, ed oncia una. Nel Piano di questo sasso si vedono due concavitàartefatte, che forse era il sito dove posavano i piedi della Statua.Questa Iscrizione poi cossì è stata interpretata dalli Eruditi, cioè.L.’Abb(at)e D(on) Bertrando Chaupì Francese nel passaggio fece da questa a 20.Maggio 1770. cossì la tradusse
Populus TauromenitanorumCelebrat Olimpum Filium Olympij Mestum
Victorem Pythiorum Equo veloci
Dalli Sig(no)r Can(oni)co D(otto)r D(o)n Domenico Schiavo Panormitano, fù tra-dotta della seguente maniera
Populus TauromenitanusOlympum Olympij Filium Messenium
Victorem in Pythis cum Celeri idest cum veloci equoanno 10.
Dal Sig(no)r Conte D(on) Cesare Gaetani è stata tradotta della maniera che siegue
Populus TauromenijOlympium Olympij Filium Plenum Victorem in Pythiis Equo veloci p(er)fecit
[1124]
L’altra Iscrizione dice cossì.GAIOS KLAUDIOS
MAARKOUUIOS MAARKELLOS
G
171 Palermo, Biblioteca Comunale, ms. Qq H 272, ff. 1123-1124.172 S. BATTAGLIA (ed.), Grande dizionario della lingua italiana, XII, Torino 1984, p. 916,
s.v. Pedamento: « Basamento su cui poggia una costruzione, un edificio, ecc.», dal lat. peda-mentum; la grafia pidamento può essere considerata un sicilianismo (G. PICCITTO - G. TROPEA,Vocabolario siciliano, III, Catania-Palermo 1980, p. 723, s.v. Pidamentu).
173 Nella trascrizione la forma dell’omega e del theta sono fedelmente riprodotte.
456 REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D’ARCH. – VOL. LXXXII
Il Sasso di questa Iscrizione è di pietra rossa nostrale, e lungo palmi tre, ed oncie sei;Alto di fronte dove è l’iscrizione palmo uno, ed oncie sei, largo palmi tre.Dalla Parte di sopra di questo Sasso, vi sono due sesti (?) di aste, cioè una per parte.174
L’interpretazione, che si ha dal detto Sig(no)r Chaupì è stata la seguente.
Cajus Claudius Marci Filius MarcelliGymnasiarcha.
Il Sig(no)r Can(oni)co Schiavo la tradusse della maniera che siegue.
Cajus Claudius Marci Filius MarcellusGymnasiarcha.
Dal Sig(no)r Conte D(on) Cesare Gaetani è stata tradotta della seguente maniera
Cajus Claudius Marci Filius MarcelliGymnasiarcha.
174 Si tratta probabilmente dei due incavi per grappe (v. supra p. 429 e fig. 15).
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE
BACCI 1980-1981 G. BACCI, Ricerche a Taormina negli anni 1977-1980, in KokalosXXVI-XXVII II.1 1980-1981, pp. 737-746.
BROUGHTON T. R. S. BROUGHTON, The Magistrates of the Roman Republic (Philolo-1951-1952 gical Monographs published by the American Philological Associa-
tion, 15), New York 1951-1952.
GENTILE 2002 L. GENTILE, ”OlÚmpij 'OlÚmpioj ed IG, XIV, 434, in EpigraphicaLXIV 2002, pp. 224-229.
La Sicile de J. DUBOULOZ - S. PITTIA (edd.), La Sicile de Cicéron. Lectures des Ver-Cicéron 2007 rines, Actes du colloque de Paris, 19-20 Mai 2006, Presses uni-
versitaires de Franche-Comté 2007.
LAZZERETTI 2006 A. LAZZERETTI, M. Tulli Ciceronis, In C. Verrem actionis secundae liberquartus (De signis). Commento storico e archeologico, Pisa 2006.
MANGANARO 1964 G. MANGANARO, Iscrizioni latine e greche dal nuovo edificio termale diTaormina, in CASA III 1964, pp. 38-68.
MANGANARO 1979 G. MANGANARO, La provincia romana, in Storia della Sicilia, II,Napoli 1979, pp. 413-461.
MANGANARO 1988 G. MANGANARO, Le tavole finanziarie di Tauromenion, in D. KNOEP-FLER (ed.), Comptes et inventaires dans la cité grecque. Actes ducolloque de Neuchâtel en l’honneur de Jacques Tréheux, Neuchâ-tel-Genève 1988, pp. 155-190.
MÜNZER 1899 F. MÜNZER, Claudii Marcelli, in RE, III,2 1899, coll. 2731-2764.
MUSCOLINO 2007 F. MUSCOLINO, I “ ragguardevoli antichi monumenti ” di Taormina.Epistolario di Ignazio Cartella con Domenico Schiavo, GabrieleLancillotto Castelli di Torremuzza e Salvatore Maria Di Blasi(1747-1797), in Mediterranea – Ricerche Storiche, anno IV,n° 11, 2007, pp. 581-616.
RIZZO 1893 G. RIZZO, La tavola dei Ginnasiarchi a Tauromenio. Contributi alla sto-ria dell’elemento dorico in Sicilia, parte I, Palermo-Torino 1893.
RIZZO 1904 G. RIZZO, Iscrizioni tauromenitane, in ASM IV 1904, pp. 107-122.
SARTORI 1954 F. SARTORI, Appunti di storia siceliota: la costituzione di Tauromenio,in Athenaeum XXXII 1954, pp. 356-383.
SGARLATA 1993 M. SGARLATA, La raccolta epigrafica e l’epistolario archeologico di CesareGaetani conte della Torre (Seia, Quaderni dell’Istituto di StoriaAntica, 10), Palermo 1993.
SIEDENTOPF 1968 H. B. SIEDENTOPF, Das hellenistische Reiterdenkmal, Waldsassen 1968.
F. MUSCOLINO - I MONUMENTI DI OLYMPIS E DI C. CLAUDIO MARCELLO A TAORMINA 457
I N D I C E
Elenco degli Accademici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V
Consiglio Accademico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII
Verbali delle adunanze pubbliche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV
COMUNICAZIONI SCIENTIFICHE
R. NARDI, Il restauro del mosaico della trasfigurazione nel monastero diSanta Caterina nel Sinai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. ANDREAE, Novità su Prassitele e Apelle . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
F. TAGLIETTI, I tondi Caetani con busti di divinità: una nuova testimo-nianza di scultura microasiatica in età tardo antica . . . . . . . . 33
F. GANDOLFO, Il riuso di materiali classici nei portali medievali del Lazio . 73
D. ROSSI, G.L. GREGORI, Recenti ritrovamenti tra il V e il VI migliodell’antica via Flaminia: un tratto di viabilità e l’adiacente areanecropolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
I. D. ROSSI, L’area archeologica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
II. G.L. GREGORI, Le iscrizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
S. PANCIERA - F. DI GENNARO, Ficulea: un nuovo frammento epigrafico.Problemi storici e topografici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
N. BONACASA, Riflessioni sulla scultura romana di Sabratha . . . . . . . 177
M. GALLI, Il busto loricato di Lucio Vero a Delo: una dedica di ErodeAttico nel santuario di Apollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
M. SAPELLI RAGNI, Novità e prospettive della ricerca archeologica a VillaAdriana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
N. AGNOLI, Scultura greca a Praeneste: una statua femminile dall’areadell’ex-seminario arcivescovile di Palestrina . . . . . . . . . . . . . 263
A. AMBROGI, Una statua togata dal ‘Ginnasio Romano’ di Siracusa: uncaso di reimpiego nella Sicilia tardoantica . . . . . . . . . . . . . . 293
P. CUGUSI, ‘Cicli’ di carmi epigrafici cristiani. Mediolanum, Roma (Late-ran., Vatican.), Nola, Spoletium, Hispalis . . . . . . . . . . . . . . . 373
F. MUSCOLINO, I monumenti di Olympis e di C. Claudio Marcello a Taor-mina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
460 REND. DELLA PONT. ACCAD. ROM. D’ARCH. – VOL. LXXVIII