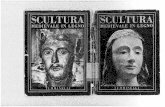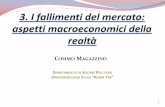Su alcuni aspetti della Mariologia medievale
Transcript of Su alcuni aspetti della Mariologia medievale
I Lezione Nella cultura cristiana, un posto privilegiato spetta al ruolo e alleprerogative della Madonna.
Nonostante il poco spazio riservatole nel Nuovo Testamento, laricchezza dei dati su di lei desumibili dalle fonti della Tradizione,la profondità della devozione popolare nutrita nei suoi confronti e lacomplessità della riflessione teologica che la riguardò hanno causatouno straordinario successo della sua figura.
Maria è divenuta un elemento fondamentale della religione cristiana, eattraverso essa delle culture che si sono intrise di questa religione,in primis quella medievale.
Constatare la persistenza e lo sviluppo dell'idea mariana nel Medioevoè, in conseguenza di ciò, una spia indicativa di svariati fenomenistorico-culturali, e merita perciò un'attenzione particolare.
In effetti, uno studio del genere permette di seguire attentamente losviluppo storico della teologia, della devozione, del culto liturgico,e di ciò che vi è connesso, come l'arte e la letteratura sacre,rendendo alla storia religiosa un servizio non comune.
Ma tale studio ci restituisce, almeno parzialmente, la fisionomia dellesocietà che custodirono e svilupparono l'idea mariana nel Medioevo.
Ciò avviene a livelli sempre più profondi, da quello sociologico aquello psicologico collettivo o all'antropologico. E questo perché laMadonna è una figura simbolica, profondamente radicata nelle dinamichepiù intime del vivere umano, come del resto tutte le figure religioseche incarnano il divino in chiave femminile.
Si consideri per esempio l'importanza sociologica della Madonna, siacome elemento che influenza lo sviluppo religioso, sia come realtà asua volta condizionata, da come nelle varie epoche è stata concepita.
Per esempio, all'epoca delle Crociate baltiche, in seguito allaconsacrazione alla Vergine dei paesi dell'area, la loro conquistadivenne un atto di devozione a lei, che nella letteratura religiosa,nella devozione, nel magistero ecclesiastico e nella pietà privataassunse i caratteri di una "divinità" guerriera assai esigente.
Oppure, nel momento della fioritura della Scolastica, fu l'accentoteoretico posto sul concetto di persona ad acuire il ruolo mediativodella Vergine nell'economia salvifica.
D'altra parte, nessuno ignora gli influssi sociali del culto mariano,che si manifestano in fondazioni socio-caritative, culturali, religiose, per cui appare superfluo insistere sulla rilevanza sociologica dellafigura di Maria.
Analogamente, si riscontra uno sviluppo storico della psicologiacollettiva proprio in chiave mariana. Infatti, la nozione della Madonnanella mente dei più influenza la percezione che essi hanno dei valori,degli affetti, della vita e della morte, della religione.
Questo avviene senz'altro per l'alto contenuto etico-esistenziale dellafigura di Maria, ma, andando in maggiore profondità, anche perché essa,come fatto psichico, può essere assimilata all'idea di anima delpantheon archetipico junghiano.
In tal senso, la storia della considerazione che si è avuta dellaMadonna in un dato periodo investe gli stessi aspetti antropologicidella civiltà di allora, in quanto ci mostra che considerazione essa hadell' homo, e che funzione ha il femminile in relazione ad esso.
Infatti, se la Madonna è stata considerata sempre dai cristianil'essere umano più nobile, questo ha influito sulla considerazione ditutti gli altri esseri umani; ma è anche vero il contrario: la maggioreo minore misoginia dei tempi ha più o meno isolato la Madonna dal restodell'umanità.
Alla luce di ciò, l'idea della Vergine nella storia ha un valoresimbolico, nel senso etimologico, rispetto all'idea che ogni società ecultura ha di sé, e di come essa si mostra nel quotidiano e nellostraordinario.
E allora quale fu l'idea mariana nel corso del Medioevo? Sapendo che lacultura medievale si fonda sulla tradizione patristica, partiremo daquesta per inquadrare lo sviluppo mariologico, inteso sia come fatto dialta cultura (la teologia) che come devozione vissuta.
II Lezione
LA TEOLOGIA MARIANA
Per il primo aspetto, bisogna evidenziare che il Medio Evo èdebitore, come dicevamo, alla mariologia patristica, a sua voltafortemente fondata sulla Bibbia; tuttavia non mancarono ovviamenteapporti originali, legati specialmente alla teologia scolastica.
Generalmente i Padri inserirono il discorso mariologico in uncontesto più ampio, di tipo cristologico o ecclesiologico osoteriologico.
Nella letteratura patristica si rinvengono sin dalle originiimmagini e concetti assai importanti nel mondo medievale (e nonsolo), come ad esempio il parallelismo tra Eva e Maria, trattodall'Adversus Haereses di Ireneo e dal Dyalogus cum Tryphone di Giustino,(1) mentre qua e là si scorgono importanti ma dispersi contributiteologici (come nei vari De Incarnatione di Apollinare, Ambrogio,Teodoreto di Ciro, Nestorio, o nei vari De Trinitate di Ilario, Eusebio di
Vercelli, Cirillo Alessandrino), inseriti in commenti biblici (diOrigene, Ambrogio, Cirillo, Gregorio Nisseno), in omelie ecatechesi (Gregorio Nisseno, Anfilochio, Severiano, Agostino,Basilio, Cirillo Gerosolimitano), nei trattati ascetici sullaverginità (Atanasio, Gregorio Nisseno, Ambrogio), negli innicristologici (Efrem Siro, Giovenzio, Sofronio).
Già da quest'epoca emergevano i temi della corredenzione, delladivina maternità, della verginità perpetua e del culto mariano. (2)
I primi secoli svilupparono anche delle forme narrative, omiletichee dogmatiche, di teologia.
Nel primo caso, va ricordato il Protovangelo di Giacomo, o Natività diMaria, apocrifo del II secolo, i cui dati sulla biografia dellaMadonna hanno influenzato fino ad oggi la devozione religiosa, e acui faranno seguito altri apocrifi fino all'VII secolo, tuttiincentrati su Maria: (3) da essi vengono informazioni come i nomidei genitori di lei, la sua presentazione al Tempio e la suaeducazione presso di esso (entrati tutti nella liturgia enell'arte), oltre a elementi dogmatici come la virginitas in partu,la dormitio e l'assunzione.
Nell'ambito omiletico, abbiamo un corpus nutrito di sermoni che, daquello sulla Vergine ed Elisabetta di Atanasio nel 346, (4) arriva, senzasoluzione di continuità teologica, sino ai complessi mariologici diTeodoto d'Ancira (V sec.), Giacomo di Sarug (†521), Andrea di Creta(†730 ca.), Germano di Costantinopoli (†733) e Giovanni Damasceno(†749). (5)
Infine, la trattatistica dogmatica, partendo dal De Margarita diEfrem (†373) e dall'Adversus Helvidium di Girolamo, si arricchisce, nelMedioevo greco, delle opere di Cirillo d'Alessandria (†444), diLeonzio di Gerusalemme (VI sec.), di Filosseno di Mabbug (†523), diSevero di Antiochia (†538), e di Rabbula (V sec.), e in quellooccidentale di quelle di Ildefonso di Toledo. (6)
I tempi teologici erano maturi per una mariologia tipicamentemedievale, basata sul metodo scolastico, volta ad enfatizzare lamediazione della Vergine e a mettere in luce questioni comel'Immacolata Concezione e la perpetua verginità, e capace dipromuovere una fattiva devozione mariana. Addirittura essa generanuovi tipi letterari, come il Mariale, "quod est de laude Mariae".(7)
Tra i tanti fioriti nei secc. XII-XV, il più scolastico è quello disant'Alberto Magno, a cui segue a ruota quello di Riccardo di SanLorenzo (†1260). attribuito un tempo allo stesso Alberto. (8)
Nell'ambito omiletico, invece, scrittori mariani prolifici furonoBernardo di Chiaravalle col De Laudìbus Virginis, e Jacopo da Varagine oBenedetto da Busto (†1500), con le loro raccolte di sermoni.
Specifiche monografie mariane si hanno nelle forme letterarie piùsvariate, dall'epistola (Cogitis me di Pascasio Radberto, nel IXsec.) al trattato (De Conceptione Sanctae Mariae di Eadmero, XII sec.; DeExcellentia Gloriosae Virginis Mariae di s. Anselmo) fino alla biografia(l'anonimo Itinerarium Virginis Mariae, o l'Historia Virginis ex Cantico Canticorum,anonima e illustrata) e ai mìracula, tipici del Basso Medioevo,seguiti dai dialoghi (come il Liber de Sancta Maria di Ramon Lull, o ilDialogus Mariae et peccatoris di Dionigi il Certosino, morto nel 1471) edalle preghiere (quelle celebri di Anselmo d'Aosta e lo PsalteriumVirginis o rosario).
Un discorso a parte meritano i trattati teologici del tipo dellasumma. Tommaso d'Aquino, Duns Scoto, Antonino da Firenze riservanoalla Madonna significative sezioni delle loro opere. E', tuttoquesto, l'insieme di una vitale tradizione che, raggiunto l'acmetra l'XI e il XIV sec., senza esaurirsi nemmeno in etàrinascimentale, confluirà nella cultura teologica dellaControriforma, per arrivare sino ai giorni nostri.
Temi tipici della teologia mariana sono ovviamente quellidogmatici, e infatti rintracciamo una complessa riflessione suquelli che sono i grandi misteri della Fede sulla Vergine.
Ci possiamo porre un quesito preliminare: lo sviluppo storico deldogma mariologico dall'antichità al Medioevo ha conosciutosoluzione di continuità? Ossia, dobbiamo considerare i dogmimariani come un elemento estrinseco alla dottrina originaria delcristianesimo, o essi sono un esplicitazione del depositum fìdei?
A questa domanda possiamo dare una risposta migliore seconsideriamo i filoni dogmatici mariani più importanti.
Viene spontaneo partire dall'Assunzione, il dogma più recente, lacui formulazione si deve a Pio XII, nel 1950, con la costituzioneapostolica Mumfìcentissimus Deus. (9)
Il pontificato di Pacelli segna l'apogeo del movimento marianomoderno; ma è lecito presumere che il dogma da lui promulgato,nella ricchezza della sua teologia, sia realmente riconducibileallo sviluppo storico della dottrina cristiana, così come si èconfigurato tra Tardo Antico e Medioevo, e poi sino all'EtàModerna?
In effetti, tra il IV e il V secolo, noi abbiamo le attestazionidottrinali più antiche della diffusa convinzione che la fine di
Maria fosse stata diversa da quella degli altri mortali.
S.Efrem siro, il padre della teologia siriana, afferma apertisverbis che il corpo di Maria, in quanto verginale, non ha subitocorruzione dopo la morte. (10)
Evidentemente, nella mente del dottore appariva strano immaginareche Dio preservasse sua madre dalla unione carnale e non dallacorruzione del sepolcro, tanto più che la prima era nell'ordinedelle cose anche anteriore al peccato originale, mentre la secondano; in ogni caso, per Efrem l'illibatezza era segno e preludio diuna intangibilità più radicale, ontologica: quella dellacorporeità, espressa in modo assoluto dall'assenza didecomposizione.
Tale teologia è, ovviamente, una di tutte quelle cheinesorabilmente hanno portato alla definizione dogmatica.
Timoteo di Gerusalemme, invece, in modo meno sottile ma piùradicale, afferma che la Madonna è rimasta immortale ed è stataassunta in Cielo. (11)
La sua teologia è identica a quella del dogma. Il fatto poi che ildottore neghi la dormitio non tocca un punto dottrinale definito,in quanto non è di fede che la Madonna sia morta, anche se ciòappare logico.
S.Epifanio di Salamina afferma invece che la Madonna quasicertamente possiede già il Regno celeste con la carne. (12) Egli,quindi, più che dare una definizione teologica, comunica unanotizia.
L'Anonimo degli Obsequia B.Virginis, il cui originale è in siriaco,ribadisce lo stesso concetto, affermando che il corpo di Maria si èriunito all'anima subito dopo la morte. (13)
A queste testimonianze patristiche vanno aggiunte quelle degliapocrifi che, descrivendo la fine della vita di Maria, accreditanola versione della glorificazione postuma della Vergine. Non a casoi più antichi apocrifi assunzionisti risalgono proprio a questoperiodo. (14)
Cosa si deduce, storicamente parlando, da queste testimonianze? Chegià dal V secolo la comunità cristiana credeva nell'Assunzione, purnon avendo un'unanimità nei particolari narrativi del fatto; masoprattutto che essa si tramandava, evidentemente, una dottrina chenecessariamente doveva avere un riscontro documentario.
In effetti, se consideriamo i monumenti legati alla Dormitio
Mariae, scopriamo che le basi storiche della credenza assunzionistasono più remote ancora: i documenti più antichi (II - III sec.),ebioniti, fanno morire Maria a Magdalìa, presso Gerusalemme, e ladanno sepolta nel Gethsemani.
Tale tradizione sepolcrale è confermata dai testi giovanniti delIV-V sec. e da quelli bizantini del V, che invece discordano sulfatto - secondario - del luogo della morte.
Ciò attesta che già dal II sec. si sapeva dov'era sepolta laMadonna. Tale tomba, oggi nella cripta che fu del monastero diS.Maria di Giosafat, non solo corrisponde alle descrizioni degliantichi apocrifi siriaci, ma, posta tra altre tombe - solo daitempi di Teodosio I essa fu isolata sul modello del Santo Sepolcro- risale senz'altro al I sec., come hanno dimostrato i sopralluoghiarcheologici del 1972:(15) evidentemente, come per la credenzareligiosa della Resurrezione di Cristo, alla base di quelladell'Assunzione di Maria c'è una tomba vuota, identificata comequella di un morto che però non è più lì.
Su quella tomba, già dal IV sec. i monofisiti eressero una chiesa,conservando la memoria cultuale dei vari elementi dell'escatologiamariana: la casa della morte, la processione dei parenti, il ruolodegli angeli psicopompoi, ripresi dai cicli eterodossi ebioniti.(16)
Evidentemente, la nozione storica della fine straordinaria dellaMadonna, anche se già rivestita teologicamente, risale, nelle sueformulazioni giudaico-cristiane, ai primordi della Chiesa, per cuianche le più antiche testimonianze patristiche ortodosse avevanouna tradizione consolidata alle spalle, di cui dovevano tenerconto, anche a dispetto delle dispute sulla dottrina escatologicadei primi secoli cristiani: ossia, l'Assunzione, prima ancora diessere un dato teologico, fu considerato un fatto storico, e la suarecezione da parte della Grande Chiesa (greco-latina) avviene solonel V sec. a causa della pregiudiziale antiebionita.
Nel VI sec., la diffusione della festa dell'Assunta tra greci,copti, abissini favorì la crescita della fede in questo privilegiomariano, e anche questo è un momento fondamentale per la formazionedel dogma: lex orandi, lex credendi, si dice, e infatti la festanon avrebbe avuto ragione di essere se non avesse rispecchiato unsentire profondo del popolo devoto.
A livello di teologia culta, le opposizioni non scompaiono deltutto, ma in Oriente i nomi più illustri, sino al X sec., sonofavorevoli all'Assunzione.
In Occidente, invece, professano agnosticismo in materia Isidoro di
Siviglia e Beda il Venerabile: le invasioni barbariche hannoinfatti causato un regresso teologico e una difformità cultuale,che si ripercuotono sulla riflessione dogmatica mariana. A Roma,infatti, dove la festa si celebrava dal VII sec., non vi fu alcunavoce di dissenso o di perplessità. Da lì, l'uso liturgico, colcodazzo teologico, passò in Francia ed Inghilterra.
Sullo scorcio dell'età carolingia, fu il Liber de Assumptione delloPseudo-Agostino che fece da battistrada a una più universale formadi consenso. (17)
Coprendo col nome dell'Ipponense la dottrina assunzionista,l'anonimo autore attesta indirettamente che essa era ormai assaicondivisa. Da allora, fu un consenso ininterrotto tra i granditeologi: Tommaso d'Aquino, Alberto Magno, Bonaventura.
Anche l'Oriente bizantino, dopo il 1000, è ancora più unanime nellafede assunzionista. Questo unanimismo teologico fu incrinato, inOccidente, dalla Riforma, ma non fermò il processo teologico diapprofondimento in campo cattolico, culminato col dogmapacelliano.
Andando a ritroso nella storia dei dogmi, vediamo che l'ImmacolataConcezione, definita dal b.Pio IX nel 1854, ebbe nel Medioevo unagestazione lunga e difficile. In effetti, nell'ambiente giudaico-cristiano esso era stato sempre affermato, e aveva trovatoun'espressione mitica nel racconto della concezione verginale diS.Anna nel Protovangelo di Giacomo. (18)
La patristica raffermò indirettamente, calcando la mano sullasantità di Maria e sulla sua libertà dal diavolo; i pelagiani laproclamarono esplicitamente, e così facendo consegnarono ladottrina ad una polemica plurisecolare.
Infatti, nonostante il sensus fìdei dei credenti non accettassel'idea che Maria avesse avuto il peccato originale, la teologiaalta ebbe difficoltà ad argomentare in favore di questo privilegio,per la pregiudiziale antipelagiana: infatti proprio iltraducianesimo di Agostino si oppose all'Immacolata Concezione comenoi la concepiamo. (19)
Tuttavia la fede popolare nella dottrina immacolista rimaseintatta, e ciò apparve come argomento probante del fatto chefacesse parte della Rivelazione divina per Eadmero (20) (†1134 ca) ,da cui prese le mosse_una corrente teologica basata sul concetto diredenzione anticipata, ossia usufruita dalla Vergine prima dicontrarre la colpa.
Ma le concezioni antropologiche dell'epoca rendevano più difficile
una costruzione teologica più precisa, e Alessandro di Hales,Alberto Magno, Tommaso d'Aquino, Bonaventura e persino Anselmo diAosta e Bemardo di Chiaravalle furono sostanzialmente macolisti.
Assai ostile all'Immacolata Concezione fu Giovanni XXII (1316-1334), anche se espresse quest'opinione come parere personale inalcune omelie. E nonostante una così agguerrita opposizione, ilb.Giovanni Duns Scoto (†1308) riprese da Pietro di Giovanni Olivila tesi della redenzione preservativa, che perfezionava quella diEadmero: la Madonna era stata preservata dal peccato originale, invista della funzione che avrebbe dovuto svolgere.
Questa tesi non era stata presa in considerazione perché Pietro diGiovanni Olivi era un eretico, ma grazie al magistero di DunsScoto, essa ora riacquistava una credibilità e veniva formulata inmodo impeccabile.
Il dottore, peraltro, con tatto e prudenza, definì l'ImmacolataConcezione probabile nelle sue lezioni oxfordiane, dove l'empirismorendeva più accettabile la sua riflessione teologica, e possibile aParigi, dove più forte era la tradizione teologica precedente. (21)
Da Duns Scoto prende le mosse una corrente immacolista nuova,tipicamente francescana, a cui aderirono presto tutte leuniversità, compresa la Sorbona, e che fece proseliti persino tra itomisti.
Sisto IV (1471-1484) vietò poi ai macolisti e agli immacolisti diaccusarsi reciprocamente di eresia, ed estese la festa liturgicadell'Immacolata a tutta la Chiesa.
In questo modo il Medioevo consegnava al futuro quelli chesarebbero stati i cardini della definibilità dogmaticadell'Immacolata Concezione; il sensus fidei dei fedeli, comeelemento probante espresso attraverso la lex orandi, e la dottrinadella redenzione preservativa.
Il dogma della Perpetua Verginità di Maria è invece altomedievale:il Concilio generale del Laterano, convocato da s.Martino I nel649, definì questo dogma,(22) in polemica con ogni interpretazionedocetistica della dottrina tradizionale, mettendo in evidenza chela verginità di Maria rimase intatta in modo tanto reale quanto lofu il suo parto.
Riprendeva così un insegnamento di papa s. Ormisda (514-523), eapriva un dibattito sulla possibilità di conciliare, in modorazionale, la virginitas in partu e il parto stesso. In effetti,già s. lldefonso di Toledo (†667) scrisse un trattato sulla
verginità perpetua di Maria. (23)
Ratramno di Corbie (†875 ca) prese la penna contro il neo-docetismotedesco, come del resto anche Pascasio Radberto (†865). (24)
Ma la questione era sempre la stessa: come aveva conservato Mariala verginità fisica, se aveva partorito normalmente? Non potendosiaccettare le posizioni docetistiche sulla nascita di Gesù, che lavolevano accaduta in modo anche solo parzialmente incorporeo, iteologi esploravano ogni possibilità, dalla compenetrazione deicorpi a quant'altro, ma senza mai trovare qualcosa disoddisfacente.
Fu s. Tommaso d'Aquino a tagliar corto, attribuendo all'onnipotenzadivina un fatto assolutamente inspiegabile per qualsiasifilosofìa. (25)
Il dogma della Maternità Divina arrivò al Medioevo già bell'e fattodal Tardo Antico e dai Concili efesino (431) e calcedonese (451):gli altri sinodi non dovettero che ripeterlo, e proprio essiaprirono la strada alla definizione del dogma della PerpetuaVerginità, quando, coi canoni del II Concilio di Costantinopoli(553), introdussero il riferimento alla "sempre vergine Madre diDio". (26)
Tra le altre dottrine certe della fede, ma non definitedogmaticamente, vanno ricordate, per il dibattito medievale, quellache fa di Maria la Madre della Grazia divina, e quindi la madrenostra, quella della Corredenzione, quella della Mediazioneuniversale e quella della Regalità.
Dal II sec. Maria è chiamata unanimemente Madre della Grazia.
Nel Medioevo asserirono questa verità Ambrogio Autperto (†781),Giorgio di Nicomedia (†860), Giovanni Geometra (X sec.), Goffredodi Vendôme (†1132), Bernardo di Chiaravalle. (27)
Strettamente connessa a questa verità, quella della Corredenzionefu sostenuta con la medesima convinzione, a partire però dal XIIIsec.
In esso si sviluppò la devozione all'Addolorata, che divennedevozione ai Sette Dolori nel XIV sec.
Istituendo poi la festa liturgica connessa, il Concilio provincialedi Colonia, il 22 aprile 1423, evidenziava il valore salvificodelle sofferenze mariane.
Tale valenza venne sottolineata poco dopo da Sisto IV, che estese a
tutta la Chiesa la festa di Nostra Signora della Pietà (1482).
Più antico il consenso esplicito attorno alla Mediazione universaledi Maria, sviluppatesi dal VI al XII sec., e poi pressocchèunanime.
Se ne occupò con competenza anche s. Tommaso d'Aquino, (28) sebbenenon si fosse tutti d'accordo sul come Maria esercitasse lamediazione.
Tipicamente medievale è anche la fede nella Regalità di Maria,attestata nei documenti sin dal IV sec.
Appare evidente che non vi è soluzione di continuità tra ladogmatologia mariana del Medioevo e quella dei secoli successivi,fino ad oggi.
(1) Cfr. PG VI, 709-712: VII 933- 958-960.
(2) Cfr. S.DE FIORES, Mariologia, in DE FIORES - MEO, Dizionario, pp. 896-897: E.TONIOLO,Padri della Chiesa, ibid., pp. 1044-1079.
(3) Cfr. E.PERETTO, Apocrifi, in DE FIORES - MEO, Dizionario, pp. 106-125.
(4) In Corpus Marianum Patristicum, a cura di S.ALVAREZ CAMPOS, Burgos 1970 ss., IV/2 p.542
(5) Cfr.DE FIORES, Mariologia, pp. 897-898.
(6) In PL XC, 93-110.
(7) Cfr. A.PEDROSA, El Mariale de Saint-Evraul, « Ephemerides Mariologicae » (EM), 11(1916), pp.5-63.
(8) I testi in ALBERTO MAGNO, Opera omma. Parigi 1898, vol. 36, pp. 1-841; vol. 37; pp. 1-362.
(9) PIO XII, Mumfìcentissimus Deus, "Acta Apostolicae Sedis", 42 (1950), pp. 768-770.
(10) D.SARTOR, Assunta, in Dizionario, pp. 162-185, in particolare p. 167.
(11) TIMOTEO DI GERUSALEMME, Homilia in Simeonem et Annam, in PG 86, 246.
(12) EPIFANIO DI SALAMINA, Adversus Haereses, in PG 41, 777B.
(13) SARTOR, Assunta, p. 167.
(14) E.PERETTO, Apocrifi, in Dizionario, pp. 106-125, in partic. p. 121.
(15) Cfr. P.B.BAGATTI, L’apertura della tomba della Vergine al Getsemani, "Liber Annus"(LA) 23 (1973), pp. 318ss.
(16) E.PERETTO, Apocrifi, in Dizionario, p. 886.
(17) In PL XL, 1141-1148.
(18) Protovangelo di Giacomo, a cura di A.DI NOLA, s.l. 1977, p.34.
(19) AGOSTINO, De natura et gratia, in PL XLIV, 267; Contra Iulianum, in PL XLV, 1418.
(20) EADMERO, Tractatus de Conceptione B.M.V., in PL CLIX, 301-302.
(21) GIOVANNI DUNS SCOTO, Ordinatio, III, d. 3, q. 1.
(22) J. D. MANSI, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, voll. I-XXXI, Firenze–Venezia 1759-1798, in particolare vol. X, pp. 1151-1152.
(23) ILDEFONSO DI TOLEDO, De Virginitate Perpetua B.M.V., in PL XCVI, 53-110.
(24) RATRAMNO, De eo quod Christus ex Virgine natum est, in PL CXXI, 81-102; PASCASIORADBERTO, De Partu Virginis, in PL CXX, 1370.
(25) TOMMASO D'AQUINO, Summa Theologica, a cura di T. S. CENTI, Firenze 1963 ss., III, q.28 a.2
(26) Cfr. S. DE FIORES, Vergine, in DE FIORES - MEO, Dizionario, pp. 1418-1469, inparticolare pp. 1454-1461.
(27) LEANDRO, De institutione Virginum, in PL LXXII, 878 C; AMBROGIO, Sermo inPurifìcatione, in PL LXXXIX, 1297 B - C; GIORGIO DI NICOMEDIA, In Sanctam Mariamassistentem Cruci, in PG C, 1476 C-D; GOFFREDO, In sermone septimo de Purificatione S.M.in PLCLVII, 265D-266A.
(28) TOMMASO D'AQUINO, Summa Theologica III, q. 26, a.2. III Lezione
LA DEVOZIONE
Per la pietà popolare, bisogna riscontrare alcune linee di tendenzache, iniziate nell'età patristica, si protraggono per tutto il Medioevoe ci lasciano significative informazioni.
Per esempio, dal IV secolo fino alla Riforma, fu tutto un susseguirsidi eresie mariane, che, se nei tempi più arcaici attestano ilprepotente sviluppo della devozione popolare (penso alle Colliridiane,adoratrici di Maria, con cui polemizzò Epifanio, a causa del loro cultoesagerato), nelle età successive sono invece una reazione spessointellettualistica alle degenerazioni superstiziose della pietà dimassa.
D'altro canto, invale l'uso della devozione privata, che giunge fino ainostri giorni, e iniziano ad essere attestate, sin dall'epoca diSozomeno e di s. Gregorio Taumaturgo, atti di culto iatrico eagiofanie, destinate a moltiplicarsi fino all'inverosimile nelMedioevo, legandosi spessissimo, nel primo caso, all'esistenza di fontisacre (si pensi a Chartres), e a forme sparse di pellegrinaggispontanei e di devozioni iconiche, attestate sino dai tempi di Basilioil Grande e diffusesi a macchia d'olio nel Basso Medioevo, quando
tantissimi santuari fecero risalire le proprie origini all'arrivo inOccidente di statue o immagini scampate, in Oriente, alle persecuzioniiconoclastiche, o, in ogni caso, legarono le proprie sorti a quelle dimanufatti assai venerabili (come Boulogne o Rocamadour o Coutances:tipici luoghi di culto legati ad una statua famosa).
Sin dal IV secolo, inoltre, nascono le feste liturgiche mariane,dapprima congiunte a quelle cristologiche (Natale e Presentazione delSignore), e poi da sole (a partire da quella della Madre di Dio edell'Assunta).
Nel corso del Medioevo, non solo si moltiplicheranno le festeliturgiche, ma si differenzieranno molto localmente. Peraltro, lafigura di Maria si sostituisce, per i suoi tratti materni, a quelladella Chiesa, intesa come madre, che perde di tenerezza agli occhi deifedeli per la crescente clericalizzazione della vita religiosa; diconverso, proprio la natura gerarchica della società medievale implicòl'esaltazione della regalità mariana.
Questa, lungi dall'attutire gli aspetti più umani della figura dellaMadonna, si unisce saldamente alla considerazione dei misteri dolorosidella sua vita, che la presentano come modello e mediatrice di grazia.Ciò fa fiorire la preghiera.
Le sue forme realizzano una sacralizzazione al femminile di spazio etempo. In effetti, ogni preghiera, col suo svolgersi in un momento, colsuo prolungarsi, costituisce un mezzo per sacralizzare il tempo, mentreil suo elemento discorsivo consegna al divino l'elemento linguistico.
Il fiorire delle più svariate forme di orazione, intese spesso comefatto letterario di massa, e sempre come fatto esistenziale, attestacome la coscienza collettiva medievale abbia perseguito proprio questiobiettivi. Per esempio, sin dall'età delle eresie cristologichecompaiono preghiere mariane accorate e ricche di pathos: il trionfo deldogma dell'unione ipostatica, elevando la natura umana di Cristo semprepiù in alto, attenua la percezione che i fedeli hanno di lui qualemediatore capace di compatire, e spingono la devozione a cercare formecompensative di mediazioni subordinate, su cui eccelle quella mariana.
Ricordo con ammirazione le antichissime preghiere di Ildefonso diToledo, poi confluite nella liturgia mozarabica , e le precicarolingie, legate, dal Liber Sacramentorum ai tituli, al nome diAlcuino di York (†804) e al grande progetto della rinascita culturale.
Anche i secoli più bui, quasi a compensare l'eclisse di sensibilità cheli caratterizza in mezzo a tante lotte, elevano alla Madre di Dio innie litanie assai tenere , che preludono ad una ben più fioritaproduzione eucologica del sec. XI, in cui si distinse s. Fulberto diChartres, e che ebbe in Farfa, Montecassino, Nonantola i suoi centri di
irradiazione.
Tale patrimonio eucologico culmina nelle antifone ancor oggi in uso,come la Salve Regina, l'Alma Redemptoris Mater, la Regina Coeli.
Sussunta di questo plurisecolare fervore poetico e religioso saranno lelitanie lauretane, capaci di ridurre in brevi formule tutto ilcomposito retroterra patristico dei secoli precedenti.
Del resto, sin dal V secolo, sono attestate invocazioni litaniche deisanti, che si allungano molto dall'VIII secolo, riservando alla Verginealcune invocazioni.
Diffuse dai monaci irlandesi, le litanie ebbero, attorno al 1000,svariati formulari, o in prosa o in rima. Dal XII sec. fiorisconolitanie mariane autonome, classificate in quattro tipi: veneziane,lauretane, deprecatorie magontine. Le veneziane sono attestate dal XIIsec., come del resto le lauretane.
Queste ultime riecheggiano la liturgia, la teologia, gli omiliaricarolingi e persino autori remoti come Venanzio Fortunato, o EfremSiro.
Le magontine sono coeve, ma hanno una struttura più composita, m quantocomprendono deprecazioni, versetti, orazioni, rime ternarie e altroancora.
Le deprecatorie sono legate invece ad una struttura, e non ad un luogo:si basano infatti sulla richiesta d'intercessione.
A partire da un manoscritto magontino del XII sec., se ne conosconoparecchie versioni fino al XV sec.
Diffuse da ordini e confraternite, che introducevano le proprie litaniespesso in alternative ad antifone, tropari e laudi, queste forme dipreghiera mariana conobbero una pluralità di tipi che perdurò fino allaControriforma, quando, per estinguere gli abusi e prevenirli, i grandiriformatori imposero le lauretane, il cui successo era legato allafioritura del santuario marchigiano.
Esse passarono a concludere la recita del rosario, anch'esso punto diarrivo di una complessa gestazione devozionale, ricca di spuntipoetici, specie nelle numerose clausole aggiunte alla salutazioneangelica dopo il nome "Jesus".
Del resto il rosario confonde la sua preistoria con quella dell'AveMaria. L'uso devozionale delle prime due parti dell'Ave risaleaddirittura al IV sec., in Oriente, e dal VI sec. lo troviamo anche inOccidente.
L'uso penitenziale di recitare tutto il salterio a scopo penitenzialeviene, tra l'VIII e il X sec., commutato, specie per gli analfabeti, inquello della recita di 150 Pater, validi anche per sopperire apenitenze fisiche.
Di commutazione in commutazione, si arrivò alla recita di 150 Ave, osalterio mariano.
Sostenuta dalla predicazione dei monaci irlandesi, la pia praticasuperò l'anno mille, dopo il quale divenne fenomeno di massa.
Nel XII sec. era una preghiera assai comune, nel XIII san Domenicoiniziò a predicarla, con un gesto che l'ordine dei Predicatoriconsiderò un esempio da imitare, e che creò la particolare sinergia trai domenicani e il rosario.
Non a caso si formò la leggenda dell'apparizione della Vergine aDomenico di Guzman (che a mio avviso ha un fondamento storico), in cuiquesti avrebbe ricevuto il precetto di predicare il salterio mariano;non a caso lo si diffuse in mezzo alle regioni abitate da eretici, comestrumento di ricattolicizzazione, impresa in cui i Predicatori eranoimmersi fino al collo; non a caso i maggiori innovatori della praticafurono spesso domenicani.
La divisione in quindici decine fu di Enrico di Kalkar (sec. XIV), esolo Giovanni Paolo II l'ha modificata, inserendone altre cinquenell'ottobre 2002, e segnando la definitiva separazione del rosario dalsalterio, visto che le Ave ora sono più dei salmi.
Fu invece il b.Alano de la Roche a predicare il rosario nel XV sec.,disseminando nei suoi scritti quelle "promesse della Madonna ai devotidel suo rosario" che hanno costituito la consolazione di decine edecine di generazioni di fedeli.
In effetti, poche devozioni hanno avuto tanta rilevanza nella storiadel costume come il rosario: milioni di persone l'hanno recitato e lorecitano ogni giorno, o durante la settimana o il mese, e in generenelle più svariate occasioni.
Preghiera contemplativa per eccellenza, ha insegnato a milioni dipersone una forma semplice ma soda di meditazione, e ha fatto dacatechismo con la proposizione quasi visiva dei quadri misterici insuccessione.
Su di esso inoltre si sono formate decine di altre corone devozionali,per duplicazione, e non solo mariane.
Si tratta in effetti di un vero e proprio fenomeno sociologico mariano,capace di innestarsi in tutte le culture, e che anzi trova parecchicorrispettivi in altre religioni, come l'Islam e il buddismo, anch'essicoi loro rosari basati sull'ossessiva e cadenzata ripetizione di
formule.
Eppure il rosario non ha subito modificazioni di rilievo dal '400,quando anche l'Ave Maria ha assunto la sua forma definitiva, conl'aggiunta del "Sancta Maria" (1483): è una bella prova di vitalitàplurisecolare.
Legate allo sforzo di sacralizzare il tempo nella successione dei suoimomenti, sono le fioriture di altre devozioni mariane, che scandisconole giornate, le settimane, gli anni.
Tra le prime a proporne ci fu s. Matilde di Hackeborne (1241-1299), cheaveva insegnato a salutare la Vergine mattina e sera con tre Ave, pervenerare i suoi legami con la SS. Trinità. Tale pratica, ricevuta invisione dalla santa, prometteva l'intercessione mariana in punto dimorte.
Ma di gran lunga più importante è quella dell'Angelus Domini, ancoraoggi fiorente.
Già dal 1197 i concili provinciali invitano a recitare le Ave in certimomenti della giornata.
Dal 1263 i Minori, guidati da Bonaventura, nel loro capitolo generale,iniziano a salutare la Vergine a compieta con più Ave : è unaduplicazione mariologica dell'ufficio delle ore, e la scelta della seracome primo momento rivela un bisogno collettivo di protezione materna,da parte di adulti senza affetti privati, alle soglie della notte, chesempre fa paura all'uomo.
Da quest'iniziativa, l'Angelus primordiale si diffonde in parrocchie eabbazie.
La concessione dell'indulgenza a questa pia pratica da parte diGiovanni XXII, e la sua volontà di introdurla in Roma, attestano nel'300 la diffusione della devozione, sostenuta da vescovi e prelati.
In quanto poi all'Angelus mattutino, l'uso rimonta alla congregazionecassinese (1285-1288), e si diffonde pienamente nel XIV sec.
Puntualmente, arrivò l'indulgenza, da Bonifacio IX. Nel XIV sec., l'Angelus mattutino si era generalizzato.
Ibrido tra i due usi, nasce poi l'Angelus del mezzogiorno, peresplicita volontà di Callisto III (in preparazione della Crociata), conla bolla Cum his superioribus annis (1455).
I Francesi, tutt'altro che favorevoli alla sconfitta dei Turchi,preferirono recitare la preghiera solo per la pace. Tale uso fu
approvato e indulgenziato da Sisto IV, nel 1476.
Fu invece Alessandro VI, nipote di Callisto, che nel 1500 rinnovò ilprecetto dello zio. Infine, Leone X, per la sua devozione mariana,estese il precetto dell'Angelus meridiano. Per cui, alle sogliedell'età moderna, l'Angelus si era definito.
Se l'Angelus sacralizza in senso mariano la scansione del tempoquotidiano, il sabato devozionale, squisitamente medievale, scandisceil ciclo ebdomadario, con un rituale che getta un ponte tra la liturgiae la pietà popolare.
Fu Alcuino di York ad inserire il formulario votivo mariano del sabatonei sacramentari. Questa devozione liturgica non conobbe regressi, enel XII sec. era universale.
Già dall'età carolingia si diffonde l'officium correlato, il parvum deBeata , che fu una delle devozioni più comuni del Medioevo , e che sidiffuse con le Crociate ancora di più, agganciandosi alla riformamonastica.
Tuttavia l'eccessivo peso assunto dall'officium nelle devozioni spinsei Mendicanti, nel XIII sec., a limitare il suo uso, fino a quando s.Pio V, confermando la meritorietà dell'officium parvum, assieme aquello di Sanata Maria in Sabato, li rese tuttavia facoltativi.
Essi rimasero vincolanti per chi aveva certe devozioni private, come ilparvum per gli adepti dello scapolare carmelitano.
A santificare l'anno ci pensò invece la pia pratica del mese mariano.Il mese mariano per eccellenza, maggio, che è anche il più antico -essendo settembre e ottobre mariani un uso controriformistico - ha unamatrice bizantina.
Nel rito costantinopolitano c'è infatti un mese dedicato alla Madonna,costruito attorno alla festa dell'Assunta. I primi quattordici giornisono preparatori alla festa, la cosiddetta piccola quaresima dellaMadonna, comune anche alle Chiese precalcedonesi, mentre i successiviquindici sono un prolungamento festivo.
Il rito alessandrino conosce un uso analogo, ma in un periodo dell'annodiverso, quello natalizio: attorno a quelle liturgie sorge l'uso delmese di kîahk.
In Occidente, la cristianizzazione dei riti primaverili di feconditàcomportò la nascita della devozione di maggio. Già Alfonso X il Saggio,re di Castiglia (1221-1284), e il b. Enrico Suso (†1336) promossero unculto mariano stagionale.
Ma la sanzione definitiva si sarebbe avuta solo con la Controriforma,che anche in questo è il punto di arrivo dello sviluppo storico-
religioso del cattolicesimo medievale.
Ma la lettura antropologica della pietà, che fa la storia religiosa edel costume in senso lato, e che da il saggio dell'ampiezza dellarilevanza della fenomenologia religiosa stessa, ci spinge a considerareun altro atto devoto, tipico del mondo medievale e non solo, ilpellegrinaggio.
Esso sacralizza lo spazio, e innesta dinamiche sociologiche assaicomplesse, rimescolate dalla prassi del viaggio, che accomuna tutte leclassi sociali e che si riverbera nella cultura in senso lato.
La devozione mariana è, dopo quella cristologica, la più grandealimentatrice di viaggi sacri. Essi si snodano lungo parecchiedirettrici, che percorrono la Terra Santa, l'Oriente bizantino,l'Occidente latino.
Vale la pena ricordare i centri più importanti. Proprio cominciandodalla Terra Santa, troviamo come oggetto di devozione le memoriestoriche più antiche dell'esistenza terrena di Maria di Nazareth. AGerusalemme, per esempio, sin dal I secolo i giudeo-cristianiinaugurarono la prassi della visita alla Casa della Madonna.
Essa fu in origine una domus ecclesia, legata al culto iatrico di BetEsdatain, di matrice ebraica, e durò anche oltre la profanazionedell'imperatore Adriano, con elementi sincretici. Espulsi questi daCostantino, la domus divenne una doppia basilica bizantina conTeodosio, su cui poi i crociati avrebbero costruito il capolavororomanico della chiesa di Sant'Anna.
Sempre a Gerusalemme, sin dal I secolo fu venerata, come si è detto,una tomba di Maria, vuota, presso la necropoli del Gethsemani,custodita fino al IV sec. dai giudeo- cristiani, poi divenuti ebioniti,che vi eressero un luogo di culto; questo fu trasformato in unabasilica bizantina da Teodosio, che l'affidò ai giovanniti, ai quali,divenuti monofìsiti, fu sottratta dagli ortodossi, capeggiati dalvescovo Giovenale, nel V secolo.
Riedificata in forma più sontuosa da Maurizio, la basilica fu distruttadagli Arabi nel 614, ma non cessò di attirare devoti. Furono i crociatia riedificare un luogo cultuale, il monastero fortificato di SantaMaria di Giosafat, poi abbattuto dal Saladino, che però risparmiò lacripta sepolcrale, che esiste tuttora.
Accanto a questi luoghi specificamente mariani, in Sion la memoriadella Madonna era anche molto legata al Calvario, sotto i cui ambientisacri giudeo-cristiani del I-II sec. sono state rinvenute vestigia diantica devozione mariana, destinate a confluire nella basilica delSanto Sepolcro.
Un altro polo di attrazione mariana era Nazareth. Lì sorgevano la casa
di Maria e quella di Giuseppe. La prima, riconoscibile agli scavi del1955-1960, fu una domus ecclesia sin dal I sec., divenne sinagogagiudeo-cristiana nel III sec., e basilica bizantina nel 430 ca.; icrociati vi eressero una basilica romanica, che fu distrutta daiMamelucchi nel 1263, senza che però scomparisse il culto.
La seconda, casa paterna di Gesù, risale anch'essa al I sec., eall'epoca divenne un ambiente battesimale dei parenti di Giuseppe; igiudeo-cristiani la custodirono fino a tutto l'Alto Medioevo, e inepoca crociata arrivarono i francescani . Ovviamente, anche a Betlemmeci fu un forte culto mariano, legato alla basilica della Natività,costruita da Costantino su un ambiente giudaico-cristiano profanato daAdriano.
La basilica, ristrutturata da Giustiniano, trasformata in moschea erestaurata dai crociati, ha una dipendenza tutta mariana, lataumaturgica Grotta del Latte della Madonna, del VI sec.
Centri mariani minori erano ad Ain Karin e a Cana. Nella prima sivenerava la triade Elisabetta, Giovanni Battista e Maria, sin dal Isec. Nella seconda il culto fiorisce dal III sec.
Fuori della Palestina, Costantinopoli fu una civitas mariana per quasimille anni. In essa vi erano 125 chiese mariane, santificate dareliquie e icone venerabili; per esempio quella di Chalcopratèia (Vsec.), in cui c'era la cintura di Maria, o quella dove se ne conservavail velo (V sec.), o quella che conteneva 1' Odighitria. Famosa eraSanta Maria della Sorgente, frequentata da pellegrini fino al XV sec.,e detta "Lourdes del Medioevo".
In Occidente, Roma aveva moltissime chiese dedicate alla Madonna, cheattiravano pellegrini. Ovviamente, la maggiore era Santa MariaMaggiore, fondata da papa Liberio (352-266), sulla base diun'indicazione divina, e detta perciò notoriamente liberiana, e poiampliata e abbellita da s. Sisto III (432-440), tanto da dover esseredetta, forse più opportunamente, sistina; essa custodi e custodisce lagreppia di Betlemme sin dal sec. VII, contendendosi con la città diDavide l'onore di possedere l'originale culla di Gesù, che moltoprobabilmente fu divisa in più parti, o che santificò ex contactu ilegni romani, e l'icona della Salus Populi Romani.
Un'infinità di altre chiese conservavano icone venerabili (la piùantica è forse quella di Santa Maria Nova, datata negli anni '30 al VIsec.), e i templi più visitati erano Santa Maria Antiqua (cuore dellaRoma greca nell'Alto Medioevo, e persino residenza papale tra il VII el'VIII sec.), Santa Maria in Domnica, Santa Maria Sopra Minerva, SantaMaria Rotunda e Santa Maria in Cosmedin.
Nel resto d'Europa, era tutta una fitta trama di santuari mariani,spesso legati a venerate reliquie: Chartres (X sec.), con la fonte
sacra e la veste della Vergine (attestata dal Basso Medioevo), che fuanche centro di una rinomata scuola teologico- fìlosofìca; Lione (IXsec.), che vantava origini apostoliche; Le Puy (XI sec.), dedicataall'Assunzione, e presso cui il mese di agosto era festeggiato in modosolenne e allegro: esso ebbe la celebre statua nel 1254; Clermont (diepoca gallo-romana), la cui statua, tardiva, era modellata sul tipo diLe Puy, e da cui Urbano II bandì la Crociata; Arras (XI sec.), nato exvoto dopo una paurosa epidemia di peste nera; Boulogne, tra i piùcelebri nell'XI-XII sec., che secondo la leggenda accolse unavenerabile statua della Vergine già nel VII sec., quando essa fu messain salvo dall'Oriente devastato dall'iconoclastia; Rocamadour (XIIsec.), la cui statua, preziosissima, attirava migliaia di fedeli coisuoi sgargianti colori; la svizzera Einsiedeln (X sec., roccafortemariana benedettina); il santuario della Virgen del Pilar di Saragozza,dove ab immemorabili si custodisce la statua che la Madonna stessa, daviva, accompagnata dagli angeli, avrebbe consegnato a s. Giacomo ilMaggiore, impegnato ad evangelizzare la Spagna (ma il santuariofiorisce con la Reconquista); Montserrat (IX sec.), anch'esso spagnolo,dalla fastosa ricchezza, anch'esso insediamento benedettino.
Un discorso particolare meritano le reliquie della Vergine: mancandoquelle corporali a causa della sua Assunzione, ci si accontentava divesti, cimeli, parti del suo corpo distaccatosi da esso prima della suaglorificazione (capelli), o anche del suo latte, sparso in tutto ilmondo. Coutances, che pure aveva una celebre statua lignea, assieme adAstorga e Laon conservava i capelli; Walsingham, il più grandesantuario inglese, nato attorno ad un'imitazione della Santa Casavoluta dalla Vergine tramite un veggente, e munito di due fonti sacre,custodiva il latte. Esso, coi capelli e tante altre reliquie, eracustodito anche a Santa Maria Maggiore.
Il maggior santuario mariano tedesco, ad Aquisgrana, eccezionalmentefrequentato tra Trecento e Quattrocento, tanto che la città era divisain quartieri nazionali e che c'era un numero chiuso di pellegrini chepotevano varcare le mura, era il custode della veste della Vergine, cheil califfo aveva regalato a Carlo Magno . I maggiori santuari italianierano Oropa, Montevergine, la Consolata di Torino, la Madonna dellaGuardia a Bologna, con l'icona attribuita a san Luca.
Il più celebre era Loreto, ma esso fiorì tardi, solo nel XV sec.,sebbene la reliquia della Santa Casa, risultata autentica all'esamearcheologico, fosse giunta in Italia nel 1294 . Altri santuaridivennero il centro morale delle proprie nazioni, come Chzestochowa ,nato già nel XIV sec. attorno ad una venerabile icona. I santuarifurono centri d'irradiazione culturale e artistica (presso di essi sisviluppa il teatro religioso), nodi viari, luoghi d'assistenza.
Dai suoi templi, la Madonna esercitò una forte influenza nella civiltàmedievale. Altrettanto spesso, il santuario mima il movimento del sacroverso l'uomo: non solo le processioni simboliche - come quella dellaSalus Populi Romani che incontra l'icona acheropita del Salvatore a
Roma- ma anche le prime forme di peregrinatio Mariae, attestate inItalia dall'XI sec., segnano questo costume religioso.
Se le devozioni scandiscono la sacralizzazione del tempo, e ilpellegrinaggio quella dello spazio, esistettero inoltre forme di pietàche santificavano la persona in una sorta di unione assimilatricedell'amato con l'amante, riconducibili alla modalità dellaconsacrazione.
Nel caso di Maria, essa aveva origini antichissime , e si sviluppòflorida nel Medioevo, attraverso una vasta gamma di tipologie. Ci fuper esempio l'affidamento collettivo, documentato per la prima voltaper Costantinopoli, che attribuì alla Vergine la difesa e il successocontro tutti i nemici. Ci fu la professione di servizio all'ancillaDomini, inventata da Ildefonso di Toledo. Ci fu la più impegnativaforma di consacrazione, inaugurata da s. Giovanni Damasceno.Squisitamente feudale fu la commendatio alla Vergine, praticata da s.Odilone di Cluny (†1049), da Eusebio di Angers (†1081), da s. Anselmodi Lucca (†1086), da Matilde di Canossa, da s. Anselmo d'Aosta.
Nel XIII sec., l'ordine dei Serviti si propone la deditio alla Vergine,per riceverne la tuitio . Anche questa forma di consacrazione èpropriamente medievale.
La cultura cavalleresca favorì la consacrazione mariana, specie negliordini monastico-militari. In questo contesto, particolare appare lospirito carmelitano. La consacrazione fu tipica di quest'ordine. Glieremiti del Carmelo che nel XIII sec. consacrarono la loro chiesettaalla Vergine, fecero con ciò una scelta spirituale netta, una tradilìopersonarum a favore della loro protettrice. Ma Arnaldo di Bustio,scrivendo nel 1479 il De Patronatu et Patrocinio, presentò la Verginecome patrona, ma anche come sorella e madre, sganciandola così dalmodulo giuridico-feudale. Proprio dal '400 si diffuse quella che fu lapiù singolare forma di consacrazione medievale alla Vergine, e avvennesotto il segno del Carmelo.
Il Catalogo dei Santi Carmelitani (1411 ca.) tramanda la visione di s.Simone Stock (16 luglio 1251), che ricevette lo scapolare, come pegnodi predestinazione per chi l'avesse portato, avesse recitato l'OfficiumParvum, avesse praticato la castità secondo il proprio stato e avesserinunciato alle carni i giorni di mercoledì, venerdì e sabato.
Questa consacrazione è riconducibile chiaramente al modello feudale, ela "bolla Sabatina" dello pseudo-Giovanni XXII accrebbe i privilegi dicoloro che portavano lo scapolare, promettendo la liberazione dalpurgatorio il primo sabato dopo la morte.
Come si vede, il fervore religioso, sia che si esprima sotto la formadella ricerca teologica, sia che si manifesti nelle molteplici formedevozionali, fa convergere l'attenzione dei posteri su alcunespecificità mariane indiscutibili, legate alla sua potenza mediatrice e
al suo ruolo benefico nella vita dei singoli e dei gruppi. Oggetto ditenero amore, spesso ingenuo o rozzo, la Vergine addolcisce il pesodell'esistenza a tutti.
IV Lezione
LA LITURGIA
II luogo figurato in cui l'alta teologia e la pietà spontaneas'incontrano è la liturgia. La fisionomia del culto mariano sidefinì già in età prenicena: già da allora vi è una riccainnografia (Odi di Salomone, Oracula Sybillina), una tradizioneomiletica (cfr. Melitone di Sardi ),(1) una produzione liturgica (adesempio la Traditio Apostolica di Ippolito) e paraliturgica (giàcol Protovangelo di Giacomo, fonte inesauribile di dati biograficimariani, poi entrati nella tradizione, come i nomi dei suoigenitori, o le tappe della sua vita prima dell'Annunciazione ), (2)un'esegesi biblica mariologica, specie del salterio. (3)
Le tipologie liturgiche, che sopravvissero tutto il Medioevo earrivarono fino ad oggi, sono quelle della Nuova Eva, (4) dellaterra vergine dell'Eden, (5) della pietra staccatasi dal monte delsogno di Nabucodonosor, (6) della nube leggera,(7) dell'Arcadell'Alleanza, (8) della Verga di Iesse. (9) Nel VI sec. si avràun'esplosione del culto liturgico mariano, con le quattro grandifeste della Madonna: Natività, Annunciazione, Purificazione,Dormizione. Esse arrivarono a Roma nel VII sec. dall'Oriente.NelI'VIII sec. giunse la Presentazione al Tempio, e nel IXl'Immacolata Concezione; solo nel XIV sec, nacque la Visitazione,in Occidente.
Per la Natività di Maria, va detto che già ai tempi di Romano ilMelode (536-566) c'era una grande festa (10) che arrivò appunto inOccidente nel VII sec. Papa s. Sergio I (687-701) la solennizzò conuna processione, introducendo in Occidente un po' del fastoliturgico mariano a cui lui, come siriano, era abituato. Dal sec.XI la festa crebbe d'importanza, e il II Concilio di Lione le diedeun'ottava (1245). L'uso, antichissimo, di celebrarla l'8 settembreserviva ad aprire l'anno liturgico greco.
L'Annunciazione era celebrata già prima del VII sec. in Occidente,ma non il 25 marzo; anzi ogni chiesa nazionale barbarica aveva lasua data. Il 25 era solo la data della Chiesa orientale, data dellacreazione del mondo, dell'uomo, della redenzione. (11) Già dal IVsec. in Palestina si celebrava questa solennità. L'uso romano, conla data di marzo, divenne normativo per tutto l'Occidente, apartire dalla Riforma gregoriana.
La Purificazione della Vergine, abbinata alla Presentazione delSignore al Tempio, sulla scorta del racconto lucano, erafesteggiata in Palestina già dal IV sec., come attesta la
Peregrinano Etheriae. (12) Giustiniano estese la festa a tutta laChiesa, fissandola al 2 febbraio, col nome di Ypapantè. Dal V sec.si parla nelle fonti di luci e candele, (13) introdotte a Bisanzioalla fine del VI sec. e a Roma nel VII. (14) Qui la processione eraparticolarmente solenne, e sempre Sergio I diede alla festa quelcarattere mariano che conservò fino alla riforma liturgica delVaticano II.
L'Assunzione era festeggiata il 15 agosto), come Dormitio dellaVergine, sin dal V-VI sec. in Palestina. L'imperatore bizantinoMaurizio (582-602) la estese a tutta la Chiesa. Assai solennizzatadai Bizantini nel corso del loro mese mariano, la festa risulta aRoma sotto s. Sergio I, che vi istituisce una processione.NelI'VIII sec. fu istituita invece la vigilia con il digiuno,mentre s.Leone IV (847-855) volle la celebrazione dell'ottava. Diessa, già s. Niccolo I faceva un cardine dell'anno liturgico. (15)
La festa della Presentazione della Vergine, il 21 novembre, basatasul racconto del Protovangelo di Giacomo, nella Chiesa bizantinafaceva parte del ciclo delle dodici feste importanti della Madonna,il Dodecaòrton. Aveva una preparazione e una chiusura, in tutto disei giorni (20-25 novembre). Nata in Palestina, la festa divennepiù nota ai tempi di Giustiniano, che nei pressi del Tempiosalomonico costruì la basilica cosiddetta nuova, dedicata allaPresentazione, e oggi distrutta. Bisanzio tuttavia comincia acelebrare la festa di sicuro solo dall'VIII sec. In Occidentearriva nell'XI sec., tramite i monasteri greci dell'Italiameridionale, da cui giunge in Inghilterra, per via dei contattiintercorrenti tra i Normanni di entrambe le regioni. Fu solo nel1373, però, che Gregorio XI (1370-1378) permise la celebrazione intutta la Chiesa; essa divenne obbligatoria con Sisto IV, nel 1472.(16)
In quanto all'Immacolata, già dall'VIII sec. aveva la sua festaliturgica in Oriente, fissata al 9 dicembre e intitolata allaConcezione di s. Anna. Passata in Occidente sempre tramite ilMeridione italiano e l'Inghilterra, assunse la data e ladenominazione attuali. Poiché la liturgia metteva l'accento, piùche sul fatto biologico della concezione della Vergine,sull'assenza della colpa originale nella concepita, la festaconobbe un declino nel XIII sec., in corrispondenza dell'offensivamancolista della teologia scolastica, ma rifiorì nel XIV sec., dopol'insegnamento di Duns Scoto, e addirittura il Concilio di Basilea,nel 1438, compose un'officiatura nuova per la festa, con un gestoche, terminato il Piccolo Scisma, sarebbe stato imitato da SistoIV, che in due riprese ristrutturò la liturgia dell'Immacolata(1477, 1480).
La festa della Maternità divina ha una storia molto più semplice.Praticamente da sempre esistita, legata alla definizione dogmaticaefesina, la solennità ha a Roma la data attuale già dal VII sec., e
veniva celebrata al Pantheon con una statio liturgicaapposita. Dall'età carolingia emerge il carattere cristologicodella festa (17) (che è pur sempre l'ottava di Natale, e quindigiorno della circoncisione di Gesù), che rimarrà fino alla riformaliturgica del Vaticano II, in cui, con una tendenza opposta aquella delle altre innovazioni, l'aspetto mariologico acquista unanuova rilevanza.
La Visitazione, infine, fu festeggiata per secoli durante ilperiodo d'avvento. Solo ai tempi del Grande Scisma d'Occidentel'arcivescovo di Praga Giovanni Jenstein, per scongiurare la finedella divisione ecclesiale, istituì la festa nella suagiurisdizione ecclesiastica, e propose ad Urbano VI (1378-1389) diestenderla a tutta la Chiesa. Questi preparò il decreto nel 1389,che però fu promulgato dal successore, Bonifacio IX (1389-1404),nel 1390, fissando la data della festa al 2 luglio. Col Concilio diFirenze (1438-1445), le Chiese orientali oramai unite a Romaaccettarono la festa, mentre Niccolo V (1447-1455) ripromulgò ildecreto bonifaciano, perché avesse vigore in tutta la Chiesafinalmente riunificata. (18)
[1] Cfr. MELITONE DI SARDI, Omeliae, in Sources Chrétiennes (SC), CXXIII, 90 ss. [2] Cfr. I.CALABUIG, Liturgia, in DE FIORES-MEO. Dizionario , pp- 770-773. [3] Cfr. p.es. TERTULLIANO, De Carne Christi, in CCL II, 909; Contra Prasseam, in CCL II, 1172 ;Cantra Marcionem, in CCL I, 567, ecc. [4] GIUSTINO, Dyalogus cum Tryphone, in PG VI, 709-712; IRENEO, Adversus Haereses, in SC XXXIV,378-382. [5] IRENEO, Adversus haereses, in SC XXXIV, 370; TERTULLIANO, De Carne Christi, in CCL II, 904;METODIO DI OLIMPIA, Convivium, in PG XVIII, 68. [6] IRENEO, Adversus Haereses, in SC XXXIV, 330-332. [7] TEODORETO DI CIRO, Dyalogi, in PG LXXXIII, 88. [8] IPPOLITO, In Psalmos, in PG X, 609. [9] TERTULLIANO, Cantra Marcionem, in CCL 1, 530. [10] ROMANO IL MELODE, Inni, a cura di G.GHARIB, Roma 1981, pp. 159-172. [11] AGOSTINO, De Trinitate, in PL XL1I, 834. [12] Peregrinano Etheriae, a cura di P.SINISCALCO- C.SCARAMPI, Roma 1985, p.72. [13] Cfr. la testimonianza in PG LXXVII, 1040-1041. [14] Ordo Sancii Petri, in PL LXXVIII,653. [15] Cfr. B.CAPELLE, L’assunzione e la liturgia, "Marianum" 15 (1953),pp.241-276. [16] Cfr. G.GHARIB, Presentazione di Maria, in DE FIORES-MEO, Dizionario ,pp.l 155-1161 [17] Cfr. I.CALABUIG, Festa di Maria Madre di Dio, "Servizio della Parola" 134 (1981) pp.97-107.
[18] Cfr. D.SARTOR, Visitazione, in DE FIORES-MEO, Dizionario , pp. 1476-1482V Lezione
MADONNA E CULTURA MEDIEVALE
Questo fervore di fede si trasfuse, come ho detto, nelle moltepliciforme della civiltà, producendo alti modelli di cultura cristiana, checontribuirono esse stesse a definire la fisionomia dottrinale ereligiosa della Vergine nel Medioevo. A titolo esemplificativo,indicherò esempi artistici, letterari e musicali, atti ad esprimere laprofondità dell'ispirazione religiosa della cultura nel periodo
medievale.
In relazione all'arte, specie figurativa, va detto che l'antichità nonconservò un ritratto di Maria "Neque enim novimus facies VirginisMariae". (1) Nonostante ciò la tradizione iconografica della Vergine èantichissima, e risale all'arte funeraria catacombale, con soggettitratti dai Vangeli canonici e apocrifi, specie dell'infanzia. Questitemi influenzeranno l'arte posteriore, assieme a quelli legati alladefinizione dogmatica di Efeso (431). Ai suoi tempi, Roma aveva giàquattro grandi basiliche mariane: la liberiana. Santa Maria Antìqua,Santa Maria Rotunda, Santa Maria in Trastevere, ognuna coi suoi tesoriartistici. Il titolo di Sancta Maria è l'equivalente latino teologicodel titolo Theotòkos - come attesta l'iscrizione dell'ambone di SantaMaria Antiqua: "Noviter fecit: + IOHANNES SERVUS S(an)C(t)AE MARIAE/IOANNOY ?OY?OY THS TEOTOKOY".(2) In quanto ai soggetti catacombali,subiscono una variazione: la Vergine viene isolata, e in grembo a leiil Bambino sta come sul trono, con angeli e santi intorno. (3) Troviamoquesta tipologia per esempio alla catacomba di Commodilla, in unaffresco del VI sec., o a S. Apollinare Nuovo a Ravenna.Contemporaneamente, l'Oriente sviluppa la tipologia della Vergine cheindica la via, o Odighìtria: l'antica icona attribuita a San Luca fuvenerata a Costantinopoli dal 451, e fu il modello di moltissime altreicone. A partire da questo periodo, poi, l'iconografìa mariana compareanche sulle pareti absidali. Essa raggiunge l'apogeo a Santa MariaMaggiore: la Maternità divina, l'Adorazione dei Magi e quella diAfrodisio, l'Annunciazione, la Presentazione di Gesù rappresentano laMadonna come Basilissa, creando un modello che sarà ripreso in SantaMaria Antiqua, nell'arte benedettina (che la diffonderà ovunque) e inSanta Maria in Trastevere. L'iconoclastia orientale favorirà ladiffusione dei tipi iconici occidentali (si pensi alla ripresa diquesto modello in Santa Maria Antiqua nella cappella dei SS.Quirico eGiulitta e nel sacello di San Pietro voluti da Giovanni VII (705-707),e al mosaico del catino absidale di Santa Maria in Domnica, voluto das. Pasquale I (817-824). (4) In generale, ovunque in Italia, dal S.Salvatore di Brescia fino a S. Sofìa di Benevento, si riscontra il temadell'Incarnazione.
In Oriente invece, superata la crisi iconoclastica, la produzioneiconica riprende rigogliosa, ma anche stereotipata, per evitare abusi.I tipi più importanti sono parecchi. L' Odighìtria, di cui si è detto,si diffuse a Roma, Grottaferrata, Bari, Venezia, Monopoli, Bologna,Torino, in Russia, in Polonia (Czestochowa), Medio Oriente, Balcani. L'Eleùsa (Madonna della Tenerezza, col Bambino guancia a guancia),attribuita a san Luca, si diffuse in Francia (Cambrai, XII sec., conl'icona famosa in cui Bernadette Soubirous riconobbe la Vergine vistain visione), in Russia, nell'Illirico. Ci sono poi i tipi della Vergineorante: l'Aghiosoritissa, detta così dalla chiesa dell'Urna Santa(Aghìa Sóros;), contenente la veste della Vergine, a Costantinopoli,riprodotta a Roma, a Frisinga, sul Monte Athos, in Egitto, in Russia;la Blachernitissa, dal santuario di Blachèrne, copiata a Nicea, inRussia e a Venezia; la Deèsis, il cui nome indica la triade Gesù, Maria
e il Battista. Infine vanno ricordati il tipo della Madonna cheallatta, o Galaktotrofùsa, proveniente dall'Egitto e diffusa ovunque vifossero reliquie del latte di Maria; quello della Madonna del Segno,legato all'Annunciazione; il tipo miracoloso della Tpicherùsa, e laKiriotìssa o Basilìssa, di cui ho detto (diffusa in Medio Oriente,Africa, Balcani, Russia, Italia). Quasi tutti questi tipi entrerannonelle arti romanica e gotica. (5) Il Medioevo occidentale sviluppaun'arte autonoma mariana a partire dal XII sec., ed essa viene diffusadai Cistercensi e dai Premostratensi. In onore della Vergine sorgono lemeravigliose cattedrali di Laon (1150), Parigi (1163), Amiens (1220),Chartres (1194), ecc. Esse sono modello per tutta Europa: Westminster,York, Burgos, Colonia, Palma di Maiorca, Tolosa; santuari mariani comeArras e Clermont fungono poi da modello per tutta la Francia. InSicilia la Martorana di Palermo è dedicata alla Madre di Dio (1143) daGiorgio di Antiochia, mentre Guglielmo II (1166-1189) dedica invecealla Vergine la cattedrale di Monreale. Anche Suger di Saint-Denis(luogo che fu lo scrigno più eccelso di tutte le forme dell'artegotica) immortala nelle vetrate della sua abbazia il mistero marianodell'Annunciazione. E nella statuaria, troviamo capolavori come lascultura che fa da pilastro divisorio alla cattedrale di Reims. AParigi, due portali sono dedicati a Maria, la cui vita è immortalatanella cattedrale di Senlis. Le raffigurazioni si arricchiscono deglispunti più disparati, tratti dalla Bibbia, dalla patristica,dall'innografia, dalle leggende agiografìche, dalla devozione, senzaperò mai sacrificare l'aspetto umano e sentimentale: si veda peresempio la "tempesta che è nel cuore", ossia la raffigurazione tipicadel dubbio di Giuseppe davanti alla nascita di Gesù, quando gli siripropone l'angoscioso dilemma sulla sua nascita, insinuatogli daSatana, e fugato dalla Vergine che mostra amorevolmente il Figliodivino (abside di Santa Maria Maggiore, opera di Jacopo Torritti, finesec. XII). Non mancarono raffigurazioni simboliche, come per esempioquella della "Sedes Sapientiae", in cui Maria è tra i massimi filosofie tra le figure delle arti liberali (facciata di Chartres). Bisogna poiricordare le Maestà toscane e umbre, ad un certo punto influenzatedallo spirito francescano (Madonna con gli Angeli e s. Francesco, nellaBasilica Inferiore ad Assisi; Maestà di Duccio di Buoninsegna,all'Opera del Duomo di Siena; Madonna Rucellai a Firenze, in SantaMaria Novella). (6)
Nella letteratura, la Vergine ricevette un'attenzione ancora maggiore:la grande tradizione mediolatina si nutre di elementi mariani.L'agiografia produce centinaia di Miracula, o raccolte di prodigiattribuiti alla Vergine, generalmente avvenuti presso i suoi santuari.La poesia si sbizzarrisce con inni, tropi, sequenze, spessocaratterizzati da virtuosismi versificatori, come acrostici (peresempio: "Mater Alma Redemptoris Iubar Aurei viroris" è un esempio diacrostico perché le prime cinque iniziali formano il nome Maria), siain un solo verso, che in più strofe, in cui ogni parola inizia per lalettera che si vuole mettere in rilievo (per esempio, "Margaritamundans mentes /mater mitigans maerentes/ mel misericordiae// Aulaagni, Abel ara / arbor auferens amara/ ales alimoniae", che danno le
prime due lettere del nome Maria, mentre le altre tre lettere sono leiniziali delle parole delle strofe tre, quattro e cinque), osemplicemente in più versi, inizianti tutti con la stessa lettera (adesempio: "Mater mirabilis, Maria, nomine/ multum lucidior, quocumquelumine/ muni me miserum, mortis in limine/ malignis obvians tuoiuvamine", che suggeriscono la prima lettera del nome Maria). Nonmancano mesostici e telostici combinati tra loro, o versi disrupti, incui il nome della Vergine è scomposto in sillabe, dislocato su versidiversi. Versi assai creativi anche in ordine alle rime si hanno con lestrutture dei cruciferi, con rima incrociata ("Angelico verbo tactustuus intumet alvus/ ut fieret salvus homo tentus ab hoste superbo"),dei serpentini, con l'ultima parola dei vari cola che rima con la primadel colon successivo ("Ave, porta poli, noli te plaudere mota/ votatibi grata suscipe, dirige mentem"; "Tu es fìlia novella/ cellaeloquentiae/ simplex, clara columbella/ stella excellentiae/ ornansstipem tu agnella/ fiscella clementiae"), dei trinini salientes, conesametri rimati tra coppie di membri dattilici e clausole, e condivisioni basate su cesure tritemimere e eftemimere ("Stella maris,quae sola paris, sine coniuge prolem/ iustitiae clarum specie superomnia solem"). (7) La Madonna entra anche nel mondo del lamento poetico,con i planctus Mariae, che spesso assumono forma drammatica, esconfinano nei ludi scaenici, di svariato argomento religioso, e quindianche mariano, rappresentati sovente presso i santuari. I maggioriautori mediolatini che scrissero di Maria in età barbarica furono:Gregorio Magno (570-604), Isidoro di Siviglia (560-636), Cesario diArles (470-542), Beda il Venerabile (672-735), che ne parlarono comepadri e dottori, da un punto di vista strettamente teologico-religioso;Ennodio (473-521) e Venanzio Fortunato (530-600ca), in componimentipoetici di sapore classicheggiante; Draconzio (V-VI sec.), nelle poesiedel De Laudibus Dei; Lussorio (VI sec.), nell'imitazione dell'epigrammaclassico; Avito (450-518), come poeta epico-biblico, e Adelmo diMalmesbury (640-709), come poeta didascalico. Durante il rinascimentocarolingio, scrissero della Vergine Alcuino di York, i raffinati poetiTeodulfo d'Orléans (760-821), Vandalberto di Prum (813 - 850 ca.) ePrudenzio di Troyes (†861), i poligrafi Rabano Mauro (784-856) eValafrido Strabone (809-849). In età feudale, la Madonna diedeispirazione alla poesia di Nokter il Balbo (840 ca. - 912), allapoliedrica produzione di Odone di Cluny (1930), di Odilone suosuccessore (†1049), alla teologia di Remigio d'Auxerre (841 ca.- 908) edi Silvestro II (999-1003), alla drammaturgia di Rosvita di Gandersheim(935-973). L'età scolastica riprese temi mariani con Fulberto diChartres (964- 1045), Pier Damiani (1007-1072), Anselmo d'Aosta (1033-1109), Abelardo (1079-1142), Bernardo di Chiaravalle (1090-1153), Ugodi San Vittore (1097-1141), Riccardo di San Vittore (†1173), PietroLombardo (†1164): tutti dottori che non hanno bisogno di presentazione.E ancora parlarono di Maria Gioacchino da Fiore (†1203), e i poligrafiGilberto Porretano (†1154), Ildegarda di Bingen (†1179), Giovanni daSalisbury (1120-1180 ca.), Ildeberto di Lavardin (1056-1123), Alano diLilla (1118-1203), più il poeta Adamo di San Vittore (1112-1192) e unnumero infinito di anonimi autori di poesie e drammi sacri. Laletteratura erudita dei secc. XIII-XIV ha nei grandi Dottori (Tommaso
d'Aquino, Alberto Magno, Bonaventura, Duns Scoto, Vincenzo di Beauvais,Raimondo Lullo) gli autori mariani più fecondi, accanto ai predicatorie agiografi più insigni come Antonio da Padova (†1231), Giacomo diVitry (†1240), Roberto Grossatesta (1175-1253), lacopo da Varazze(1230-1298). Più di un'intera generazione di lirici sacri cantò laVergine - Filippo il Cancelliere (1160-1236), Stefano Langton (†1228),Giovanni Peckham (†1292), Iacopone da Todi (†1236) - distribuita sututto il continente. Come si vede, un'intensa produzione latinaplurisecolare. (8)
Nella letteratura volgare, la Vergine trova altrettanto posto. Ilgenere letterario che più si sostanzia di elementi mariani è la lauda.Il suo maggior autore è il b. Jacopone da Todi, che ci ha lasciatopagine di intensa commozione, specie in "Donna de' Paradiso". I varipoeti italiani in volgare del Duecento, come Guittone d'Arezzo oBonvesin della Riva, hanno dedicato versi alla Vergine, spesso di nongran valore, fino a che la poesia devota trovò il suo campione inDante, la cui Divina Commedia ha un'altissima ispirazione mariana,lungo l'arco di tutte e tre le cantiche, presentando Maria comemediatrice di salvezza, e dedicandole la splendida preghiera attribuitaa San Bernardo. Meno devota la vita, ma altrettanto sentita la poesiamariana del Petrarca, che elevò alla Vergine un'invocazione di salvezzache è la pietra angolare di tutto il Canzoniere, e che Carducciconsiderò la più bella di tutte le poesie mariane. Meno ispirate lepoche liriche del Boccaccio dedicate a Maria, mentre in generale itrecentisti minori, come Fazio degli Uberti o Sannuccio del Bene,seguirono un'ispirazione mariana costante ma più tenue rispetto allamusa dell'Alighieri e del Petrarca. In clima umanistico, la lauda "Dì,Maria dolce", di Giovanni Dominici (1357-1419), è certamente la paginapiù ispirata, anche se non la più erudita; chi cercasse taleraffinatezza, dovrebbe leggere le liriche del Magnifico o delPoliziano: sebbene il secondo non sia stato disprezzabile nei suoicomponimenti mariani, tali opere rimangono piuttosto asettiche. Moltopiù sentita fu la Confessione che, con importanti elementi mariani, ilPulci scrisse dopo il 1481.
In Francia la lirica volgare dei secc. XII-XIII è altamente marianamentre si sviluppa un teatro sacro che tocca la vetta artistica con iMiracles de la Vierge di Gautier de Coincy (†1236) e il Miracle deThéophile di Théophile de Rutebeuf (XIV sec.). Anche nell'anonimo Jeud'Adam si rintraccia un'ispirazione mariana di tipo patristico, chesviluppa l'equiparazione Eva - Maria. Il Quattrocento ha poi un'operasplendida ne La Balade pour prier Notre Dame, di François Villon. InInghilterra gli antichi Anglosassoni ebbero il loro poeta mariano inCynewulf (sec. IX), e durante tutta l'età normanna abbondarono lirichee opere mariane in genere, proseguite fino a tutto il Trecento, egiunte ad alto livello artistico con G.Chaucer (1340-1400) e di JohnLydgate (1370-1451 ca.).
In Spagna, emersero le figure di Gonzalo de Berceo (1195-1268) e del re
Alfonso X il Saggio, assieme all'anonimo autore dei duecenteschiMiraclos de Nuestra Señora. Le loro opere posero motivi letterari chevennero riecheggiati per tutto il '400. In Germania, tra i secc. XII eXIII, fiorirono laudari e canzonieri mariani, ispirati dallaletteratura francese, che però andarono isterilendosi nel '400. (9)Ovviamente, anche la musica fu intrisa di spirito mariano, a partiredal canto cristiano bizantino. Esso è la prima forma di civiltàmusicale che s'ispira largamente a temi religiosi cristiani. I suoicanti furono raggruppati secondo l'uso liturgico, ed ebbero dal V sec.dei grandi autori. Il primo fu Efrem Siro, a cui si attribuiscono tremilioni di versi. Assenzio e Romano, di poco posteriori, sonoconsiderati gli iniziatori del genere del kontàkion, ossia di unacomposizione di ventisei strofe, di cui una introduttiva e una finale.Perfezionatore del kontàkion fu Giovanni Damasceno, che tuttaviacompose versi e musiche anche in altri sistemi metrici e strofìci.Ovviamente, tutti costoro scrissero anche melodie specificamentemariane. Il maggior poeta dei kontàkia fu Romano il Melode, a cui sideve la celebre raccolta di canti mariani e Parthènos, e a cui siattribuisce persino l'inno Akhàtistos, il più grande capolavoropoetico-musicale della tradizione greca sulla Vergine. Quest'inno, lacui musica c'è stata tramandata nel kontakàrion del codexashburnamensis LXIV della Biblioteca laurenziana di Firenze, è talmentelungo che veniva cantato a pezzi da gruppi diversi, che si alternavanostando in piedi (da cui il nome, che significa appunto "che sta inpiedi"). Il testo è sostanzialmente litanico, e ha un retroterra assaicomposito di cultura biblica, liturgica e patristica. (10)
Andrea di Creta, padre della Chiesa, fu invece l'iniziatore del sistemastrofico del canone, inno in nove odi, ciascuna di almeno tre tropi. Alui seguirono, in questo genere di composizione, Giovanni Damasceno,Teodoro e Giuseppe Studita e molti altri.
Nel canto gregoriano abbiamo una produzione altrettanto varia,suddivisa nelle aree geoturgiche romana, gallicana, ambrosiana,mozarabica. Tipicamente monodico, il gregoriano ha generatoinnumerevoli messe cantate, di cui la più celebre e bella è la Cumiubilo; molte erano dedicate alla Vergine, e anche quelle di altro temaavevano un ricco tropario mariano, come soprattutto la Alme Pater. Unaraccolta importante era contenuta nel Commune festorum B.M.V., in cuispesso le melodie mariane adattavano musiche ancora più antiche, comead esempio la messa di S. Maria m sabato. Con l'avvento della polifoniae dell'Ars Antiqua intorno al X sec., irradiatasi dai grandi santuari -spesso mariani, come Parigi e Chartres - si diffondono nuovecomposizioni mariologiche, a due, tre o più voci: tra esse ci sono lecanzoni di Gautier de Coincy, che in esse adattò i suoi stessiMiracles. Arrivata l'Ars nova (XIII-XIV sec.), la polifonia si svilupparigogliosa, e nascono opere come la Messe de Notre Dame, di Guillame deMachant (1300-1377), o i suoi mottetti Rex Virginum e Felix VirgoInviolata. Non mancano antifone e tropi, specie in Inghilterra, dovefioriscono le cosiddette antifone votive. Nell'isola, l'innografìa fu
diffusa soprattutto dai francescani, che se ne servirono come strumentodi evangelizzazione. Anche inglesi furono i carols, ossia le melodie acarattere religioso non liturgico, usate nelle processioni o al terminedelle messe. Nomi illustri della musica mariana europea delQuattrocento furono Lionel Power (†1445), John Dunstable (†1453),Guillame Dufuy (†1474), che musicarono celebri preghiere e antifonepreesistenti. (11)
(1) AGOSTINO, De Trinitate, in PL XLII, 952. (2) In Dictionnaire d'Archèologie Chrétienne et de Liturgie (DACL), a cura di F.CABROL- H.LECLERCQ, vol. I-
XV, Parigi 1924-1953, in particolare vol. V, s.v., c.2017. (3) M.VLOBERG, Type romaine de la Vierge Reine, "Art Sacrè» 142 (1938). (4) Cfr. P.AMATO, Arte/Iconologia, in DE FIORES - MEO, Dizionario pp. 138-154, in particolare pp.140-144. (5) Cfr. G.GHARIB, Icone, in DE FIORES-MEO, Dizionario, pp.670-679, con bibl. (6) Cfr. AMATO, Arte, pp. 138-154. (7) Cfr. D.NORBERG, Introductìon à l'ètude de la versification Iatine medievale Stoccolma 1955 pp.43-70. (8) Cfr. la sintesi in V.PALADINI M.DE MARCO, Lingua e letteratura mediolatina, Bologna 1980 2 , pp.120-266. (9) Cfr.G.FRANCINI, Letteratura, in DE FIORES - MEO, Dizionario, pp. 735-759, in particolare pp.735-742. (10) Cfr. sull'arg. E.M.TONIOLO, L’Inno Acatisto, monumento di teologia e di culto mariano nella Chiesa Bizantina,in De cultu mariano saeculis VI-XI, vol. IV, Roma 1972, pp. 1-39. (11) Cfr. sull'arg. P. SANTUCCI, La Madonna nella musica, Bologna 1984