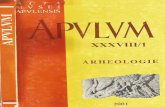Una tomba di cavaliere della metà del V secolo da Arzignano (Vicenza), “Archeologia Medievale”,...
Transcript of Una tomba di cavaliere della metà del V secolo da Arzignano (Vicenza), “Archeologia Medievale”,...
ARCHEOLOGIA MEDIEVALE
Cultura materiale. Insediamenti. Territorio.
Rivista fondata da Riccardo Francovich
Comitato di Direzione:GIAN PIETRO BROGIOLO
SAURO GELICHI (responsabile)
Comitato Scientifico:GRAZIELLA BERTILANFREDO CASTELLETTIRINALDO COMBAPAOLO DELOGURICHARD HODGESGHISLAINE NOYÉPAOLO PEDUTOCARLO VARALDOCHRIS WICKHAM
Redazione:ANDREA AUGENTIALEXANDRE GARDINICRISTINA LA ROCCAMARCO MILANESEALESSANDRA MOLINARISERGIO NEPOTI (responsabile sezione scavi in Italia)LIDIA PAROLI (capo redazione)ROBERTO PARENTIALDO A. SETTIAMARCO VALENTIGUIDO VANNINI
Corrispondenti:PAUL ARTHURVOLKER BIERBRAUERHUGO BLAKEENRICA BOLDRINIMAURIZIO BUORAGISELLA CANTINO WATAGHINENRICO CAVADANEIL CHRISTIEGIULIO CIAMPOLTRINISTEFANO COCCIAMAURO CORTELAZZOFRANCESCO CUTERILORENZO DAL RICOSIMO D’ANGELA
FRANCO D’ANGELOFRANCESCO DOGLIONIMARIA GRAZIA FIOREALESSANDRA FRONDONIENRICO GIANNICHEDDAFEDERICO MARAZZIROBERTO MENEGHINIEGLE MICHELETTOMASSIMO MONTANARIGIOVANNI MURIALDOMARIA MADDALENA NEGRO PONZI MANCINIHANS NORTHDURFTERGABRIELLA PANTÒHELEN PATTERSONLUISELLA PEJRANIPHILIPPE PERGOLARENATO PERINETTIGIULIANO PINTOMARCELLO ROTILIDANIELA ROVINALUCIA SAGUÌMARIAROSARIA SALVATOREANDREA R. STAFFADANIELA STIAFFINISTANISŁAW TABACZYNSKIBRYAN WARD PERKINSDAVID WHITEHOUSE
Autorizzazione del Presidente del Tribunale di Firenze n. 2356 del 31 luglio 1974
Indirizzi Redazione:c/o Edizioni ALL’INSEGNA DEL GIGLIO s.a.s. via della Fangosa, 38; 50032 Borgo San Lorenzo (FI); tel. +39 055 8450216; fax +39 055 8453188 web site www.edigiglio.it e-mail [email protected]; [email protected]
ABBONAMENTI 2010«Archeologia Medievale»: Italia € 44,00; Estero € 50,00; «Archeologia Medievale» + «Archeologia dell’Architettura»: Italia € 65,00; Estero € 78,00; Per gli invii in contrassegno o all’estero saranno addebitate le spese postali. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati esclusivamente per l’invio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi per alcun motivo.
ISSN 0390-0592ISBN 978-88-7814-527-6
© 2011 All’Insegna del Giglio s.a.s.
Stampato a Firenze nel dicembre 2011
431
Archeologia MedievaleXXXVIII, 2011, pp. 431-457
Elisa Possenti
Una tomba di cavaliere della metà del V secolo da Arzignano (VI)
In ricordo del mio amato maestroOtto von Hessen (3.6.1937-3.1.1998)a tredici anni dalla sua scomparsa
1. IL RINVENIMENTO
Nel comune di Arzignano (provincia di Vicenza) (fig. 1) vennero casualmente alla luce il 19 ottobre 1995, durante lavori di escavazione di ghiaia in via Canove, località Cava Poscola, i resti di una sepoltura a inuma-zione visibili in sezione nella parte centrale di un lembo di terra non ancora asportato dalla ruspa (fig. 2). Le operazioni di documentazione e rilievo effettuate nei giorni immediatamente successivi consentirono alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto di recuperare quanto restava della deposizione e di verificare l’assenza di altre tombe nell’area della cava non ancora asportata dall’escavatore. Della sepoltura, orientata nord-sud si conservava la porzione meridionale mentre non rintracciabile risultò la maggior parte dei resti osteologici asportati dalla benna della macchina operatrice. Dalla base della sezione furono comunque recuperati alcuni frammenti di ossa pertinenti all’inu-mato e, inoltre, alcuni materiali, verosimilmente relativi al corredo del defunto.
Le operazioni di scavo consentirono inoltre di ve-rificare la presenza, ad alcuni metri di distanza, di due tratti di fondazione muraria in ciottoli, l’uno orientato nord-sud, l’altro est-ovest, forse appartenenti ad un unico ambiente (fig. 2, a-b). Le fondazioni erano state scavate nelle ghiaie sterili al di sopra delle quali era un livello sabbioso-organico, verosimilmente in fase con le murature, caratterizzato dalla presenza di frammenti laterizi, malta, pietre e qualche frammento di ceramica grezza. La sequenza era quindi sigillata da un riporto di sabbie alluvionali di età non determinabile, a sua volta coperto dal livello agrario attuale. Sulla base di alcuni reperti rinvenuti (prevalentemente ceramici) è verosimile ritenere che i resti fossero relativi ad un edificio rustico di età romana, relativamente al quale non poterono essere tuttavia chiariti, al momento della scoperta, i rapporti cronologici con la sepoltura ad inumazione; ciononostante sembrerebbe potersi dire che la porzione di edificio messa in luce dai lavori di escavazione era già stata dismessa al momento della deposizione1.
2. STRUTTURA TOMBALE
La sepoltura era stata deposta all’interno di una fossa in nuda terra, orientata nord-sud (figg. 4, 6), che incideva le ghiaie sterili per circa 45 cm, anche se la profondità originaria, non calcolabile a causa del compattamento del terreno causato dal passaggio dell’escavatore, doveva essere superiore. La fossa, in origine probabilmente ovale, aveva il lato breve di forma arrotondata, pareti inclinate e fondo piatto; la lunghezza massima conservata era di 1,3 m, la larghezza di 1,3 m. Nella parte superiore della fossa il riempimento era costituito da una matrice nera-stra argilloso-sabbiosa con frustoli di carbone, frammenti laterizi, ciottoli di piccole dimensioni e alcuni frammenti ceramici. Al di sotto era uno strato di laterizi spesso circa 20 cm che copriva i resti di un individuo maschile deposto supino e di una deposizione parziale di cavallo. Detti resti erano direttamente appoggiati sulla nuda terra.
I laterizi erano tegoloni ad alette (60×45 cm), po-sizionati trasversalmente all’asse longitudinale della fossa e disposti in doppio strato ad eccezione della superstite parte centrale dove ne erano conservati tre livelli (figg. 3, 5). Il fatto che fossero in frammenti ma in-teramente ricomponibili fece ipotizzare, già al momento della scoperta, la presenza di una cassa lignea sottostante e una conseguente rottura dei singoli elementi in seguito al peso della terra soprastante. Tale ipotesi appare inoltre confermata dal fatto che la larghezza dei tegoloni non superava i 60 cm mentre la larghezza della fossa (1,3 m) misurava più del doppio2. La disposizione dei tegoloni e dei resti scheletrici dell’uomo e del cavallo (questi ultimi in parte al di fuori dello spazio coperto dagli elementi laterizi) fanno d’altro canto supporre che il cavallo fosse stato deposto successivamente alla cassa lignea; è inol-tre verosimile ritenere che in un terzo momento furono quindi collocati i tegoloni e una grossa pietra calcarea che copriva parzialmente le ossa dell’animale.
3. LO SCHELETRO DEL CAVALIERE
Dello scheletro (figg. 4, 6) di cui si riporta in appen-dice la nota redatta da Alessandro Canci, Pamela Corsi e Letizia Pulcini dell’Università degli Studi di Padova, si
1 Archivio Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, d’ora in poi ASAV (relazioni dell’assistente di scavo Michele Buso e dell’archeologo David Hosking). Una notizia preliminare è in Checchi, De Mani 1996. 2 ASAV; il dato si desume dalla relazione di David Hosking.
432
NOTE E DISCUSSIONI
fig. 1 – Ubicazione di Arzignano (VI).
conservavano in situ le sole gambe riconducibili a una deposizione supina del defunto con capo a nord e piedi a sud. Nel terreno caduto alla base della sezione furono inoltre raccolti alcuni frammenti relativi alla parte su-periore del corpo.
Di rilievo appare il dato (infra Canci, Corsi, Pulcini) che l’inumato fosse un individuo adulto maturo (35-45 anni), particolarmente robusto (altezza 169 cm circa; peso oltre i 70 kg), sottoposto ad un’attività fisica intensa tra cui compariva anche l’uso abituale del cavallo.
4. LO SCHELETRO DEL CAVALLO
All’interno della sepoltura erano state deposte alcune parti selezionate di un cavallo (figg. 4, 6), oggetto di uno studio paelozoologico una decina di anni fa3. Come detto sopra, è probabile una loro deposizione in un secondo momento, successivamente all’inserimento della cassa di legno con il corpo del cavaliere.
Le parti del cavallo, rinvenute intorno ai piedi e alle gambe del defunto, erano relative alle quattro gambe (estremità dei quattro autopodi), a parte della coda (tre vertebre coccigee) e alla testa (cranio e mandibola), posizionata quest’ultima parallelamente alla gamba destra dell’uomo. Al momento della scoperta i diversi elementi erano in corretta articolazione anatomica anche se caoticamente disposti tra loro ai piedi dell’inumato. Nel complesso le ossa dell’animale erano protette dai tegoloni posizionati più a sud all’interno della tomba e da un elemento di pietra calcarea. Solo la testa, in minima parte coperta dalla pietra calcarea, era priva, o quasi, di protezione (figg. 3, 5).
Lo studio archeozoologico ha evidenziato che l’anima-le era un esemplare maschile di circa otto anni di origine probabilmente occidentale. Altro elemento degno di nota
3 Reggiani, Rizzi 2005. I dati di questo studio sono stati ripresi in Salvadori 2009, p. 42.
è la presenza di sottili tagli sulla superficie delle ossa, pro-babilmente inferti da una lama tagliente e riconducibili ad un programmato depezzamento dell’animale.
5. ELEMENTI DI CORREDO, CONTESTO DI RINVENIMENTO E CATALOGO
In seguito alle operazioni di documentazione e recu-pero della sepoltura furono documentati e raccolti alcuni oggetti alcuni dei quali ancora in situ, altri rinvenuti alla base della sezione ma verosimilmente appartenenti al corredo del cavaliere.
5.1 Reperti rinvenuti in situ
Tra i materiali rinvenuti in situ c’era una lunga spada a due tagli, fratturata in due parti ricomposte in sede di restauro, che al momento della segnalazione alla Soprin-tendenza fuoriusciva parzialmente dalla sezione (fig. 7). L’arma, di cui furono recuperati nella terra franata alla base della sezione alcuni frammenti delle guarnizioni del fodero, era stata deposta lungo il fianco sinistro del defunto quasi in aderenza al femore. Lungo il filo destro della lama, in prossimità della frattura, erano alcune punte di freccia. Al di sopra di ognuna delle due tibie, in corrispondenza delle calzature, erano una fibbietta in bronzo cui facevano pendant tre piccoli chiodini a testa piatta (fig. 4, 1-2).
5.2 Reperti rinvenuti alla base della sezione
Nel terriccio franato alla base della sezione creata dall’escavatore furono raccolti alcuni materiali proba-bilmente appartenenti al corredo e, pertanto, origina-riamente deposti nella parte superiore della sepoltura in corrispondenza della zona compresa tra il bacino e la testa del defunto.
Oltre ad alcune guarnizioni del fodero della spada, i reperti erano costituiti da una spada corta a due tagli, rinvenuta in due frammenti successivamente ricomposti in sede di restauro (fig. 13), una fascetta in ferro forse parte di una faretra (fig. 14), un anello di fibbia in ferro (fig. 15), un ardiglione in bronzo con due rebbi (fig. 16), una placca in ferro con tre borchie emisferiche in bronzo (fig. 17), un secondo frammento di placca in ferro (fig. 18), due gancetti bronzei (fig. 19-20), un acciarino (?) in ferro (fig. 21) cui era forse relativa una fibbietta pure in ferro con ardiglione in bronzo (fig. 22), un coltello (fig. 23) e una pinzetta in bronzo (fig. 24). Nel medesimo terreno fu inoltre raccolto un massello di ferro di forma irregolare (fig. 25), la cui pertinenza alla sepoltura resta però problematica.
5.3 Catalogo
Reperti rinvenuti in situ1) Spada. Ferro, bronzo. Lacune lungo i taglienti e, in più punti, in corrispondenza delle guarnizioni in ferro del fodero; deformata e in due frammenti ricomposti (fig. 8).Lama a due tagli. Codolo di forma trapezoidale allungata a sezione rettangolare. Elsa in ferro di forma romboidale schiac-ciata. Sulla lama presenza di probabili tracce del fodero ligneo. Resti delle guarnizioni metalliche del fodero costituite da a) una fascetta metallica in bronzo a sezione rettangolare con tre sca-nalature orizzontali in corrispondenza dell’imboccatura, b) un
433
NOTE E DISCUSSIONI
fig. 2 – Arzignano, via Canove, Cava Poscola: area di intervento archeologico con indicazione delle murature di età romana (retino grigio) e porzione meri-dionale della sepoltura distrutta dalla ruspa. ASAV.
fig. 3 – Arzignano, via Canove, rilievo di scavo; copertura in laterizi, pietra e cranio del cavallo. ASAV.
fig. 4 – Arzignano, via Canove, rilievo di scavo; deposizione del cavaliere e del cranio del cavallo. ASAV.
puntale lacunoso in ferro, in due frammenti non ricomponibili, di forma rettangolare e con base ovale, originariamente fissato su un lato da quattro chiodini in bronzo a testa semicircolare appiattita e alla base da una borchia in ferro di forma irre-golarmente sferica, c) tre frammenti di fascette in ferro prive di decorazioni sulle superfici piegate ad assumere una forma semicircolare concava (questi ultimi tre elementi rinvenuti alla base della sezione e ricomposti con la spada in sede di restauro). La piegatura in due punti della lama è probabilmente dovuta al peso esercitato dai laterizi soprastanti. Misure: lungh. 102 cm; largh. lama 4,8 cm; largh. elsa 8,3 cm. N. inventario: I.G. 271960 (spada); I.G. 271961 (puntale del fodero); I.G. 271962 (frammenti di fascette laterali in ferro).
2) Punte di freccia. Ferro. Numerose lacune lungo i bordi, un esemplare in tre frammenti non ricomponibili (fig. 9).
Sette punte di freccia a tre alette con codolo appuntito per l’inserimento nella parte lignea. Tre sono riunite in unico insieme a causa dei prodotti di corrosione (I.G. 271965), una è in due frammenti non ricomponibili (I.G. 271969). Misure: lungh. compresa tra 8 cm (esemplari interi) e 6,3 cm; fram-menti lungh. max 4,3 cm (I.G. 271969). N. inventario: I.G. 271965-271969.
3) Punta di freccia. Ferro. Lacunosa (fig. 10).Cuspide di forma parallelepipeda con parte superiore appuntita a sezione triangolare e corpo cavo a sezione irregolarmente circolare con foro a sezione quadrangolare. Misure: lungh. 6,1 cm; largh. 1,3 cm. N. inventario: I.G. 271972.
4) Guarnizioni delle scarpe. Bronzo (figg. 11a-b, 12a-b).Due fibbiette in bronzo. Placca in lamina ripiegata di forma semicircolare con tre borchie di forma emisferica sulla parte a
434
NOTE E DISCUSSIONI
fig. 5 – Arzignano, via Canove, foto con particolare della co-pertura in laterizi e cranio del cavallo (da ovest). ASAV.
fig. 6 – Arzignano, via Canove, foto con particolare della depo-sizione del cavaliere e del cranio del cavallo (da est). ASAV.
fig. 7 – Arzignano, via Canove, foto con particolare dell’impu-gnatura della spada al momento della scoperta. ASAV.
vista per il fissaggio al cuoio delle calzature. Anello di forma emisferica solcato da profonde scanalature con ardiglione leg-germente arcuato e piccolo dado. Una delle due fibbie presenta piccole lacune e risulta arcuata. Ad ogni fibbia erano relativi tre piccoli chiodini in bronzo a testa piatta (uno solo integro).a) fibbia e chiodini della scarpa sinistra (fig. 11): Misure: lungh. 3,8 cm; largh. 2,2 cm (fibbia); diam. max 0,7 cm (chiodini). N. inventario: I.G. 271973 (fibbia), 271975 (chiodini).b) fibbia e chiodini della scarpa destra (fig. 12): Misure: lungh. 3,2 cm; largh. 2,2 cm (fibbia); diam. max 1 cm (chiodini). N. inventario: I.G. 271974 (fibbia), 271976 (chiodini).
Reperti rinvenuti alla base della sezione5) Spada corta. Ferro. Lacune lungo i taglienti, in due frammenti ricomposti (fig. 13).Lama a due tagli. Codolo di forma rettangolare a sezione ret-tangolare. Sulla lama presenza di probabili tracce del fodero in materiale organico. Misure: lungh. 36 cm; largh. lama 3,1 cm. N. inventario: I.G. 271963.
6) Fascetta. Ferro. In tre frammenti ricomposti (fig. 14).Sottile fascetta arcuata di forma e sezione rettangolare. Misure: lungh. 36 cm; largh. lama 3,1 cm. N. inventario: I.G. 271971.
7) Anello di fibbia. Ferro. Lacunoso (fig. 15).Anello, in origine probabilmente di forma ovale, con tracce di doppia insellatura e con sezione semilunata. Privo di decorazioni. Misure: lungh. 3,9 cm; largh. 1 cm. N. inventario: I.G. 271979.
8) Ardiglione. Bronzo. Lacunoso (fig. 16).Ardiglione con due rebbi molto arcuati; dado di forma qua-drangolare decorato da una X incisa e con un foro passante all’interno del quale è inserito il perno di fissaggio lacunoso della parte terminale. Misure: lungh. 2,9 cm; largh. 1,6 cm. N. inventario: I.G. 271980.
9) Placca. Ferro, bronzo. Lacunosa di una borchia (fig. 17).Placca di forma irregolarmente trapezoidale e con sezione emi-sferica molto schiacciata. Restringimento nella parte centrale ed estremità di minori dimensioni terminante con due protomi arcuate rivolte verso l’esterno. Sulla parte a vista presenza di due borchie (originariamente tre) in bronzo con capocchia emisferica schiacciata; della terza borchia resta l’impronta sulla parte in ferro. Misure: lungh. 5,8 cm; largh. 3 cm. N. inventario: I.G. 271981.
10) Placca. Ferro, materiale organico. (fig. 18).Placca di forma irregolarmente triangolare a sezione rettango-lare con un foro passante lungo uno dei bordi per il passaggio di un perno. Su ambedue i lati presenza di materiale organico, in un caso di tessuto di lana, nell’altro forse di cuoio. Misure: lungh. 7,1 cm; largh. 3,6 cm. N. inventario: I.G. 271982.
11) Due placchette circolari con anello. Bronzo. Lacunose (figg. 19-20).Due placchette circolari in lamina ripiegata. Quella meglio conservata presenta un anellino inserito nell’occhiello e un chiodino di fissaggio a testa emisferica. Il secondo elemento è lacunoso dell’anello e della testa del chiodino. Misure: lun-gh. 2,1 cm e 1,5 cm; largh. 1,3 e 1,1 cm. N. inventario: I.G. 271984-271985.
12) Acciarino. Ferro. Lacunoso della parte superiore e delle estremità laterali (fig. 21).Placca di forma irregolarmente pentagonale a sezione trapezoidale. Nella parte superiore presenza di un foro passante all’interno del quale è un chiodino con capocchia irregolarmente sferica che trattiene da una parte e dall’altra due piccole placchette lacunose di forma irregolarmente ret-tangolare. Misure: lungh. 6,1 cm; largh. 2,7 cm; spessore 1 cm. N. inventario: I.G. 271978.
13) Anello di fibbia. Ferro, bronzo. (fig. 22).Anello in ferro di forma ovale e sezione circolare. Piccolo e sottile ardiglione diritto in bronzo, leggermente arcuato al-l’estremità. Misure: lungh. 2,6 cm; largh. 1,6 cm. N. inventario: I.G. 271977.
14) Coltello. Ferro. (fig. 23).Coltello con codolo a sezione rettangolare con tracce di materiale organico relativo all’impugnatura. Lama a sezione triangolare. Misure: lungh. 9 cm; largh. 1,9 cm. N. inventario: I.G. 271964.
15) Pinzetta. Bronzo. Lacunosa lungo i bordi, con parziali integrazioni (fig. 24).Pinzetta costituita da una fascetta a sezione rettangolare con estremità di forma trapezoidali. Priva di decorazioni. Misure: lungh. 7,9 cm; largh. 1,3 cm. N. inventario: I.G. 271983.
figg. 8-14 – Arzignano, via Canove, elementi di corredo. 8. Spada; 9. Punte di freccia; 10. Punta di freccia; 11-12. Guarnizioni delle scarpe; 13. Spada corta; 14. Frammento di faretra (?). ASAV, disegni di Silvia Tinazzo.
8
14
10
9
11 12
13
b b
aa
436
NOTE E DISCUSSIONI
figg. 15-25 – Arzignano, via Canove, elementi di corredo. 15. Anello di fibbia; 16. Ardiglione; 17. Placca; 18. Placca; 19-20. Ösenringe; 21-22. Acciarino; 23. Coltello; 24. Pinzette; 25. Elemento in ferro. ASAV, disegni di Silvia Tinazzo.
23
18
17
20
16
19
15
25
21
24
22
437
NOTE E DISCUSSIONI
6. ELEMENTI DI CORREDO, ANALISI TIPOLOGICA
6.1 Armi
6.1.1 SpadaLa spada di Arzignano (fig. 8) raggiunge nell’insieme
102 cm di lunghezza a fronte di una lama particolarmen-te lunga (91 cm) e stretta (4,8 cm). Quest’ultima, non damaschinata, così come evidenziato dalle analisi radio-grafiche, ha una sezione lenticolare appena appiattita, lati paralleli con breve estremità appuntita e un lungo codolo a sezione rettangolare di forma trapezoidale. Al-tro elemento distintivo è rappresentato dall’elsa massiccia in ferro (Parierstange), a sezione rettangolare e di forma romboidale, inserita nel codolo tramite un foro passante. La lama era probabilmente inserita in un fodero ligneo con alcune componenti metalliche applicate all’imbocca-tura e alla base; più dubbia è invece la posizione di alcune fascette laterali, in origine probabilmente posizionate nella parte mediana o superiore del fodero4.
Da un punto di vista tipologico, la spada rientra in un gruppo di materiali la cui prima attestazione in Europa occidentale risale al 1932 quando nel quartiere di Wien-Leopoldau furono casualmente scoperte una sepoltura e due depositi votivi che restituirono, insieme ad altri oggetti, tre spade tipologicamente affini all’esemplare di Arzignano (fig. 26). Già allora, nella pubblicazione di alcuni anni più tarda (1936), fu proposta da Beninger una datazione nell’ambito del V secolo e ritenuta verosimile l’attribuzione ad un contesto culturale germanico5. Suc-cessivamente un primo inquadramento tipologico si ebbe da parte di J. Werner nell’opera Beiträge zur Archäologie des Attila Reiches (1956), nella quale i manufatti di Vienna furono collegati a rinvenimenti simili dell’Europa orientale, a loro volta attribuiti al gruppo misto di po-polazioni riconducibili alla cosiddetta “confederazione unna”. Nel lavoro del Werner era inoltre affrontato il problema dell’origine delle spade con elsa romboidale massiccia in ferro che, sulla base di confronti soprattutto iconografici, veniva ricondotta a prototipi persiani6.
In tempi relativamente recenti l’accresciuto numero di reperti, rinvenuti in occidente ma anche nei territori dell’Europa orientale compresa l’ex Unione Sovietica, ha consentito agli studiosi di riconsiderare il tema di queste spade spesso indicate come di tipo “unno”. Comune deno-minatore di questi lavori distribuiti nell’arco degli ultimi trent’anni7 è l’averne riconosciuto in modo quasi unanime
la matrice orientale, ribadendo l’ipotesi di Werner che il tipo fosse caratteristico dei cavalieri nomadi delle steppe euro-asiatiche, ovvero dell’area compresa tra i territori a nord del Mar Nero e il Caucaso settentrionale antica-mente abitata da stirpi quali gli Unni, i Goti Tetrasciti, i Sarmato-Alani e gli Akzari8. Ugualmente condivisa è l’idea che queste spade, definitivamente attestate in area pontica entro l’ultimo venticinquennio del IV secolo, nell’Europa orientale-danubiana e occidentale furono contemporanee e probabilmente conseguenti alla costituzione dell’impero unno nel secondo quarto-secondo terzo del V secolo.
Non risolta resta invece per ora la questione dell’origi-ne. Anche se alla luce di alcuni ritrovamenti complessiva-mente distribuiti tra I e IV secolo d.C. sembra verosimile la proposta che il tipo si fosse sviluppato nella medesima area eurasiatica o pontica dove sono attestate le spade di fine IV-V secolo9, la mancanza di dati archeologici soddisfacen-ti non esclude infatti, per ora, una derivazione da prototipi persiani, già a suo tempo proposta da Werner, a cui avreb-be fatto seguito, in un rapporto incrociato, un’influenza esercitata dalle manifatture tardo romane, in particolare sugli esemplari con elsa decorata a cloisonné noti per lo più a nord del Mar Nero e per questo definiti “di tipo pontico”10. Per quanto concerne l’elsa massiccia in ferro altrettanto suggestiva è l’ipotesi di una derivazione o per lo meno di un’influenza esercitata dalle produzioni cinesi centro-asiatiche di II secolo a.C.-II secolo d.C., in merito alle quali resta comunque da chiarire l’eventuale rapporto con le manifatture persiane11. Un ulteriore spunto è infine in alcuni lavori di Kazanski; secondo questo studioso la produzione di spade con elsa massiccia in ferro potrebbe essere infatti stata au moins en partie, dans différent ate-liers du monde méditerranéen, aussi bien à l’Ovest qu’à l’Est12; questa affermazione apre scenari complessi sulle problematiche e sull’articolazione delle produzioni tar-doantiche di spade, che appaiono tuttavia non risolvibili con i dati archeologici attualmente a disposizione.
Procedendo ad un’analisi più di dettaglio l’esemplare di Arzignano è attribuibile, nell’ambito delle spade già definite “di tipo unno” al cosiddetto tipo “asiatico” di Menghin13, in cui il termine “asiatico” non ha comunque un’accezione geografica ma allude, piuttosto, in senso lato, all’origine dei proprietari14. Dal punto di vista terminologico tale definizione sostanzialmente equivale al tipo “europeo orientale” proposto da Anke15. Indipen-dentemente da come la si voglia etichettare, si tratta di una spada i cui elementi distintivi sono costituiti dalle dimensioni considerevoli (lunghezza media in genere su-periore al metro), dalla lama lunga e stretta e dall’elsa in ferro, massiccia e di forma romboidale con una larghezza generalmente doppia rispetto a quella della lama. Il tipo,
4 Tale ipotesi deriva dal fatto che le fascette laterali furono recupe-rate nel terreno franato alla base della sezione creata dalla ruspa. In sede di restauro le fascette sono state posizionate nella parte terminale della lama, ma la posizione è ipotetica.
5 Beninger 1936. L’edizione critica più recente del ritrovamento di Wien-Leopoldau è in Friesinger 1984 (con bibliografia precedente). I materiali, molto noti, sono stati successivamente analizzati e riproposti, in più sedi (tra cui Tejral 1988, p. 283; Kazanski 1999, p. 299; Tejral 2002a, pp. 513-514; Tejral 2007a, pp. 98-99), compresi alcuni cata-loghi di mostre (Germanen, Hunnen und Awaren, pp. 182-183, Attila und die Hunnen 2007, pp. 182-183). Vista l’ampiezza, la bibliografia citata è da considerarsi indicativa.
6 Werner 1956, pp. 38 segg.7 Szameit 1984, pp. 136-150, Menghin 1994-95; Anke 1998, I,
pp. 73-85; Miks 2007, pp. 133-134. Si veda inoltre anche Bóna 1991; Tejral 2007a, pp. 92-96; Bierbrauer 2008, pp. 39-41.
8 Sulle popolazioni insediate tra Mar Nero e Mar Caspio Bier-brauer 2008.
9 Anke 1998, 1, pp. 73-74.10 Sul tipo “pontico” v. infra.11 Miks 2007, pp. 133-134 e 196-199. Cfr. inoltre Anke 1998, 1,
p. 75 nota 424.12 Kazanski 1999, pp. 295-298.13 Menghin 1994-95, pp. 165-175.14 Al riguardo si vedano le osservazioni di Miks 2007, p. 106 e le
critiche di Anke 1998, 1, p. 76, nota 427.15 Anke 1998, 1, pp. 79-83.
438
figg. 26-33 – Spade di tipo asiatico. 26. Wien-Leopoldau, deposito 2. Particolare dell’impugnatura; 27-29. Spada e particolari dell’impugnatura e del fodero di Szirmabesenyo; 30-31. Spada e particolari dell’impugnatura di Tarnaméra; 32-33. Spada e
particolari della decorazione del fodero di Jakusowice (scale diverse). Da Tejral 2007.
31
28
3230
26
27
29
33
439
NOTE E DISCUSSIONI
sostanzialmente databile nelle fasi D2 e D2/D3 (secondo terzo del V secolo) o, tutt’al più nelle prima metà del V secolo16, è caratteristico di contesti, per lo più sepolture ma anche depositi votivi, riferibili agli Unni o a cavalieri entrati in diretto contatto con questi ultimi e in quest’ul-timo caso riconducibili, quando rinvenuti all’esterno del limes, alla cosiddetta “confederazione unna”17. In Europa tra le spade di tipo “asiatico” o “europeo orientale” rientrano quelle sopra citate di Wien-Leopoldau e altri esemplari scoperti tra la Bassa Austria e l’Ungheria, oltre ad alcuni materiali rinvenuti più a nord (Jakusoswice in Polonia) (fig. 32-33) o ad occidente (Digione in Francia, Beja in Portogallo)18. Un certo altro numero è inoltre noto dai territori pontici e a nord del Caucaso. Nel complesso il numero è comunque relativamente esiguo e i siti di provenienza superano appena con l’esemplare di Arzignano, la trentina di unità (fig. 34)19.
Le spade di tipo “asiatico” si affiancavano a quelle di tipo “pontico”, simili per dimensioni e per la decorazione metallica di alcuni foderi ma differenziate per tecnica di costruzione e decorazione dell’elsa (non massiccia, molto più alta e con cloisonné policromo)20; questo ultimo tipo di spade, da parata e ritenuto da alcuni autori di produ-
zione “bizantina”, appare più di frequente nei territori a nord e a est del mar Nero e secondo Menghin sarebbe principalmente riferibile a guerrieri alani21. In ogni caso è probabile, vista la somiglianza delle lame, che i due tipi, “pontico” e “asiatico”, avessero un’origine comune22.
6.1.2 Fodero della spadaRelativamente al fodero, probabilmente in legno23, la
particolarità maggiore è costituita dalla presenza di alcune guarnizioni metalliche, il cui numero era forse originaria-mente più elevato. L’unica guarnizione integra è costituita da una semplice fascetta in lamina di bronzo, scanalata, che decorava la parte superiore del fodero. Parziali sono anche i dati relativi al puntale, la cui forma conferiva un profilo rettangolare all’estremità del fodero.
Il puntale in ferro, lacunoso e in due frammenti non ricomponibili, era costituito in origine da una sorta di capsula con una base di forma ovale e pareti lisce verticali probabilmente costituite da un’unica fascetta rettangolare. Su uno dei lati conservati sono osservabili quattro chiodini bronzei a testa leggermente schiacciata, la cui funzione, oltre che decorativa, doveva essere fun-zionale al fissaggio alla parte lignea. La base inferiore è decorata da un bottone in ferro a testa quasi sferica, al quale faceva probabilmente pendant un secondo ele-mento, non conservato, situato all’estremità opposta; problematica è invece la presenza di un terzo bottone intermedio, compreso tra i due più esterni24. Il puntale
16 Menghin 1994-95, p. 185 (fasi D2 e D2/D3) e Miks 2007, p. 106.
17 Menghin 1994-95, pp. 165-175 e 190-191. L’opinione è sostan-zialmente condivisa da Anke 1998, 1, p. 82 e Miks 2007 p. 134. Sulla “confederazione unna” e i suoi risvolti archeologici Tejral 2007a, pp. 72-96; Bierbrauer 2008, pp. 36-38 (con bibliografia precedente); incisive sintesi sono inoltre in Bierbrauer 2007a e Tejral 2007c.
18 Menghin 1994-95, p. 184, fig. 42; Bierbrauer 2008, p. 40 fig. 3.
19 Anke 1998, 1, p. 205, lista V.120 Eccezionalmente una decorazione con cloisonné, seppure più
semplice, poteva essere presente anche sull’elsa massiccia di spade di tipo asiatico come testimoniano gli esemplari di Beja in Portogallo (Pinar, Ripoll 2007, pp. 79-80) e Mokraja Balka, tomba 123 nel Caucaso settentrionale (Kazanski 1999, p. 296, fig. 2).
21 Menghin 1994-95, pp. 176-186. Sul tipo anche Kazanski 1991, pp. 128-130; Miks 2007, pp. 191-195; Bierbrauer 2008 p. 41.
22 L’opinione è condivisa da Bierbrauer 2008, p. 41.23 Non è stato possibile in questa sede, poter disporre dei dati
paleobotanici sulle componenti organiche della spada, relative a impugnatura e fodero.
24 Sulla parte conservata, accanto al bottone rimasto, è infatti ancora visibile al centro del fodero l’impronta di un bottone (non conservato) situato tra i due bottoni (di cui uno mancante) più esterni.
fig. 34 – Carta di distribuzione delle spade di tipo asiatico. Rielaborata da Anke 1998.
440
NOTE E DISCUSSIONI
fig. 35 – Puntale di tipo Gundremmingen. Da Miks 2007.
doveva raggiungere un’altezza minima di tre centimetri, pari all’altezza massima dei frammenti conservati; non è escluso che potesse essere decorato sulla parte a vista da altri chiodini in bronzo. Problematico resta il rapporto con le tre fascette in ferro, probabilmente relative alla decorazione laterale del fodero, rinvenute nella terra franata alla base della sezione provocata dalla ruspa. Le condizioni di rinvenimento non consentono infatti di risalire alla posizione originaria anche se appare verosi-mile un’applicazione nella parte superiore o centrale della lama. Pertinente alla decorazione dell’imboccatura del fodero era infine la sopra citata sottile fascetta bronzea solcata da scanalature orizzontali.
Il puntale del fodero della spada di Arzignano è riferibile al tipo Gundremmingen25, o secondo una defini-zione più recente “Gundremmingen-Jakuszowice”26 che, seppure non molto frequente, è comunque attestato con un certo numero di esemplari in associazione con spade di tipo “asiatico” e “pontico”. Come già indicato da altri autori la prima attestazione del tipo è iconografica ed è costituita dal gruppo in porfido dei Tetrarchi (inizi IV secolo) presso l’ingresso di Palazzo Ducale a Venezia. La documentazione archeologica è tuttavia più tarda e pre-valentemente compresa tra l’ultimo trentennio del IV e la prima metà-secondo trentennio del V secolo. Come per le spade di tipo “asiatico” anche per questo manufatto è stata proposta un origine orientale. Puntali di forma ret-tangolare con tre bottoni all’estremità erano infatti stati introdotti nell’equipaggiamento militare romano già nel III secolo, forse in seguito ai contatti con i Parti e quindi con i Persiani, andando a sostituire i tipi di età precedente con puntale circolare. Dal punto di vista morfologico il tipo “Gundremmingen”, in ferro, bronzo o argento, era costituito, come nel caso di Arzignano, da una capsula con base ovale piatta a cui era fissata, eventualmente con l’ausilio di chiodini, una sottile lamina rettangolare; tipici anche se non sempre presenti erano inoltre tre bottoni con testa cilindrica, a forma di fungo o di sfera (talvolta ridotti a due) applicati sul fondo della capsula27.
Secondo le ultime proposte proprio la presenza o meno dei chiodini potrebbe rivelare la divisione in due sottogruppi, senza che sia tuttavia possibile escluderne
rapporti e interferenze reciproche. Un primo gruppo (“Gundremmingen”) (fig. 35), caratterizzato dai chio-dini sul fondo e da un’altezza maggiore della fascetta, sarebbe stato tipico dei territori occidentali e, di fatto, l’evoluzione più diretta dei prototipi tardoromani più antichi; un secondo (“Jakuszowice”) (fig. 33), contrad-distinto da una fascetta molto più bassa priva di chiodini sul fondo, sarebbe invece stato prevalente nei territori orientali oltre il limes, in particolare nelle aree influenzate dalla cultura unna. Ambedue i puntali potevano essere inoltre associati a fascette metalliche applicate lungo i lati e all’imboccatura del fodero.
Alla luce di queste considerazioni il puntale di Arzi-gnano sembrerebbe configurarsi come una variante poco rifinita del sottotipo Gundremmingen o, forse piuttosto, come una forma intermedia tra i due sottogruppi Gun-dremmingen e Jakusowice, analogamente a quanto è stato proposto per quello ungherese di Szirmabesenyo (tardo IV-prima metà V secolo), caratterizzato da due bottoni sul fondo e da lunghe fascette lungo i lati del fodero (fig. 27-29)28. In particolare, per quanto riguar-da l’esemplare vicentino, indicatori significativi di una diversità rispetto ai manufatti più occidentali sembrano essere i chiodini in bronzo applicati all’esterno della lamina probabilmente con una duplice funzione deco-rativa e di fissaggio alla parte lignea. Per risolvere la questione manca purtroppo, come già sopra ricordato, un elemento determinante, ovvero la misura dell’altezza originaria della fascetta metallica che costituiva i lati della capsula.
Relativamente alla decorazione in lamina bronzea scanalata all’imboccatura del fodero questa non sembra invece riferibile ad una tipologia e cronologia partico-lari29. Tra i confronti raccolti il più stringente è quello offerto dalla spada di Tarnaméra (Ungheria), datata al 440-460/70 (figg. 30-31), il cui fodero è il più simile a quello di Arzignano. All’imboccatura è infatti una la-mina scanalata in bronzo mentre buona parte dei lati è decorata da fascette laterali bronzee30. Colpisce inoltre la somiglianza tra l’esemplare di Arzignano (in bronzo) e quello del deposito 2 di Wien-Lepoldau (in argento), caratterizzato inoltre da un motivo cordonato (fig. 26)31. Dalla medesima località austriaca è noto, dal deposito 1, anche un frammento di lamina scanalata in bronzo con resti di cuoio che, per quanto in via ipotetica, è stata messa in relazione con la guarnizione del fodero32.
Le fascette laterali, come abbiamo visto non più po-sizionabili con precisione, trovano confronti con alcuni elementi associati a spade di tipo “asiatico” rinvenuti in Europa orientale e Crimea. Oltre al sopra citato fodero di Tarnaméra (Ungheria) (figg. 30-31), con lunghe fa-scette metalliche in bronzo con terminazione superiore configurata a testa di rapace33, possono essere ricordati
28 Miks 2007, p. 411.29 Miks 2007, p. 386.30 Bóna, Nagy 2002, tav. 57, 1 e p. 241. Il puntale, in lamina
di bronzo, è invece del tipo “Jakuszowice”. Per la datazione Tejral 2007a, pp. 92-96.
31 Friesinger 1984, p. 131 e fig. 13, 8.32 Friesinger 1984, p. 130; Szameit 1984, p. 136.33 Bóna, Nagy, tav. 57, 1 e p. 241.
25 Werner 1966. Sulle modalità di costruzione del puntale Gilles 1979, fig. 1.
26 Miks 2007, pp. 408-411.27 Miks 2007, p. 408.
441
NOTE E DISCUSSIONI
l’esemplare di Abrau-Djurso (tomba 300) in Crimea34 (con testa di rapace all’estremità) e le guarnizioni laterali della spada di tipo “pontico” di Altlussheim35. Si tratta di confronti non puntuali, fatto questo che non deve essere tuttavia sopravvalutato dal momento che le decorazioni di foderi finora note, per lo più attestate nei territori a nord del Mar Nero in spade di tipo “pontico”, sono tutte diverse le une dalle altre in quanto probabilmente prodotte non in serie.
Alla luce di queste considerazioni (differenza rispet-to al tipo Gundremmingen classico, fascette laterali confrontabili con manufatti analoghi rinvenuti in aree orientali) appare pertanto plausibile attribuire il fodero di Arzignano ad un ambito culturale e probabilmente anche artigianale ubicato oltre l’antico limes pannonico.
6.1.3) Spada corta a due tagliOltre alla spada di tipo “asiatico” il cavaliere di Arzi-
gnano aveva una seconda arma costituita da una spada corta a due tagli (fig. 13), lunga e stretta, rinvenuta nella terra crollata alla base della sezione e quindi probabil-mente deposta nella zona del bacino o delle spalle del defunto. Il manufatto misura 36 cm di lunghezza (ma poteva essere forse un po’ più lunga dal momento che si tratta di due frammenti ricomposti) e ha una lama a sezione lenticolare schiacciata larga 3,1 cm.
Diversamente dalle spade di tipo “unno” e “asiatico” non esiste una bibliografia specifica sulle spade corte a due tagli36. Benché da alcuni studiosi esse siano tipologi-camente assimilate agli scramasax con lama stretta di V secolo37, in questa sede, si è tuttavia ritenuto opportuno differenziare i due tipi nel tentativo di approfondire nel modo più esaustivo possibile la questione dell’ambito culturale di appartenenza del guerriero di Arzignano.
Lame corte a due tagli, anche se con una forma diversa da quella dell’esemplare qui esaminato, erano ben conosciute nel mondo tardoantico, sia nell’ambito dell’esercito tardoromano, sia nei territori più orientali in particolare nelle zone danubiane e pontiche abitate dalle tribù sarmate. Per quanto concerne l’occidente sono finora noti materiali di età imperiale (fino alla metà del III secolo) con lame che richiamano quelle delle spade38. Per l’oriente possono essere invece menzionati i cosid-detti pugnali di tipo sarmatico la cui versione più tarda
(tipo Micia) (fig. 36) era contraddistinta da una forma piuttosto tozza e da una caratteristica impugnatura cruciforme39. Quest’ultima versione era prevalentemente diffusa tra il I e il IV secolo d.C. nella zona compresa tra il basso Dnjepr e la Crimea40 oltre che in area bal-canico-danubiana41. Alcune attestazioni sono tuttavia leggermente più tarde e arrivano alla prima metà/decenni centrali del V secolo, così come testimoniato da alcune sepolture della Crimea (necropoli di Djurso)42 – dalla maggior parte degli autori riferite a Germani Orientali (Goti Tetrasciti)43 – e da alcune tombe ungheresi riferibili al cosiddetto Csóngrad-Gruppe44.
A fronte della penuria di dati attualmente disponibili relativamente alle due entità militari più importanti del-l’età tardoantica (l’esercito romano e quello persiano), un’ipotesi sull’origine delle spade corte di V secolo si deve a Kazanski secondo il quale alcune raffigurazioni iconografiche persiane di IV secolo (quindi anteriori alle attestazioni archeologiche finora disponibili) potrebbero essere interpretabili come spade corte a due tagli, in effetti archeologicamente documentate in oriente (Abkhazia, Azerbaigian e Afghanistan) tra V e VI secolo45. Sempre allo stesso studioso si deve inoltre l’ipotesi di una pro-duzione orientale/bizantina di spade corte nel corso del V secolo. Tale proposta è stata in particolare avanzata sulla base di un esemplare rinvenuto a Zaragij (Russia) (fig. 37), in area nord-caucasica, nella sepoltura a camera di un guerriero, verosimilmente un capo alano46. Grazie alla decorazione a cloisonné del fodero del puntale, la spada è stata infatti considerata una produzione orien-tale/bizantina realizzata intorno o poco dopo la metà del V secolo47. A sostegno di questa ipotesi può essere d’altro canto citata la proposta di Vanessa Sopault che, sulle sponde settentrionali e orientali del Mar Nero (Abkahzia e Regno Cimmerico), le aristocrazie locali (come sopra ricordato in Abkazia dotate anche di spade corte) avessero significativamente modificato nel corso del IV-V secolo il loro equipaggiamento militare in se-guito all’influenza esercitata dall’esercito tardoromano48.
34 Dmitriev 1979, p. 224, fig. 7, 1-2; Bóna 1991, p. 82, fig. 30/1.
35 Menghin 1994/95, p. 176.36 Per i territori occidentali un cenno è in Bierbrauer 2007a, p. 102;
mentre per quelli orientali una breve nota è in Kasanski, Mastykova 2007, p. 27. Un breve inciso è anche in Anke 1998, 1, pp. 93 in cui si evidenza la presenza nei territori delle steppe dall’età scita fino a quella sarmatica. Si vedano inoltre Voronov, Senkao 1982, pp. 130-132; Sopault 1995, pp. 228-229.
37 Cižmár, Tejral 2002, p. 107 (con bibliografia precedente). In questo caso i due autori elencano nel gruppo degli scaramasax anche alcune spade corte a due tagli senza distinguerle tipologicamente. Sugli scramasax di V secolo Anke 1998, 1, pp. 139 e 144; Wernard 1998, pp. 773-774; Tejral 2002a, pp. 504-506; Cižmár, Tejral 2002, pp. 104-114; Tejral 2007a, pp. 82-86, 92-96. Sull’origine orientale dell’arma e la sua diffusione in occidente Kazanski 1991, pp. 132-134, Wernard 1998, p. 773. Per la presenza in sepolture germaniche occidentali Quast 1999.
38 Miks 2007, pp. 71-74.
39 Per la definizione Harhoiu 1988. Cfr. anche Anke 1998, 1, p. 93.
40 Simonenko 2001, pp. 217-248.41 Per esempi in area romena in sepolture di IV secolo Diaconu
et al. 1977, p. 218, fig. 24, 2; Troiani, Zorzoliu 1983, p. 217, fig. 5, 1; Harhoiu 1988.
42 Kazanski 2002, fig. 3, 11; 4, 7; 5, 8.43 Dmitrijev 1979; Kazanski 2002; Mastykova 2002; Bier-
brauer 2008, pp. 45-46; isolata e fortemente criticata resta invece per ora l’ipotesi dell’attribuzione ad un gruppo di Alani (Bóna 1991, pp. 246-247).
44 Párducz 1959-60, pp. 367-368; Germanen Hunnen und Awaren 1987, p. 146 (Csongrád, tomba 136). Sullo “Csongrád-Gruppe” Tejral 2007a, pp. 62-63 e 85-86.
45 Kazanski 1988, pp. 22-23.46 L’or des princes barbares 2000, pp. 162-163.47 Kazanski, Mastykova, Périn 2002, pp. 166-167 nel quale
la decorazione del puntale è considerata un prototipo cronologica-mente anteriore alla decorazione del fodero della spada della tomba di Childerico. Una datazione sostanzialmente analoga è proposta da Kazanski 2002, p. 145 (secondo terzo del V secolo); più tarda è invece la datazione proposta in L’or des princes barbares 2000, pp. 162-163 (seconda metà del V secolo).
48 Sopault 1995.
442
NOTE E DISCUSSIONI
figg. 36-37 – Spade corte. 36. Spada corta di tipo “Micia” da Csongrad (da Germanen, Hunnen und Awaren 1987); 37. Spada corta da Zaragij (da L’or des princes barbares 2000).
Un ulteriore spunto di riflessione in relazione all’area di origine delle spade corte di V secolo, può essere inoltre costituito dall’origine quasi certamente greca del cosid-detto parazonium, un’arma corta a due tagli portata sul fianco sinistro, caratterizzata da una testa a forma di rapace, attestata tra alto e basso impero e a quanto pare esclusiva di generali, imperatori o divinità49. Una delle raffigurazioni più note riferita a questo tipo di arma è offerta dal gruppo dei quattro tetrarchi all’in-gresso di Palazzo Ducale a Venezia. A prescindere dalla presenza dell’impugnatura a forma di rapace e del valore altamente simbolico dell’arma, significativa appare la conformazione dell’arma come una spada corta a due tagli la cui fattura doveva essere ben nota ai fabbri delle officine statali tardoantiche.
Nelle sepolture dei cavalieri nomadi orientali la spada corta era comunque poco frequente mentre era più diffu-so, anche in associazione con le spade di tipo “asiatico” o di tipo “pontico”, il già citato scramasax con lama stretta (Schmalsax). Spade con una lama corta e stretta
a due tagli, confrontabili con quella di Arzignano, erano invece decisamente più rare. La ricognizione effettuata in occasione del presente studio ha tuttavia consentito di individuarne un certo numero, la cui area di diffusione è risultata molto ampia a fronte di un numero percentual-mente basso di ritrovamenti caratterizzati da un’elevata variabilità morfologica (fig. 39)50.
La maggiore concentrazione è stata rilevata nelle aree orientali, in particolare nei territori pontici a nord e nord-est del Mar Nero abitate in parte da Goti Tetra-sciti, in parte da popolazioni locali (Abasgi, Apsili ecc.)51 e, a partire dal V secolo, anche da gruppi unni. Alcune testimonianze sono inoltre state accertate nei territori danubiani occupati dai Germani orientali. Più spora-dica è risultata la presenza nel Caucaso settentrionale in cui accanto alle popolazioni locali erano stanziati gruppi di Alani. Attualmente l’esemplare di Arzignano sembrerebbe pertanto essere, dopo quello di Flonheim (Germania), il secondo esemplare più occidentale finora noto. Cronologicamente l’orizzonte dei reperti censiti è compreso nell’ambito del V secolo, con una maggiore concentrazione a partire dal 450 anche se va segnalata, in area ungherese, la presenza di due esemplari, purtroppo
49 Sul parazonium Feugère 2002, pp. 160-161; Miks 2007, pp. 208-211.
50 1) Fedorowka (Kazachistan), lungh. 60 cm, largh. 4,5. Datata all’ultimo quarto del IV-prima metà del V secolo. Sepoltura attribuita ad un capo della confederazione unna (Bóna 1991, p. 119, fig. 46 e p. 257, n. 46. 2) Zaragij, tomba 118 (Russia, repubblica della Circassia, Caucaso del Nord), lungh. 37,1 cm; largh. lama 3,4 cm. Metà/se-condo terzo del V secolo. Sepoltura attribuita ad un Alano (L’or des princes barbares 2000, pp. 162-163; Kazanski, Mastykova, Périn 2002, pp. 166-167). 3) Macesta (Russia, territorio a nord del Mar Nero), lungh. 40 cm, largh. lama 2 cm. Fine IV-V secolo. Sepoltura attribuita ad un individuo della popolazione locale (Soupault 1995, tav. 8, riquadro 9-11). 4) Tsibilium tomba 76 (Georgia, repubblica dell’Abkhazia, territorio a nord-est del Mar Nero), lungh. 33,3 cm, largh. lama 2 cm. Fine IV-V secolo. Sepoltura attribuita ad un indi-viduo della popolazione locale (apsile?) (Voronov, Senkao 1982 tav. 11, 27; Soupault 1995, tav. 7, 9; cfr. inoltre anche Bierbrauer 2008, p. 60). 5) Chapka Abgedzrahu, tomba 44 (Georgia, repubblica dell’Abkhazia, territorio a nord-est del Mar Nero), senza indicazione delle misure. Fine IV-V secolo. Sepoltura attribuita ad un individuo della popolazione locale (apsile?). (Soupault 1995, tav. 8, riquadro 9-11). 6) Abrau-Djurso tomba 408, femminile (sic!) (Russia, territorio a nord-est del mar Nero), senza indicazione delle misure. Ultimo terzo del V-primo terzo del VI secolo. Sepoltura attribuita ad una Germana orientale (Kazanski 2002, pp. 150-151 e fig. 10, 21; Mastykova 2002, p. 232 fig. 6, 21). 7) Citarenko (Ucraina, repubblica di Crimea), in due frammenti, largh. lama 3 cm. Prima metà/metà del V secolo. Sepoltura attribuita a un unno altzagiro o utriguro (Ajbabin 1995, pp. 207-208; p. 215, fig. 5, 12). 8) Târgsoru Vechi (Romania), lungh. 45,5 cm, largh. lama 4,5 cm. Fine IV-inizi V secolo. Sepoltura attribuita ad un Alano (Lichiardopol, Ciuperca 2008, pp. 111-112) ma più probabilmente da ritenersi un individuo genericamente orientale. 9) Bistret (Romania), lungh. 40, largh. lama 4,5 cm. Seconda metà del V secolo. Sepoltura a attribuita ad un individuo di origine genericamente orientale (Marcu 1987, p. 188, fig. 3). 10) Flonheim (Germania) lungh. 52 cm, largh. lama 4,78 cm. Fine del V secolo. Sepoltura attribuita ad un guerriero franco (Miks 2007, p. 580, n. A 157, 2; tav. 149, A 157, 2, con bibliografia precedente). Meno puntualmente confrontabili sono altri due esemplari datati al V secolo dall’Abkhazia: Voronov, Senkao 1982, tav. 18, 3 e tav. 19, 1. È inoltre probabile che altri materiali provengano da territori a nord del Mar Nero (cfr. Soupault 1995, p. 244, tab. 2 di cui non è stato possibile verificare se il “gladio” indicato nelle sepolture di Tsibilium 10.4, Chaumianovka e Apouchta 2 corrisponde in realtà ad una spada corta). Come n. 11 può essere considerato quello di Arzignano.
51 Sulle aristocrazie pontiche e i loro continui rapporti politici e commerciali con il Mediterraneo bizantino Voronov 1995; Sopault 1995.
3736
443
NOTE E DISCUSSIONI
lacunosi e provenienti da vecchi rinvenimenti sconvolti, attribuiti ad un orizzonte gepide di pieno VI secolo52.
Un primo elemento di riflessione, già sopra ricordato, è costituito dalla sostanziale disomogeneità morfologica tra i vari manufatti, in cui soprattutto la lunghezza non sembra essere costante. Mentre gli esemplari di Zaragij, Macesta, Tsibilium, Bistret e Arzignano non superano i 40 cm, gli altri esemplari interi o comunque ricostruibili hanno misure comprese tra i 45 e 52 cm. Analogamente variabile è la larghezza, generalmente compresa tra i 3 e i 4,5 cm ma nei manufatti dalle coste del Mar Nero generalmente intorno ai 2 cm. Il confronto più puntuale per la spada corta di Arzignano sembrerebbe pertanto essere costituito dall’esemplare di Zaragij (fig. 37), come detto di supposta provenienza orientale/bizantina e datato, grazie alla decorazione a cloisonné del puntale, intorno o poco dopo la metà del V secolo.
Il secondo dato significativo è la variabilità degli am-biti geografici e culturali di provenienza che, a seconda dei casi, sono stati interpretati come germanico-orientali (Goti Tetrasciti, Germani orientali di area danubiana, Gepidi – questi ultimi in un orizzonte già di VI secolo), indigeni di area pontica, alani, unni o infine, in Europa occidentale, franchi.
La convergenza di due distinti fattori quali l’ampia diffusione geografica in contesti culturali differenziati e la variabilità degli oggetti pur accomunati da caratteristiche comuni induce quindi a pensare che le spade corte potesse-ro davvero essere i prodotti di più laboratori di tradizione orientale/bizantina le cui manifatture erano destinate anche alle popolazioni germaniche e orientali che nel frattempo avevano a vario titolo instaurato rapporti militari ed eco-nomici con l’impero romano d’oriente. Tale è il caso delle aree pontiche, di cui si è già evidenziato lo stretto rapporto
con il Mediterraneo orientale ma anche delle aree franche occidentali, il cui contatto con Bizanzio dopo il 476 non fu più mediato dall’organizzazione politica e militare del-l’ormai disciolto impero romano d’Occidente. E a questo proposito significativo appare il fatto che in area franca era ubicata anche la sepoltura del guerriero di Flonheim nel cui corredo erano presenti, oltre alla spada corta, una spada da parata e una fibbia da cintura in schiuma marina di probabile produzione bizantina53.
Ritornando al caso specifico di Arzignano si ritiene quindi verosimile supporre un legame del cavaliere di Cava Poscola con forniture provenienti dal bacino del Mediterraneo orientale. Questa affermazione non risolve tuttavia il problema dell’origine del cavaliere e per quali vie egli fosse giunto in Italia nord-orientale, questione che verrà ripresa nel paragrafo conclusivo.
A margine di quanto detto non si esclude infine in via d’ipotesi, in parte sviluppando quanto proposto da Kazanski54 ma partendo da presupposti diversi55, che nel corso del V secolo, a prescindere dalla questione dell’ori-gine, potessero esserci delle contaminazioni reciproche tra produzioni di spade corte a due tagli e Schmalsax ad un solo taglio. Come è già stato rilevato, gli artigiani tardoantichi non disponevano infatti di modelli fissi per la realizzazione degli scramasax e godevano di una considerevole libertà nella costruzione dei medesimi56.
fig. 38 – Carta di distribuzione delle spade corte a due tagli di V secolo. Per le corrispondenze cfr. nota 50.
53 Böhme 1994, pp. 79-82. Per la segnalazione della spada di Flonheim e della sua eccezionalità nel panorama franco coevo, pur caratterizzato dalla presenza di scramasax a lama stretta, devo rin-graziare il dott. C. Miks del RGZM di Mainz.
54 Kazanski 1988, pp. 22-23 (in particolare nota 42); Kazanski 1991, pp. 132-133.
55 Lo studioso francese propende per un’origine bizantina degli scramasax soprattutto sulla base delle raffigurazioni iconografiche conservate e delle decorazioni a cloisonné di esemplari da parata (contra Quast 1999, pp. 116-117; Tejral 2002a, pp. 505-506). Le riflessioni proposte in questa sede scaturiscono invece dalle somiglianze, a volte piuttosto equivoche, tra misure e forme degli scramasax da una parte e delle coeve spade corte della seconda metà del V secolo dall’altra.
56 Anke 1998, 1, pp. 93 ss.
52 Si tratta delle spade corte da Tiszaroff-Tiszagyenda, largh. 3 cm, lunghezza non ricostruibile (Cseh et al. 2005, p. 38, nn. 5 e 7; tav. 43.5, 44.1) e da Szoreg-Teglagyár largh. 3,6 cm, lungh. non rico-struibile (Cseh et al. 2005, p. 120; tav. 45.1). che vanno pertanto ad aggiungersi a quelli sopra citati.
444
NOTE E DISCUSSIONI
fig. 39 – Tomba maschile di Aktobe II. Da Bóna 1991.
Un riscontro a questa situazione è offerto da alcuni ma-nufatti interpretati come scramasax ad un solo taglio ma in realtà, almeno a giudicare dai disegni pubblicati, più simili a spade corte. Tale è il caso di un esemplare pro-veniente dalla fortificazione tardoantica e altomedievale di Krivina (Iatrus) sul Danubio. In questo caso l’arma,
finora un unicum, presenta una lama inferiormente ricur-va e una sezione che, almeno stando ai disegni riprodotti, è difficile dire se è a uno o a due tagli57.
57 Gomolka-Fuchs 1999a, p. 515 e fig. 5, 7.
445
NOTE E DISCUSSIONI
6.1.4 Punte di freccia e frammento di faretra (?)Un terzo tipo di armi era costituito dalle frecce (fig. 9)
di cui ne furono rinvenuti, in prossimità della punta della spada, sette esemplari del tipo a tre alette insieme ad una cuspide a sezione triangolare con cannone circolare (fig. 10).
Il primo tipo (fig. 9) è caratterizzato da una forma in cui la larghezza maggiore è in corrispondenza della parte centrale della cuspide la cui lunghezza complessiva raggiunge mediamente, negli esemplari sufficientemente conservati, una lunghezza di circa 8 cm. La foggia risulta diffusa in Europa centro-occidentale già a partire dai primi secoli dopo Cristo58, in particolare nei castelli del limes dove vengono attribuite a soldati di origine orien-tale. Successivamente, nel corso del V secolo, è frequente la sua presenza in insediamenti con tracce di incendio considerati la conseguenza di attacchi Unni (Krvina-Iatrus, Carnuntum, Hrsusica ed altri). D’altro canto in alcuni insediamenti, soprattutto balcanici, la loro pre-senza è stata messa in relazione con lo stanziamento di contingenti militari, verosimilmente corpi di cavalleria, originari delle steppe. Nella maggior parte dei casi non è comunque possibile proporne una datazione circoscritta e il tipo è pertanto databile in generico IV-VI secolo59.
Più precisi sono invece i dati relativi alle sepolture con punte di freccia a tre alette. In questo caso le attestazioni sono relativamente numerose e distribuite in un vasto territorio compreso tra le aree pontiche a nord del mar Nero e la Francia; culturalmente sono riferite, per lo meno fino alla fine del V secolo, a guerrieri orientali o a individui in ogni caso entrati nella sfera di influenza unna60. Nel caso di Arzignano degno di nota è il numero complessivo (sette unità, più la punta isolata di tipo di-verso), relativamente elevato rispetto alle coeve sepolture di cavalieri orientali in cui il numero generalmente oscilla tra le due e le tre unità, con alcuni casi limitati ad una singola punta di freccia o, in alternativa, di quattro-sei manufatti61.
Non rientra invece tra i materiali generalmente at-testati nelle sepolture germaniche orientali di V secolo la cuspide a sezione triangolare con cannone circolare cavo (fig. 10), cui era probabilmente relativo anche un secondo frammento, interpretabile come l’esito dei pro-dotti di corrosione attorno all’asticciola di legno62. La forma e le dimensioni richiamano i missilia tardoromani caratterizzati da cannoni leggermente più lunghi63, fatto questo che fa propendere per un origine tardoromana del manufatto, diversa da quella delle altre cuspidi presenti nella tomba. Visto il rinvenimento nello stesso grumo di terra è probabile che la punta di freccia, non sappiamo se destinata ad un uso particolare, fosse stata inserita insie-
me alle altre punte nella faretra. L’associazione punte di freccia con cannone-punte di frecca a tre alette è inusuale nei corredi di cavalieri di V secolo; va tuttavia rilevato che le punte di freccia con cannone erano conosciute oltre il limes per lo meno in età tardoromana, così come dimostrano alcuni rinvenimenti di età tardo imperiale attribuibili all’orizzonte della cultura di Cerniachov64.
La forma arcuata della fascetta in ferro (fig. 14), costi-tuita da tre frammenti provenienti dalla terra franata alla base della sezione, fa supporre che il manufatto potesse far parte degli elementi metallici che tenevano insieme le diverse componenti della faretra. È ipotesi prevalente, suggerita dai ritrovamenti archeologici finora documen-tati, che tali contenitori fossero per lo più in materiale deperibile (cuoio) ragion per cui la loro presenza è quasi sempre dedotta a posteriori dalla posizione delle frecce all’interno della tomba65. Una delle poche eccezioni è costituita dalla sepoltura di Aktobe II (Kazachistan) (fig. 39), dove condizioni particolarmente favorevoli avevano consentito la conservazione, accanto a manufatti metal-lici, di frammenti della faretra e di recipienti in legno66.
6.2 Ösenringe
Nel terreno franato alla base della sezione erano due laminette semicircolari bronzee, una delle quali (e probabilmente in origine anche la seconda) completata da un piccolo anellino a sezione circolare con estremità progressivamente assottigliate (figg. 19-20). Materiali di questo tipo, che si trovano con dimensioni maggiori applicati anche alle cinture militari tardoantiche di IV-primi decenni del V secolo67, sono stati interpretati nelle sepolture dei cavalieri orientali come elementi relativi alla cintura e al sistema di sospensione della spada68, più ra-ramente di briglie69 o di semplici cinture70. In questo caso le dimensioni modeste (l’esemplare intero è intorno ai 2 cm) e lo spessore esiguo della lamina rendono verosimile un’appartenenza al sistema di sospensione della spada anche se la mancanza di dati sulla giacitura primaria all’interno della sepoltura (i due manufatti provengono dalla terra raccolta alla base della sezione creata dalla ruspa) non consente di escludere altre possibilità.
58 Punte di freccia a tre alette erano già note in occidente anche in epoca anteriore ma erano caratterizzate da minori dimensioni e da una foggia leggermente diversa (Zanier 1988, pp. 5-6).
59 Anke 1998, 1, pp. 66-67.60 Ibid., 1, pp. 68-73; Tejral 2002a, pp. 506-507. Cfr. inoltre Bóna
1991, pp. 167-170; Kazanski 1991, pp. 135-136.61 Tejral 2002a, p. 506.62 Il frammento (I.G. 271970) non è stato inserito nel catalogo e
nelle immagini al tratto.63 Herrmann 1969, p. 134, fig. 4. 12-14 (esemplari della metà del
III secolo da Quintana-Künzing).
64 Kokowski 1993, p. 337. La presenza di punte di freccia tardo-romane in contesti riferibili alla cultura di Cerniachov e di Wielbark confermerebbe inoltre l’ipotesi che l’arco si sarebbe diffuso presso le popolazioni stanziate oltre il limes grazie all’influenza esercitata dall’esercito romano, indipendentemente dai contatti di età successiva con gli Unni e le altre popolazioni delle steppe.
65 Moosbrugger-Leu 1970, p. 101; Böhme 1974, p. 11; Anke 1998, 1, p. 95; Tejral 2002a, p. 506. Un esempio di fascetta metallica in bronzo, relativa alla parte inferiore di una faretra, è noto da una tomba ungherese della prima età avara (fine VI sec.): Bóna 1979, p. 6, fig. 1, 21 e p. 7, fig. 3, 6.
66 Anke 1998, 2, p. 3 e tav. 124.67 Böhme 1974, pp. 162-163; Sommer 1984. Generalmente
gli esemplari presenti sulle cinture militari di IV-primi decenni del V secolo (per lo più in bronzo, talvolta in argento) presentano una decorazione delle superfici con cerchi incisi concentrici, occhi di dado e piccole tacchette lungo i bordi non presenti negli esemplari di una generazione più tardi.
68 Bakay 1978, p. 154; Bierbrauer 2008, tav. p. 40, fig. 4.69 Cfr. Akhmedov 2002, p. 21, fig. 6, 28.70 Gürçay Damm 1988, p. 102.
446
NOTE E DISCUSSIONI
Nei contesti germanico-orientali e pontici della prima metà o del terzo venticinquennio del V secolo sono noti confronti in oro, argento e bronzo. In Europa occidentale e orientale (Untersiebenbrunn, Pouan, Lébény, Kertsch etc.)71 le testimonianze più note sono costituite da manu-fatti in oro con inserti di almandini, forse da interpretarsi come imitazioni di prototipi mediterranei, analogamente a quanto ipotizzato per le fibbie di cintura e le fibbie delle scarpe da parata della prima metà del V secolo72. Meno frequenti sono invece gli esemplari in argento e in bronzo. Per quelli bronzei un confronto puntuale per i due manufatti di Arzignano è noto dalla tomba slovacca di Šarovce/Sáró-Makóczadomb da riferire ad un Ger-mano orientale73. Secondo Bóna i cosiddetti Ösenringe, indipendentemente dal materiale con cui erano realizzati, erano uno degli elementi distintivi del costume di età unna74. In realtà nelle aree oltre il limes, il loro rinve-nimento è documentato già nel corso del IV secolo75. Visti i contesti di rinvenimento, sono probabilmente da ascriversi al cosiddetto “complesso culturale germanico-orientale danubiano” (Tejral) o alla equivalente “koiné germanico-orientale” (Bierbrauer) (v. infra).
6.3 Placca
Dubbia è l’interpretazione della placca in ferro (fig. 17) di forma irregolarmente trapezoidale con due (in origine probabilmente tre) grosse borchie emisferiche schiacciate in bronzo e, su un lato, una terminazione a due elementi contrapposti, forse di ispirazione zoo-morfa. Dal punto di vista crono-tipologico un elemento diagnostico è costituito dalle borchie in bronzo, grosse e appiattite, che richiamano alcuni materiali ritenuti guarnizioni di cinture militari bizantine della prima metà/metà del V secolo76. Un altro elemento è costituito dalle due terminazioni contrapposte sul lato breve della placca confrontabili con alcune guarnizioni caratterizzate da una doppia estremità zoomorfa, un motivo quest’ul-timo attestato, in area romano-bizantina, durante buona parte dell’età tardoantica e altomedievale. Come esempi possono essere citati i puntali di cinture militari tardo-romane in bronzo di fine IV-inizi V secolo caratterizzati da una forma circolare e da due teste equine77; alcune
guarnizioni di cinture militari bizantine della prima metà/metà del V secolo prodotte quasi certamente nei ter-ritori dell’Impero romano d’Oriente78; le fibbie a placca triangolare con due estremità contrapposte provenienti da alcune sepolture di area pontica del secondo quarto/metà del V secolo attribuibili a defunte di etnia gota ma di manifattura probabilmente bizantina79; infine, per la metà-seconda metà del VI secolo, le fibbie a placca fissa “di tipo mediterraneo”, in argento o bronzo, caratteriz-zate all’estremità da due elementi curvilinei contrapposti talvolta chiaramente zoomorfi80.
I confronti raccolti sembrerebbero pertanto orientare verso manifatture di area romano-bizantina senza che ne sia tuttavia possibile circoscrivere ulteriormente l’ambito di produzione. Dal punto di vista funzionale il manufatto in questione potrebbe essere inoltre una controplacca81 o un puntale di cintura, senza che ve ne sia tuttavia un’effettiva conferma.
Problematico è il rapporto con un secondo frammento di lamina in ferro (fig. 18), sempre proveniente dalla terra franata alla base della sezione, caratterizzato su un lato da abbondanti tracce di tessuto, sull’altro da resti di materiale organico, forse cuoio. La forma richiama quella della placca con estremità contrapposte vista sopra anche se le dimensioni e la posizione di un foro lungo uno dei lati (relativo all’inserimento di una proba-bile borchia) non corrispondono. Sembrerebbe pertanto ipotizzabile un unico insieme costituito dai due distinti elementi ai quali possono essere forse aggiunti altri due frammenti (anello in ferro e ardiglione con doppio rebbio in bronzo v. infra) recuperati alla base della sezione. Tale ipotesi è oltre modo suggestiva, soprattutto in relazione all’evoluzione delle cinture militari i cui estremi crono-logici sono costituiti dalle cinture militari tardoantiche (IV-prima metà V secolo)82, dalla cintura di Globasnitz (prima metà VI secolo)83 e, per finire, dalle cinture a cinque pezzi in bronzo e ferro di VII secolo. Tale ipotesi, purtroppo, è ostacolata dal fatto che l’assemblaggio dei pezzi rinvenuti nella tomba di Arzignano costituisce un unicum nel panorama dei ritrovamenti coevi, frutto di una ricostruzione a posteriori di materiali rinvenuti in giacitura secondaria.
Per quanto concerne le due placche, prive di conferme sono altre due ipotesi formulabili sulla base della forma e delle dimensioni del manufatto. Una prima proposta è che i due frammenti potessero far parte delle decorazioni metalliche delle briglie o della bardatura del cavallo, ipotesi questa che potrebbe trovare conferma nella ri-
71 Cfr. e Bona 1991, p. 106; Kazanki 1999; Bierbrauer 2008, p. 40 fig. 4 (con bibliografia).
72 Kazanki 1999, pp. 302-307; Bierbrauer 2008, pp. 41-42. Sulle fibbie di scarpe v. anche infra.
73 Bóna 1991, p. 106 n. 14 e p. 255, n. 41.14.74 Ibid., p. 106 fig. 41 e p. 255 n. 41 (esemplari in oro, argento e
bronzo).75 Tejral 1992, p. 233, fig. 4, 5.76 Cfr. Schülze-Dörrlamm 2002, tipo B3, pp. 41-43 e p. 81. Devo
al prof. H.W. Böhme il dato che in manufatti di V secolo è frequente l’associazione bronzo-ferro. Nel gruppo dei materiali della tomba del cavaliere di Arzignano l’associazione ferro-bronzo è del resto presente anche sul fodero della spada e nella fibbietta forse relativa all’acciarino (v. infra).
77 Sommer 1984, p. 54 (linguetta di tipo C, sottotipo c, datata alla fine IV-inizi V sec.); Böhme 1974, p. 77. Tali presenze non si limitano all’area del Mediterraneo occidentale ma sono attestate, seppure più saltuariamente, anche a est. In questo ambito un confronto morfologico significativo è costituito da alcune placche di IV secolo provenienti dalla cittadella fortificata di Chersoneso (Crimea) (Kostromichev 2008). Sul significato delle teste zoomorfe equine contrapposte presenti su
pettini ad una fila di denti ma anche su guarnizioni di cintura dell’ul-timo terzo del IV-prima metà del V secolo, interpretate come possibili indicatori di soldati di origine danubiana e germanico-orientale, si veda inoltre Petkovic 1998.
78 Schülze-Dörrlamm 2002, tipo B1, pp. 36-38.79 Dmitrijev 1979, fig. 3, 8; Dmitrijev 1982, fig. 5, 12; 12, 8.
Il confronto era già stato segnalato da Schülze-Dörrlamm 2002, p. 37.
80 Fingerlin 1967, pp. 160-165.81 Mancano tracce di un’eventuale cerniera o di qualsiasi altro tipo
di fissaggio di un anello di fibbia.82 Sommer 1984; Böhme 1974.83 Sul significato della cintura di Globasnitz in relazione ai set tar-
doantichi Pinar, Ripoll 2007, pp. 87-88; Possenti 2007, p. 290.
447
NOTE E DISCUSSIONI
corrente presenza del motivo delle due teste zoomorfe (equine?) contrapposte in set di V-VI secolo84. In questo caso, tuttavia, la principale difficoltà è costituita dal fatto che nelle guarnizioni di briglie le placche con teste equine erano mobili e non avevano ribattini per il fissaggio ad una striscia di cuoio, situazione questa che sembrereb-be essere quella dei due frammenti di Arzignano. Una seconda ipotesi è che la placca con borchie in bronzo potesse essere una decorazione del fodero della spada, secondo un gusto, latamente confrontabile, documentato in alcuni esemplari della seconda metà del V secolo. In particolare, il riferimento è ad una spada di tipo asiatico dalla tomba 300 di Abrau-Djurso e a una seconda spada da Taman (Crimea), entrambe caratterizzate da foderi decorati da fascette con estremità aviformi lungo i bordi e, al centro, da placche di forme diverse85.
6.4 Elementi di fibbia
Pertinenti probabilmente ad un unica fibbia86, forse in relazione ad altri elementi decorativi di cintura (v. supra), erano un anello di forma ovale in ferro (fig. 15) e un ardiglione in bronzo con doppio rebbio fortemente incurvato (fig. 16).
Nel caso dell’anello si tratta di un tipo frequentemente attestato, per lo più in bronzo, durante l’età tardoantica, in particolare nel corso del IV secolo87 ma documentato anche in epoca successiva. Anelli in ferro di forma analo-ga, ageminati e associati a placche rettangolari decorate a cloisonné o, più frequentemente, ad agemina sono invece frequenti in Europa occidentale in numerose sepolture germaniche della seconda metà del V secolo88.
L’ardiglione a due rebbi è caratterizzato, sulla parte a vista, da una X incisa il cui punto d’intersezione dei bracci presenta un foro con all’interno un chiodino che fungeva da perno per il fissaggio all’anello della fibbia. Non si sono individuati confronti puntuali per questo manufatto. Vista la fragilità del bronzo rispetto al ferro potrebbe essere stato un pezzo di ricambio di un manu-fatto, originariamente in ferro, rotto o andato perso. Gli ardiglioni con due rebbi, fusi in un unico pezzo, attestati nelle fibbie tardoromane a placca rettangolare talvolta traforata (fine del IV-inizi V secolo)89 sono in ogni caso piatti o quasi piatti e non presentano una curvatura così accentuata. Degna di nota è anche la presenza del chiodino per l’aggancio all’anello della fibbia che trova confronti in contesti più tardi di VI secolo90. Anche la decorazione ad X non fornisce indizi precisi. Al momento il pezzo vicentino sembrerebbe quindi un unicum privo di confronti puntuali.
Nel quadro sopra tracciato un elemento di riflessione è costituito da una certa somiglianza tra la parte supe-riore dell’ardiglione, di forma rettangolare, e i castoni con almandini o paste vitree, sempre di forma rettango-lare, tipici delle fibbie di produzione mediterranea della seconda metà del V secolo91. Al medesimo orizzonte cronologico (seconda metà del V secolo) e culturale (mediterraneo) appartiene inoltre una semplice fibbia in bronzo con placca in lamina ripiegata a forma di tasca e ardiglione incurvato con alla base un dado rettangolare decorato da una croce incisa rinvenuta in una sepoltura di area pontica (Abrau-Djürso tomba 479)92, rinvenuta in una necropoli connotata da una forte multiculturalità e attribuita dalla maggior parte degli studiosi a Germani orientali (v. supra).
6.5 Fibbie delle scarpe
Rinvenute in situ, in corrispondenza dell’attacco del collo del piede, erano le fibbiette delle scarpe (figg. 11-12), contraddistinte da una placca semicircolare in lamina ripiegata con tre grosse borchie a capocchia emisferica, da un anello con scanalature e da un ardiglione tagliato diritto con preciso accenno di dado quadrangolare. Ad ogni fibbia facevano pendant tre piccole borchie a testa piatta circolare.
Dal punto di vista funzionale e della posizione ri-spetto al corpo del defunto le due fibbiette trovano una buona corrispondenza con gli esemplari, per lo più in oro e almandini, ma anche in semplice oro, argento o bronzo, attestati in sepolture maschili e femminili datate tra la seconda metà del IV (tarda fase della cultura di Cerniachov) e la metà/seconda metà del V secolo (pre-valentemente in associazione con corredi di tipo germa-nico-orientale o unno) e rinvenuti in un ampio ambito territoriale compreso tra Inghilterra, area balcanica e Russia meridionale93.
Morfologicamente gli esemplari noti sono caratteriz-zati da una certa variabilità. Indipendentemente dal me-
84 Akhmedov 2002, p. 21 fig. 6.85 Dmitriev 1979, p. 224, fig. 7, 1-2; Kazanski 1991, pp. 130 e
p. 131, fig. 4, 3 e 4, 7a.86 I due pezzi, appoggiati l’uno sopra l’altro, combaciano perfet-
tamente.87 Keller 1971, tav. 28, 8; Sommer 1984, tav. 30, 1 (tomba di
Ságvar con monete di Valentiniano I e Valente); Konrad 1997, tav. 35, G 572, n. 1 (tomba di Bregenz con fibula a testa di cipolla del tipo Pröttel 2A).
88 Gallien in der Spätantike 1980, pp. 210-211, n. 341.b, d; Böhme 1994, p. 88; p. 123, fig. 24; p. 109 (Fundliste 2).
89 Sommer 1984, pp. 33-37.90 Koch 1977, p. 123 (Schretzheim).
91 Kazanski 1994, p. 155. Sull’origine mediterranea delle fibbie cfr. inoltre Böhme 1994. Va tuttavia specificato che nella seconda metà del V secolo gli ardiglioni con castone quadrangolare alla base si affiancano a quelli con ardiglione tagliato diritto, praticamente esclusivi della prima metà del medesimo secolo.
92 Dmitrijev 1979, p. 224, fig. 8, 2; Kazanski 1994, p. 193, fig. 20, 1-2. L’orizzonte cronologico della sepoltura è indicato dalla pre-senza di ceramica sigillata della seconda metà del V secolo (Kazanski 1994, p. 164).
93 Schmauder 2002, pp. 351-352, lista 24. Ai ventisei confronti (singoli o appaiati) elencati da Schmauder e datati tra fine IV e prima metà V secolo possono essere aggiunti, oltre al paio di Arzignano, anche altri materiali per lo più databili intorno alla metà o nella seconda metà del V secolo: una fibbia ed alcune guarnizioni dal tesoro ungherese di Szeged-Nagyszéksós (L’or des princes barbares 2000, pp. 142 n. 8, secondo terzo del V secolo); due fibbie in argento dalla sepoltura di Fedorowka in Russia (Bóna 1991, p. 257 n. 46 e p. 119, fig. 46, fine IV-prima metà del V secolo); due fibbie in bronzo dalla collezione Ráth del Museo nazionale di Budapest (Bóna 1991, p. 250, F15; due fibbie in bronzo prive di placca ma con tre ribattini a capocchia piatta da Velikaja Bakta in Ucraina (Tejral 2002a, tav. 13, 3-6, seconda metà V secolo); due fibbie in oro e almandini in stile Novogrigorievka da Murga (Tejral 2002a, tav. 12, 10-11, seconda metà V secolo); due fibbie in bronzo dalla tomba 13 di Vyškov (Tejral 2002a, tav. 12, 2-3; seconda metà V secolo); due fibbie a testa d’aquila da Mözs in Ungheria (Tejral 2002a, tav. 12, 16-17; seconda metà V secolo), due fibbie in ferro da Žaman-Togay in Kazachistan (Bóna 1991, p. 116, fine IV-V secolo).
448
NOTE E DISCUSSIONI
tallo e dall’eventuale presenza del cloisonné, nella prima metà del V secolo prevaleva il tipo con anello circolare, ardiglione tagliato diritto e placca circolare in lamina ripiegata con una o tre borchie con capocchia appena rilevata94. Nella seconda metà del V secolo la forma subì invece alcune modifiche per cui si impose, come anche in altri tipi di fibbie, il tipo con anello circolare, placca ovale fissata da tre ribattini e ardiglione decorato alla base da un dado quadrangolare95.
L’analisi formale consente di proporre una datazione del paio di fibbie da Arzignano intorno o poco dopo la metà del V secolo. In questo senso indicativi sono l’anello ovale solcato da scanalature, la forma circolare, quasi a cuore, della placca fissata da tre chiodini con testa emisfe-rica pronunciata, il piccolo dado alla base dell’ardiglione; elementi questi documentabili su buona parte delle fibbie della seconda metà del V secolo in un’area compresa tra Europa centro-orientale e le sponde settentrionali del Mar Nero96. Una cronologia non troppo oltre il 450 è invece suggerita dalla parte posteriore della placca la cui lamina posteriore ha una superficie sostanzialmente equivalente a quella anteriore97.
Non puntuali sono i confronti individuati. Tra le fibbie di scarpe la maggiore somiglianza è stata rilevata con manufatti, in realtà più antichi, rinvenuti nella se-poltura femminile n. 6 di Bratej in Romania (seconda metà del IV secolo o al più tardi degli inizi del V seco-lo)98. In questo caso il paio di fibbie in argento presenta infatti, sia il dado sulla sommità dell’ardiglione, sia i tre chiodini sulla placca, per quanto questi ultimi con una capocchia molto piccola. Un secondo confronto in argento, cronologicamente coevo o di poco successivo alla datazione proposta per i materiali da Arzignano è invece in area balcanica nella tomba 50 della necropoli germano-orientale di Viminacium-Burdelj (metà-seconda metà del V secolo)99. Anche in questo caso i tre chiodini hanno tuttavia capocchie più piccole rispetto a quelle di Arzignano mentre l’ardiglione non ha il dado sulla sommità.
Altri confronti sono offerti da fibbie da cintura o per altri usi per lo più rinvenute in sepolture germanico-orientali dell’area carpatico-danubiana. Un primo esem-pio è costituito da una piccola fibbia rinvenuta in una tomba femminile a Tamasi-Adorianpuszta in Ungheria
(fine IV-prima metà del V secolo) (fig. 40). La fibbia, lacunosa dell’ardiglione, è caratterizzata da un anello con profonde scanalature e, sulla placca triangolare, da tre grossi chiodi a capocchia emisferica100, un dettaglio decorativo, quest’ultimo, abbastanza frequente oltre che nelle già più volte citate guarnizioni di cintura militari bizantine della prima metà del V secolo anche nelle fib-bie femminili germanico-orientali delle fasi D2b e D3 di Bierbrauer (complessivamente tra 420/430 e 480/490)101. Un secondo confronto, da Drslavice (Moravia), è offerto da una fibbietta con anello ovale scanalato, ardiglione leggermente rilevato e placca ovale fissata da tre piccoli ribattini con capocchia emisferica102. Particolarmente significativa è la fibbietta in argento dalla tomba 118 di Zaragij (Caucaso del Nord) della metà del V secolo103 (fig. 41), contraddistinta da un ardiglione con dado netta-mente rilevato oltre che da una placca triangolare, quasi cuoriforme che ricorda molto i materiali di Arzignano. Dal cuore dell’impero bizantino (Achmîm-Panopolis in Egitto) (fig. 42) proviene infine un ultimo confronto, costituito da una fibbietta in bronzo abbastanza simile a quella di Zaragij, rinvenuta in un complesso di materiali copti e per la quale è stata proposta una datazione alla seconda metà del V secolo104.
Il confronto con le fibbie da Zaragij e da Achmîm-Panopolis, oltre che con le fibbie delle cinture militari bizantine della prima metà del V secolo pone il problema di quale fosse l’ambito produttivo delle fibbiette del cavaliere di Cava Poscola.
In generale le guarnizioni di fibbie di scarpe, indi-pendentemente dal tipo, sono state considerate a lungo tipiche dell’età unna o dei decenni immediatamente successivi (prima metà-primi due trentenni del V secolo) e, soprattutto per quanto concerne i materiali in oro e cloisonné, prodotti di ambito bizantino o di imitazio-ne bizantina derivate da prototipi tardoromani di IV secolo105. Recentemente Schamauder, riprendendo una posizione già di Tejral, ha però confutato sulla base dei ritrovamenti archeologici e delle fonti scritte questa ipo-tesi. Fibbie per scarpe (o per stivali) sono infatti attestate già a partire dalla fine dell’età di Cerniachov (fase D3, seconda metà del IV secolo) e non sembrerebbero essere mai presenti in contesti romano-bizantini, né tanto meno
94 Per la datazione alla prima metà del V secolo di fibbie (anche di scarpe ma non solo) caratterizzate da anello circolare, ardiglione tagliato diritto e placca circolare in lamina ripiegata Tejral 2002a, p. 508.
95 Tejral 2002a, p. 508.96 Tejral 2002a, p. 508 (per l’anello di forma ovale, la placca fissata
da tre chiodini e il dado alla base dell’ardiglione). Termini di confronto possono essere inoltre desunti da Schülze-Dörrlamm 2002, pp. 13-14 (per la presenza di scanalature su fibbie ad anello reniforme datate alla metà/seconda del V secolo), p. 54 (per placche in lamina con placca triangolare-cuoriforme datate alla seconda metà del V secolo), pp. 41-43 e 81 (per chiodi con capocchia emisferica pronunciata su fibbie datate alla prime metà/metà del V secolo).
97 Schülze-Dörrlamm 2002, p. 82.98 Per la datazione Schmauder 2002, p. 159 che anticipa quella
alla prima metà del V secolo proposta da Bârzu 1986, p. 102.99 Zotovic 1980, tav. XIII, 8. Nella medesima sepoltura è presente
una fibbia di cintura con anello circolare e grosso dado alla base dell’ar-diglione con castone per l’inserimento di una pasta vitrea o almandino, di un tipo generalmente ritenuto di produzione bizantina.
100 Bóna 1991, p. 109 n. 76 e p. 283 n. 76. Per la datazione Anke 1998, 1, p. 133.
101 Per le fibbie a placca rettangolare e placca rettangolare in lamina ripiegata dall’Europa centro-occidentale Bierbrauer 1991, fig. 7, 3 (Belgrad-Zemun), fig. 12, 2 (Gyualavári), fig. 13, 7 (“Brescia”), fig. 20, 6 (Övöspuszta); per altri esemplari dall’area della Crimea, parimenti riconducibili a Germani orientali Bierbrauer 2008, tav. 28, 9-13 (necropoli di Skalistoje) e tav. 30, 3 (Lucistoe). Esemplari del medesimo tipo di fibbia sono noti anche in epoca, secondo alcuni autori più tarda (VI-prima metà del VII secolo), nelle sepolture a camera dei Goti di Crimea (cfr. Ajbabin, Chairedinova 2009, pp. 23-27 e tav. 4, 1, tav. 48, 10, tav. 182, 2).
102 Skutil 1941, p. 181, fig. 125. Nella stessa immagine è presente anche una seconda fibbietta dalla medesima località con grosse borchie a testa emisferica e placca trapezoidale.
103 L’or des princes barbares 2000, p. 164, in alto a sinistra.104 Schülze-Dörrlamm 2002, p. 54, tipo B9.105 Tra i principali autori possono essere citati Werner e Martin. Per
una panoramica complessiva si rimanda a Schmauder 2002, pp. 156-160. Tale ipotesi è stata anche recentemente ribadita da Bierbrauer 2008, pp. 41-42.
449
NOTE E DISCUSSIONI
figg. 40-43 – Fibbie. 40. Tamasi-Adorianpuszta (da Bóna 1991); 41. Zaragij (da L’or des princes barbares 2000); 42. Achmîm-Panopolis (da Schülze-Dörrlamm 2002); 43. Abrau-Djurso tomba 408 (da (da Schülze-Dörrlamm 2002).
essere citati nelle fonti scritte e iconografiche dell’area mediterranea in cui le decorazioni con pietre preziose delle scarpe degli imperatori tardoantichi, stigmatizzate da alcune fonti scritte, non sono per ora associabili alla presenza di fibbie106. Altrettanto priva di riscontro resta l’ipotesi di un’influenza esercitata dalle produzioni persiane. Secondo Tejral e Schmauder l’origine sareb-be quindi piuttosto da ricercarsi nelle aree pontiche di cultura sarmatica di età altoimperiale da cui poi si sarebbero diffuse verso occidente in concomitanza con l’espansione unna107.
Allo stato attuale appare problematico esprimersi in questa sede a favore dell’una o dell’altra ipotesi, soprat-tutto per quanto concerne non tanto l’origine quando gli ambiti produttivi dei manufatti di V secolo. Se è infatti inequivocabile il dato che fibbie per le scarpe non sono at-testate in contesti di cultura romana (sia in occidente sia in oriente), è infatti anche vero che alcuni dettagli deco-rativi rimandano a manifatture bizantine. D’altro canto, a favore di una produzione extra limes, particolarmente significativo appare il fatto che fibbie di questo tipo non sono presenti, tra fine IV e inizi V secolo, nei corredi dei soldati di stanza lungo il limes renano e danubiano, il cui insieme offre uno spaccato molto eloquente sulle forniture militari di età tardoantica. Una possibilità è che queste fibbie (tra cui quelle di Arzignano) fossero state pertanto prodotte in un’area esterna all’impero ma da questo fortemente condizionata grazie all’arrivo di merci poi imitate o rielaborate in sede locale. L’area pontica a nord del Mar Nero, già indicata come origine dell’intero tipo e caratterizzata da una popolazione mista oltre che da una considerevole importazione di merci bizantine, potrebbe essere quella che meglio risponde al profilo fin qui emerso. Non a caso dalla sepoltura femminile n. 408 di Abrau-Djurso in Crimea108 provengono oltre a un paio di fibule a staffa in lamina d’argento attribuibili alla fase D2b (secondo quarto del V secolo), una fibbia di cintura in lamina con anello ovale, placca ovale con tre chiodini con capocchie rilevate e ardiglione con dado decorato da una croce (fig. 43), e una seconda fibbia con anello ovale,
106 Schmauder 2002, pp. 156-160; Tejral 1988, pp. 16-20.107 Tale ipotesi è sostanzialmente condivisa da Bakay 1978, pp.
161-162 che suppone una produzione degli esemplari in oro e agemina nelle aree della Russia meridionale da cui si sarebbero poi diffuse verso oriente e occidente.
108 Schülze-Dörrlamm 2002, p. 53, fig. 21.
placca circolare con un solo chiodo al centro e ardiglione con dado che, come già evidenziato, appartengono a tipi di origine e, almeno in parte, produzione bizantina.
6.6 Utensili vari
Tra i manufatti recuperati alla base della sezione c’erano anche alcuni elementi metallici in bronzo e ferro, recuperati in modo sporadico e probabilmente in origine appesi alla cintura.
Il primo è costituito da un elemento in ferro di forma triangolare (fig. 23), interpretabile come un frammento di acciarino o di chiusura di borsa al quale apparteneva, probabilmente anche una piccola fibbia in ferro con ardiglione in bronzo (figg. 21-22). Il manufatto appar-tiene a una categoria di oggetti legati alla vita quotidiana relativamente poco diffusa nelle sepolture germaniche tardoantiche e altomedioevali. Il manufatto qui analiz-zato è relativo ad un tipo, attestato in età tardoantica soprattutto durante la seconda metà del V secolo109, caratterizzato da un corpo centrale triangolare con le estremità laterali spesso ripiegate verso l’alto. Nelle sepolture germaniche del limes renano questo tipo è piuttosto raro ed è esclusivo delle inumazioni maschili110. Nell’orizzonte germanico-orientale compreso tra Austria e nord del mar Nero è a sua volta presente in tombe maschili della metà/seconda metà del V secolo dove è generalmente associato ai corredi più ricchi111.
Inusuale è invece la scelta dell’ardiglione in bronzo della fibbietta che probabilmente consentiva l’aggancio alla cintura del cavaliere. Nei ritrovamenti di età tar-doromana è infatti generalmente attestata la situazione inversa, ovvero ardiglioni di ferro su anelli in bronzo112,
109 Böhme 1974, p. 115. Il medesimo tipo è però attestato anche durante la prima metà del V secolo (v. ritrovamenti di Hobersdorf, Anke 1998, pp. 49-50) e continuò ad essere utilizzato per lo meno fino a tutto il VI secolo e parte del VII secolo così come testimoniato, solo per citare due esempi, da alcune sepolture gepidi di VI secolo (Tejral 2002a, p. 508), dalla sepoltura 109 di Castel Trosino della prima metà del VII secolo.
110 Böhme 1974, p. 115.111 Tejral 2002a, pp. 508 e 510-511; Cižmár, Tejral 2002, p.
118.112 Sommer 1984, pp. 24 (modello 1, forma C, tipo d), 31 (modello
1, forma E, con più varianti), 38 (modello 3, tipo a-b, d). L’ardiglione in bronzo su anello in ferro è invece attestato nel VI secolo a Schretzheim (Koch 1977, pp. 75-76, semplici fibbie ad anello da sepolture femminili datate complessivamente tra 545/50 e 590/600 e p. 123, fibbie in ferro ad anello da sepolture maschili datate tra 545/50 e 565/570).
40
4143
42
450
NOTE E DISCUSSIONI
soluzione che si spiega con la resistenza che deve essere esercitata dall’ardiglione sul foro della cinghia in cuoio della cintura. Tale soluzione è stata tuttavia ipotizzata anche per la fibbia forse associata alla placca con estre-mità zoomorfe (v. supra). Come in quest’ultimo caso potrebbe trattarsi di una riparazione.
Riferibili al gruppo dei piccoli utensili “portatili” erano anche il coltellino in ferro e il paio di pinzette in bronzo, prive di decorazioni e di fattura molto semplice. Anche in questo caso si tratta di oggetti estremamente diffusi sia in ambito occidentale che orientale, e non riconducibili ad ambiti cronologici e culturali specifici anche se in ambito orientale le pinzette, analogamente agli acciarini, sembrerebbero essere appannaggio delle sepolture maschili più ricche113.
7. ORIENTAMENTO E STRUTTURA DELLA TOMBA; DEPOSIZIONE DEL CAVALLO
Complementare a quanto desunto dallo studio degli elementi di corredo è l’analisi, da una parte dell’orienta-mento e della tipologia della tomba, dall’altra delle ossa di cavallo ai piedi del defunto. Non possono essere invece rilevati altri elementi, quali ad esempio la presenza di fuochi rituali o di altri resti di cibo anche se la loro pre-senza non può essere esclusa a priori, vista l’asportazione pressoché completa della parte nord della tomba.
L’orientamento nord-sud della sepoltura ben si allinea con le caratteristiche germano-orientali e nomadiche rivelate dall’analisi tipologica degli elementi di corredo. L’orientamento nord-sud era infatti prevalente sia nelle sepolture della cultura di Cerniachov, sia nelle sepolture unne o di individui attribuiti alla sfera unna. Per quanto concerne la fase più antica, ovvero la cultura di Cernia-chov, caratterizzata come noto dalla compresenza dei due riti, ad inumazione e ad incinerazione, l’orientamento nord-sud conviveva con quello est-ovest che sembra aver preso il sopravvento, per quanto in modo non esclusivo, nelle fasi più tarde (seconda metà del IV secolo) forse in seguito alla conversione o quanto meno all’avvicina-mento alla religione cristiana114.
Per la fase successiva, coincidente con l’espansione dell’impero unno in occidente (fino ai decenni centrali del V secolo, fase D2/D3), l’orientamento nord-sud con-tinuò a prevalere, sia nelle tombe attribuite ad individui di etnia unna, sia nelle sepolture ricondotte a persone che in vita erano entrate in contatto più o meno diretto con l’impero unno e sulla cui origine polietnica non ci sono dubbi115.
Un discorso analogo vale per la struttura della tomba costituita ad Arzignano da un triplo strato di tegoloni
romani al di sopra di una probabile cassa lignea. Que-st’ultima (la cassa lignea) è infatti quasi sempre attestata nelle tombe attribuite a Unni o a loro confederati, per lo meno nel caso in cui i dati di scavo si soffermano anche su questo aspetto116. D’altro canto sono noti anche alcuni casi di sepolture in lastre di pietra e, limitatamente ai territori interni all’impero romano, in laterizi di reim-piego117.
Nei territori entro o presso il limes è anche documen-tato il caso di deposizioni ricavate all’interno di edifici tardoromani in disuso (Árpás, Ungheria)118, mentre in aree esterne possono essere citate la tomba di Beljaus in Crimea, scoperta durante lo scavo dell’omonimo insedia-mento tardoantico, e quella di Aktobe II in Kazachistan (fig. 39) la cui struttura fu ricavata nell’edificio abban-donato di una fortificazione tardoantica119. Da segnalare, inoltre, che alcune sepolture riferibili alla cultura dei ca-valieri delle steppe furono rinvenute, a prescindere dalla tecnica con cui erano state realizzate, anche in prossimità di fortificazioni o insediamenti tardoromani abbandonati dall’esercito e rioccupati (o parzialmente occupati) dalle nuove popolazioni orientali. Tra queste, oltre alla sopra citata Beljaus in Crimea, caratteri orientali caratterizza-vano alcune sepolture ungheresi messe rispettivamente in luce a Keszthely-Fenékpuszta, poco fuori le mura del castello omonimo, ed a Szabadbattyán, a circa 6 km dal castello di Gorsium120. Relativamente a quest’ultimo aspetto va tuttavia sottolineato che nel caso di Arzignano non sappiamo se l’edificio di età romana in cui era stato sepolto il cavaliere di via Canove fosse ancora, del tutto o in parte, funzionante o in completo stato di abbandono, né quale fosse la sua funzione anche se è lecito supporne, vista l’ubicazione, un utilizzo rurale.
Un ultimo spunto di riflessione è offerto dalla depo-sizione di alcune parti selezionate di cavallo (testa, parti superiori e inferiori, coda), disposte intorno ai piedi del defunto. Come evidenziato dallo studio archeozoologico le ossa presentavano chiari segni di macellazione. Contra-riamente a quanto ci si potrebbe aspettare, l’animale era inoltre di origine probabilmente occidentale121. Questo aspetto del rituale funerario rimanda probabilmente ad un banchetto funebre e deve essere ben distinto dalla sepoltura completa di cavalli attestata saltuariamente in contesti orientali e nomadici di V secolo122. La deposi-
113 Per le pinzette in area germano-orientale Tejral 2002a, pp. 510-511 e Cižmár, Tejral 2002, p. 118; per gli esemplari nelle sepolture germaniche occidentali Böhme 1974 pp. 127-128.
114 In generale sull’orientamento e le caratteristiche delle sepolture della cultura di Cerniachov Bierbrauer 1994. Per le sepolture della fase più tarda Levinschi 1999.
115 Tomka 2007, pp. 255-256. In questo quadro tendente ad una più o meno spiccata uniformità del costume funerario, non devono essere dimenticati i rapporti di acculturazione reciproca registrati alla fine del IV secolo sulle sponde settentrionali del Mar Nero tra le popolazioni locali di origine sarmatica e le popolazioni germano orientali immigrate (cfr. von Der Lohe 1999).
116 Tomka 2007, pp. 255-256.117 Tra gli esempi con laterizi di reimpiego possono essere ricordati
Beja in Portogallo, Sirmium e Szabadbattyán in Ungheria. Un caso di riutilizzo di sepoltura in un’area di cimitero tardoantica è a Hrtkovic presso Sirmium in Serbia (Anke 1998, 2, pp. 12-13; 52; 117; 125).
118 Tomka 2007, p. 256.119 Anke 1998, 2, pp. 3, 13.120 Ibid., 2, pp. 61-62, 125. Sulle sepolture tardoantiche di Ke-
szthely-Fenékpuszta che attestano tuttavia la permanenza di popo-lazioni locali tardoantiche anche dopo l’abbandono della fortezza si veda il recente contributo di Müller 2010.
121 Reggiani, Rizzi 2005. Come evidenziato dai due medesimi autori la presenza di un cavallo occidentale in una sepoltura con ca-ratteristiche culturali orientali trova comunque confronti, ad esempio nelle tombe di avanzato VII secolo di Vicenne in Molise (cfr. Bököhyi 1988, p. 73).
122 In generale sulle deposizioni di cavallo Steuer 2003 (con bi-bliografia di riferimento). Relativamente alla rarità delle deposizioni intere di cavallo questo dato è stato desunto dallo spoglio del catalogo di Anke 1998, 2.
451
NOTE E DISCUSSIONI
zione di parti selezionate all’interno di una sepoltura che poteva essere sia maschile sia femminile è nota dal canto suo, durante la prima metà del V secolo, in un ampio ambito territoriale compreso tra il basso Danubio, le sponde settentrionali del Mar Nero, il Caucaso setten-trionale e le aree settentrionali del Kazachistan (fig. 44); ambito territoriale al quale si aggiungono il ritrovamento di Arzignano e, forse, una seconda sepoltura italiana rinvenuta lungo la Salaria nell’area in disuso delle terme di Cotilia nel comune di Castel S. Angelo (Rieti) e per la quale è stata proposta una datazione di fine V-prima metà VI secolo123. In questo caso, poco conosciuto in letteratura, la sepoltura, in laterizi di reimpiego, era infatti caratterizzata dalla presenza dell’arto anteriore sinistro di un cavallo deposto assieme ad una piccola bottiglia in vetro124.
Più in generale, nelle sepolture dei cavalieri delle steppe di V secolo potevano essere presenti recipienti per bere o mangiare mentre i resti del cavallo erano generalmente presenti, quando attestati, in maniera simbolica e a volte limitati, come ad Arzignano, alla testa e alle estremità, talora associate alla pelle dell’ani-
male. In alcuni casi potevano essere presenti, accanto o in alternativa alle ossa, piccole sculture zoomorfe, in legno ricoperte da una sottile lamina metallica in oro o in argento125.
Lo spoglio effettuato in occasione del presente stu-dio ha consentito di distinguere tra la deposizione di generiche ossa di cavallo, interpretabili come offerte di cibo (analogamente alle ossa di pecora attestate da sole o in associazione a quelle di cavallo), e deposizio-ni selezionate costituite da testa, gambe e coda, il cui valore simbolico era forse maggiore e probabilmente riconducibile al banchetto funebre (fig. 44)126. In ogni caso ambedue le varianti (ossa generiche da una parte, testa/coda/gambe dall’altra) sono risultate distribuite in un’area che si spinge ben dentro l’Asia centro-set-tentrionale e nel cui ambito Arzignano e caso mai il ritrovamento nelle terme di Cotilia costituiscono la testimonianza più occidentale. Altro dato di rilievo è che in quasi tutti i casi la presenza di ossa di cavallo, sia selezionate sia come offerta di cibo, è risultata associata a sepolture databili tra fine IV e prima metà V secolo con ricchissimo corredo, femminili o maschili, caratterizzate dalla presenza di manufatti aurei quali diademi, orec-
123 Tomka 2007, pp. 255-256. Per la carta di distribuzione la base è statacostituita dal catalogo dei rinvenimenti nomadico-orientali pre-sente in Anke 1998. La deposizione di ossa selezionate di cavallo non deve essere tuttavia essere considerata esclusiva della prima metà/metà del V secolo dal momento che è attestata con certezza in area orientale anche nei secoli successivi, in sepolture avare (secoli VII-VIII) e ungare (secoli VIII-X) (Bóna 1989; Steuer 2003, pp. 61-62).
124 De Palma 1985, p. 191. Dalla descrizione si desume che la sepoltura, scavata negli strati di abbandono del complesso termale era delimitata lungo il lato breve (in prossimità della testa) da una tegola ed era inoltre coperta da alcuni laterizi. Non è specificata la posizione dell’osso del cavallo. Per le ossa del cavallo cfr. inoltre De Grossi Mazzorin 1995, p. 310 (parte dell’arto anteriore sinistro di un cavallo di 3-4 anni alto circa 135/138 al garrese).
fig. 44 – Carta di distribuzione delle sepolture con ossa di cavallo. Deposizioni parziali di cavallo (lettere romane): A. (fuori carta), Arzignano, B. Stráže; C. Kubej; D. Beljaus; E. Zdviženski; F. Verechnee-Pogrmnoe; G. Kara Agac; H. Kanattas. Ossa varie cavallo (numeri arabi): 1. Budapest XIV-Zúglo; 2. Jakusowice; 3. Aleški; 4. Staraja Igren; 5. Melitopol; 6. Kalinin; 7. Kišpek; 8. Rassvet,
9. Birsk, 10. (fuori carta) Castel S. Angelo, Terme di Cotilia.
125 Tomka 2007, pp. 255-256.126 Sepolture (in ordine alfabetico) con deposizione di testa, gambe
ed eventualmente coda di cavallo: Beljaus, Kanattas, Kara Agac (solo testa e pelle), Kubej, Stráže (solo frammenti della testa), Verchnee Pogromnoe (inoltre con alcune costole), Zdvinžnskoe presso Stavro-pol. Sepolture con ossa generiche: Aleško, Birsk (2 tombe), Budapest XIV-Zúglo, Jakusowice (dubbia), Kalinin-Sovchose, Kišpek, Melitopol Rassvet e Staraja Igren’. Per Jakusowice l’incertezza nasce dal fatto che si tratta di un vecchio ritrovamento e non è noto il tipo e la quantità di ossa di cavallo presenti. Alle sepolture con ossa generiche possono essere aggiunti i due depositi votivi di Sagi presso Aleški e Seelmann sul Volga. Per la bibliografia si rimanda alle omonime schede in Anke 1998, 2.
452
NOTE E DISCUSSIONI
chini e guarnizioni in lamina di selle e archi compositi per i quali l’attribuzione ad un ambito culturale unno è fuori discussione127. Altrettanto significativo è il fatto che, quando presenti, le analisi antropologiche hanno spesso riconosciuto la deposizione di individui di razza mongoloide. Una percentuale decisamente minore è in-vece costituita da sepolture per le quali è probabilmente più esatto parlare di una generica componente orientale con influssi culturali unni. Si tratta della sepoltura di Jakusowice (Polonia) con ossa di cavallo come offerta di cibo attribuita ad un capo della nobiltà locale128, e della tomba di bambino (peraltro forse di razza mongoloide) nella piccola area funeraria di Stráže in Slovacchia (con un frammento della testa del cavallo) il cui corredo era costituito da alcuni manufatti in ceramica129. Un ultimo dato è infine relativo al fatto che, a parte la sopra ci-tata sepoltura infantile di Stráže e forse di Jakusowice, tutte le sepolture con deposizione selezionata di testa, gambe ed eventualmente coda di cavallo appartengono a sepolture tipologicamente attribuibili ad inumati del gruppo unno.
8. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
Al termine di questo lavoro restano da verificare alcuni aspetti, in merito ai quali le proposte qui di se-guito formulate sono desunte dall’analisi tipogica dei reperti incrociata con i dati relativi al rituale funerario. In particolare si tratta di stabilire quale potesse l’ambito cronologico e culturale del cavaliere sepolto in via Cano-ve, quali furono le cause e le modalità che lo portarono nella Venetia occidentale e, quindi, quale è il rapporto con le restanti testimonianze archeologiche coeve.
Per quanto riguarda il primo aspetto la sepoltura di Arzignano può essere collocata da un punto di vista cro-nologico intorno alla metà/decenni centrali del V secolo, ovvero nella fase D2/D3 di Tejral e D2b di Bierbrauer, coincidenti con gli ultimi anni e il periodo immedia-tamente successivo alla disfatta dell’impero unno. Se infatti per la maggior parte dei pezzi è proponibile una datazione piuttosto ampia nella prima metà/primi due trentenni del V secolo (spada, spada corta, punte di freccia, Ösenringe), le fascette laterali del fodero della spada, le fibbiette delle scarpe e la presenza di pinzette e acciarino richiamano un orizzonte cronologico che parte dalla metà del V secolo130.
I singoli oggetti dal canto loro appaiono riconducibili ad ambiti culturali diversi. Prevalente è un generico ambito culturale germanico-orientale collegabile alla cosiddetta “koiné germanica” (Bierbrauer) o “com-plesso culturale danubiano-germano orientale” (Tejral) caratterizzato da un’accentuata dipendenza politica e culturale dall’impero unno131 che, dal canto suo, da una parte manteneva una propria e definita facies funera-ria, dall’altra aveva alcuni elementi in comune con le
popolazioni sottoposte132. Tra questi ultimi rientrano la spada di tipo asiatico, le punte di freccia e gli Ösenringe. Decisamente spostata verso un orizzonte nomadico delle steppe è la deposizione parziale del cavallo (testa, zampe e coda). Più problematica è invece la valutazione delle spada corta, delle fibbie delle scarpe e della placca con grosse borchie emisferiche per le quali sembra esserci un certo richiamo alla tradizione romano-bizantina, per quanto forse mediata dalle aree pontiche a nord del Mar Nero. In particolare la spada corta, come sopra ricordato, richiama un orizzonte pontico-caucasico in cui al momento ancora sfumato resta il rapporto con un’eventuale produzione da parte di manifatture bizan-tine “originali”. Dal canto loro la probabile placca di cintura e le fibbie delle scarpe trovano precisi riscontri formali con produzioni bizantine, in particolare at-tribuite a guarnizioni militari (v. supra). Attribuibile tanto ad un orizzonte romano quanto genericamente germanico restano infine gli utensili (acciarino, pinzette) per le quali la coeva presenza in sepolture germaniche occidentali del limes renano e danubiano fa forse pro-pendere per una derivazione da prototipi romani. Privo di caratterizzazione resta ovviamente il coltello.
Ricapitolando la sepoltura di Arzignano vede quindi la compresenza di almeno tre elementi culturalmente differenziati: germanico-orientale, nomadico delle steppe e romano/bizantino. A questi va aggiunto quello pontico-caucasico, in realtà fortemente polietnico, culturalmente e geograficamente a cavallo delle tre componenti sopra elencate. In questo quadro la perdita della parte superiore della sepoltura, in particolare del cranio, si rivela partico-larmente penalizzante dal momento che avrebbe potuto dare indicazioni preziose sull’origine del defunto133. Allo stato attuale, per quanto ne sappiamo e sulla base dei confronti, il cavaliere potrebbe essere stato di razza europea ma anche mongoloide; contemporaneamente avrebbe anche potuto avere il cranio deformato artifi-cialmente. Pur con questi limiti, al momento insormonta-bili, si ritiene comunque verosimile proporne un’origine orientale, probabilmente non germanica vista la presenza della deposizione parziale del cavallo e nonostante la fa-cies germanico-orientale appaia ben definita nell’insieme del corredo e della sepoltura134. È inoltre verosimile che a un certo punto della sua vita il guerriero di Arzignano fosse transitato (se non era addirittura nato lì) attraverso le aree caucasiche e a nord del Mar Nero. Un tale passag-gio infatti è quello che maggiormente giustifica, accanto a materiali di tipo germanico-orientale e nomadico, la presenza di reperti inusuali quali la spada corta e le guar-nizioni di produzione o ispirazione bizantina (probabile placca di cintura, placche delle scarpe) per i quali non è tuttavia da escludersi un approvvigionamento tramite forniture militari.
Un’altra serie di riflessioni è relativa alle cause e alle modalità che portarono il cavaliere di Arzignano a mo-
127 Anke 1998, I, pp. 137-150; Bierbrauer 2008, pp. 48-55.128 Godłowski 1995.129 Anke 1998, 2, pp. 123.130 Cižmár, Tejral 2002; Tejral 2002a.131 Bierbrauer 2008 e Tejral 2007a (con bibliografia precedente,
per lo più ad opera dei due medesimi autori).
132 Anke 1998, 1, pp. 137-150; Bierbrauer 2008, pp. 48-55.133 Al proposito si deve soprattutto lamentare la perdita di tutti i
denti che opportunamente analizzati avrebbero potuto dare informa-zioni precise sul luogo di origine del defunto.
134 Inizialmente si era propeso per un’attribuzione germanico-orien-tale tout court del defunto (Possenti 2011) che però in questa sede è stata rivista alla luce dello studio analitico qui effettuato.
453
NOTE E DISCUSSIONI
rire in Italia nord-orientale, un territorio molto lontano da quello dove era nato. Vista la sovrapposizione cro-nologica si potrebbe pensare ad un guerriero che aveva partecipato alle razzie di Attila in Italia settentrionale nel 452, occasione nella quale caddero anche le vicine Aquileia ed Altino.
Una seconda proposta è che questi fosse in realtà un soldato al servizio di Roma, il cui esercito come noto, già da tempo si avvaleva di forze di origine barbarica. Questa ipotesi potrebbe essere convalidata dall’even-tuale origine bizantina della placca e in particolare dal suo legame con le guarnizioni di cintura militari della prima metà del V secolo. In questa direzione potrebbero parimenti indirizzare le fibbie delle scarpe e la spada corta per le quali non si è escluso un rapporto con ma-nifatture di tipo romano/bizantino. A favore di questa ipotesi appare d’altro canto la posizione di Arzignano, decentrata rispetto alla viabilità principale segnata dalla via Postumia e collocata lungo una direttrice secondaria (non attestata archeologicamente) la cui prosecuzione verso nord sfocia nella valle dell’Adige all’altezza di Rovereto (TN), un’area il cui significato strategico è ben noto da tempo, anche se in relazione al periodo ostrogoto e longobardo135.
La collocazione cronologica nella fase D2b o D2/D3 trova d’altro canto significativi e coevi riscontri archeologici in alcune sepolture femminili generalmente attribuite a mogli di soldati germano-orientali al servi-zio di Roma. Al riguardo possono essere citati gli esempi di Castelbolognese e quello più antico di Pollenzo136 a cui possono essere accostati alcuni rinvenimenti più occidentali relativi a tombe maschili e femminili137, tra cui un particolare significato è assunto dalle spade di tipo asiatico del museo di Digione (Borgogna) gene-ralmente attribuite a guerrieri germanico-orientali al servizio dell’impero138. Alcune testimonianze indirette sono infine costituite dai materiali sporadici di alcuni musei tra i quali spicca una probabile guarnizione di briglie del secondo trentennio del V secolo nel Museo Archeologico Nazionale di Altino139. Quanto il quadro generale, in particolare relativo all’esercito, potesse es-sere articolato e variegato è d’altro canto testimoniato dalla sepoltura maschile con spada rinvenuta a Capraia. La tomba, attribuita ad un soldato di origine germanica occidentale, è stata infatti ricondotta alla presenza di un presidio militare di stanza sull’isola, forse per pro-teggere le rotte marittime tirreniche successivamente alla conquista vandala dell’Africa140.
Ritornando al cavaliere di Arzignano, è difficile pronunciarsi sulle effettive modalità che portarono all’arrivo in Italia nord-orientale di un cavaliere forse di origine pontico-caucasica la cui sepoltura riflette da una parte contatti con i Germani orientali, dall’altra la cultura delle steppe. Nelle fonti storiche, come ci si poteva immaginare, non si è trovato al proposito un riscontro puntuale e preciso. Un passaggio di Procopio di Cesarea potrebbe tuttavia forse fornire un indizio, per lo meno allusivo alla temperie storica e culturale in cui questo arrivo era maturato. Nel primo capitolo de La guerra gotica si apprende infatti che al tempo di Ricimero (459-472) erano arrivati in Italia grazie ad un patto di alleanza (quindi non come invasori ma probabilmente come truppe al servizio di Roma) “Sciri, Alani e alcune altre popolazioni gotiche” non meglio specificate i quali riuscirono poi con Odoacre ad otte-nere l’assegnazione di un terzo delle terre italiche141. La presenza di questi “federati interni” è stata utilizzata per spiegare la sepoltura femminile di Castelbolognese, deposta in un sepolcreto della popolazione romana142 ed è stata anche richiamata, seppure in modo più sfumato, per il paio di fibule di Villalta di Gazzo Pa-dovano (450-490 circa), una località ad est di Vicenza distante alcune decine di chilometri da Arzignano143. La cronologia e la composizione mista degli “alleati” citati da Procopio o di altri simili arrivi non citati dalle fonti potrebbe pertanto spiegare anche la sepoltura di Arzignano, forse ubicata come sopra ricordato in un antico fondo romano lungo una direttrice stradale di una certa importanza.
Un ultimo appunto è infine relativo alla posizione sociale del guerriero di via Canove. Nell’ambito delle sepolture con spade di tipo asiatico della prima metà e metà del V secolo il corredo è infatti generalmente ca-ratterizzata da una certa ricchezza, segnata da accessori in argento (in primis fibbie dell’abito e delle scarpe) che a volte diventa vera e propria opulenza in presenza di manufatti in oro con o senza inserti in pietre preziose. In questo caso, se facciamo fede ai materiali che si sono conservati, il corredo, per quanto quantitativamente e tipologicamente articolato è invece caratterizzato dall’esclusiva presenza di manufatti in ferro o bronzo. Questo si accorda, in generale con le caratteristiche di alcune sepolture maschili germanico-orientali e noma-diche della seconda metà del V secolo, in cui tuttavia la spada non è presente ed è sostituita dallo Schmalsax144. Se paragoniamo il corredo pervenutoci con le tombe germanico-orientali con spada della metà e seconda metà del V secolo, dobbiamo pertanto ipotizzare di trovarci di fronte alla rara testimonianza di un cavaliere di grado intermedio, il cui equipaggiamento per quanto dotato di spada non poteva competere con quello degli altri cavalieri coevi le cui ricche sepolture come Pouan e Apahida, solo per citare alcuni esempi, ci sono note sia in Europa occidentale che orientale145.
135 Brogiolo 2007; Brogiolo, Possenti 2008, pp. 454-455.136 Bierbrauer 1991; Bierbrauer 1994, pp. 40-44; Micheletto
2003; Bierbrauer 2007b, pp. 94-101 (che anticipa alla fase D2a le fibule di Pollenzo considerate invece di fase D2b da Micheletto 2003).
137 Una panoramica è nel catalogo della mostra L’or des princes barbares 2000 (con bibliografia relativa).
138 Vallet 1993. Cfr. inoltre Anke 1998, 1, p. 82 e Miks 2007, pp. 134 e 564.
139 Possenti 2008 e da ultimo a Possenti 2011 a cui si rimanda anche per una più generale rassegna delle testimonianze germanico-orientali di V secolo nell’Italia nord-orientale.
140 Ciampoltrini 1991. Sul tipo di spada (tipo Yllerup-Wyhl) Miks 2007, p. 556.
141 Procopio, I, 1.142 Bierbrauer 1991, pp. 588-589.143 Possenti 2005.144 Tejral 2002a.145 L’or des princes barbares 2000, passim.
454
NOTE E DISCUSSIONI
APPENDICE
Note antropologiche relative allo scheletro proveniente dalla sepoltura di Arzignano, Cava Poscola, via Canove (Ales-sandro Canci, Pamela Corsi, Letizia Pulcini – Dipartimento di Archeologia, Università di Padova).
I resti scheletrici umani sui quali è stata effettuato lo studio antropologico erano caratterizzati da mediocre condizioni di conservazione e cioè frammentari ed incompleti anatomica-mente come descritto dal seguente inventario:
1 piccolo frammento di volta cranica (osso parietale);frammenti di ridotte dimensioni di seconda (L2) e terza vertebra lombare (L3);quarta vertebra lombare (L4) completa ed in discrete condizioni di conservazione;1 frammento di osso sacro;13 frammenti costali;1 frammento relativo all’epifisi distale dell’omero destro;2 frammenti estremamente deteriorati ed incompleti dell’ulna destra;2 frammenti deteriorati ed incompleti del radio destro;1 frammento di diafisi di radio sinistro con macchia verdastra;5 tra metacarpali e falangi della mano destra;2 frammenti di anca destra con superficie della sinfisi pubica preservata;2 frammenti di anca sinistra con superficie della sinfisi pubica preservata;femore destro quasi completo; femore sinistro mancate di quasi tutta la diafisi;rotule destra e sinistratibia destra; tibia sinistra mancante di un frammento del terzo distale della diafisi;fibula destra mancante della testa; frammento estremamente deteriorato di diafisi mediale della fibula sinistra;calcagno destro e sinistro (con perdita di sostanza);astragalo destro (con macchia di colore verdastro) e sinistro;ossa tarsali destre e sinistre;ossa metatarsali destre e sinistre;4 falangi prossimali, 2 falangi mediali, 1 falange distale (lato destro);4 falangi prossimali, 2 falangi mediali, 2 falangi distali (lato sinistro).
I resti scheletrici appartengono ad un uomo per la stretta incisura ischiatica osservabile sulle anche, per l’assenza del solco preauricolare, per il diametro verticale della testa del femore (49 mm), che ricade nel campo di variazione maschile, ed infine per la marcata robustezza complessiva.
L’età alla morte, stimata sulla base della morfologia delle su-perfici di entrambe le sinfisi pubiche e superfici auricolari delle anche e su quella delle estremità sternali delle costole, è quella adulta ed è verosimilmente compresa tra i 35 e i 45 anni.
Una misura di lunghezza del femore destro (45,3 cm) ha permesso di stimare la statura del soggetto tra 168,6 cm, e 169,2 cm. Inoltre, la misura del diametro della testa del femore consente di proporre una stima del peso medio del soggetto in vita di oltre 70 kg.
Per quanto riguarda lo stato di salute le ossa rinvenute do-cumentano la presenza di osteoartrosi all’epifisi distale dell’ulna destra di una vistosa corona osteofitica sul bordo superiore della quarta vertebra lombare che esibisce, inoltre, anche una debole ernia di Schmörl. Per quanto riguarda l’arto inferiore, infine, le superfici articolari prossimali di tutte e cinque le ossa metatarsali del lato destro presentano marcate modificazioni conseguenti ad una grave osteartrosi probabilmente conseguen-ti a sollecitazioni di natura meccanica a carico del piede.
L’insieme di queste osservazioni è in accordo con l’età matura del soggetto e suggerisce un’attività fisica intensa ed impegnativa molto probabilmente connessa ad un’attività di equitazione abituale. Più specificatamente su entrambi i femori si osservano
inserzioni muscolari particolarmente marcate a carico dei muscoli glutei ed adduttori. Sono inoltre visibili, sia sul lato destro che sinistro degli stessi femori, faccette di Poirier particolarmente evi-denti. Si tratta dell’estensione della superficie articolare della testa del femore sul collo dell’osso conseguente a prolungata flessione e abduzione della coscia la cui formazione è compatibile con i movimenti e postura della coscia durante l’atto del cavalcare.
RingraziamentiAl termine di questo lavoro mi sento di dover ringraziare un
nutrito numero di persone senza le quali questo mio studio non sarebbe mai stato terminato. In primo luogo la dott.ssa Marisa Rigoni della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto che mi ha gentilmente offerto di studiare questo complesso da lei fortunosamente recuperato in un momento non facile della sua vita. Un grazie cordiale è quindi per la dott.ssa Annachiara Bruttomesso, conservatore del Museo “G. Zannato” di Mon-tecchio Maggiore, che ha sempre espresso il più vivo interesse per il guerriero di Arzignano. Altrettanto grata sono ai dott. Alessandro Canci e Mauro Rottoli che mi hanno cortesemente messo a disposizione i dati da loro elaborati.
Per il riconoscimento e il corretto inquadramento della sepoltura sono veramente molti i colleghi con i quali mi sono confrontata e che con pazienza e competenza hanno espresso un loro parere e mi hanno dato suggerimenti fondamentali. Tra questi ricordo il prof. Volker Bierbrauer che ancora nel 2000 mi aveva confermato l’appartenenza del cavaliere ad un contesto culturale orientale; più recentemente il prof. Jaroslav Tejral (Brno), il dott. Dieter Quast (Mainz, Römisch-Germanisches Zentral Museum), il dott. Michael Miks (Mainz, Römisch-Germanisches Zentral Museum) e il prof. Horst W. Böhme (Mainz). In particolare un sentito grazie è per il dott. Quast tramite il quale mi è stato possibile soggiornare nel giugno del 2009 presso la foresteria del Museo di Mainz di cui ho potuto utilizzare la ricchissima biblioteca. Un ultimo confronto è stato infine proficuamente instaurato nel dicembre del 2009 con i partecipanti al convegno “Akkulturation beiderseits der Alpen” organizzato a Lendorf dall’università di Vienna (prof. Herwig Friesinger) e dal museo di Klagenfurt (dott. Franz Glaser).
Come sempre ringrazio il dott. Francesco Granzotto che mi ha messo a disposizione la sua biblioteca, oggi forse la più ricca biblioteca privata italiana sui ritrovamenti funerari tra V e VII secolo, e che con la consueta disponibilità ha tradotto la bibliografia in lingua russa e serbocroata oltre ad aver discusso con me l’impostazione e il contenuto dell’articolo.
L’ultimo ricordo è infine per il prof. Otto von Hessen. Una prima redazione del lavoro era stata scritta nel lontano 1996 ma non era più stata pubblicata perché c’erano, come lui stes-so aveva detto, “troppi se e troppi ma”. Ora finalmente sono arrivata alla fine.
BIBLIOGRAFIA
Akhmedov I., 2002, Cheek-pieces and elements of harness with zoomorphic decoration in the Great Migration period, in Tejral 2002b, pp. 11-30.
Ajbabin A., 1995, Les tombes de chefs nomades en Crimée de la fin du IVe siécle au VIe siécle, in Vallet, Kazanski 1995, pp. 207-216.
Ajbabin A.I., Chajredinova E.A., 2009, Das Gräberfeld beim Dorf Lucistoe, Ausgrabungen der Jahre 1977, 1982-84, Monographien des Römischen-Germanischen Zentralmu-seums, 83, Mainz.
Anke B., 1998, Studien zur reiternomadischen Kultur des 4. bis 5. Jahrhunderts, Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas, 8, Bd. 1-2, Weissbach.
Attila und die Hunnen 2007 = Attila und die Hunnen, catalo-go della mostra (Historisches Museum der Pfalz Speyer), Speyer-Stuttgart.
455
NOTE E DISCUSSIONI
Bakay K., 1978, Bestattung eines vornehmen Kriegers vom 5. Jahrhundert in Lengyeltóti (Komitat Somogy, Kreis Marcali), «Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae», 30, pp. 149-172.
Bârzu L., 1986, Monumente geramanice descoperite la Bratej, jud. Sibiu, «Studii si Cercetari de Istorie Veche si Archeo-logie», 37, pp. 89-104.
Beninger E., 1936, Germanenfunde des 5., Jahrhunderts aus Wien XXI – Leopoldau, «Mannus», 28, pp. 252-266.
Bierbrauer V., 1991, Das Frauengrab von Castelbolognese in der Romagna (Italien) – Zur chronologischen, ethnischen und historischen Auswertbarkeit des ostgermanischen Fundstoffs des 5. Jahrhunderts in Südosteuropa und Italien, «Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz», 38, pp. 541-592.
Bierbrauer V., 1994, Archäologie und Geschichte der Goten vom 1.-7. Jahrhundert Versuch einer Bilanz, «Frühmitte-laterliche Studien», 28, pp. 51-171.
Bierbrauer V., 2007a, Ostgermanen in mittleren und unteren Donauraum. Die hunnische Herrschaft, in Attila und die Hunnen 2007, pp. 97-103.
Bierbrauer V., 2007b, Neue ostgermanische Grabfunde des 5. und 6. Jahrhunderts in Italien, «Acta Praehistorica et Archaeologica», 39, pp. 93-124.
Bierbrauer V., 2008, Ethnos und Mobilität im 5. Jahrhundert aus archäologischer Sicht: Vom Kaukasus bis nach Nie-derösterreich, Bayerische Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse, Abhandlungen, Neue Folge, 131, München.
Böhme H.W., 1974, Germanische Grabfunde des 4. bis 5. Jahrhunderts zwischen unterer Elbe und Loire, Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, 19, München.
Böhme H.W., 1994, Der Frankenkönig Childeric zwischen Attila und Äetius. Zu den Goldgriffspathen der Merowin-gerzeit, in C. Dobiat (a cura di), Festschrift für Otto-Her-man-Frey zum 65. Geburtstag, «Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte», 16, pp. 69-110.
Bökönyi S., 1988, Analisi archeozoologica dello scheletro del cavallo nella necropoli di Vicende, «Conoscenze», 4, pp. 69-75.
Bóna I., 1979, Das Reitergrab von Szegvár-Sápoldal, «Archeo-logiai Ertesito», 106, pp. 3-32.
Bóna I., 1989, Beiträge zum asiatischen Ursprungs der awa-renzeitlichen partiellen Pferdebestattungen, in International conferenze on early middle Ages, «A Wosinski Mór Mú-zeum Évkönyve», XV, Szeksárd, pp. 113-124.
Bóna I., 1991, Das Hunnenreich, Stuttgart.Bóna I., Nagy M., 2002, Gepidische Gräberfelder am Theis-
sgebiet, I, Monumenta Germanorum Archaeologica Hun-gariae, I, Monumenta Gepidica, Budapest.
Brogiolo G.P., 2007, Episodi militari e castelli nel territorio gardesano tra tardo antico e altomedioevo, «Annali bena-censi», 13-14, pp. 287-302.
Brogiolo G.P., Possenti E., 2008, Aktuelle Forschungen und Ansätze der langobardischen Archäologie in Italien, in J. Bemmann, M. Schmauder (a cura di), Kulturwandel in Mitteleuropa, Langobarden-Awaren-Slawen, Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte, 11, Bonn, pp. 449-466.
Checchi A., De Mani G., 1996, Il guerriero di Canova, «Studi e Ricerche», VI, pp. 42-43.
Ciampoltrini G., 1991, Capraia (Livorno). Materiali di corredo tardoantico, «Bollettino di Archeologia», 7, pp. 54-59.
Cižmár Z., Tejral J., 2002, Kriegergräber aus dem 5. Jh. n. Chr. in Prostejov-Držovice, in Tejral 2002b, pp. 99-124.
Cseh J. et al., 2005, Gepidische Gräberfelder am Theissgebiet, II, Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae, II, Monumenta Gepidica, Budapest.
Diaconu et al. 1977 = Diaconu G., Tzony M., Costanti-nescu M., Drambocianu V., L’ensemble archéologique de Pietroasele, «Dacia», XXI, pp. 199-220.
De Palma G., 1985, Terme di Cotilia, in Archeologia Laziale VII, Settimo incontro di studio del comitato per l’archeolo-gia laziale, Quaderni del centro di studio per l’archeologia etrusco-italica, 11, Roma, pp. 185-192.
De Grossi Mazzorin J., 1995, La fauna rinvenuta nell’area del-la Meta Sudans nel quadro evolutivo degli animali domestici in Italia, in Atti del 1° Convegno Nazionale di Archeozoolo-gia (Rovigo 1993), Padusa Quaderni, 1, pp. 309-318.
Dmitrijev A.V., 1979, Pogrebeniya vsadnikov i boevyh konei v mogil’nike epohi pereseleniya narodov na r. Djurso bliz Novo-rossiiska, «Sovjetskaja Archelogija», 4, 1979, pp. 212-229.
Dmitrijev A.V., 1982, Rannesrednevekovie fybuli yz mogyl-nika ma r. Djurso, in Drevnosti epochi velikogo pereselenija narodov V-VIII vekov, Moskva, pp. 69-106.
Feugère M., 2002, Les armes des Romains de la République à l’Antiquité tardive, Paris.
Fingerlin G., 1967, Eine Schnalle mediterraner Form aus dem Reihengräberfeld Güttingen, Ldkrs. Konstanz, «Badische Fundberischte», 23, pp. 159-184.
Fischer T., Precht G., Tejral J. (a cura di), 1999, Germanen beiderseits des spätantiken limes, Spicy archeologického Ústavu av cr Brno, 14, Köln-Brno.
Friesienger H., 1984, Bemerkungen zu den frühgeschichtli-chen Grab- und Siedlungsfunden von Wien-Leopoldau, «Archaeologia Austriaca», 68, pp. 127-154.
Gallien in der Spätantike 1980 = Gallien in der Spätantike. Von Kaiser Constantin zu Frankenkönig Childerich, Catalogo della mostra (Mainz, 29 ottobre 1980-4 gennaio 1981), Mainz.
Germanen Hunnen und Awaren 1987 = Germanen Hunnen und Awaren, Schätze der Völkerwanderungszeit, Catalogo della mostra (Nürnberg, 12 dicembre 1987-21 febbraio 1988), Nürnberg.
Gilles K.-J., 1979, Ein spätrömischer Ortbandbeschlag aus Trier, «Trierer Zeitschrift», 42, pp. 129-133.
Godłowski K., 1995, Das «Fürstengrab» des 5. Jhs. und der «Fürstensitz» in Jakusowice in Südpolen, in Vallet, Kazanski 1995, pp. 155-179.
Gomolka-Fuchs G., 1999a, Zur Militärbesatzung im spätrö-mischen Limeskastell Iatrus vom 4. bis zum zweiten Viertel des 5. Jahrhunderts, «Eurasia Antiqua», 5, pp. 509-522.
Gomolka-Fuchs G. (a cura di), 1999b, Die Sîntana de Mures-Cerniachov-Kultur, Akten des Internationalen Kolloquiums in Caputh vom 20. bis 24. Oktober 1995, Kolloquien zur Vor-und Frühgeschichte, 12, Bonn.
Gürçay Damm I., 1988, Goldschmiedearbeiten der Völke-rwanderungszeit aus dem nördlichen Schwarzmeergebiet. Katalog der Sammlung Diergardt 2, «Kölner Jahrbuch für Vor-und Frühgeschichte», 21, pp. 65-210.
Harhoiu R., 1988, Das Kurzschwert von Micia, «Dacia» 32, pp. 79-91.
Herrmann F.-R., 1969, Der Eisenhortfund aus dem Kastell Künzing, «Saalburg Jahrbuch» XXVI, pp. 129-141.
Kazanski M., 1988, Le mobilier funéraire de la tombe de Childeéric Ier, «Revue Archéologique de Picardie», 3/4, pp. 13-55.
Kazanski M., 1991, A propos des éléments de harnachement “orientaux” en occident à l’époche des Grandes Migra-tions (IVe-Ve S.) «Journal of Roman Archaeology», 4, pp. 123-139.
456
NOTE E DISCUSSIONI
Kazanski M., 1994, Les plaques-boucles méditerranéennes des Ve-VIe siècles, «Archéologie Médievale», XXIV, pp. 137-198.
Kazanski M., 1999, Les tombes des chefs militaires de l’époque hunnique, in Fischer, Precht, Tejral 1999, pp. 293-316.
Kazanski M., 2002, Die Chronologie der Anfangsphase des Gräberfeldes von Djurso, in Tejral 2002b, pp. 137-157.
Kazanski M., Mastykova A., 2007, La civilisation de Tsebel-da, in M. Kazanski, A. Mastykova (a cura di), Tsibilium. La necropoli apsile de Tsibilium (VIIe av. J.-C.-VIIe J.C.). (Abkhazie, Caucase), 2, L’étude di site, BAR International Series S1721, pp. 13-53.
Kazanski M., Mastykova A., Périn P., 2002, Byzance et les royaumes barbares d’Occident au début de l’époque mérovingienne, in Tejral 2002b, pp. 159-193.
Kokowski A., 1993, L’art militaire des Goths à l’époque romai-ne tardive (d’après les données archéologiques), in Vallet, Kazanski 2003, pp. 335-354.
Keller E., 1971, Die spätrömischen Grabfunde in Südbayern, Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, 8, Mün-chen.
Koch U., 1977, Das Reihengräberfeld bei Schretzheim, Germa-nische Denkmäler der Völkerwanderungszeit, A, 13, Berlin.
Konrad M., 1997, Das römische Gräberfeld von Bregenz-Bri-gantium I, Münchner Beiträge zur Vor-und Frühgeschichte, 51, München.
Kostromichev D.A., 2008, Details of weapon and Military Costume from the “Citadel” of Chersonesos, «Materialy po archeologij, istorii i étnografii Tavrii», XIV, pp. 39-60.
Levinschi A., 1999, Gräberfelder der späten Sîntana de Mures-Cerniachov-Kultur, in Gomolka-Fuchs 1999b, pp. 23-32.
Lichiardopol D., Ciuperca B., 2008, The presence of the Alans in the Lower Danube region during the Age of the Huns, in Hunnen zwischen Asien und Europa, Speyr, pp. 109-118.
L’or des princes barbares 2000 = L’or des princes barbares. Du Caucase à la Gaule Ve siècle après J.-C., Catalogo della mostra (Saint-Germain-en-Laye, 26 settembre 2000-8 gennaio 2001), Paris.
Marcu D., 1987, Un mormînt de înumatie descoperit la Bistret, jud. Dolj, «Studi si Cercetari istorie veche si archeologie», 38, pp. 184-191.
Mastykova A., 2002, Soziale Hierarchie der Frauengräber der nordkaukasischen Dürso-nekropole im fünftem bis sechsten Jahrhundert (anhand der Trachtmaterialen), in Tejral 2002b, pp. 225-236.
Menghin W., 1994-95, Schwerter des Goldgriffspathehorizon-ts im Museum für Vor- und Frühgeschichte, Berlin, «Acta Praehistorica et Archaeologica», 26-27, pp. 140-191.
Micheletto E., 2003, Materiali di età gota in Piemonte: un aggiornamento, in R. Fiorillo, P. Peduto (a cura di), III Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Salerno 2003), II vol., Firenze, pp. 697-704.
Miks C., 2007, Studien zur römischen Schwertbewaffnung in der Kaiserzeit, I-II, Kölner Studien zur Archäologie der Römischen Provinzen, 8, Rahden/Westfalen.
Moosbrugger-Leu R., 1970, Die Schweiz zur Merowinger-zeit, Bern.
Müller R., 2010, Die Gräberfelder vor der Südmauer der Befestigung von Keszthely-Fenékpuszta, Castellum Pann-nonicum Pelsonense, I, Rhaden/Westfalen.
Párducz M., 1959-60, Archäologische Beiträge zur Geschichte der Hunnenzeit in Ungarn, «Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae», 11-12, pp. 309-398.
Petkovic S., 1998, Meaning and Provenance of Horses’ Pro-tomes Decoration on the Roman Antler Combs, «Starinar», XLIX, pp. 215-228.
Pinar J., Ripoll G., 2007, Männergräber in Aquitanien, Septi-manien und Hispanien (ca. 450-520). Neue Überlegungen, «Acta Praehistorica et Archaeologica», 39, pp. 65-92.
Possenti E., 2005, Un rinvenimento della seconda metà del V secolo a Villalta di Gazzo, in S. Gelichi (a cura di), L’Italia alto-medievale tra archeologia e storia. Studi in ricordo di Ottone d’Assia, Padova, pp. 205-235.
Possenti E., 2007, Abbigliamento e rango in Italia settentrio-nale tra V e VI secolo, in G.P. Brogiolo, A. Chavarría Arnau (a cura di), Archeologia e società tra tardo antico e alto medioevo, Documenti di Archeologia, 44, Mantova, pp. 279-298.
Possenti E., 2008, Elemento decorativo unnico di cintura, in G. Piussi (a cura di), Cromazio di Aquileia 388-408 al crocevia di genti e religioni, Catalogo della mostra (Udine, 6 novem-bre 2008-8 marzo 2009), Cinisello Balsamo, p. 130
Possenti E., 2011, Presenze orientali e bizantine nella Ve-netia di V e VI secolo, in C. Ebanista, M. Rotili (a cura di), Archeologia e storia delle migrazioni: Europa Italia, Mediterraneo fra tarda età romana e alto medioevo, pp. 141-156.
Quast D., 1999, Auf del Suche nach fremden Männern – Die Herleitung schmalen Langsaxe vor dem Hintergrund der alamannisch-donauländischen Kontakte der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts, in Fischer, Precht, Tejral 1999, pp. 115-128.
Reggiani P., Rizzi J., 2005, I resti del cavallo rinvenuti nella tomba di via Canove ad Arzignano (Vicenza), in Atti del 3° Convegno Nazionale di Archeozoologia (Siracusa 2000), pp. 459-468.
Salvadori F., 2009, Indicatori archeozoologici nell’età di transizione, in G. Volpe, P. Favia (a cura di), V Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Foggia-Manfredonia 2009), Firenze, pp. 40-44.
Schmauder M., 2002, Oberschichtgräber und Verwahrfunde in Südosteuropa im 4. und 5. Jahrhundert, Bukarest.
Schülze-Dörrlamm M., 2002, Byzantinische Gürtelsch-nallen und Gürtelbeschläge im römisch-germanischen Zentralmuseum, Teil I, Die Schnallen ohne Beschläg, mit Laschenbeschläg und mit festem Beschläg des 5. bis 7. Jahrhundert, Kataloge Vor-und Frühgeschichtlicher Alter-tümer, 30, 1 Mainz.
Simonenko A.V., 2001, Bewaffnung und Kriegswesen der Sar-maten und späte Skyten im nördlichen Schwarzmeergebiet, «Eurasia Antiqua», 7, pp. 187-327.
Skutil J., 1941, Moravské prehistorické vycopy a nàlezy Oddelení mor. praveku Zemského musea 1933-1936, «Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums», N.F., I, pp. 180-181.
Sommer M., 1984, Die Gürtel und Gürtelbeschläge des 4. und 5. Jahrhunderts im römischen Reich, Bonner Hefte zur Vorgeschichte, 22, Bonn.
Sopault V. 1995, Les tombes à épée au nord-est et à l’est de la mer Noir au Bas-Empire, in Vallet, Kazanski 1995, pp. 227-245.
Steuer H., 2003, Pferdegräber, in Reallexikon der Germani-schen Altertumskunde, 23, Berlin-New York, pp. 50-96.
Szameit E., 1984, Zu den Waffen von Wien-Leopoldau «Ar-chaeologia Austriaca», 68, pp. 136-152 (contributo all’in-terno di Friesienger 1984).
Tejral J., 1988, Zur Chronologie der frühen Völkerwanderun-gszeit im mittleren Donauraum, «Archaeologia Austriaca», 72, pp. 223-304.
457
NOTE E DISCUSSIONI
Tejral J., 1992, Einige Bemerkungen zur Chronologie der späten Römischen Kaiserzeit im Mitteleuropa, in Probleme der relativen und absoluten Chronologie ab Latènzeit bis zum Frühmittelalter, Krakow, pp. 227-248.
Tejral J., 2002a, Neue Erkenntnisse zur Frage der donaulän-disch-ostgermanischen Krieger- beziehungsweise Männer-gräber des 5. Jahrhunderts, «Fundberichte aus Österreich», 41, pp. 496-524.
Tejral J. (a cura di), 2002b, Probleme der frühen Merowin-gerzeit im Mitteldonauraum, Spicy archeologického Ústavu av cr Brno, 19, Brno.
Tejral J., 2007a, Das Hunnenreich und die Identitätsfragen der barbarischen “gentes” im Mitteldonauraum aus der Sicht der Archäologie, in Tejral 2007b, pp. 55-119.
Tejral J. (a cura di), 2007b, Barbaren im Wandel, Beiträge zur Kultur-und Identitätsumbildung in der Völkerwanderungs-zeit, Spicy archeologického Ústavu av cr Brno, 26, Brno.
Tejral J., 2007c, Das Attilareich und die germanischen gentes im Mitteldonauraum, in Attila und die Hunnen 2007, pp. 107-113.
Tomka P., 2007, Über die Bestattungsitten der Hunnen, in Attila und die Hunnen 2007, pp. 253-257.
Trohani G., Zorzoliu T., 1983, O necropoli din sec. al IV-lea e.n. descoperita la Draganesti-Olt, «Cercetari Arheologice», VI, pp. 209-223.
Vallet F., 1993, Une implantation militaire aux portes de Dijon au Ve siècle, in Vallet, Kazanski 1993, pp. 249-258.
Vallet F., Kazanski M. (a cura di), 1993, L’armée romaine et les barbares du IIIe au VIIe siècle, Mémoires publiées par l’Association Française d’Archéologie Mérovingienne, V.
Vallet F., Kazanski M. (a cura di), 1995, La noblesse romai-ne et les chefs barbares du IIIe au VIIe siècle, Mémoires publiées par l’Association Française d’Archéologie Méro-vingienne, IX.
von der Lohe K., 1999, Das Gräberfeld von Skalistoje auf der Krim und die Ethnogenese der Krimgoten, Die Frühphase (Ende 4. bis Anfang 6. Jahrhundert), in Gomolka Fuchs 1999b, pp. 33-58.
Voronov J., 1995, La civilisation matérielle de l’aristocratie apsile (la côte est de la mer Noire) du IVe au VIe siécle, in Vallet, Kazanski 1995, pp. 217-225.
Voronov J.N., Senkao N.K., 1982, Vooruzenie voinov Abhazii IV-VII vv, in Drevnosti epohi velikogo pereselenija narodov V-VIII vekov: sovetsko-rengerskij sbornik, Moskva, pp. 121-165.
Wernard J., 1998, “Hic scramasaxi loquuntur”. Tipologi-sch-chronologische Studie zur einschneidigen Schwert der Merowingerzeit in Süddeutschland, «Germania», 76, pp. 747-787.
Werner J., 1956, Beiträge zur Archäologie des Attila-Reiches, Bayerischer Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Abhandlungen, N.F. 38, München.
Werner J., 1966, Spätrömische Schwertortbänder vom Typ Gunderemmingen, «Bayerische Vorgeschichtblätter», 31, pp. 134-141.
Zanier W., 1988, Römische dreiflügelige Pfeilspitzen, «Sal-burg-Jahrbuch», 44, pp. 5-27.
Zotovic L., 1980, Nekropola iz vermena seobe naroda sa uže gradske teritorije Viminacija, «Starinar», n.s., XXXI, pp. 95-115.