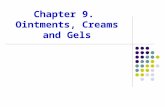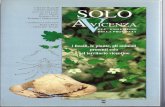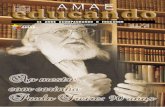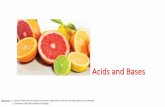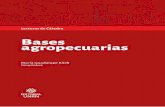Paragano D. And F. Fois ‘Localization of military bases and opposition movements: the case of...
Transcript of Paragano D. And F. Fois ‘Localization of military bases and opposition movements: the case of...
Riv. Geogr. Ital.119 (2012), pp. 373-399
DANIELE PARAGANO, FRANCESCA FOIS
STRUTTURA E SPAZIALITÀ DEI MOVIMENTI DI OPPOSIZIONE
ALLA LOCALIZZAZIONE DI BASI MILITARI: IL CASO DI VICENZA
IntroduzIone. – Una base militare, definibile come un’installa-zione permanente destinata all’utilizzo delle forze armate (Calder, 2007; Harkavy, 1989), costituisce un elemento altamente impattan-te sugli equilibri locali, anche in fase di non conflitto. Nonostante i tentativi di ridurre i loro effetti, le basi militari, in particolar modo nella fase dell’installazione, generano una decisa frattura all’interno degli equilibri locali preesistenti. Sempre più frequentemente dai processi di costruzione e ampliamento di strutture militari sca-turiscono movimenti di protesta e opposizione (Mccaffrey, 2002). Tali opposizioni potrebbero portare a includere le basi militari tra le opere, sovente pubbliche, sgradite alle comunità e che generano confitti locali (Bobbio e Zeppetella, 1999; Della Porta e Piazza, 2008; Faggi e Turco, 1999; Fedi e Mandarini, 2008). Nel coacervo delle opere sgradite, tuttavia, le basi militari costituiscono un caso particolare, come verrà evidenziato nel corso del lavoro, per via della loro natura, della loro funzione e delle specificità del processo decisionale ad esse associato.
La costruzione di strutture militari è spesso il risultato di un percorso decisionale articolato su vari livelli nel quale s’inseriscono elementi di natura politica e militare, sovente considerati d’ordine superiore e/o di interesse collettivo. Allo stesso tempo nella piani-ficazione dei siti idonei talune caratteristiche territoriali assumo-
* Il lavoro è frutto di una riflessione comune e le tesi esposte sono di piena respon-sabilità degli autori. Un ringraziamento particolare a Filippo Celata e Giuseppe Fiorino che hanno contribuito con commenti e riflessioni critiche alle prime stesure del testo e ai due revisori anonimi.
374
no un aspetto centrale, tale da rendere ogni sito essenziale per il mantenimento dell’intero quadro strategico. La presenza di questi elementi fa sì che l’eventuale progetto possa difficilmente essere oggetto di negoziazioni o modifiche.
In questo contesto i movimenti d’opposizione alla presenza militare assumono, spesso, una portata che travalica il solo ridi-mensionamento o annullamento del progetto, ma acquisiscono soprattutto finalità simboliche. La presenza di tali motivazioni, che discendono dalla natura stessa delle istallazioni, costituisce un elemento centrale e caratterizzante l’opposizione contro le basi militari. La presenza di questi elementi genera sia una mutazione degli obiettivi e della natura della protesta sia, allo stesso tempo, una sua crescita dimensionale e un incremento di visibilità e d’at-tenzione sul tema.
In questo quadro, l’obiettivo del lavoro è analizzare non solo come un movimento d’opposizione locale si strutturi e agisca, in relazione a una decisione apparentemente indiscutibile come la costruzione di una base militare sul proprio territorio, ma anche come questi elementi possano originare a diverse spazialità e una differente genesi e percezioni dei luoghi. Dal punto di vista teori-co, l’analisi si riconnette principalmente a due filoni di ricerca: la geografia militare critica e il dibattito sui movimenti sociali. La geografia militare critica (Woodward, 2004; Woodward, 2005), ribaltando l’approccio consueto e tradizionale tra conoscenza geo-grafica e tecniche militari (Paragano, 2009) pone l’attenzione sulle geografie degli spazi militarizzati e su come la presenza militare possa avere ricadute territoriali. All’interno dell’ampia letteratura sui movimenti sociali, invece, verranno utilizzati alcuni recenti contributi volti ad analizzare in maniera relazionale le variabili considerate più determinanti per la comprensione dei movimenti d’opposizione (Bosco, 2001; Della Porta e Piazza, 2008; Diani e Mcadam, 2003; Fedi e Mandarini, 2008; Leitner et al., 2008; Nichol-ls, 2009; Pierce et al., 2011).
La prima parte del lavoro è finalizzata a comprendere il ruo-lo delle basi militari (in particolar modo statunitensi) all’interno dell’attuale contesto strategico e, in particolare, le motivazioni che portano alla localizzazione di nuove strutture e la centralità delle componenti territoriali. Nella seconda parte dell’articolo il movi-mento di opposizione vicentino “No Dal Molin” verrà analizzato all’interno del quadro teorico, in particolare, considerando quattro
375
variabili di riferimento (networks, motivazioni, spazialità e luo-ghi). Interviste in profondità e l’analisi dei documenti prodotti dal movimento costituiscono il supporto metodologico utilizzato per comprendere le dinamiche, la spazialità e le ragioni politiche alla base del conflitto.
2. - La LocaLIzzazIone deLLe basI mILItarI e I Loro effettI suL ter-rItorIo.
2.1 Le basi militari all’estero nel contesto internazionale. – L’idea di base militare richiama, nell’immaginario collettivo, il ricordo di contrapposizioni passate, ormai al limite del desueto, narrando storie d’avamposti romani, d’imperi coloniali o di contrapposizio-ne bipolare. Con la caduta del cosiddetto sistema dei due blocchi, sia nella retorica del conflitto sia nell’immaginario collettivo, una presenza massiccia di forze armate stanziate sul territorio che si contrappongono è sembrata poter diventare solo un ricordo. Le evoluzioni nel quadro delle relazioni internazionali, soprattutto in relazione alla fine dell’equilibrio bipolare, l’emergere di nuove tecniche militari (come la urban warfare e la 4th generation warfare) e l’utilizzo massiccio della tecnologia (Alberts et al., 2000; Aspin, 1993; Echevarria Ii, 2004, 2005; Kundani, 2004; Lind et al., 1989; Mini, 2008; Nye, 2005; Perry, 2004) avrebbero potuto far ipotizza-re la possibilità di una drastica riduzione del numero delle basi all’estero e del loro ruolo all’interno delle relazioni internazionali (Paragano, 2009). Nonostante tali premesse, la presenza militare sul territorio costituisce invece un elemento costante, sebbene in continuo mutamento in termini spaziali e funzionali.
La centralità del posizionamento militare estero nella politica degli Stati Uniti, paese con il maggior numero di militari stanziati fuori dai propri confini anche in fase di non conflitto, è stata riba-dita dalla predisposizione nel 2004 del principale piano di riposi-zionamento strategico successivo a quello degli anni ’50 (1) (Har-kavy, 2005). Il piano del 2004 esplicita sia il ruolo che dovrebbero avere le basi militari nel corso dei prossimi decenni sia le future
(1) In particolar modo si fa riferimento al nsc68 – United States Objectives and Programs for National Security (4 aprile 1950) che costituisce il principale piano di ri-posizionamento globale strutturato, precedente a quello del 2004. Per approfondimenti si può anche fare riferimento a Paragano, 2009.
376
strategie militari, delle quali il posizionamento strategico rimane un elemento centrale. In particolare, quello che emerge dal nuovo progetto di posizionamento strategico è un approccio diverso basa-to principalmente su una dislocazione più flessibile delle basi. La nuova pianificazione non è più orientata intorno a un centro rap-presentato dall’Unione Sovietica (threat-based planning), ma incline a interventi rapidi, diffusi e potenzialmente verificabili in un’area più estesa, capabilities-based approach (Krepinevich e Work, 2007). I profondi cambiamenti geopolitici internazionali e la necessità di ridurre le spese militari conducono anche a un posizionamento delle basi secondo una struttura hub and spoke, con alcune basi in cui accentrare le funzioni principali che fungono da riferimento per una serie di strutture minori di limitate dimensioni e maggior-mente diffuse territorio tra i vari paesi ospitanti (Paragano, 2009; Department of Defense, 2004).
Le differenti funzioni assegnate alle basi, il quadro delle rela-zioni internazionali e le dotazioni tecnologiche portano alla defini-zione di regioni d’interesse strategico (Paragano, 2009) all’interno delle quali diventano determinanti gli elementi territoriali. All’in-terno delle regioni d’interesse strategico, definite a scala globale, la determinazione dei siti idonei muove principalmente da moti-vazioni di natura infrastrutturale. Accanto alla necessità di condi-zioni fisiche e morfologiche adatte all’installazione, le basi militari devono poter avere accesso a delle infrastrutture di base essenziali, di collegamenti con i principali nodi di trasporto e l’accesso a fonti di approvvigionamento, in particolar modo di combustibile. Oltre a queste motivazioni di carattere infrastrutturale, la presenza o la prossimità di elementi d’interesse turistico costituiscono un valore aggiunto per le strutture militari, destinate ad accogliere i soldati e le loro famiglie spesso per lunghi periodi.
Un ulteriore aspetto che dovrebbe essere centrale è l’accetta-zione da parte della popolazione; secondo le attuali impostazioni, le truppe usa in fase di non conflitto dovrebbero essere “invocate, benvenute e richieste” (Rumsfeld, 2004). Proprio quest’aspetto risulta essere sempre più di difficile raggiungimento, stando alle esperienze che provengono principalmente dai paesi, quali Italia, Sud Corea, Giappone e Germania, in cui questa presenza è mag-giore e maggiormente consolidata nel tempo. Questa crescente ostilità verso nuove installazioni può essere ricondotta alla variata percezione dei benefici della loro presenza a fronte dell’incremento
377
delle loro criticità. La fine del paradigma bipolare, all’interno del quale queste installazioni erano state accettate dalla popolazione, ne ha mutato la funzione di difesa del paese ospitante da potenziali invasioni estere in una pressione militare proprio sul paese ospi-tante. Il nuovo quadro di posizionamento globale accresce infatti il ruolo simbolico delle basi militari rispetto alla loro funzione ope-rativa. La presenza di un numero elevato di forze armate, nonché lo stanziamento di armamenti (talvolta anche nucleari) costituisce un potenziale strumento di pressione diplomatica, anche se legato da alleanze, per il paese ospitante.
La crescente autosufficienza delle installazioni militari, inoltre, riduce l’impatto economico che un’installazione militare potrebbe apportare al territorio in cui fa parte. La presenza di servizi all’in-terno delle basi e l’obiettivo sempre più centrale della riduzione dei costi conducono, in molti casi, alla nascita di vantaggi d’agglomera-zione conseguenti a precise strategie di posizionamento delle nuove basi in territori che già ospitano altre strutture simili, dando vita a spazi altamente militarizzati.
Le dinamiche localizzative che si esprimono alle varie scale, sono tra loro legate in maniera decisa e sono difficilmente modifi-cabili. La definizione dei singoli siti, anche se derivanti da motiva-zioni totalmente differenti alla pianificazione a scala globale, costi-tuisce elemento centrale per la definizione dell’intero sistema; un ipotetico spostamento, anche minimo, di una base, quindi, potreb-be portare all’impossibilità di localizzazione in quella regione, met-tendo in discussione l’intero posizionamento, visto che molti degli elementi necessari alla costruzione di una base sono difficilmente riproducibili o ricreabili se non a costo di ingenti investimenti.
2.2 Le basi militari, opere spesso sgradite: gli effetti della presenza militare sul territorio e le cause di opposizione locale. – La cronaca e parte della letteratura critica sul tema delle basi militari enfatiz-za come, in particolar modo nei paesi di antica presenza militare estera, la costruzione di nuove strutture costituisca spesso fonte di vigorose opposizioni da parte delle comunità locali (Mccaffrey, 2002). Per comprendere le possibili cause di tali opposizioni, può essere opportuno analizzare i principali effetti territoriali di un’in-stallazione militare: in primo luogo verranno analizzati gli effetti economici, successivamente quelli culturali e sociali e infine le pos-sibili conseguenze ambientali.
378
L’aspetto maggiormente connesso alla presenza militare è quel-lo economico. Tale aspetto costituisce il principale elemento a soste-gno della presenza delle basi militari anche se la portata economica delle basi militari sovente viene ad essere sopravvalutata (Poppert e Herzog, 2003). La valutazione degli effetti economici della presenza militare è resa complessa sia dalla presenza di elementi secretati, che rendono difficile la misura degli investimenti, sia per la trasver-salità dei suoi effetti; le ricadute economiche presunte, infatti, sono soprattutto di tipo indotto e quindi difficilmente misurabili nella loro totalità e imputabili alla presenza militare. Tali effetti, tuttavia, evidenziano negli ultimi anni un deciso ridimensionamento dovu-to principalmente alle differenti gestioni delle strutture militari, orientate verso l’accentramento delle strutture dei servizi e delle funzioni necessarie al suo operato all’interno delle basi. L’elevata e crescente autosufficienza delle basi riduce quindi drasticamente le connessioni tra la base e il territorio in cui è inserita, creando una sorta di enclave militare. L’effetto principale della presenza milita-re, in termini economici, può essere quindi ravvisato nello stesso processo di costruzione. Questo, tuttavia, non può essere conside-rato foriero di crescita locale sia per la sua limitatezza temporale sia per la sua restrizione a poche imprese appaltanti (Simich, 1991). Nel medio termine, invece, la presenza di servitù militari e di limitazioni connesse alla presenza d’installazioni militari (2), potrebbe avere un effetto deleterio sullo sfruttamento produttivo del territorio, in particolar modo a finalità turistiche (Camera dei deputati, 2007). Gli impatti economici delle basi militari, tuttavia, dipendono decisamente dal contesto territoriale in cui sono inserite e in particolar modo dalla dimensione dei centri urbani in cui sono localizzate (Woodward, 2004).
La letteratura geografica si è spesso soffermata sull’impatto che la presenza militare può avere in termini di spin off tecnologico. La nascita di cluster tecnologici è spesso stata legata, come mostrano alcune analisi empiriche dell’industrializzazione del sunbelt ame-ricano (Markusen et al., 1991; Saxenian, 2002), alla presenza di basi militari. I cospicui investimenti accordati dalle forze armate statunitensi a centri d’eccellenza universitari e imprese di tecno-
(2) Per un approfondimento sulle tipologie di limitazioni connesse alla presenza militare e della sua misura sul territorio nazionale si rimanda a precedenti pubblicazioni (Paragano, 2009).
379
logie belliche sono stati ampiamente analizzati per il loro ruolo di volano dello sviluppo industriale. Tali effetti, tuttavia, non possono verificarsi nel caso della presenza di forze armate estere poiché, i processi d’innovazione vengono svolti esclusivamente presso le strutture nazionali mentre alle basi localizzate fuori dai confini vengono trasferite tecnologie mature.
Se l’impatto economico costituisce la dimensione più rilevante nel dibattito sui benefici connessi alla presenza militare, gli effetti di quest’ultima non si limitano a tale ambito. La presenza stabile di strutture e forze militari può dar luogo a fenomeni di militariz-zazione (3) della società. La presenza militare ha spesso costituito anche un elemento cruciale dell’espansione culturale costituendo un mezzo di trasferimento di valori e attitudini differenti da quelli della società locale (Shaw, 1991; Baker, 2004) ed essendo in molti casi il primo momento di contatto tra culture diverse. In termini sociali, un aspetto molto complesso è la connessione tra presenza militare straniera e sicurezza. Le strutture militari, in particolar modo estere, sviluppano sistemi di sicurezza ad hoc per la propria difesa e non del territorio in cui sono inserite, che viene invece lasciata alle locali forze di polizia. La presenza militare, inoltre, potrebbe rappresentare una fonte d’insicurezza per l’area ospitante sia perché la rende obiettivo di possibili azioni di terrorismo sia per fenomeni di criminalità comune (in particolar episodi di violenza e problematiche connesse alla prostituzione) legati, soprattutto, all’abuso di sostanze alcooliche da parte dei militari (Baker, 2004; Woodward, 2004; Cooley e Marten, 2006).
Infine, uno degli aspetti più controversi connessi alla presen-za militare in un territorio è l’impatto ambientale delle attività militari in fase di non conflittualità. Come evidenziato da Rachel Woodward (2004), tali effetti sono decisi e interessano molteplici aspetti; questi effetti vengono tuttavia ridimensionati nel dibattito pubblico anche a seguito della segretezza circa le attività svolte. La stessa presenza militare viene indicata positivamente come tu-tela nei confronti dell’eccessiva antropizzazione di alcuni territori (Camera dei deputati, 2007). Ancor più delicata è la valutazione
(3) Il termine “militarizzazione” è spesso utilizzato quale sinonimo di “milita-rismo”. Dall’analisi della letteratura (Lumsden, 1980; Shaw, 1991; Thee, 1980, tra gli altri), nell’applicazione con la quale si intende utilizzarlo, è da preferirsi il primo. Per una trattazione più estesa delle differenze terminologiche si rimanda a lavori precedenti (Paragano, 2009).
380
dell’impatto che le attività militari, in particolar modo i poligoni, possono avere sulla salute delle persone che vi vivono in prossimità. Questo problema è stato ampiamente dibattuto, sia nella letteratu-ra medica sia legale, in relazione all’utilizzo dell’uranio impoverito e in quella che viene comunemente definita sindrome di Quirra (4). Tra le conseguenze ambientali, inoltre, si possono annoverare i decisi impatti sulla struttura urbana e sulla viabilità.
La presenza delle basi militari, nel suo complesso, impone un differente utilizzo dello spazio e dei luoghi in cui si localizza, carat-terizzandoli in tutte le sue componenti fisiche e sociali.
3. – IL caso dI VIcenza: La creazIone deLLa base mILItare e gLI effettI suL terrItorIo.
3.1 Perché Vicenza? L’importanza del sito nel nuovo progetto di posizionamento strategico statunitense. - All’interno del quadro di riposizionamento globale messo in atto dagli Stati Uniti a partire dal 2004, la dislocazione delle basi presenti in Italia sta manifestan-do decisi cambiamenti (cromfs, 2005; Jones, 2006). Ad esser inte-ressato è il complesso di installazioni militari, presenti a Vicenza. La città costituisce, a partire dal 1965, un sito d’elevato interesse per gli Stati Uniti. Accanto alla base attualmente attiva (Caserma Ederle), è stato infatti presente per lungo tempo un sito, denomi-nato Site Pluto (Fig. 1), spesso indicato come deposito di stoccaggio di elementi nucleari (Desiderio, 2007; Assemblea permanente “No Dal Molin”, 2008). Oltre alla presenza di militari statunitensi, il cui numero è notevolmente cresciuto nel corso degli anni, la presenza di altre istituzioni militari sovranazionali (tra i quali il comando generale della Gendarmeria Europea) fa di Vicenza una città a ele-vata militarizzazione.
Nella politica di concentrazione delle basi, prevista all’interno del piano usa, la base di Vicenza sarà destinata ad accogliere altre componenti della 173a brigata aviotrasportata attualmente disposta anche in due sedi in Germania. La presenza militare a Vicenza,
(4) Con sindrome di Quirra viene definita la diffusione elevata e maggiore rispetto alle medie nazionali di malattie tumorali fatta registrare dalla popolazione residente in prossimità del Poligono interforze di Quirra. Per approfondimenti si rimanda, tra gli altri, a Camera dei deputati: Commissione IV Difesa, 2007; Cao, 2005; Masella e Saso, 2007a; Masella et al., 2007; Di Martino e Alegi, 2006.
381
connessa logisticamente (seppur non funzionalmente) a quella sita in Aviano e a Camp Darby, dovrebbe quindi costituire una sorta di polo militare statunitense.
La creazione di nuove installazioni militari nella città si con-cretizza nell’utilizzo dell’aeroporto cittadino “Dal Molin” (prece-dentemente gestito dall’aeronautica italiana quale aeroporto civile), che si localizza in prossimità del centro cittadino in posizione dia-metralmente opposta all’attuale base usa.
Fig. 1 – Disposizione delle aree militari gestite dagli Stati Uniti nella città di Vicenza.Fonte: Elaborazione propria
La struttura, sulla cui progettazione definitiva permangono ipotesi contrastanti e i cui lavori in corso d’opera si sviluppano
fornire originale migliore
382
sulla parte ovest dell’area (5), dovrebbe portare allo sviluppo di una base completa destinata ad accogliere altri 2.000 militari (raddop-piando quindi la popolazione militare usa presente in città).
3.2 La presenza statunitense a Vicenza: l’evoluzione di una coope-razione verso il conflitto. – Le relazioni tra presenza militare statu-nitense e tessuto urbano vicentino si sono decisamente modificate nel corso degli anni, come evidenziato anche da testimonianze degli stessi cittadini ottenute tramite interviste a rappresentati dei principali comitati d’opposizione. La presenza dei militari statuni-tensi è stata, inizialmente, molto ben accetta da parte della comuni-tà locale e frequenti sono stati gli scambi e le relazioni tra militari e popolazione. Tale rapporto positivo è andato però deteriorandosi con il tempo e la scarsa accettazione dei militari statunitensi da parte della popolazione vicentina è diventata sempre più evidente (Coppola e Gioppi, 2007) completando quel processo di separa-zione tra soldati statunitensi e città (Desiderio, 2007). Pur non essendo registrabili episodi cui riconnettere direttamente questo allontanamento, è possibile ipotizzare che esso sia stato in parte favorito dall’accresciuta autosufficienza della base, che ha ridotto opportunità di contatto, dalla crescita della città sulla cui struttu-ra economica l’impatto della base si è decisamente ridotto e dalla sua elevata militarizzazione. Questi elementi latenti si sono quindi evidenziati in relazione al processo di costruzione/ampliamento (6) della presenza militare usa in atto negli ultimi anni.
Il processo d’ampliamento/costruzione comincia a trapelare a partire dal 2003 attraverso delle anticipazioni de Il Giornale di Vicenza e della rivista militare usa Stars and Stripes che ha costituito la fonte informativa spesso più esaustiva e affidabile sull’interno iter decisio-nale. Il processo decisionale è stato caratterizzato da un continuo al-ternarsi di conferme e smentite circa i progetti in corso e le trattative tra i soggetti coinvolti (Paragano, 2009). L’assenza di chiarezza e il mancato coinvolgimento degli attori locali, sono stati, tra gli altri, ele-menti che hanno determinato l’opposizione locale a tale progetto. Co-
(5) Per approfondimenti sul dibattito circa il progetto si rimanda a Paragano, 2009.(6) La doppia dicitura indica il differente approccio che le parti hanno della que-
stione; nell’approccio statunitense e sostenuto dal Governo italiano il progetto costitui-sce infatti un ampliamento della già esistente Caserma Ederle, mentre per gli oppositori costituisce un progetto di nuova costruzione. Data la sua relazione con il tessuto urbano e la localizzazione, nel prosieguo del lavoro verrà utilizzato il termine “costruzione”.
383
me da prassi, in assenza di documentazione pubblica (7), il processo decisionale relativo alla localizzazione delle basi e ai progetti di co-struzione si svolge esclusivamente tra capi di Stato e di Governo e non è previsto alcun coinvolgimento di soggetti locali istituzionali e non istituzionali. Contrariamente a quanto avviene per altre opere pubbliche, caratterizzate invece dalla sperimentazione di processi più o meno inclusivi (Celata, 2004), la localizzazione delle basi mi-litari costituisce ancora un processo centralizzato che non prevede alcuna forma di consultazione o partecipazione.
4. I moVImentI dI opposIzIone: una Lettura teorIca. – Dopo aver evidenziato le motivazioni che portano alla considerazione del sito di Vicenza come essenziale nel processo di ridefinizione della pre-senza militare estera e dopo aver individuato come il rapporto tra Vicenza e la presenza militare statunitense sia radicalmente mutato nel corso degli anni, è possibile rileggere, alla luce della letteratura di riferimento, le dinamiche evolutive della protesta vicentina foca-lizzandosi, in particolar modo, su quali siano le peculiarità dell’op-posizione alla base militare.
Questa analisi può essere condotta soffermandosi su alcune variabili di riferimento, desunte dalla recente letteratura in tema di movimenti sociali: networks, motivazioni, spazialità e luoghi.
La prima variabile di riferimento sono i networks. Secondo al-cuni autori, individuare i networks di un movimento sociale signifi-ca sia identificare gli attori coinvolti nel movimento di opposizione sia fare luce sulle relazioni esistenti tra di essi. Fedi e Mandarini (2008) suggeriscono infatti che:
Per ricostruire la complessità interna di un fenomeno di mobilitazio-ne, è necessario cogliere e descrivere la pluralità degli attori e dei soggetti che la costituiscono: realizzare cioè una mappatura dei soggetti coinvolti (ibid., p. 18).
Capire chi siano gli attori coinvolti in un movimento d’opposi-zione può quindi essere, secondo tale approccio, il primo passaggio
(7) Va segnalato come il processo decisionale non è regolamentato da alcuna nor-ma pubblica. Questo iter potrebbe essere contenuto all’interno del primo accordo sul tema, l’Accordo bilaterale sulle Infrastrutture del 1954, la cui segretezza rende impossibile una valutazione esaustiva.
384
per attribuirne una soggettività e analizzarne la complessità. Altri studiosi preferiscono invece evidenziare la variabile relazionale piuttosto che quella individuale (Bosco, 2001; Della Porta e Piazza, 2008; Leitner et al., 2008; Diani e Mcadam, 2003; Nicholls, 2009). Della Porta e Piazza (2008) identificano “i reticoli o networks” co-me primo livello di analisi, prestando attenzione quindi non solo ai soggetti coinvolti ma anche alle relazioni che si creano tra di loro e di conseguenza alle reti create dagli stessi oppositori. Molto rile-vante è, in tal senso, anche il contributo di Fernando Bosco il cui obiettivo è quello di “fornire un quadro per analizzare i movimenti sociali e per spiegare come l’azione collettiva può essere sostenuta attraverso le reti” (Bosco, 2001, p. 307). L’autore ritiene che analiz-zare i networks sia fondamentale per comprendere la dipendenza delle azioni collettive dalle relazioni sociali e, dunque, l’azione delle reti sociali quali costituenti il movimento stesso. L’autore cerca, in questo modo, di comprendere i ‘processi di network’ in relazione alla loro dimensione spaziale, distinguendo quindi tra reti interper-sonali (ovvero tra gli attivisti), reti tra individui e organizzazioni e reti tra organizzazioni. Malgrado ognuna di queste reti non abbia una definita scala di riferimento, si può però presumere che ten-denzialmente ognuna di esse abbia una spazialità prevalente. Le reti interpersonali, ad esempio, si creano tra gli attivisti locali e a loro volta facilitano sia il coinvolgimento di persone sia la loro partecipazione; le relazioni tra le varie organizzazioni, invece, so-no cruciali per raggiungere una più ampia scala di mobilitazione (ibid., pp. 310-311).
Una volta identificati i soggetti, le organizzazioni coinvolte nel movimento sociale e le reti tra essi createsi, quindi i networks, la seconda fase di analisi dovrebbe cercare di capire le motivazioni alla base dell’opposizione. Gli autori Fedi e Mandarini (2008) iden-tificano tre possibili dimensioni di un fenomeno di mobilitazione (intese come natura e confini di un conflitto): rivendicativa, politica e antagonista. Ai fini della nostra analisi, la dimensione conside-rata più rilevante è quella politica, la quale “si esprime attraverso la rottura dei confini del sistema politico, se denuncia gli squilibri di potere tra gli attori in campo e lotta per l’allargamento della partecipazione delle decisioni” (ibid., p. 18). Nella stessa direzione anche il sociologo Melucci (1980) utilizza la dimensione politica per spiegare e classificare i movimenti sociali. L’autore definisce i movimenti politici come azioni collettive volte ad allargare la par-
385
tecipazione politica e a migliorare le posizioni degli attori coinvolti nei processi decisionali. Egli approfondisce inoltre la definizione sostenendo che questa tipologia di movimenti non si manifesta necessariamente all’interno del sistema formalmente previsto per l’espressione delle istanze degli attori, ma piuttosto cerca di sor-passare il sistema proponendo nuovi canali per poter esprimere le proprie richieste e per spingere la partecipazione al di là dei limiti entro i quali le istituzioni vorrebbero confinarla.
Le motivazioni che stanno alla base di opposizioni locali contro opere sgradite alla popolazione possono essere interpretate attra-verso un’espressione ormai comunemente diffusa, la cosiddetta sindrome nImby (Not In My Back Yard). Essa cerca di spiegare la ge-nesi di quei movimenti sociali, volti alla difesa del proprio territorio (Bobbio e Zeppetella, 1999), di carattere tendenzialmente egoistico, che “si limiterebbero a opporsi alla costruzione delle opere pubbli-che senza preoccuparsi di indicare soluzioni alternative, lanciando messaggi del tipo ‘fatele dove volete, purché non vicino a casa mia’” (Della Porta e Piazza, 2008, p. 9). Ridurre a nImby le motivazioni che portano a opposizioni locali può mirare a ridurne la portata; tale obiettivo può essere raggiunto anche contrapponendole a eventuali istanze concettuali solitamente valutate come di spessore superiore. Attraverso l’analisi del caso di studio, invece, si cercherà di evidenziare come queste motivazioni possano interrelarsi e con-vivere all’interno dello stesso movimento.
Le motivazioni, inoltre, assumono una rilevante interconnes-sione con la terza variabile di riferimento, le spazialità. Le due variabili sono particolarmente collegate perché a seconda delle motivazioni alla base dell’opposizione si crea una sovrapposizione di più scale (8). In tal senso risulta utile il lavoro di Leitnerd, Shep-pard e Skiarto (2008) che, oltre che a negare l’esistenza di una scala fissa e predefinita, evidenziano come i soggetti coinvolti nel movi-mento sociale possano, agendo su differenti scale d’azione, sfidare le esistenti relazioni di potere.
I luoghi sono, infine, l’ultimo fattore determinante per poter analizzare i conflitti politici. Per Leitner, Sheppard and Skiarto (2008) sono importanti perché:
(8) Interessante a questo riguardo potrebbe essere il contributo di Ash Amin, Spa-tialities of Globalization (2002).
386
I luoghi sono permeati di significato e di potere, e sono ugualmente di fondamentale importanza nei conflitti politici. I movimenti sociali spesso cercano strategicamente di manipolare, sovvertire e ridare significato a quei luoghi che simbolizzano le priorità e gli immaginari che essi conte-stano; di difendere quei luoghi che rappresentano le loro priorità e imma-ginari, e di produrre spazi nuovi nei quali tale visione può essere messa in pratica, dentro e oltre i luoghi stessi (Leitner et al., 2008, pp. 161-162).
I luoghi, dotati di una forte valenza simbolica possono diven-tare, come nel nostro caso studio, l’oggetto stesso del conflitto e la rappresentazione metaforica delle differenti motivazioni. I movi-menti sociali, quindi, cercano sia di difendere quegli spazi dotati di valore simbolico sia, coerentemente con la visione del movimento stesso, di crearne dei nuovi. In Pierce, Martin e Murphy (2011), i luoghi sono infatti considerati come un oggetto di negoziazione generati dai processi politici messi in atto dalle parti del conflitto. Quindi secondo i tre autori, tutti i luoghi sono relazionali e formati da quei processi politici che attraverso la negoziazione danno vita ai luoghi stessi.
Networks, motivazioni, spazialità, e luoghi sono quindi le quat-tro variabili principali attraverso le quali si propone l’analisi del movimento di opposizione “No Dal Molin”. Seguendo il contributo di Leitner, Sheppard and Skiarto, ciò che è rilevante non è solo l’iden-tificazione delle variabili ma anche l’utilità delle stesse, nel momento in cui vengono spiegate reciprocamente, per la comprensione dei movimenti sociali. Non si tratta solo di co-esistenza (delle variabili definite), ma più che altro di come loro formino l’una con l’altra, mo-dellandosi reciprocamente, la traiettoria del contenzioso politico.
5. - IL moVImento dI opposIzIone aLLa base mILItare “no daL moLIn”.
5.1 L’evoluzione temporale del movimento del “No Dal Molin”. – La griglia presentata (Tab. 1) ha l’obiettivo di sintetizzare i fatti salienti dell’opposizione vicentina e in particolare di evidenziare come gli attivisti del “No Dal Molin” abbiano risposto in maniera dinamica e reattiva al susseguirsi di decisioni politiche volte alla realizzazione della nuova base militare. Si ritiene comunque im-portante sottolineare che i fatti indicati non sono gli unici accaduti,
387
ma solo quelli ritenuti più significativi per l’analisi del movimento vicentino. Continue proteste, manifestazioni, occupazioni, dibattiti con rappresentanze politiche e tra cittadini e monitoraggi sono sta-ti all’ordine del giorno nell’arco di tempo analizzato, non solo nel territorio vicentino ma anche nel resto d’Italia e anche attraverso missioni delle delegazioni del movimento all’estero.
Tab. I – eVentI saLIentI deL moVImento “no daL moLIn” In ordIne cronoLogIco
Data Fatti
2003 Il dipartimento di Difesa degli Stati Uniti decide di raddoppiare il numero di soldati. Nasce il piano di costruzione di un’ul-teriore base militare nell’area vicentina dell’ex Aeroporto Dal Molin.
26 ottobre 2006 Il consiglio comunale di Vicenza discute l’approvazione della nuova base militare nell’area del Dal Molin. Prima importante manifestazione locale nella Piazza del Municipio. I manifestanti esprimono la loro opposizione al nuovo progetto tramite pento-le, padelle, fischietti.
2 dicembre 2006 Prima manifestazione nazionale contro la base: partecipano 30.000 persone (in prevalenza vicentini).
16 gennaio 2007 Il Governo Prodi non si oppone alla costruzione della nuova base militare. I manifestanti occupano un terreno ed erigono un capannone in uno spazio adiacente all’area dell’ex aeroporto. Nasce il “Pre-sidio Permanente”.
17 febbraio 2007 Seconda manifestazione nazionale contro la base: partecipano 120.000 persone da tutta Italia.
6-17 settembre 2007 Prima edizione del Festival “No Dal Molin” a Caldogno.Una delegazione del movimento riesce a entrare nella zona dell’ex Dal Molin e pianta un centinaio di alberi per dare vita al “Bosco della Pace”.
15 dicembre 2007 Manifestazione europea a Vicenza alla quale partecipano 80.000 persone.
18 giugno 2008 Il “No Dal Molin” vince il ricorso al tar, che accoglie la richiesta di sospensione dei lavori della base sia per presenza vizi formali (assenza accordo scritto) sia per possibili impatti ambientali.
1 agosto 2008 Il consiglio di Stato sospende la sentenza del tar dando il via libera ai lavori per costruire la nuova base motivando che la costruzione di basi militari è una decisione di carattere politico non sindacabile a livello giurisdizionale e non è sottoponibile a valutazioni di carattere formale.
5 ottobre 2008 Si svolge una consultazione popolare per conoscere l’opinione degli abitanti riguardo alla possibilità che il consiglio comunale di Vicenza compri l’area dell’ex aeroporto Dal Molin previa sde-manializzazione. Più di 24.000 persone (su circa 84.000 aventi diritto) sono favorevoli. La consultazione non ha comunque valore legale.
388
31 gennaio-2 febbraio 2009
500 presidianti occupano il lato est dell’aeroporto Dal Molin che non è stato incluso nel progetto della nuova base. Dopo due giorni il Comune di Vicenza avvia la procedura per assicurarsi la gestione di quest’area, che verrà chiamata il “Parco della Pace”.
10 maggio 2009 Il territorio del Presidio Permanente viene acquistato da oltre 500 persone di tutta Italia.
12 settembre 2009 Il sindaco Variati annuncia l’intenzione del Comune di Vicenza di non opporsi ulteriormente ai lavori della nuova base, richie-dendo piuttosto misure compensative. Nello specifico, il primo intervento compensativo promosso è stata la costruzione di una tangenziale nella parte nord della città.
24 aprile 2010 Un centinaio di attivisti occupa il Parco della Pace in segno di protesta contro la possibilità che l’enac (Ente Nazionale Avia-zione Civile) vi costruisca un eliporto.
6 maggio 2011 Con la delibera approvata dal cIpe vengono stanziati 11,5 milio-ni di euro per la realizzazione del Parco della Pace.
7 luglio 2011 Il Governo italiano sottoscrive il documento con il quale cede alla comunità vicentina il Parco della Pace, eliminando la possi-bilità che in quello spazio sia realizzato un eliporto.
26 agosto-11settembre 2011
Quinto Festival del “No Dal Molin”, con evento finale nel Parco della Pace con l’obiettivo di coinvolgere la popolazione nella partecipazione di proposte alternative da realizzare nel Parco.
Fonte: Elaborazione propria da Lanaro, 2010; Il Corriere di Vicenza; pagina web del mo-vimento “No Dal Molin”.
5.2 Networks: Un movimento, tanti movimenti. – Il processo di opposizione è inizialmente portato avanti da comitati di quartiere, cui rapidamente si sono aggiunti esponenti delle forze politiche di centro-sinistra, sindacati di base e della cgIL, gruppi militanti tra cui alcuni riferibili ai centri sociali del Nord-est e altre associazioni locali. Il movimento, soprattutto in questa fase, ha trovato un soste-gno nell’attuale contesto veneto caratterizzato da numerosi conflitti locali in atto e dalla “presenza di uno spontaneismo massiccio di comitati di diverse estrazioni” (Fregolent, 2011), condividendone soprattutto i soggetti coinvolti nonché linguaggi e pratiche. Già dal-le sue origini il movimento è abbastanza variegato nella sua com-posizione includendo persone con differenti esperienze di protesta e background culturali.
All’interno di quello che, apparentemente si configurava come un movimento unitario, coeso e compatto, e come tale si mostrava all’esterno, si iniziano a creare gruppi differenziati per obiettivi e strategie. Il “No Dal Molin” conta infatti un numero indefinito di gruppi e associazioni che, nonostante facciano capo a un movimen-to sorto con l’obiettivo unico, riconosciuto e condiviso di impedire
389
la costruzione della nuova base militare, promuovono strategie e metodi differenti a tale scopo (Fois e Paragano, 2011). Di seguito si analizzano alcuni dei gruppi considerati più emblematici dagli autori dell’articolo:
– Presidio Permanente: uno dei gruppi del “No Dal Molin” è il Presidio Permanente, il cui attivismo è mosso principalmente da finalità etiche e ideologiche quali anti-militarismo e anti-imperia-lismo. Come dichiarato da uno dei suoi membri “il presidio nasce proprio dalla volontà di alcuni di fare un passo avanti rispetto all’at-tività politica” (Intervista A). Infatti, a differenza di altri gruppi, il Presidio Permanente ha messo in atto più strumenti per portare avanti la propria protesta, talvolta sfiorando il limite della legalità. Per i suoi membri, la lotta contro la base militare statunitense non si limita alle conseguenze negative che l’installazione può creare sia in termini ecologici sia sociali, ma assurge a netta contrapposizione alla manifestazione concreta dell’egemonia degli Stati Uniti.
– Coordinamento Cristiani per la pace: comprende diversi gruppi, le associazioni di quartiere e tutti i cittadini di solito avulsi da attivismo; è mosso da motivazioni prettamente territoriali, con-tro la costruzione della nuova base e l’aumento dei soldati in città. Il loro atteggiamento era prevalentemente moderato rispetto ad altri gruppi più radicali.
– 5 ottobre - “No Dal Molin”: Associazione per la riconversione civile e lo sviluppo non militarizzato: creata dopo il referendum del 2008 l’Associazione ha un approccio fortemente caratterizzato da antimilitarismo e pacifismo. È in costante conflitto contro il Presi-dio Permanente soprattutto circa gli strumenti utilizzati nella pro-testa e le azioni intraprese. L’associazione sostiene infatti interventi e iniziative nonviolente e promuove strumenti pacifici.
Al di là delle differenze interne, il movimento vicentino (chia-mato vicentino proprio perché gli attori coinvolti erano tenden-zialmente – in particolare nella prima fase storica – gli abitanti di Vicenza) ha dato vita a una serie di reti tra persone appartenenti a gruppi sociali e a generazioni diverse. Infatti ciò che caratterizza il “No Dal Molin”, indipendentemente dalla divisione in gruppi d’azione, sono i rapporti di solidarietà che difficilmente si sarebbe-ro creati se non fosse stato per la condivisione di un obiettivo di più grande portata (Intervista B). L’obiettivo comune di opposizione al-la costruzione della nuova base ha generato una rete sociale tra gli abitanti di Vicenza che sino allora non esisteva. Allo stesso modo,
390
ha contributo alla collaborazione tra persone di diverse generazio-ni, quindi per esempio i figli protestavano insieme ai loro genitori e nonni. Le reti inter – personali diventano quindi i pilastri del movi-mento “No Dal Molin”, travalicando le potenziali contrapposizioni degli obiettivi – dando vita a una solida base di reti sociali anche per successive battaglie che i vicentini portano avanti (per esempio contro la privatizzazione dell’acqua o in relazione alle alluvioni degli anni successivi).
Con il passare del tempo, il movimento di protesta che si svi-luppa in relazione al progetto di costruzione della base diventa di interesse nazionale. Il numero degli oppositori inizia a crescere in maniera esponenziale e dopo qualche mese dal suo inizio le po-che decine di migliaia di persone iniziali diventano circa 120.000 persone provenienti da tutta Italia nella manifestazione nazionale tenutesi nel febbraio 2007 (Lanaro, 2010). Si iniziano così a creare reti con gruppi esterni al movimento, italiani e di altri paesi, con i quali condividono tematiche originarie quali antimilitarismo e opposizione alle basi (Comitato Internazionale Antibasi) oppu-re elementi che diventano centrali come la riconsiderazione dei processi decisionali sulla gestione dei territori (No Ponte, No taV, ecc.). La creazione di legami con organizzazioni esterne rafforza il movimento del “No Dal Molin” e ne amplia la visibilità all’esterno. Il numero dei vicentini simbolicamente aumenta.
5.3 Motivazioni e spazialità. – Data la stretta connessione tra motivazioni e spazialità, la seconda e la terza variabile verranno di seguito analizzate congiuntamente. Nella prima fase del conflitto le motivazioni della protesta si riconnettono all’utilizzo dello spazio urbano senza un processo decisionale che abbia coinvolto le istan-ze locali. Di conseguenza, la scala d’azione e di risonanza è stret-tamente locale, il supporto di forze internazionali è minimo e le modalità sono di mera resistenza. In questa prima fase la protesta può essere ricondotta a nImby, per la quale gli oppositori protestano contro la costruzione della base militare nel territorio di Vicenza con l’obiettivo di difendere il loro spazio urbano.
A queste istanze, che permangono all’interno del movimento grazie soprattutto a gruppi come i Cristiani per la pace, in un se-condo momento, si associano motivazioni diverse tendenzialmente riconducibili a opposizione verso il militarismo, contro la sovranità e gli squilibri di potere tra le due parti del conflitto. Questo pas-
391
saggio è reso molto rapido proprio dalla natura militare dell’opera che, contrariamente ad altre opere pubbliche, rende minore la dimensione dei benefici, trovando quindi anche minor sostegno e approvazione. La natura dell’opera, quindi, attrae l’interesse e la partecipazione di numerosi soggetti non direttamente connessi alle problematiche territoriali. Questo aspetto si riconnette a una diffe-rente spazialità del movimento. Nonostante la diffusa consapevo-lezza dell’impossibilità di modificare la messa in atto del progetto, Vicenza, con la sua base, e i movimenti di protesta, emergono come simbolo di battaglie più ampie, di interessi che travalicano i confini urbani per adattarsi a tematiche generali e complesse. Il quadro degli accordi internazionali sulla gestione delle basi all’estero, l’as-senza di un quadro legale chiaro che ne supportino la costruzione, la necessità di un coinvolgimento locale nelle decisioni diventano i capisaldi della protesta.
L’ambito d’azione del movimento è evidentemente flessibile e la crescita del movimento non indica un mero cambiamento di scala ma piuttosto una sovrapposizione delle stesse. La protesta permane di carattere territoriale perché fisicamente vuole essere localizzata a Vicenza, ma racchiude inevitabilmente un’opposizione di natura globale
Parallelamente, si sovrappongono anche gli attori della contro-parte. Anche se la prima manifestazione ha come bersaglio princi-palmente il sindaco e la giunta municipale, rei di aver approvato il nuovo progetto urbano, gli interlocutori principali diventano sia il Governo italiano sia quello degli Stati Uniti. L’esistenza di più interlocutori diventa visibile solo in una seconda fase della prote-sta, quando appunto si prende coscienza del fatto che il comune di Vicenza non ha un potere decisionale sulle decisioni sovrane di carattere militare. Infatti, se il Comune di Vicenza inizialmente è considerato come controparte data la sua volontà di avviare i lavori per la base, successivamente con il nuovo sindaco Variati (eletto anche grazie alla sua campagna elettorale contro la base militare) è informalmente diventato parte del movimento vicentino, sostenen-do gli attivisti nell’opposizione alla base.
È proprio di fronte a questa sovrapposizione di spazialità che il movimento da un lato si rafforza e dall’altro si indebolisce. Si rafforza nel momento in cui prende coscienza che i vicentini non sono solo gli abitanti di Vicenza, ma tutti coloro che si oppongo-no a un potere insindacabile top-down e che di conseguenza, la
392
protesta anche se fisicamente materializzata a Vicenza, simbo-licamente si estende a un’opposizione di carattere globale. Allo stesso tempo si indebolisce nel momento in cui l’oggetto del con-flitto travalica il “Dal Molin” e si prende consapevolezza che le decisioni politiche e militari della controparte sono difficilmente impugnabili e vanno ben aldilà degli interessi territoriali. Uno dei presidianti infatti chiarisce questa presa di consapevolezza con le seguenti parole:
Credo ci siano stati dei momenti in cui veramente mancasse poco e gli equilibri si sarebbero spostati ma adesso mi sembra logico che la battaglia è sempre stata neanche di Davide contro Golia, ma di Davide contro un esercito di Golia, perché dall’altra parte c’era sia lo Stato Italiano sia quello Americano, come si faceva! (Intervista A).
Nel 2009, l’avvio dei lavori della base nell’area dell’ex aeroporto segna per i vicentini un netto cambiamento di rotta tra le varie fra-zioni del “No Dal Molin”. Per alcuni si tratta di una sconfitta dato che uno spazio della città è stato rubato ai vicentini.
L’intensità dell’impegno è diminuita di molto, sia perché le energie sono quelle che sono, sia perché sono passati quattro anni, sia perché c’è questo dato di fatto che si vede (la base) e che… deprime. … Di fronte a questo (i lavori di costruzione) è impossibile vedere che la base non esiste, esiste, quindi bisogna arrendersi (Intervista B).
Invece, secondo uno degli intervistati (C) di un altro gruppo, non c’è tempo per darsi per vinti, ma “Dobbiamo ragionare da militari, non da civili”, spiegando che per contrastare i progetti mi-litari non è sufficiente proporre mere strategie di reazione, quanto piuttosto siano necessari dei progetti a lungo termine e quindi con delle visioni future più ampie, proprio come si fa in campo militare. Per alcuni gruppi come I Cristiani per la Pace si tratta quindi di una sconfitta ad opera di una controparte più forte; viceversa, per grup-pi quali il Presidio Permanente e l’Associazione per la riconversione civile e lo sviluppo non militarizzato, l’opposizione non sarebbe dovuta terminare in questa fase. Proprio questa persistente oppo-sizione si materializza e territorializza, alle origini del movimento, nell’occupazione del Presidio Permanente e, successivamente, nella creazione del Parco della Pace.
393
5.4 Luoghi: Il Presidio Permanente e il Parco della Pace. – Il Pre-sidio Permanente non è solo uno dei gruppi del “No Dal Molin”, ma ne rappresenta il fulcro spaziale e simbolico. La sua costituzione definisce in primo luogo la spazializzazione del movimento, che non solo si concretizza intorno ad esso tanto da costituire l’ele-mento rappresentativo dell’intero “No Dal Molin” ma, soprattutto, ne trova la sua dimensione spaziale. Nella notte del 16 gennaio 2007, infatti, un gruppo di manifestanti occupa un’area adiacente al Dal Molin, dandole il nome di Presidio Permanente. Dopo aver montato un capannone di decine di metri quadri, questo spazio, oltre ad acquisire un valore simbolico, diventa il punto d’incontro e sede del movimento “No Dal Molin”. Qui le persone s’incontravano mattina e sera per discutere le strategie di opposizione, monitorare l’area dell’aeroporto e informare e aggiornare tutti i vicentini sulle vicende della nuova base militare. Il Presidio non è stato solo una sede organizzativa ma anche un punto d’incontro per i cittadini: un nuovo spazio sociale che ha permesso ai cittadini di riscoprire un senso di comunità, esulando quindi da spinte di sola opposizione. Lo spazio diventa quindi centro della protesta, ma allo stesso tem-po sua metafora (Fois e Paragano, 2011).
Il movimento del “No Dal Molin”, e in particolare i presidianti, hanno in questo modo messo in campo una strategia di reazione simbolica contro la decisione ‘sovrana’ di costruire la nuova base militare: se il Governo statunitense, tramite il Governo italiano, occupa l’aeroporto Dal Molin, i vicentini si riappropriano degli spazi urbani, occupando un altro territorio della città. In questo esempio si nota chiaramente come le reti politiche possano pro-durre un certo spazio, come i luoghi di contestazione. Il Presidio Permanente è un esempio di luogo di contestazione prodotto dal-le reti che costituiscono il movimento “No Dal Molin”. Di fronte all’egemonia dei governi italiano e statunitense, manifestatasi con l’utilizzo coatto dello spazio cittadino e l’esclusione degli abitanti di Vicenza nel processo partecipativo, il “No Dal Molin” ha messo in atto una reazione forte e visibile come il Presidio Permanente. Occupare un’area adiacente allo spazio destinato alla costruzione della base, anche se di dimensioni non paragonabili a quella utiliz-zata per fini militari, ha dato avvio a un processo di resistenza e opposizione non solo espresso verbalmente ma anche fisicamente. La dimensione spaziale ha avuto sin dalle sue origini un valore sim-bolico: non importa quindi se lo spazio occupato è evidentemente
394
di ridotte dimensioni rispetto all’area destinata alla base militare, ma l’importante è da un lato dimostrare che i vicentini reagiscono e sono capaci di occupare ugualmente un territorio urbano, e dall’al-tro far sentire la loro presenza e sorveglianza in maniera continua e persistente.
Un secondo luogo emblematico è il Parco della Pace. Si tratta di uno spazio prospiciente alla base stessa, nella zona est dell’aero-porto Dal Molin. L’area, chiamata Parco della Pace, per ben 4 anni è stata oggetto di negoziazione tra più attori in campo (Governo statunitense, enac, città di Vicenza). Questa negoziazione porta a un risultato concreto nel 2011, quando il Governo italiano decide di assegnare l’area del Parco della Pace alla città di Vicenza e ai vicen-tini come forma compensativa (stanziando contemporaneamente 11,5 milioni di euro per la sua realizzazione).
Il Parco della Pace è quindi un esempio rappresentativo in quanto si tratta di un luogo prodotto dalla negoziazione dei proces-si politici, generatosi dallo scontrarsi di forze politiche. Esso può assurgere a emblema dell’opposizione alla base militare di Vicenza e può, idealmente, essere considerato la metamorfosi del movimen-to, la sua manifestazione spaziale, la sua concretizzazione. Que-sto nonostante, non si tratti di una vittoria che inneschi processi partecipativi dal basso nelle decisioni militari, oppure che blocchi l’utilizzo dello spazio urbano per scopi militari (dato l’avanzamento nella costruzione della base), quanto piuttosto di un’area ottenuta all’interno di un consueto processo compensativo.
Lo spazio ottenuto, e forse “vinto”, acquista un valore simboli-co maggiore di altre possibili forme di compensazione, in relazione alla natura militare dell’opera; la denominazione Parco della Pace enfatizza proprio la contrapposizione che, dall’uso dello spazio, si estende metaforicamente alla presenza di diverse modalità di ge-stione dei conflitti. È dunque uno spazio localizzato, ma permeato di significati più ampi e globali come antimilitarismo, pacifismo e partecipazione.
A sua volta, il Parco e la relativa gestione sono sintesi delle va-rie anime che hanno costituito il movimento. Mentre per i gruppi più radicali, come quelli mossi da antimilitarismo e volontà di di-fesa da processi egemonici, il Parco è il risultato della protesta, per i gruppi mossi da istanze territoriali il Parco evidenzia la sconfitta del movimento, nonostante le sue potenzialità come spazio urbano gestibile dalla comunità.
395
6. concLusIone. – Il movimento di opposizione alla costruzione della base di Vicenza costituisce un esempio di opposizione alla creazione di opere pubbliche sgradite alla collettività che s’inserisce all’interno dell’universo, eterogeneo ed evolutivo, dei movimenti sociali contemporanei.
La costruzione di basi militari, in particolar modo da parte di altri Stati, tuttavia, presenta delle peculiarità che ne aumentano la complessità. Infatti, l’installazione militare è la sintesi di un pro-cesso decisionale trans-scalare e multi-attore la cui interruzione e/o sospensione costituisce una casistica alquanto rara. Lo stesso processo decisionale si configura verticalizzato e definito, con margini ristretti per la partecipazione di attori differenti da quelli istituzionali e per i portatori di interessi locali. Allo stesso tempo, la tematica militare è per sua stessa natura, caratterizzata dalla presenza di elementi ideologici o ideologizzabili quali, ad esempio, il militarismo e le tematiche riconducibili all’imperialismo. La pre-senza di questi elementi si riverbera sulla dinamica, sulla natura e sulla composizione del processo di opposizione.
A fronte dell’apparente omogeneità e compattezza, il movimen-to si compone da molteplici gruppi portatori di proprie esperienze e istanze, fautori di diversi metodi d’azione e d’opposizione. La presenza di tale eterogeneità porta il movimento, attraverso la cre-azione di networks, ad essere un importante momento di aggrega-zione e crescita collettiva per la popolazione vicentina. Le differenti motivazioni convivono quindi all’interno del movimento, superan-do l’ontologico dualismo tra scale che talvolta porta alla contrap-posizione tra istanze locali e tematiche globali. Proprio questa contrapposizione può portare a sminuire la portata di tematiche territoriali a fronte di aspetti considerati di spessore maggiore. Il caso Dal Molin, evidenzia come non necessariamente il movimento debba mutare le motivazioni ma integrarle in un movimento unico. La sovrapposizione di motivazioni si riflette su un’analoga sovrap-posizione di scale, di attori destinatari della protesta e da origine a una differente spazialità del movimento stesso. A seguito dell’as-sunzione all’interno del movimento di istanze non strettamente territoriali, vicentini diventano tutti coloro che – a vario titolo – si schierano e prendono parte alle fasi della protesta. Vicentino quindi non rappresenta solo “l’essere di Vicenza” ma si configura come aggettivo d’appartenenza simbolica. Nonostante la crescita dimen-sionale e spaziale del movimento, la protesta mantiene, nelle sue
396
manifestazioni principali, la centralità di Vicenza, ricercando ed enfatizzando l’importanza dello spazio e dei luoghi.
I luoghi si costituiscono quindi come elementi caratterizzanti e centrali all’interno del movimento. Fin dalla prima fase, il movi-mento ha necessità di spazializzarsi, di creare un luogo (il Presidio) che possa sia dare fisicità e spazialità al movimento sia costituirne il fulcro simbolico. La creazione del Parco della Pace diventa a sua volta, per una sorta di contrappasso, la principale “vittoria” del movimento, e allo stesso tempo, oggetto di negoziazione non solo tra le parti del contenzioso ma addirittura tra i diversi gruppi del movimento di opposizione stesso.
Dall’analisi del caso studio si nota come una lettura relazio-nale delle variabili indicate (networks, motivazioni, spazialità e luoghi) sia necessaria per la comprensione del fenomeno stesso. La complessità insita nei fenomeni sociali come i movimenti di op-posizione può essere compresa solo nel momento in cui piuttosto che ridurre le variabili principali, esse siano considerate reciproca-mente. Dal caso studio si evince, quindi, come le spazialità si mo-dellino in relazione alle motivazioni e viceversa, come i networks coinvolti incidano sulle spazialità e come esse siano supportate da diverse motivazioni. A loro volta, i luoghi, generatesi dai networks, hanno tante possibili interpretazioni quante sono i gruppi. Tali luoghi possono quindi essere considerati sia come l’oggetto della negoziazione tra gli attori coinvolti, sia come strumenti e risultati del conflitto stesso.
BIBLIOGRAFIA
ALberts A.D. et al., Network Centric Warfare: Developing and Leveraging Information Supe-riority (2 ed.), C4ISR Cooperative Research Program, 2000. Disponibile su: <http://www.dodccrp.org/files/Alberts_NCW.pdf> [ultimo accesso 15 gennaio 2012].
amIn A., “Spatialities of globalisation”, Environment and planning A, 34, 2002, pp. 385-399.
AspIn L., Report on the bottom-up review, Office of Secretary of Defense, Washington, 1993. Disponibile su: <http://www.fas.org/man/docs/bur/index.html> [ultimo ac-cesso 15 gennaio 2012].
AssembLea Permanente “No DaL MoLIn”, C. B., ComItato “No DaL MoLIn, sI aLLa pace” dI Longare, Gruppo Presenza Longare (a cura di), Site Pluto, ieri oggi e domani, Vice-nza, 2008.
Baker A.P., American Soldiers Overseas: The Global Military Presence, New York, Praeger Publisher, 2004.
BobbIo L., ZeppeteLLa A. (a cura di), Perché proprio qui?: Grandi opere e opposizioni locali, Milano, FrancoAngeli, 1999.
397
Bosco F.J., “Place, space, networks, and the sustainability of collective action: the Madres de Plaza de Mayo”, Global Networks, 1, 2001, n. 4, pp. 307-329.
CaLder K.E., Embattled Garrisons: Comparative base politics and american globalism, Princeton, Princeton University Press, 2007.
Camera deI DeputatI: CommIssIone IV DIfesa, “Atti Parlamentari: Indagine conoscitiva sulle servitù militari: Schema di documento conclusivo”, Roma, 2007.
Cao M., “Sardegna, sentina della portaerei Italia”, in Zucchetti M., Il male invisibile sempre più visibile: La presenza militare come tumore sociale che genera tumori reali, Scienziate e scienziati contro la guerra, Roma, Odradek, 2005, pp. 219-228.
Caruso L., FedI A., “L’opposizione locale alle opere sgradite”, in Fedi A. e Mandarini T., Oltre il Nimby: La dimensione psico-sociale della protesta contro le opere sgradite, Milano, FrancoAngeli, 2008, pp. 15-41.
CeLata F., “Partecipazione, attori locali e pianificazione regionale”, tesi di dottorato in Geografia economica, Roma, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 2004.
cromfs - CommIssIon on ReVIew of OVerseas MILItary FacILIty Structure of the UnIted States, “Report to the congress”, Washington D.C, 2005, agosto.
ConsIgLIo dI Stato, “Sentenza n. 5344/2008”, Roma, 2008, 29 luglio.CooLey A., Marten K., “Base Motives: The Political Economy of Okinawa’s Antimilita-
rism”, Armed Forces & Society, 32, 2006, n. 4.CoppoLa M. e GIoppI G., “Video: Se muori ci hai provato”, Gruppo Cineoperatori Avere
Ventanni, 2007.DeLLa Porta D., PIazza G., Le ragioni del no: Le campagne contro la Tav in Val di Susa e il
Ponte sullo Stretto, Milano, Feltrinelli, 2008.Department of Defense, “Strengthein U.S. Global Defense Posture: Report to Congress”,
Washington D.C., 2004, settembre.DesIderIo A., “La fatal Vicenza: Viaggio nelle basi usa in Italia - 2”, Limes, 15, 2007, n. 4,
, “Il mondo in casa”, pp. 297-316.DI MartIno B., ALegI, G., “Poligono sperimentale del Salto di Quirra”, Rivista Aeronau-
tica, Roma, 6, 2006. Disponibile su: <http://rivista.aeronautica.difesa.it/indice.asp?id=27&art=569> [ultimo accesso 15 gennaio 2012].
DIanI M., McAdam D. (a cura di), Social movements and networks: relational approaches to collective action, Oxford, Oxford University Press, 2003.
EcheVarrIa II A.J., Toward an american way of war, Strategic Studies Institute [online], U.S. Army war College, Carlisle, 2004. Disponibile su: <http://permanent.access.gpo.gov/websites/armymil/www.carlisle.army.mil/ssi/pdffiles/00365.pdf> [ultimo accesso 15 gennaio 2012 ].
EcheVarrIa II A.J., Fourth-Generation War and other Myths, Strategic Studies Institute, U.S. Army war College, Carlisle, 2005. Disponibile su: <http://www.strategicstudies-institute.army.mil/pdffiles/pub632.pdf> [ultimo accesso 15 gennaio 2012].
FregoLent L., Malessere territoriale e proteste dai cittadini. Caratteri e peculiarità delle mobilitazioni territoriali nel Veneto, Legambiente Veneto e Università IUAV di Ven-ezia. Disponibile su <http://www.legambienteeste.altervista.org/?page=documenti> [ultimo accesso 5 luglio 2012].
FaggI P., Turco A., Conflitti ambientali: Genesi, sviluppo, gestione, Milano, Unicopli, 1999.FedI A., MandarInI T. (a cura di), Oltre il Nimby: La dimensione psico-sociale della protesta
contro le opere sgradite, Milano, FrancoAngeli, 2008.FoIs F., Paragano D., “‘Autonomous Geographies’ in the Anti-U.S. Military Base Move-
ments”, Peace Review: A Journal of Social Justice, 23, 2011, pp. 313-319.HarkaVy R.E., Bases Abroad: The Global Foreign Military Presence, New York, Sipri-
Oxford University Press, 1989.HarkaVy R.E., “Thinking about basing in Reposturing the Force: U.S. Overseas Presence
in the Twenty-first Century”, Newport, Carnes Lord Editor, 2005 (Naval War Col-lege Newport Papers, 26).
398
Jones J.J., “Dichiarazione del comandante comando europeo dell’esercito statunitense davanti alla commissione per i servizi armati del senato”, Washington D.C., 2006, 7 marzo.
KrepIneVIch A., Work R.O., A new Global Defense Posture for the second Transoceanic Era, Washington D.C., Centre for Strategic and Budgetary Assessments, 2007.
KundanI A., “Wired for War: Military Technology and the Politics of Fear”, Race&Class, 46, 2004, , n. 1, pp. 116-125.
Lanaro G., Il popolo delle Pignatte. Storia del Presidio Permanente No Dal Molin (2005-2009), Verona, Qui Edit, 2010 (Quaderni di storiAmestre).
LeItner H. et al., “The spatialities of contentious politics”, Transactions of the Institute of British Geographers, 33, 2008, n. 2, pp. 157-172.
LInd W.S. et al., “The Changing Face of the War: Into the Forth Generation”, Marine Corps Gazette, October, 1989, pp. 22-26.
Lumsden M., “Militarism: cultural dimension of militarization”, in Eide A. e Thee M., Problems of contemporary militarism, London, Croom Helm, 1980, pp. 356-370.
Markusen A. et al., The rise of gunbelt: The military remapping of Industrial America, New York, Oxford University Press, 1991.
MaseLLa F. et al., “Sigonella US Base: The imminent danger”, Reportage condotto per RaiNews24, 2007.
Id., Saso A., “La sindrome di Quirra: Misteriose malattie attorno al più grande poligono d’Europa”, Reportage condotto per RaiNews24, 2007a.
McCaffrey K.T., Military Power and Popular Protest: The U.S. Navy in Vieques, Puerto Rico, New Brunswick, New Jersey and London, Rutgers University Press, 2002.
MeLuccI A., “The new social movements: A theoretical approach”, Social Science Infor-mation, 19, 1980, n. 2, pp. 199-226.
MInI F., Soldati, Torino, Einaudi, 2008.NIchoLLs W., “Place, networks, space: theorising the geographies of social movements”,
Transactions of the Institute of British Geographers, 34, 2009, n. 1. pp. 78-93.Nye J.S.J., Soft Power:The means to success in world Politics, New York, PublicAffairs,
2005.Paragano D., Le basi militari degli Stati Uniti in Europa: posizionamento strategico, per-
corso localizzativo ed impatto territoriale, PhD Thesis [online], University of Trieste, 2009. Disponibile su: <http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/3056>.
Perry W.J., “Military technology: an historical perspectiv”, Technology in Society, 26, 2004, pp. 235-243.
PIerce J. et al., “Relational place-making: the networked politics of place”, Transactions of the Institute of British Geographers, 36, 2011, n. 1, pp. 54-70.
Poppert P.E., Herzog H.W.J., “Force reduction, base closure, and the indirect effects of military installations on local employment growth”, Journal of Regional Science, 43, 2003, n. 3, pp. 469-481.
RumsfeLd D.H., Testimony as Prepared for Delivery by Secretary of Defense Donald H. Rumsfeld, Senate Armed Committee, Washington D.C., 2004. Disponibile su: <ht-tp://armed-services.senate.gov/statemnt/2004/September/Rumsfeld 9-23-04.pdf> [ultimo accesso 28 novembre 2009].
SaxenIan A., Il vantaggio competitivo dei sistemi locali nell’era della globalizzazione – cul-tura e competizione nella Silicon Valley e nella Route 128, Milano, FrancoAngeli, 2002.
Shaw M., Post-Military Society: Militarism, Demilitarization and War at the End of the Twentieth Century, Oxford, Polity Press, 1991.
SImIch L., “The corruption of a Community’s Economic and Political life: The Cruise Missile base in Comiso”, in Gerson J. e Birchard B., The sun never sets: Confront-ing the network of foreign U.S. Military Bases, Boston MA, South end Press, 1991, pp. 77-94.
399
Thee M., “Militarism and militarization in contemporary international relations”, in Eide A. e Thee M. (a cura di), Problems of contemporary militarism. London, Croom Helm, 1980, pp. 15-35.
Woodward R., Military Geographies, rgs-Ibg Book Series, Oxford, Blackwell Publishing, 2004.
Id., “From Military Geography to militarism’s geographies: disciplinary engagements with the geographies of militarism and military activities”, Progress in Human Geography, 26, 2005, n. 6, pp. 718-740.
Ricercatore indipendente; [email protected], dottorato in Geografia Economica, Dipartimento MeMoTef dell’Università
degli Studi“La Sapienza”; [email protected]
SUMMARY: Localization of military bases and opposition movements: the case of Vicenza. – What happens if local people oppose an apparently unquestionable military decision? This paper examines the structure and the spatiality of social movements in opposition to “sovereign” decisions related to the installation of U.S. military bases abroad. Therefore, it analyzes the decision making process linked to the location of military bases, the effects of military presence in foreign territory and its opposition. It examines the case of the “No Dal Molin” movement, born in 2006 against the project of new U.S. military installations in the area of Vicenza (Venetia region). This paper com-bines two fields of research: the critical military geography and more recent literature on social movements.
rÉsumÉ: Localisation des bases militaires et mouvements d’opposition: le cas de Vicence. – Qu’arrive-t-il si la population locale s’oppose à une décision militaire apparem-ment incontestable? L’article examine la structure et la spatialité de mouvements sociaux opposés à des “décisions souveraines” concernant l’installation de bases militaires des États Unis à l’étranger. On analyse le processus décisionnel lié à la localisation des bases militaires, les effets de la présence militaire sur un territoire étranger et les oppositions qui en découlent. L’objet de l’article c’est le cas du mouvement “No Dal Molin”, né en 2006, contre le projet de nouvelles installations militaires des États Unis dans la ville de Vicence (Vénétie). L’article combine deux domaines de recherche: la géographie militaire critique et la littérature récente sur les mouvements sociaux.
Termini chiave: Movimenti sociali, basi militari, geografia militare critica, VicenzaKeywords: Social movements, military bases, military critical geography, Vicenza
Mots-clés: mouvements sociaux, bases militaires, géographie militaire critique, Vicence
[ms. pervenuto il 22 maggio 2012; ult. bozze il XXX 2012]