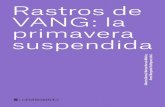GAMBULI FABIO - PRIMAVERA 431, L’ATTACCO TEBANO A PLATEA
Transcript of GAMBULI FABIO - PRIMAVERA 431, L’ATTACCO TEBANO A PLATEA
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
PRIMAVERA 431, L’ATTACCO
TEBANO A PLATEA Resoconto e contestualizzazione storica
Fabio Gambuli
A.A. 2012-2013
1
La guerra archidamica, prima parte della guerra del Peloponneso narrataci da
Tucidide, scoppiò dopo una lunga serie di sgarbi diplomatici, forzature militari ed
ingerenze politiche. Tra gli eventi che determinarono lo scoppio delle ostilità tra la
lega navale capitanata da Atene e la cosiddetta lega peloponnesiaca spartana gli
storici generalmente ricordano, grazie anche all’importanza che attribuisce ad essi
Tucidide, il caso corcirese e l’editto megarese. Ad essi viene solitamente aggiunta
l’inevitabilità del conflitto che, sempre secondo la tesi tucididea, avrebbe portato
le due potenze ormai giunte all’apice del loro potere ad un naturale scontro per
l’egemonia in Grecia. Spesso però viene dato poco spazio ad un evento che lo
stesso Tucidide definisce l’inizio vero e proprio delle ostilità tra le due fazioni,
ovvero il fallimento della spedizione tebana a Platea del 431. Può essere esso
considerato il primo vero fatto di guerra o è solo una delle tante cause parallele che
precedono l’invasione dell’Attica? Prima di addentrarci nell’argomento è
importante ricapitolare ed analizzare i fatti così come riportatici da Tucidide.1
E’ proprio con l’evento di Platea che, secondo la narrazione tucididea, “Comincia
[…] 1a guerra tra gli Ateniesi e i Pe1oponnesiaci e i rispettivi alleati”2, evento
che colse impreparata sia Atene, la quale come vedremo non riuscirà a reagire in
modo tempestivo, che Sparta, del tutto disinformata del tentativo di coup de main
dell’alleato tebano.3
E’ dunque nella primavera del 4314 che circa trecento Tebani
5 guidati da
Pitangelo, figlio di Filide, e Diemporo, figlio di Onetoride, celati dall’oscurità
1 Diodoro, Diod. XII 41-42, nel suo racconto non si discosta da quel che dice Tucidide tranne che per la
parte finale. 2 Thuc. II 1
3 Erano veramente alleate Tebe e Sparta prima dell’inizio della guerra? Vedi l’analisi delle pagine seguenti
e JONATHAN J. PRICE, Thucidydes and Internal War, Cambridge 2001, pp. 284-287 4 Tucidide non ci dice il giorno esatto, ma in II 4,2 ci riferisce che il tentativo avvenne nella fine di un mese.
Dato che il calendario era lunare si è supposto che la possibile data dell’attacco riportata al calendario
Giuliano sia compresa tra il sesto e l’ottavo giorno del mese di Marzo, vedi ARNOLD W. GOMME, A
Historical Commentary on Thucydides, Oxford 1956, p. 2 oppure, cosa che ritengo più probabile, intorno
all’ottavo giorno di Aprile come ipotizza SIMON HORNBLOWER, A Commentary on Thucydides, Oxford
1991, pp. 237-238. 5 Secondo le stime di Erodoto il contingente ammontava a quattrocento opliti Hdt. VII 233.2
2
della notte e con l’ausilio della fazione oligarchica platense6, riuscirono ad entrare
a Platea. Inizialmente i cittadini, colti dalla sorpresa ed ignari dell’esiguo numero
del contingente tebano, non concessero resistenza e si arresero alle richieste
nemiche. Nonostante la fazione oligarchica smaniasse per l’eccidio immediato dei
propri avversari politici il contingente tebano preferì invece un approccio
pacificatore sulla spinta di una comunanza di stirpe7 ed iniziarono quindi le
trattative per un accordo. Solo nel momento in cui i Plateesi, la maggioranza dei
quali non voleva assolutamente infrangere l’alleanza con Atene, si accorsero
dell’esiguità della guarnigione tebana decisero di passare al contrattacco: poco
prima del giungere dell’alba, quando ancora l’oscurità avrebbe accresciuto
l’impatto emotivo della manovra, i trecento opliti furono attaccati da ogni fianco e
tempestati di proiettili da parte di servi e donne che dalle loro case scagliavano
tegole e pietre. La porta della città dalla quale entrarono gli opliti fu
immediatamente bloccata e solo pochi Tebani riuscirono a fuggire, i restanti
furono massacrati o catturati.8
Nel mentre era in avvicinamento il grosso dell’esercito tebano il quale era di
supporto al piccolo gruppo di opliti che erano entrati in città. Quando vennero
informati della complicata situazione che si era venuta a creare all’interno di
Platea, il contingente si diresse, nonostante la pioggia battente, a passo spedito in
direzione dei territori della città con l’intenzione di catturare i Plateesi che non
erano ancora riusciti a fare ritorno all’interno delle mura. L’idea dei Tebani era
quella di entrare in possesso di una contropartita per trattare la liberazione dei
propri prigionieri attraverso un scambio.
I Plateesi chiesero quindi ai Tebani, attraverso un araldo, di allontanarsi dal loro
territorio senza colpo ferire in cambio della salvezza del loro contingente catturato,
per rendere sacro ed ufficiale l’accordo le due parti suggellarono un giuramento9.
Allontanatisi dunque, come da accordo, dal territorio nemico senza arrecare nessun
6 Che Tucidide identifica con Nauclide e i suoi compagni Thuc. II 2.2
7 In Thuc. III 61.2 i Tebani dicono che Platea era stata fondata da Tebe, già Omero la considerava una città
beotica Iliade II 504 8 Tuch. II 4.1-8
9 Tucidide sottolinea come la parte platese neghi questo dettaglio, Thuc. II 5.6
3
danno i Tebani aspettarono invano la liberazione dei propri compagni; infatti i
Plateesi si ritirarono all’interno delle mura con tutti i propri averi e
successivamente, rompendo l’accordo precedentemente siglato, trucidarono tutti i
centoottanta prigionieri tra cui Eurimaco.10
Nel frattempo dalla città erano partiti due araldi alla volta di Atene, il primo era
partito all’arrivo del contingente tebano mentre il secondo al momento della
cattura, quindi agli ateniesi la notizia della morte dei prigionieri non era ancora
giunta. Infatti, nella città attica, c’era ancora la speranza di poter salvare la
situazione e di relegare il maldestro tentativo tebano al ruolo di semplice incidente.
Preventivando la possibilità di qualsiasi azione tebana sul territorio, gli Ateniesi si
prodigarono nell’arrestare tutti i Tebani presenti nell’Attica. Nello stesso momento
inviarono un araldo a Platea con l’ordine di non far prendere alcuna sanzione
definitiva nei confronti dei prigionieri. Una volta arrivato in città l’araldo trovò i
prigionieri uccisi e dovette riportare la notizia ai suoi concittadini, i quali decisero
quindi di inviare un esercito a Platea e di far evacuare donne, vecchi e bambini
preparando dunque la città ad un possibile imminente assedio. Dopo questi fatti “il
trattato, era stato apertamente violato, gli Ateniesi si preparavano a fare la guerra, e
si preparavano anche i Lacedemoni e i loro alleati”.11
E’ dunque Tucidide a mettere in risalto l’evento come casus definitivo, motivo per
cui la stragrande maggioranza degli studiosi moderni prende questa informazione
come un dato di fatto.12
Una delle poche voci critiche a riguardo è quella di Price
che, con il suo recente lavoro,13
prova a studiare più approfonditamente la
10
Questo è il momento in cui la narrazione di Diodoro, vedi sopra, si discosta da quella di Tucidide, infatti
l’autore del I secolo sostiene che “[...]i Tebani si ripresero i prigionieri, restituirono il bottino e partirono
verso Tebe”, quindi con una soluzione pacifica della questione. E’ solo l’intervento ateniese, con l’invio di
una guarnigione, che porta gli Spartani a giudicare l’azione come un’aperta violazione della tregua. Da
questa testimonianza la reazione spartana sembrerebbe spropositata pare quindi a mio avviso molto più
plausibile la motivazione riportata da Tucidide.
Circa invece la figura di sappiamo che era figlio di Leontiade, il nobile tebano che portò la città di Tebe
dalla parte dei Persiani, vedi Hdt. VII 233. 11
Thuc. II 7.1 12
Mi riferisco ai già citati GOMME (1991), HORNBOWER (1991) e a DAVID CARTWRIGHT, A
Historical Commentary on Thucydides, Ann Arbor: The University of Michigan 1997. 13
PRICE (2001).
4
rilevanza storica dei fatti connessi all’attacco tebano a Platea. In questo studio
Price imbastisce la sua tesi utilizzando diversi punti dell’opera tucididea in modo
da dimostrare come questo evento non solo non sia il primo evento bellico relativo
alla guerra archidamica ma che addirittura sia un incidente ad essa estraneo.14
Egli
pertanto considera la prima invasione dell’Attica da parte di Archidamo come il
primo episodio della guerra. Tra i passi che secondo l’autore statunitense
avvelerebbero questa ipotesi egli inserisce le due conferenze tra gli alleati
peloponnesiaci, tenutesi nel 432,15
nelle quali viene presa la decisione di muovere
guerra ad Atene nell’anno seguente, ovvero nell’estate del 431. A mio avviso
tuttavia questo punto non ha molta rilevanza poiché sono i fatti a contare, ovvero
l’attacco tebano a sorpresa durante la primavera, e non l’invasione dell’Attica fatta
dall’esercito spartano durante il periodo estivo, nonostante fosse stata
preannunciata come data di inizio delle ostilità per gli Spartani. Questa stessa
risposta può essere benissimo usata per il motivo seguente, ovvero l’intenzione
tebana di attaccare “[…] mentre durava ancora la pace, e la guerra non era ancora
iniziata apertamente”16
, che secondo Price sottolineerebbe come quello tebano sia
solo un incidente prima che la guerra avesse inizio.17
Molto più arguta e rilevante
è, sempre secondo il mio parere, la critica rivolta all’esistenza di un’alleanza
solidale tra Tebe e Sparta. Se questa ipotesi fosse esatta non si potrebbe
assolutamente considerare l’attacco tebano a Platea come atto di inizio della guerra
archidamica ma non solo, l’evento non apparterrebbe nemmeno alla serie di eventi
che portarono al suo scoppio.18
Secondo Price non ci sono prove evidenti per
congetturare che Sparta e Tebe fossero formalmente obbligate di soccorrersi in
caso di guerra prima del 431, o che Tebe ed i Beoti facessero parte degli accordi
della tregua trentennale. Alle sue ragioni Price accorpa il fatto che sebbene le due
poleis fossero in rapporti amichevoli ormai da tempo, non significa tuttavia che
fossero alleate. La prova più evidente per quanto riguarda questa ipotesi è il
14
PRICE (2001) pp. 283-289 15
Tra i quali si noti, non viene menzionata Tebe (che però potrebbe comunque esserci). Thuc. I 119-125. 16
Thuc. II 2.3 17
PRICE (2001) p. 284 18
Ed è qui che si potrebbe inserire la segnalazione di Price su Thuc. I 125.2.
5
ritardo, ben due anni, con cui Sparta portò aiuto ai Tebani.19
Infine ci sarebbe da
correggere l’interpretazione di Thuc. II 7,120
la cui nuova interpretazione
rivelerebbe già dal testo tucidideo come l’attacco a Platea fosse unicamente un
fattore parallelo, il quale incrinerebbe semplicemente i rapporti già tesi tra le due
fazioni, ma non intaccherebbe la tregua trentennale la cui violazione sarebbe
sempre e comunque connessa ai fatti di Corcira, Megara e Potidea.21
Sebbene tutte queste prove siano indiziarie e a mio avviso non completamente
esaustive, come invece sembrano essere in certi casi le parole di Tucidide,22
non
trovo possibile però non considerare questa ipotesi, ovvero l’alleanza tra Tebe e
Sparta, plausibile.
Sicuramente, nel caso in cui Sparta e Tebe non fossero alleate,23
l’evento di Platea
prenderebbe tutt’altro risalto all’interno di un conflitto che non sarebbe quello tra
le due leghe egemoni del periodo, ma quello tra Atene e Tebe.
I rapporti tra Atene e la Lega Beotica, ma in modo particolare Tebe la quale aveva
il ruolo di città egemone, erano in forte contrasto ormai dalla fine delle guerre
persiane durante le quali i Beoti, con l’esclusione di Tanagra e Platea, passarono
dalla parte del nemico persiano. Sconfitti i barbari le sorti della lega furono nelle
mani dei vincitori i quali però non decisero di scioglierla.24
La città che ebbe un
contraccolpo maggiore da questa sconfitta fu indubbiamente Tebe che, colpita
nell’orgoglio ed indebolita dalla disastrosa sconfitta, perse la propria egemonia
19
PRICE (2001) p. 285 20
Con “because of what happened in Plataea and because the treaty had been openly broken [at Corcyra
and Potidaea], Athens and Sparta started preparing for war” (corsivo e parentesi dell’autore) PRICE pp.
285-286. 21
Le quali rimangono comunque, secondo Price, le cause scatenanti anche se Tebe fosse stata inclusa nella
tregua trentennale, mentre la l’invasione dell’Attica del 431 rimane comunque il primo atto di guerra. In
questo caso, come ho già precedentemente detto, mi trovo avverso alla sua tesi visto l’azione tebana fu una
spudorata azione di guerra nei confronti di una città facente parte dell’opposto schieramento e nel caso in
cui Tebe fosse stata ufficialmente alleata di Sparta l’azione sarebbe stata sicuramente il primo atto di
guerra, anticipando di qualche mese l’invasione dell’Attica precedentemente preparata. 22
Thuc. II 1; II 7.1. 23
Ovvero come Price sostiene. 24
ROBERT J. BUCK, A History of Boeotia, Edmonton: The University of Alberta 1979, p. 139 ss.
6
lasciando per le decadi successive l’iniziativa politica e Tanagra.25
Con l’inizio
delle ostilità tra Atene e Sparta la cosiddetta Prima Guerra del Peloponneso e la
mai sopita volontà tebana di tornare ad avere un ruolo primario all’interno della
Lega Beotica spinsero Tebe a chiedere aiuto a Sparta, negoziando in cambio il
proprio intervento armato ai danni di Atene.26
A questo punto le fonti ci riportano
un provvedimento spartano in Beozia per risolvere una situazione di stasis di cui
però non sappiamo realmente molto, probabilmente una disputa tra pro-ateniesi e
pro-spartani, con un susseguirsi di eventi che portano l’intera lega dalla parte di
Sparta. Nel frattempo la rivalità tra i peloponnesiaci ed ateniesi sfocia nella
battaglia di Tanagra,27
durante la quale a supporto del vittorioso esercito spartano
possiamo annoverare la presenza di un contingente beotico.28
Risolta la stasis e
sconfitto il nemico ateniese il contingente lacedemone è costretto a causa delle
ingenti perdite a fare ritorno in patria senza poter né prevedere né ostacolare la
violenta reazione ateniese che si concretizza con una spedizione contro la Lega
Beotica. Sessantadue giorni dopo la battaglia di Tanagra le forze beotiche vengono
pesantemente sconfitte dal contingente ateniese comandato da Mironide nei pressi
di Enofita, con questa vittoria finisce l’egemonia di Tanagra le cui mura vengono
fatte radere al suolo. Giunti a questo punto le città della Lega Beotica vengono
assoggettate a governi filo-ateniesi29
, a Tebe viene persino instaurata la
democrazia.30
Per supportare maggiormente il proprio predominio sulla Lega
Beotica, che anche in questo caso non viene distrutta, gli ateniesi vi fecero entrare
l’ormai fedele alleato plateese in una posizione privilegiata.31
Da questo momento
non abbiamo più una città egemone all’interno della lega, anche se è assai
25
BUCK (1979) pp. 142-144 26
Diod. XI 81 27
BUCK (1979) p. 147 28
Pl. Alc. mai. 112C; Paus. 1.29.9 29
Di stampo comunque oligarchico. 30
Nonostante Diodoro faccia espressamente riferimento all’esclusione di Tebe da tali provvedimenti
secondo BUCK (1979) pp. 147-148 è evidente invece come essa fosse sicuramente compresa. Aristotele in
Pol. 1302 b 29-32 ci dice che a Tebe la democrazia fu sovvertita dopo la battaglia di Enofita. 31
Platea era infatti alleata di Atene oramai dal 519 a.C. , mentre per la sua posizione all’interno della lega
vedi BUCK (1979) pp. 148-149, 155, 176
7
possibile che Tanagra fosse rimasta nominalmente la città capitale.32
La lega si
trovò quindi a cooperare con Atene dal 457 fino al 447 ovvero fino alla complicata
situazione ateniese di quegli anni. E’ infatti in quel periodo che si susseguirono in
poco tempo il fallimento della spedizione ateniese in Egitto, i tentativi di defezione
da parte di alcune poleis della Lega Delio Attica, i rapporti che si andavano a
rinsaldare tra Sparta e gli Achemenidi oltre che all’intervento di Atene nella
Seconda Guerra Sacra. Tutti questi fattori distolsero l’attenzione dallo scenario
beotico dove la situazione stava peggiorando, infatti la gestione dei democratici a
Tebe e quella dei partiti oligarchici pro-ateniesi nel resto della Beozia si stava
rivelando pessima portando il malcontento tra i cittadini beoti. Fu così che molti
degli uomini esiliati durante il decennio precedente rientrarono in Beozia per
riprendere potere. Le forze oligarchiche pro-tebane entrarono quindi ad Orcomeno
aiutati anche dalla popolazione locale ed iniziarono ad organizzarsi per liberare le
altre città della regione. In tutta risposta Atene inviò mille opliti sotto il comando
di Tolmide33
i quali riuscirono a sottomettere Cheronea ma furono pesantemente
sconfitti nei pressi di Coronea.34
Dopo la sconfitta di Coronea Tebe e le altre città
scontente della Beozia si liberarono dei governi filo-ateniesi, con l’unica eccezione
di Tespie e Platea la quale probabilmente fuoriuscì dalla lega in questa
occasione.35
Nonostante Atene avesse preparato un esercito per ritornare in
possesso della propria influenza sulla regione la situazione non migliorò ed infine
la Lega Beotica tornò autonoma.
A questo punto pare giusto soffermarci sul rientro degli esuli beotici ad Orcomeno,
è possibile che questo evento abbia delle analogie con l’attacco a Platea con cui
abbiamo iniziato questo studio? Non abbiamo narrazioni dettagliate di questo
episodio ma è assai probabile che i due possano avere dei punti in comune,
proviamo ad individuarli. Sia ad Orcomeno che a Platea la gestione politica della
città era in mano ad un partito filo-ateniese ed in entrambi i casi fu la fazione rivale
32
BUCK (1979) p. 176 33
Probabilmente affiancati da truppe alleate. 34
Thuc. I 113.1-2. 35
BUCK (1979) pp. 153-155
8
a chiedere aiuto ad una forza esterna, c’è quindi un’importante somiglianza che
potrebbe darci una spiegazione riguardo alla leggerezza con cui i Tebani
organizzarono il secondo attacco.36
E’ infatti ipotizzabile che ad Orcomeno gli
esuli quando rovesciarono il potere non ebbero alcun bisogno di venire alle armi
dato che la maggioranza della popolazione provava simpatia per le loro intenzioni,
inoltre è altresì probabile la possibilità che la fazione pro-ateniese sia stata
scacciata della città senza essere sterminata. Questi due fattori crearono un
precedente che influì in maniera determinante nel comportamento tebano durante il
tentativo di conquista37
del 431 a Platea, infatti furono inviati solo trecento opliti
per la presa di una cittadina, che per il suo background di alleanze ne avrebbe
sicuramente richiesti di più. Inoltre tale atteggiamento è riscontrabile anche nel
comportamento tenuto nei primi momenti all’interno dell’agorà di Platea quando il
contingente tebano non solo non raccolse la richiesta della fazione anti-ateniese di
eliminare gli esponenti più in vista degli avversari pro-ateniesi, ma non provò
neanche a intimidire o a minacciare limitandosi a discorsi pacificatori e di
fratellanza, segno che il precedente di Orcomeno era ancora molto vivo in loro.
Va ora giustamente analizzata la motivazione di questo attacco, Tucidide ci dice
chiaramente che Tebe sapeva dell’imminente campagna di invasione dell’Attica da
parte dei lacedemoni38
il che indusse la città, quindi la Lega Beotica vista la
partecipazione di due beotarchi,39
a prendere la decisione di ascoltare ed
appoggiare le richieste della fazione anti-ateniese. Era inoltre da tempo che Tebe
cercava di convincere Platea ad entrare nella Lega Beotica40
a dimostrazione del
fatto che la città rappresentava un punto strategico all’interno della Grecia del
tempo, Platea infatti si trova nel mezzo di un importante crocevia, un passaggio
36
Anche se per loro in realtà non doveva essere un atto di guerra contro la città, bensì una risoluzione di
una stasis a favore di una delle due fazioni con la conseguente liberazione della città beotica dal giogo
ateniese. 37
O liberazione. 38
Thuc. II 2.3 39
GOMME (1956) p.3 infatti suppone che sebbene fossero presenti solo due beotarchi in questa operazione
non è detto che gli altri non ne fossero a conoscenza o che fossero contrari. I Tebani agirono dunque a nome
di tutta la Beozia. 40
Cfr. Hdt. VI 108; Thuc. III 55.1 ss
9
obbligato per chi voleva muoversi tra Attica e Beozia o tra Tebe e la Megaride.41
Dunque convinti che la guerra sarebbe scoppiata in breve tempo e considerando
l’operazione non più ardua della presa di Orcomeno, i Tebani vollero attaccare
durante il periodo di pace, forse addirittura durante una festa sacra,42
sfruttando
l’effetto sorpresa e la mancanza di una guarnigione ateniese all’interno della
città.43
Possiamo dunque tornare alla domanda che ci siam posti più volte nel corso dello
studio e da cui tutto è partito: può essere considerato l’attacco a Platea il primo
fatto bellico all’interno della guerra del Peloponneso? Accettando l’ipotesi di Price
secondo cui la Lega Beotica e quella peloponnesiaca non fossero alleate prima del
429, sebbene tra le due ci fosse un consolidato rapporto di amicizia, e tenendo in
considerazione i rapporti conflittuali che maturarono per tutto il corso del secolo
tra la Lega Beotica e quella Delio-Attica possiamo provare a rispondere. Il
consolidamento della Lega Beotica era al centro degli interessi di Tebe, essa infatti
puntava a riunire tutte le città della Beozia sotto la propria egemonia ormai dal 457
quando, come abbiamo visto, richiese l’intervento di Sparta. E’ quindi possibile
inserire l’episodio di Platea del 431 ed il successivo assedio del 429 all’interno di
quel conflitto che imperversava tra le due città rivali ormai da almeno trent’anni.
Questa impostazione però non esclude l’episodio per quel che riguarda gli eventi
correlati alla guerra del Peloponneso, è possibile infatti considerare Sparta e Tebe44
come co-belligeranti, sempre se vogliamo affidarci all’interpretazione, per me
avvallabile, di Price. La decisione presa da Sparta e dai propri alleati durante la
fine dell’anno 432 di invadere l’Attica nel 431 non deve essere interpretata come
decisione inevitabile, ovvero che avrebbe avuto sicuramente luogo. Ricordiamo
infatti che Archidamo non era convinto che la guerra andasse combattuta45
ed è
quindi possibile che l’invasione potesse non aver luogo come prestabilito nell’anno
41
Cfr. CARTWRIGHT (1997) pp. 91-92; UGO FANTASIA, La guerra del Peloponneso – Libro II, Pisa
2003, p. 232 42
FANTASIA (2003) p. 233 43
Vedi appunto le difficoltà Tebane nel periodo iniziale della guerra durante l’assedio di Platea che
richiederà poi l’intervento spartano per concluderlo positivamente. 44
Con le loro rispettive leghe. 45
Vedi ad esempio Thuc. I 85.2
10
precedente, possibilità non così recondita.46
Prendendo in considerazione tutti
questi aspetti non pare così ovvia nemmeno l’ipotesi, già precedentemente messa
in discussione, di Price secondo cui rimane comunque l’invasione dell’Attica il
primo atto della guerra Archidamica. Infatti dobbiamo ricordarci che quello
Tebano fu una vera e propria azione militare in territorio straniero, il contingente
inviato era formato da opliti in asseto da guerra e sebbene le loro intenzioni fossero
pacifiche, come abbiamo già evidenziato, erano comunque dei soldati scelti che si
intrufolarono in una città neutrale. Già questa azione sarebbe bastata a portare
Atene sul piede di guerra, sicuramente nei confronti dei Beoti e non dei
Peloponnesiaci; tuttavia le due leghe erano amiche, Sparta aveva già organizzato la
spedizione, i Beoti in seguito combatteranno per tutto il conflitto al fianco dei
Lacedemoni quindi appare evidente come l’attacco di quella notte a Platea risulti il
primo atto di guerra all’interno di quel conflitto che noi chiamiamo guerra
Archidamica. Non possiamo pensare di escludere un evento bellico così
importante e così grave avvenuto all’interno della Grecia continentale che investì
la città alleata di Atene per eccellenza, simbolo della vittoria sugli Achemenidi,
solo perché non vi partecipò Sparta o il suo re. Con quell’attacco si raggiunse il
punto di non ritorno: la guerra, come dice Tucidide, era ormai iniziata e nessuno
poteva più pensare di salvare la situazione temporeggiando47
o attraverso giochi di
diplomazia. Le armi erano state impugnate e sangue era stato versato, infatti la
sconsiderata e probabilmente eccessiva reazione plateese all’attacco tebano non
diede altra scelta ad Atene di prendere come unico provvedimento l’invio di una
guarnigione presso la città alleata, il tutto era inoltre corredato da una pesante
violazione del periodo sacro48
e del giuramento;49
non era più possibile instaurare
delle relazioni basate sulla fiducia poiché agli occhi degli dei entrambe le fazioni
erano sacrileghe. Per concludere è giusto considerare i vari passi in cui Tucidide
sembra contraddirsi. Price fa giustamente riferimento al passo contenuto nel quinto
46
In questo caso i sei mesi di preparazione potrebbero non essere dovuti alla semplice lentezza degli
Spartani ma ad un temporeggiamento. 47
Vedi Archidamo. 48
Vedi il periodo di festa sacra durante il quale Tebe attacca, FANTASIA (2003) op. cit. 49
Ovvero l’uccisione dei prigionieri Tebani, Tuch. II 5.5-6
11
libro50
dove Tucidide dice chiaramente che la guerra durò “ […] proprio dieci
anni, con l'aggiunta di pochi giorni, da quando vi fu per la prima volta l'invasione
dell'Attica, e l’inizio di questa guerra”51
, ma è chiaro anche in questo caso come
Tucidide in realtà parli apertamente del fatto di Platea in quanto l’invasione
dell’Attica avvenne ottanta giorni dopo l’attacco tebano, ovvero “[…]mentre era
estate e il grano era maturo[…]”52
, mentre la pace di Nicia fu conclusa “[…] alla
fine dell'inverno, con l’arrivo della primavera, subito dopo le Dionisie […]”53
. Lo
storico in questo caso si riferisce all’invasione dell’Attica solo perché in quel
momento al centro dell’attenzione ci sono i rapporti diretti tra Atene e Sparta54
.
Abbiamo quindi delle esternazioni esplicite di Tucidide riguardo al ruolo avuto
dall’attacco a Platea in tre diverse occasioni II 2.1, IV 133.3 e VII 18.2
contrariamente al già citato V 20.1 e a I 125.2 dove comunque il riferimento è
parziale.55
L’autore dunque quando deve essere diretto non ha dubbi, la guerra
inizia a Platea, ciò significa che era già chiaro all’epoca che l’attacco avvenuto in
quella buia e piovosa notte primaverile ebbe l’onore ed il peso storico di divenire il
primo fatto d’armi della guerra Archidamica.
50
PRICE (2001) p.284 51
Thuc. V 20.1 52
Thuc. II 19.1 53
Thuc. V 20.1 54
FANTASIA (2003) p.228 55
Ibidem p. 228-229
13
Bibliografia:
ROBERT J. BUCK, A History of Boeotia, Edmonton: The University of Alberta 1979
DAVID CARTWRIGHT, A Historical Commentary on Thucydides, Ann Arbor: The
University of Michigan 1997
UGO FANTASIA, La guerra del Peloponneso – Libro II, Pisa 2003
ARNOLD W. GOMME, A Historical Commentary on Thucydides, Oxford 1956
SIMON HORNBLOWER, A Commentary on Thucydides, Oxford
JONATHAN J. PRICE, Thucidydes and Internal War, Cambridge 2001
Fonti Antiche:
Aristotele, Politica
Diodoro Siculo, Biblioteca storica
Erodoto, Le Storie
Pausania, Periegesi della Grecia
Platone, Alcibiade
Tucidide, Le Storie