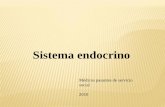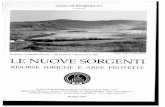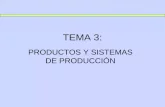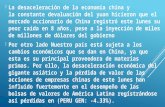“Il sistema amministrativo-contabile nelle Signorie e nei Comuni italiani a cavallo tra XIV e XV...
Transcript of “Il sistema amministrativo-contabile nelle Signorie e nei Comuni italiani a cavallo tra XIV e XV...
1
Il sistema amministrativo-contabile nelle Signorie e nei comuni italiani a cavallo tra XIV e XV
secolo: il caso dei Malatesti
1. Introduzione
Questo studio ha lo scopo di operare un tentativo di ricostruzione del sistema delle scritture
contabili e dei meccanismi di controllo amministrativo delle istituzioni pubbliche a cavallo tra il
XIV e il XV secolo, sulla base dei libri e delle scritture contabili della Signoria Malatestiana a Fano
e a Brescia presenti nell’Archivio di Stato di Fano (“Codici Malatestiani”) e dei riscontri operabili
con analoghi studi fatti sui documenti contabili di altre amministrazioni riferibili allo stesso periodo.
Lo spunto è fornito, oltre che dalla ricca e variegata documentazione che emerge dalla serie di
libri contabili malatestiani, anche dalla presenza tra questi di un registro (identificato con il n. 9) che
elenca in modo dettagliato tutti i documenti consegnati dal ragioniere al signore Pandolfo Malatesti
(libri giornale, libri mastri, registrini di contabilità preparatoria e speciale) che testimoniano un
affinato sistema di gestione documentale e di controllo sviluppato su un arco temporale decennale
(1397-1408/1409).
Dopo aver fatto un rapido cenno al modello organizzativo ed amministrativo della signoria
malatestiana nelle due aree geografiche di Fano e del comprensorio Brescia, Bergamo e Lecco, si
richiamerà brevemente il contenuto dell’Archivio dei Codici malatestiani, cercando di effettuare un
inventario ragionato dei documenti che lo compongono, distintamente per ognuna delle due aree e,
in particolare, una classificazione tipologica dei libri dell’area amministrativo-contabile della
signoria in modo da avere una prima segmentazione del complesso sistema delle scritture contabili
in essere. Emergono vari elementi di similarità rispetto ad altre contabilità dello stesso periodo
studiate in dottrina.
Preliminarmente, si rendono necessari tre ordini di considerazioni di premessa.
Il primo è legato alla necessità di far nostro un assunto posto a cardine di altri analoghi studi1:
quello della stretta connessione o correlazione fra i caratteri socio-culturali qualificanti un
particolare contesto e un determinato periodo storico e le modalità con cui si configurano le
amministrazioni pubbliche e le aziende e si modellano gli strumenti amministrativo-contabili
impiegati al loro interno. Da un punto di vista storico, sono numerosi gli studi che hanno esaminato
tale correlazione, evidenziando come, al mutare degli scenari socio-economici in cui le aziende
vivono, si sono modificate nel tempo le caratteristiche strutturali, funzionali e anche concettuali
delle aziende stesse, nonché i relativi linguaggi contabili, nei loro contenuti sia formali, sia
sostanziali2. In un determinato contesto culturale e in un dato periodo storico, quindi, l’indagine
sugli strumenti e sulle forme contabili adottate non può mai essere disgiunta dalla considerazione
delle altre dimensioni che compongono lo scenario economico-aziendale di quel contesto e di quel
periodo, a motivo delle “peculiari ed irripetibili interrelazioni esistenti tra scenario antropologico, la
dimensione della cultura economico-aziendale, le tipologie aziendali prevalenti, gli obiettivi
gestionali e gli strumenti contabili” medesimi (Di Toro, Di Pietra, 1999, p. 12)3.
1 P. Di Toro, R. Di Pietra, Amministrazione e contabilità nel XV e XVI secolo. Lo spedale senese del Santa Maria
della Scala attraverso i libri contabili, Cedam Padova, 1999, p. 5. 2 Si rimanda a M. Ciambotti, “La Storia della Ragioneria e la Storia Socio-politica”, in De Computis, Revista
Española de Historia de la Contabilidad, n. 10, giugno 2009, con le citazioni ivi contenute. 3 Cfr. ampiamente G. Catturi, Teorie contabili e scenari economico aziendali, Cedam, Padova, 1997 e La teoria
dei flussi e degli stocks ed il “sistema dei valori” d’impresa, Cedam, Padova, 1994. Sempre in P. Di Toro, R. Di Pietra,
op. cit., p. 11, si osserva che “lo strumento contabile non possa che essere in primo luogo una precipua espressione del
contesto economico-aziendale da cui esso discende. In un certo momento storico, in secondo luogo, possiamo d’altro
canto verificare come la dimensione economico-aziendale si innesti a sua volta nell’ambito di un più composito
mosaico il quale definisce i differenti profili della cultura antropologica di una data area geografica”. Poi, il sistema
delle conoscenze che scaturisce dall’utilizzo degli strumenti contabili (e di controllo) “accresce il bagaglio di esperienze
2
Come noto, il lasso di tempo considerato nel nostro studio ricade nel periodo di sviluppo
storico della Ragioneria che Melis4 definisce del Basso Medioevo, dal 1202 (l’anno del Liber Abaci
di Leonardo Fibonacci) al 1494 (l’anno della pubblicazione a Venezia del Tractatus de computis et
scripturis di Luca Pacioli).
In questo periodo si assiste al fiorire della cultura mercantile e alla correlata, forte, diffusione
della pratica contabile per scopi di controllo amministrativo, con le prime forme di determinazione
dei costi, dei ricavi e dei redditi, di calcolo dei risconti, di rilevazione di operazioni patrimoniali di
natura mercantile, industriale, bancaria e di servizi in genere (soprattutto nel campo dei trasporti, sia
terrestri che marittimi). L'esperienza medioevale della contabilizzazione delle operazioni aziendali
nasceva come semplice adattamento ai multiformi fatti mercantili delle conoscenze sui calcoli
aritmetici, già diffuse da secoli e, quindi, come "la naturale applicazione ed estensione al mondo
degli affari del 'far di conto', già storicamente sperimentato"5. Mentre questa esperienza, tuttavia, si
accresceva sempre di più e si rafforzava nei contenuti (al pari di molte altre attività nei più disparati
campi delle scienze umane e naturali, che conobbero analogo fervore innovativo), dovendosi
affrontare problemi di registrazione contabile di operazioni sempre più complesse6, non si può dire
che ci fu un altrettanto forte sviluppo simultaneo dottrinale nei riguardi della Ragioneria. Sia la
metodologia della partita doppia che i criteri di formazione dei bilanci trovavano nella pratica le
regole della loro formazione e solo con Pacioli e gli autori che ne seguirono la scia divennero
successivamente materia di studio. L'insegnamento delle conoscenze relative all'amministrazione
patrimoniale e alla soluzione dei connessi problemi di investimento, finanziamento e coordinazione
delle operazioni si trasmetteva quasi esclusivamente attraverso la prassi7. D'altronde, prima degli
autori cinquecenteschi troviamo solo matematici e abachisti che scrivevano trattati di aritmetica
mercantile, di algorismo, di geometria, di pratica della mercatura ecc. (si legga a questo proposito
l'elenco cronologico delle opere di computisteria e ragioneria venute alla luce in Italia, a partire dal
1202, curato da Giuseppe Cerboni).
Il secondo ordine di considerazione riguarda il forte legame che sussiste tra lo studio storico
delle rilevazioni contabili e l’interpretazione dei fatti storici di carattere sociale e politico che da
queste rilevazioni emergono. In tal senso, c’è chi8 considera la storia della contabilità come un
approccio privilegiato alla ricerca storica, ossia come approccio metodologico sistematico alla
personali che si trasmettono ad altri individui, contribuendo così a modificare la cultura aziendale ed attraverso questa a
fare avanzare la cultura generale” (p. 12). Cfr. anche M. Ciambotti, “La dialettica tra cultura aziendale, professione
contabile e sviluppo degli studi di Ragioneria secondo un modello dinamico di analisi”, in AA.VV., Cultura aziendale e
professione contabile, Atti del VII Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della Ragioneria (Bari, dicembre
2003), Casa editrice RIREA, Roma, 2005, pp. 255 e segg. 4 F. Melis, Storia della Ragioneria. Contributo alla conoscenza e interpretazione delle fonti più significative
della storia economica, Zuffi, Bologna, 1950, p. 18. 5 G. Catturi, Lezioni di Economia Aziendale, Cedam, Padova, 1984, p. 29.
6 Gli aspetti prevalenti dell'"arte di tenere i conti" sono, nel medioevo, quelli dell'enumerazione e del computo
dei beni scambiati o ceduti, con "la determinazione dei conti da aprire nei libri dell'azienda, l'attribuzione di una
intestazione appropriata, la determinazione del numero dei fatti da riferire a ciascun conto, la formazione di una
meccanica riepilogativa ed espositiva dei risultati quanto più possibile aderente agli scopi delle scritture" (S. Pezzoli,
Profili di Storia della Ragioneria, Cedam, Padova, 1986, p. 5). Circa questo ultimo aspetto, come noto, si svilupparono
metodi diversi di tenuta dei conti: a sezioni sovrapposte (scuola toscana); a sezioni contrapposte su due pagine (scuola
veneziana); a sezioni contrapposte nella stessa pagina (scuola lombarda). 7 V. Masi, La Ragioneria nell’età moderna e contemporanea, Giuffrè, Milano, ed. 1997, pp. 44 e segg. e G.
Catturi, op. cit., pp. 29-30. 8 E. Hernandez Esteve, La historia de la contabilidad, vía privilegiada de aproximación histórica: Cuentas de
los fondos recibidos por la Factória General de los Reinos de España para financiar la guerra de Felipe II contra el
Papa Pablo IV y Enrique II de Francia (1556-1559), Real Academia de Doctores de España, Madrid, 2010 e “La storia
della contabilità, un approccio privilegiato alla ricerca storica”, in E. Hernandez Esteve, M. Martelli (a cura di), Before
and after Luca Pacioli, Atti del II Incontro Internazionale, 17-19 giugno 2011, San Sepolcro-Perugia-Firenze, Centro
Studi “Mario Pancrazi”, San Sepolcro, 2011, pp. 365-380.
3
conoscenza storica tout court. Come sottolineato altrove9, lo storico della contabilità mira ad
indagare ed interpretare sia il significato economico che emerge dalla raccolta e dall’analisi dei
documenti (contabili e non), sia il legame tra questo significato e altri temi di carattere storico
presenti non solo nella storia economica ma, anche, nelle vicende sociali e politiche di un
determinato Stato o di una determinata collettività sociale, nelle relazioni familiari e personali di
singole persone o di una comunità di persone, nella morfologia geografica, nella storia dell’arte, in
quella dell’architettura, ecc.
Si concorda in tal senso con Costa10
quando afferma che lo studio del documento contabile
d’archivio non costituisce mai il punto di arrivo per uno storico della contabilità, arrestandosi ad un
lavoro di mera erudizione, bensì il punto di partenza per operare una “fusione” “del nostro
‘orizzonte’ con quello del passato oggetto d’indagine, al quale chiediamo risposte a problemi che
sono tutto sommato attuali, ma non per questo avulsi dal nesso storico in cui essi si manifestarono”.
Alla luce di questo approccio, continua Costa, l’obiettivo della ricerca sui documenti originari
scaturenti dalla vita amministrativa, resta triplice:
- ricostruire in sé il contenuto documentale riportato e, quindi, le operazioni amministrative
che stavano dietro a tali rilevazioni;
- studiare l’azienda e le sue oggettivazioni o tracce lasciate attraverso l’uso del linguaggio
contabile, alla luce del pensiero “proto-amministrativo” dei tempi e, se possibile, del
pensiero economico e sociale ante litteram e generale, rifuggendo dal soffermarsi troppo
sulle micro-storie locali, anzi cercando di inserire il fenomeno locale nei suoi corretti nessi
globali;
- ricostruire il nesso particolare di storia economica cui quest’impresa dà un contributo.
La Storia della Ragioneria potrà trovare ulteriore motivo di sviluppo proprio in un lavoro
continuo di scoperta e valorizzazione delle fonti archivistiche di questo tipo, considerate nel legame
con altre di diverso tipo e dalle quali insieme ricavare utili elementi di giudizio sulla realtà dei fatti
del passato e sulla vita sociale ed economica di intere comunità11
.
Il terzo ordine di considerazioni attiene alle finalità e alle caratteristiche generali del sistema
di rilevazioni scritturali che componevano l’amministrazione di un’azienda o di una Istituzione nel
periodo storico di cui ci stiamo interessando. Come sottolineato altrove12
, le scritture e i libri
contabili, nonché le regole di compilazione e le procedure di correzione e conservazione, servivano
fondamentalmente per i due scopi primari di prevenire e aiutare a risolvere le controversie legali e
di “serbar nota”, ossia tener memoria dei fatti aziendali 13
.
Alla prima finalità si associa una funzione giuridico-istituzionale della contabilità,
indispensabile per l’esercizio delle attività commerciali, che esigevano scritture contabili accettate,
9 M. Ciambotti, “Ricerche archivistiche di contabilità e conoscenza della storia”, in E. Hernandez Esteve, M.
Martelli (a cura di), Before and after Luca Pacioli, op. cit., pp. 391-400. 10
G. Costa, “Il ritrovamento del più antico Mastro mercantile siciliano: il ‘Quaterno’ del ‘mercerio palermitano’
Battista da Bologna (XV secolo)”, in Contabilità e Cultura Aziendale, n. 2, 2008, p. 99. 11
L’importanza e l’originalità di fare riferimento ai documenti contabili nella lettura delle vicende storico-
economiche, già sottolineate ampiamente in dottrina (cfr. P. Di Toro, R. Di Pietra, op. cit., p. 26 e i riferimenti a Zerbi,
Melis e Catturi), si associano alla consapevolezza che questo tipo di indagine storica richiede un ricco bagaglio di
strumenti concettuali e dottrinali e una visione multidisciplinare (conoscenze archivistiche, paleografiche, filologiche
ecc.), tale da consentire non solo la comprensione delle metodologie contabili e dei sistemi di rilevazione aziendale, ma
anche di superare gli inevitabili ostacoli di analisi paleografica, filologica, linguistica, storica, che inevitabilmente si
devono affrontare, specie nella lettura ed interpretazione dei libri di conto medievali. 12
Cfr. M. Ciambotti, “Finalità e funzioni della contabilità in partita doppia nell’opera di Luca Pacioli”, in F.
Cesaroni, M. Ciambotti, E. Gamba, V. Montebelli, Le tre facce del poliedrico Luca Pacioli, AGE – Arti Grafiche
Internazionali, Urbino, 2010 e “Luca Pacioli, la partita doppia e la storia della contabilità e della società”, in E.
Hernandez-Esteve, M. Martelli (a cura di), op. cit., pp. 300-307. 13
Cfr. M. Turco, “Finalità e funzioni della contabilità in partita doppia nella prima esposizione teorica di Luca
Pacioli”, in Contabilità e Cultura Aziendale, n. 2, 2002, pp. 196-215.
4
aventi valore probatorio in caso di liti o controversie che potevano sfociare in giudizio14
. Nei
tribunali, infatti, i giudizi sulle liti si basavano proprio sui documenti contabili, in particolare sul
Libro Giornale che, come documento cronologico attestante le transazioni intercorse, acquisì
credito proprio nella composizione delle dispute legali15
. Per questa funzione dei libri contabili,
occorreva che gli stessi fossero tenuti nel rispetto non solo di formalità intrinseche che si rifanno al
concetto di una ordinata contabilità, ma anche di formalità estrinseche, connesse alla loro
autenticazione presso un apposito ufficio. Il Pacioli stesso “annota che, se asseverati a dette
formalità, tali libri potranno avere efficacia probatoria, qualora dovessero essere prodotti in
giudizio, sia contro il mercante che a suo favore nei rapporti con gli altri. In questo modo, secondo
il Maestro, si viene ad instaurare un rapporto di fiducia e di apprezzamento con i terzi, così da
indurli a fare affidamento su un partner corretto e leale”16
. Inoltre, attraverso la contabilità si poteva
dimostrare l’esistenza giuridica e il corretto titolo di possesso dei beni patrimoniali, nonché ottenere
l’autorizzazione preventiva al compimento di certi atti17
.
Alla seconda finalità corrisponde una funzione informativa e di controllo nell’interesse del
mercante e dei terzi, legata alla necessità di tenere in ordine le vicende aziendali e di registrarne gli
esiti in maniera quanto più dettagliata possibile e alla fine di ogni anno perché “come dice il
proverbio ragion spesa, amistà lunga” (conti corti e amicizia lunga)18
.
Successivamente, con l’evoluzione della metodologia contabile e l’affermarsi, anche dal punto
di vista teorico, della partita doppia attraverso l’opera del Pacioli, la contabilità assume pure una
funzione sociale (legata alle scelte e ai comportamenti dei mercanti e alla loro credibilità verso i
terzi) ed una funzione informativa che va al di là del semplice “tener memoria” per diventare
funzione di “ragionamento”, ovvero di conoscenza, gestione e guida nella conduzione di attività
economiche19
.
Soffermiamoci, in ultimo, brevemente, sul significato dei termini che si utilizzeranno nel
corso del lavoro: rilevazione contabile, scritture o registrazioni contabili, conto, sistema di
scritture20
.
Le rilevazioni sono la memoria scritta dei fatti amministrativi così come desunti
dall’osservazione, ponendone in rilievo i caratteri qualitatitivi e quantitativi. Le scritture o
registrazioni sono rilevazioni di conto trascritte in libri o registri, dove il termine “conto” indica una
14
Già Benedetto Cotrugli nella sua opera “Della mercatura et del mercante perfetto”, pubblicata nel 1573 ma
scritta 36 anni prima del manoscritto del Pacioli, indicava nelle registrazioni contabili lo strumento non solo attraverso
il quale si “conserva e tiene memoria di tutte le transazioni”, ma anche “per far sì che esse siano un mezzo per evitare
molte liti, scandali…” (passo citato da M. Turco, op. cit, p. 201). Sulla questione, dibattuta nel corso del ‘300 tra
creditori, debitori e curatori fallimentari, di “quale valore attribuire alle prove fornite dai registri contabili delle società,
pur tenuti con scrupolosa esattezza, quale alle quietanze, quale alla corrispondenza attraverso la quale venivano
registrate dalla sede centrale le partite riscosse e pagate nelle sedi periferiche”, si rinvia a G. Piccinni, “Libri di
contabilità privata e di memorie in Siena: considerazioni in merito all’esistenza, alla conservazione e alla scomparsa
(XIII-XIV secolo)”, in Bollettino Senese di Storia Patria, Accademia Senese degli Intronati, Siena, 2008, pp. 195 e
segg. 15
M. Turco, op. cit., p. 202. 16
G. Cavazzoni, “Alla ricerca dei prodromi del bilancio nell’opera di Luca Pacioli”, in AA.VV., Riferimenti
storici e processi evolutivi dell’informativa di bilancio tra dottrina e prassi, Atti dell’VIII Convegno Nazionale della
Società Italiana di Storia della Ragioneria (Atri-Silvi, 22-23 settembre 2005), Casa Editrice RIREA, Roma, 2006, p.
430. Cfr. A. Montrone, “Autenticazione dei libri ed omogeneità della moneta di conto nell’opera del ‘Paciolo’”, in
Summit, Gli speciali di Summa, Supplemento al n. 76 di Summa, dicembre 1993, pp. 58 e segg. e E. Hernandez Esteve,
“Riflessioni sulla natura e le origini della contabilità in partita doppia”, in Contabilità e Cultura Aziendale, n. 1, 2009,
pp. 14-15. 17
P. Di Toro, R. Di Pietra, op. cit., p. 83. 18
M. Turco, op. cit., p. 202. Si leggano G. Catturi, “Evoluzione storica del conto come fonte di informazioni per
le decisioni aziendali”, in AA.VV., Atti del primo Convegno Nazionale di Storia della Ragioneria (Siena, 20-
21/12/1991), SISR, 1993, pp. 5 e segg. e P. Di Toro, R. Di Pietra, op. cit., p. 82, con i richiami a Fabio Besta ivi
contenuti. 19
M. Turco, op. cit., pp. 211-212. 20
Cfr. P. Di Toro, R. Di Pietra, op. cit., pp. 82-84, con i richiami bibliografici delle definizioni di Besta,
Amodeo, Onida, Catturi.
5
serie di scritture riguardanti un oggetto determinato (affari singoli, depositi, spedizioni marittime,
transazioni mercantili, movimenti di merci o materie prime, crediti e debiti, ecc.), esprimibile con
grandezze commensurabili, in modo da serbar memoria della condizione e misura di tale oggetto in
un dato istante e dei mutamenti che subisce (accrescitive o diminutive). Un sistema di scritture,
infine, è l’insieme delle scritture fra loro coordinate, riguardanti un determinato oggetto complesso,
secondo una forma e un ordine particolare, dettate dal seguire un certo metodo di registrazione.
Sono interessanti alcune distinzioni che è possibile effettuare con riguardo alle scritture e ai
libri contabili21
.
Si distinguono, innanzitutto, le scritture e i libri “ausiliari” da quelli “principali”: le prime
sono di preparazione e di supporto alle seconde, svolgendo una funzione di mezzo rispetto al fine.
Si possono distingure, poi, le scritture tenute in via “ordinaria” da quelle “straordinarie”, a
seconda della costanza (ricorrenza) o dell’occasionalità dell’accensione dei relativi libri contabili. I
libri contenenti registrazioni di tipo straordinario sono legati a scopi contingenti o a periodi
eccezionali e generalmente non sono costituiti in serie (come invece lo sono quelli di tipo
ordinario).
Con riguardo alla coordinazione dei fatti amministrativi acquisiti in contabilità, si distinguono
le scritture cronologiche (tipiche dei “libri giornali”) da quelle sistematiche. Le prime “riportano gli
accadimenti rispettando e seguendo rigidamente il loro snodarsi temporale; i registri rispondenti ad
un ordinamento sistematico prediligono invece, in prima battuta, altri criteri di organizzazione dei
contenuti, quali quelli di raggruppare questi ultimi per classi omogenee, per categorie con connotati
comuni, per oggetti univoci”22
o in relazione a specifici obiettivi conoscitivi23
. Le scritture
sistematiche, quindi, sono quelle tipiche dei mastri.
Un’ultima, interessante ai nostri fini, classificazione concerne il grado di dettaglio con cui si
seguono ed annotano contabilmente i fatti amministrativi. Al riguardo, si distinguono le scritture
“analitiche” da quelle “sintetiche”. I libri che contengono rilevazioni analitiche registrano gli
accadimenti oggetto di osservazione badando alle loro specifiche componenti (e ai processi che
hanno dato loro origine), mentre quelli di tipo sintetico, o riassuntivi, offrono una sintesi riferita a
fatti omogenei, i cui dati grezzi sono già stati elaborati e coordinati in altre rilevazioni24
.
Analogamente a quanto rilevato da Di Toro e Di Pietra per lo Spedale del Santa Maria alla
Scala di Siena25
(1999, p. 138), anche nel caso dell’amministrazione malatestiana si potrà constatare
che “le qualificazioni appena menzionate possono variamente sovrapporsi e combinarsi
reciprocamente”.
L’Archivio storico dei Codici Malatestiani è costituito in larghissima parte da libri contabili,
di diverse fattispecie, ognuna caratterizzata da contenuti e finalità di registrazione diverse. Si vedrà
che ciascun libro, pur avendo una sua specifica funzione, non può essere considerato se non in
stretta relazione con gli altri presenti nell’Archivio stesso o comunque richiamati da citazioni in essi
contenute. Tali interrelazioni riflettono la natura complessa delle molteplici attività
dell’Amministrazione malatestiana sulle due aree sopra citate e “l’esigenza di seguire le vicende
amministrative in tutte le loro manifestazioni, riconducendole, però, contemporaneamente, ad una
necessaria visione d’insieme, allo scopo di permettere una saggia e oculata amministrazione
unitaria”26
. I libri contabili presentano relazioni tra loro su diversi livelli di importanza e di
21
Si legga P. Di Toro, R. Di Pietra, op. cit., p.137. 22
Ibidem, p. 137. 23
G. Catturi, Teorie contabili e scenari economico-aziendali, op. cit., p. 73. 24
Per esempio, nell’archivio Datini di Prato i libri contabili sono classificati secondo le tipologie di scritture
definitive o di sintesi (Libro debitori e creditori o Libro grande; Libro di mercanzie; Libro delle entrate e delle uscite) e
scritture preparatorie o di analisi (Memoriale; Quaderni di cassa, di spese di mercanzie, di ricevute e mandate di balla,
di spese di casa delle ricordanze). Cfr. le schede informative della Fondazione Istituto Internazionale di Storia
Economica “F. Datini” di Prato. Cfr. anche F. Melis, L’azienda nel medioevo, Le Monnier, Firenze, 1991. 25
P. Di Toro, R. Di Pietra, op. cit., p.138. 26
Usiamo le stesse parole impiegate da P. Di Toro, R. Di Pietra, op. cit., p. 86 con riferimento al complesso
sistema di registrazione e di scritturazione contabile dello Spedale del Santa Maria della Scala di Siena (nei secoli XV e
6
contenuto funzionale, che andranno necessariamente approfonditi, anche con riguardo a
documentazioni contabili analoghe dello stesso periodo.
2. Il modello organizzativo e amministrativo della Signoria malatestiana a Fano e a
Brescia, Bergamo e Lecco
Il panorama politico e sociale dell’Italia sul finire del XIV secolo e l’inizio del XV secolo è
caratterizzato, come noto, dal completamento del processo di concentrazione economica e politica
rappresentata dal sorgere delle Signorie e dei Principati che, ponendosi al di sopra delle variegate e
fino ad allora assolutamente indipendenti realtà comunali, assicuravano un potere più organico,
solido, capace di stabilire l’ordine e garantire la sicurezza di vita dei cittadini. Il saggio di Anna
Falcioni che precede questo scritto ha messo in luce efficacemente gli elementi cardine del
complesso rapporto che si andava stabilendo tra i Comuni e le Signorie, enucleati sulla base
dell’esperienza del dominio di Pandolfo III Malatesti a Fano (1385-1427), così come a Brescia
(1404-1421), a Bergamo (1407-1419), a Lecco (1408-1418) 27
:
1) Il progressivo imporsi della Signoria come sovrastruttura rispetto alle istituzioni comunali,
che conservano esteriormente la loro autonomia (personalità giuridica), ma quasi del tutto
svuotata a favore della personalità superiore e sovrana del signore, nelle cui mani si
concentrano tutti i poteri di uno Stato: legislativo (il signore può liberamente interpretare,
correggere, prorogare le leggi e gli statuti cittadini); amministrativo (con autorità di
governo su cittadini e magistrati e possibilità di alienare e disporre dei beni dei Comuni);
giudiziario (con il diritto di annullare e di cassare le sentenze legalmente pronunciate dai
magistrati)28
;
2) La sopravvivenza delle strutture e dei procedimenti amministrativi di ciascun governo
comunale sotto una sovrastruttura burocratica di nomina signorile, che progressivamente
introduce elementi e realtà nuove. Come osserva Bonfiglio-Dosio29
, “gli studiosi hanno
ben evidenziato la trasformazione, nel corso del trecento, degli apparati amministrativi
cittadini e la costituzione di organizzazioni statali robuste ed ordinate, supportate dalla
presenza e dalla disponibilità di ‘notabilati burocratici’ che porteranno alla costituzione di
cancellerie urbane e signorili. L’organizzazione di apparati burocratici alle dirette
dipendenze di un signore fu allora un poderoso strumento di governo e ora una fonte
significativa sull’inserimento del dominus nel contesto della città” 30
;
XVI). Si leggano anche le pp. 109-118 circa le numerose interrelazioni rilevabili tra sezioni o parti di un medesimo
volume, o fra libri contabili temporalmente successivi ma della medesima specie, od anche fra registri di natura diversa
ma tenuti contestualmente. Gli autori notano l’utilizzo non solo di “chiari meccanismi di richiami di scritture, bensì, a
monte, anche (di) tecniche di identificazione reciproca e di rinvio schematico fra i diversi volumi che le contenevano”
(p. 110). 27
A. Falcioni, “L’economia di Fano in età malatestiana (1355-1463)”, in Fano Medievale, Fano, 1997, pp. 102 e
segg. 28
M. Saltamacchia, Costruire cattedrali. Il popolo del Duomo di Milano, Marietti 1820, Genova-Milano, 2011,
pp. 18-19, osserva che, nel periodo visconteo di fine trecento, sebbene l’organizzazione del Comune di Milano appaia
immutata rispetto all’ordinamento podestarile precedente, in realtà “le strutture e le istituzioni preesistenti vengono
svuotate di effettivo potere autonomo e divengono strumento amministrativo nelle mani dei Visconti, che controllano
l’operato e decidono le elezioni delle cariche principali”: così, “…i milanesi non sono più considerati cittadini, ma
sudditi”; “…il potere del Podestà, la principale autorità giudiziaria, diviene gradualmente più fittizio, e finisce per
diventare un funzionario al servizio del Signore, che ne regolava l’elezione”; man mano “svanisce l’ultima traccia del
libero Comune”. 29
G. Bonfiglio-Dosio, “Il variopinto mondo della cancelleria signorile”, in G. Bonfiglio-Dosio, A. Falcioni (a
cura di), La Signoria di Pandolfo III Malatesti a Brescia, Bergamo e Lecco, Centro Studi Malatestiani di Rimini, vol.
VIII, Bruno Ghigi Editore, Rimini, 2000, p. 72. 30
Come afferma A. Falcioni nel presente lavoro (retro, p. 8) citando P.J. Jones, l’unificazione in uno Stato
centralizzato era piuttosto un fatto personale del signore garante e coordinatore della vita pubblica e appariva come
qualcosa di rudimentale e precario, frutto di operazioni spartitorie o per successione o per appannaggio.
7
3) La circolazione di competenze burocratiche non solo nell’ambito del rapporto fra strutture
comunali e Signoria ma anche fra territori diversi appartenenti allo stesso Stato o a Stati
differenti;
4) La nomina, diretta da parte del signore, dei funzionari amministrativi, finanziari e militari
operanti nelle realtà comunali e territoriali facenti parte della stessa Signoria. Nel caso di
Pandolfo III e del suo dominio su Brescia e Bergamo, è appurato che egli nominò alle più
alte cariche (vicario del signore, ruoli amministrativi e burocratici, capitani, castellani
ecc.) persone originarie di Fano e delle Marche o della Romagna o dell’Emilia, che
vengono inserite nelle società cittadine “pur non possedendo a volte i requisiti giuridici
tradizionalmente richiesti”, ma indispensabili per esercitare un controllo strategico delle
città e dei vari possedimenti e per la stessa conservazione della Signoria31
;
5) La forte interconnessione della complessa contabilità della camera32
signorile con le
strutture amministrative comunali e periferiche, tale da generare, come si vedrà più avanti,
un coordinato sistema contabile, specializzato e rigoroso nel tener conto delle esigenze di
controllo e delle peculiarità dei territori e delle “succursali” soggette alla volontà del
signore.
La segnalata osmosi tra Signoria e Comune si esemplifica nel caso di Pandolfo III e del
Comune di Fano in una complessa e fitta struttura organizzativa, rappresentata sinteticamente nella
Tab. 1.33
In questa si associano ruoli e funzioni svolte all’interno di una struttura integrata in cui
spesso risulta difficile specificare l’appartenenza alla camera signorile o al Comune. Ovviamente, a
capo di tutta la struttura si poneva il signore, la cui volontà regolamentava il funzionamento di tutte
le magistrature cittadine (Falcioni, ivi, p. 11).
Tabella 1 Ruoli e funzioni nella struttura della Signoria di Pandolfo Malatesti su Fano,
Brescia e altri territori
RUOLO FUNZIONE ESERCITATA
Podestà Incaricato dal signore e suo agente; principale magistratura nei vari
Comuni presenti nella Signoria (Fano, Senigallia, Pergola, Serra dé
Conti, Iesi, Osimo, Castelfidardo, Montelupone, Filottrano, Staffolo,
Montefano, Offagna, Monte Milone oggi Pollenza, Amandola,
Montecassiano, Montolmo oggi Corridonia)
Consiglio del Comune – generale
(ex maggiore) e speciale
- Cooperazione con il signore nell’organizzazione e realizzazione di
progetti riguardanti lavori pubblici e infrastrutture o manutenzione
porti, strade ecc.;
- Cooperazione con il signore nell’organizzazione di imprese
belliche;
- Responsabilità decisionali nei settori della sanità e dell’istruzione;
- Verifica legittimità degli atti (anche signorili);
- Elezione di alcuni funzionari ausiliari;
- Approvazione di regolamenti di corporazioni e di svolgimento di
31
G. Bonfiglio-Dosio, op. cit., p. 72. “La decisione del signore di collocare in punti nevralgici del suo sistema
difensivo persone direttamente dipendenti dalla sua volontà e forestiere rispetto al territorio da governare rientrava nel
più generale piano di prevenzione delle rivolte organizzate da esponenti delle fazioni politiche indigene, in grado di
approfittare della loro carica per scatenare nuove lotte intestine” (p. 85). Analoga politica veniva seguita in altre realtà
signorili. Per esempio, come scrive M. Saltamacchia, op. cit., p. 19, con riferimento al dominio visconteo a Milano,
“secondo le antiche consuetudini cittadine la scelta del Podestà doveva ricadere su un forestiero, per evitare collusione e
favoritismi nello svolgimento del proprio incarico. I Visconti ovviano a questo caveat eleggendo sempre forestieri
provenienti dalle città alleate, e quindi loro dipendenti”. 32
Per “camera” deve intendersi l’organismo preposto all’amministrazione finanziaria della casa e dello Stato. 33
Con riferimento al Ducato Sforzesco, F. Leverotti, “Gli officiali del ducato sforzesco”, in Annali della
Classe di Lettere e Filosofia della Scuola Normale di Superiore, Serie IV, Quaderni I , 1997 (distribuito in formato
digitale da Reti Medievali), distingue gli Uffici Centrali da quelli periferici e individua, a livello dei primi, le seguenti
classi di magistratura: giudiziaria, finanziaria, militare, sanitaria.
8
fiere;
- Decisioni su donazioni e sussidi al signore;
- Controllo dei prezzi di generi alimentari e servizi;
- Organizzazione dell’estimo; ricerca evasori fiscali; imposizione,
distribuzione e spesa della colletta; vendita all’asta di tasse agli
appaltatori; ecc.
Vicario generale, o vicario del
Tribunale d’appello (vicarius
domini super appellationibus)
Dottore in legge con funzioni vicariali del signore, giudice di appello,
spesso ambasciatore del signore e con competenze specifiche anche in
questioni finanziarie (come giudice dei dazi e delle gabelle comunali)
Vicari dei vicariati fanesi presenti
nei territori dominati dal signore
Funzioni vicariali in alcune città controllate dal signore (Mondavio,
Montalboddo o Ostra, Mondolfo, Borgo San Sepolcro)
Cancelliere Ufficio di cancelleria con funzioni amministrative e notarili relative
alla compilazione dei decreti del signore, all’aggiornamento del libro
degli impiegati, alla registrazione degli atti presso il tribunale, alla
stesura dei verbali dei consigli comunali, ecc.
Referendario del signore Ufficiale incaricato con funzioni di magistratura finanziaria e fiscale,
controllo delle spese (tramite emissione di bollette), vigilanza,
consulenza all’organo consiliare, supervisione dei referendari
cittadini, gestione ufficio delle gabelle ecc.
Maestri delle entrate ordinarie e
straordinarie
Funzioni relative alla riscossione delle entrate ordinarie e
straordinarie registrate nei libri “bastardelli”, controllo sulla tesoreria
Depositario o Tesoriere (della corte
signorile o dei singoli Comuni)
Funzioni di tesoreria e gestione finanziaria (incassi e pagamenti),
redazione del bilancio signorile o di quello comunale
Primo e secondo Ratiocinator
(ragioniere) della Camera signorile
e del Comune
Funzioni di revisione e controllo contabile
Camerari, spenditori, esattori e
sescalchi
Funzionari dell’apparato amministrativo-finanziario e contabile della
Signoria
Massaro del Comune Di nomina da parte del consiglio speciale del Comune, con funzioni
esecutorie dei deliberati; depositario di pegni giudiziari; responsabile
di alcune attività economico-finanziarie del Comune (riscossione
multe, controllo esecuzione lavori pubblici, ecc.)
Notaio Garantisce la regolarità dei contratti conclusi tra la Camera e i terzi
Ufficiali del sale Responsabili della gestione dell’ufficio del sale (acquisto, trasporto e
commercializzazione del sale)
Ufficiali dei danni dati, giudici dei
malefici e delle gabelle, sindaci dei
castelli ed altri funzionari fiscali
Funzioni relative all’amministrazione della giustizia (gestione delle
multe o sanzioni relative ai danni dati, ai malefici, ecc.; gestione
gabelle varie) e alla ripartizione ed esazione delle tasse
Fattori dei vari possedimenti
signorili (Marotta, Molini di Fano,
Caminata ecc.)
Funzioni di gestione, anche amministrativo-contabile, dei
possedimenti di Pandolfo Malatesti
Castellani delle Rocche Capitani comandanti delle fortezze cittadine e delle sue milizie,
nominati semestralmente direttamente dal signore oppure dal
consiglio generale
Uffici militari delle vicarie:
capitani delle porte o conestabili,
capitani di castelli e ville, ufficiali
della custodia, ufficiali delle
munizioni, ecc.
Funzioni militari e di difesa delle fortezze e rocche, alle quali si
potevano aggiungere anche funzioni fiscali di carattere locale (ad
esempio, riscossione dei dazi)
3. I libri e le scritture contabili della Signoria malatestiana di Fano
3.1 L’archivio dei Codici Malatestiani di Fano secondo la ricostruzione di Aurelio Zonghi
9
L’archivio noto con la denominazione Codici Malatestiani34
, sopravvissuto alle massicce
campagne di scarto, che nel corso dell’Ottocento depauperarono importanti archivi della
documentazione contabile35
e oggi conservato nella Sezione di Archivio di Stato di Fano, è
composto da 112 volumi e 1 busta miscellanea che vanno dal 1357 al 1463, ovvero dalla Signoria di
Galeotto I alla fine di quella di Sigismondo Pandolfo Malatesti36
.
Il riordino effettutato dallo Zonghi segue un ordine sostanzialmente cronologico, percorrendo
la sequenza delle successioni dinastiche dei membri della famiglia Malatesti e scorporando tali
unità archivistiche dal resto dell’archivio del comune di antico regime. L’approccio adottato
privilegia soprattutto il contenuto informativo dei documenti e trascura gli aspetti istituzionali ed
archivistici, i quali invece hanno avuto un peso determinante sulla produzione dei documenti stessi
e diventano una fonte importante per indagare i soggetti produttori e la loro organizzazione
amministrativa e burocratica.
L’intero Archivio è suddiviso dallo Zonghi in 9 raccolte di volumi, distinte a seconda dei
soggetti di riferimento e delle diverse dominazioni esercitate37
:
1. vol. 1 (1367-1368, con bandi, deputazioni di ufficiali, elenchi di nomi, dichiarazioni, decreti
di nomina, intimazioni di pena e note di sentenze) e vol. 2 (1373, nota delle spese sostenute
per le nozze di Gentile Varano, cugino della moglie di Galeotto Malatesti): libri di Galeotto
I Malatesti;
2. voll. dal 3 al 39 (1386-1426), libri di Pandolfo III, come Signore di Fano:
voll. 3, 4, 5 e 6, contenenti Bandi, decreti, suppliche, lettere e ordinamenti vari scritti
in tempi diversi;
vol. 7 (1410-1424): elenco dei luoghi soggetti alla dominazione dei Malatesti nella
Marca e degli ufficiali di ciascun luogo, eletti e stipendiati dagli stessi;
vol. 8 (1410-1424): rassegne del personale che i Podestà, i vicari, i castellani e i
conestabili dovevano tenere nei diversi luoghi;
vol. 9: inventario dei libri di amministrazione (“de la raxione”) dei beni di Pandolfo,
relativi a possedimenti diversi e descritti anno per anno, dal 1397 al 1410, l’ultimo
dei quali è quello riferibile al vol. 19, redatto dal fattore Antonio d’Andriuccio da
Sassoferrato;
vol. 10 (1392-1393), vol. 11 (1396-1404) e vol. 12 (1397): registri di spese
sostenute per la corte di Pandolfo;
voll. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 2438
: registri relativi all’amministrazione
tenuta da Giovanni Bettini e da Andrea Bettini da Firenze, depositari del signore a
34
La denominazione è fuorviante, in quanto richiama concetti codicologici più che archivistici. Fu attribuita
dall’illustre studioso fanese Aurelio Zonghi, che riordinò e descrisse alla fine del secolo scorso l’archivio comunale di
Fano (A. Zonghi, Repertorio dell’antico archivio comunale di Fano,Tip. Sonciniana, Fano 1888); ed è stata poi
mantenuta dalla redazione della Guida generale (Ministero per i Beni Culturali e Ambientali – Ufficio Centrale Beni
Archivistici, Guida generale degli Archivi di Stato italiani, III, Roma 1986, p. 572). 35
Sulla temperie culturale e storiografica nella quale collocare tali imponenti scarti archivistici si veda
soprattutto I. Zanni Rosiello, “Spurghi e distruzioni di carte d’archivio”, in Quaderni storici, XVIII/56, 1983, pp. 984-
1017, ora in C. Bianchi, T. Di Zio (a cura di), L’archivista sul confine. Scritti di Isabella Zanni Rosiello, Pubblicazioni
degli Archivi di Stato, Saggi, n. 60, Roma, 2000, pp. 273-303. 36
Come riferisce lo Zonghi (pp. 3-4), infatti, la famiglia Malatesti esercitò la signoria su Fano e il suo distretto in
qualità di vicari pontifici tra il 1355 e il 1463: Galeotto fra il 1355 e il 1385; il figlio Pandolfo III fra il 1385 e il 1427;
suo figlio Sigismondo Pandolfo dal 1427 al 1463 (cfr. A. Falcioni, “Il governo consortile di Sigismondo Pandolfo e di
Malatesta Novello nel territorio fanese”, in M. Mengozzi, C. Riva (a cura di), Malatesta Novello nell’Italia delle
Signorie: fonti e interpretazioni: atti del convegno (Cesena, 26-27, marzo 2004), Cesena, 2005, pp. 87-106. 37
Si veda M. Ciambotti, “Il sistema dei registri contabili della cancelleria di Pandolfo III. Il Liber viridis
rationum curie domini (1407-1409), in M. Ciambotti, A. Falcioni, Liber viridis rationum curie domini. Un registro
contabile della cancelleria di Pandolfo III Malatesti, Argalìa Editore, Urbino, 2007. Cfr. G. Bonfiglio-Dosio, “Il
variopinto mondo della cancelleria signorile”, op. cit, p. 31. 38
Come osserva lo stesso A. Zonghi, op. cit., p. 5 e p. 44, alcuni di questi libri di amministrazione sembrano
piuttosto appartenere al Comune di Fano che alla Camera di Pandolfo. Ma è l’Autore stesso a spiegare che il Malatesta,
10
Fano (il primo dal 1401 al 1405, il secondo dal 1406 al 1416), con indicazione di
entrate (dazi, gabelle, taglie e provvigioni pagate al Signore dalle città e dai contadi)
ed uscite, sia ordinarie che straordinarie; e voll. 25, 26 e 27: registri dei debiti/crediti
del depositario medesimo riferiti ad anni compresi tra il 1401 e il 1419 e tra il 1420 e
il 1423 (con altri depositari)39
;
diversi registri di prestanze, introiti ed uscite di cassa a vario titolo, per partite di
grano (voll. 28, 34, 35) o cibarie necessarie alla Corte (vol. 36), per le spese
sostenute per la Camera di Pandolfo a Fano (voll. 29, 30, 31, 32, 33, tutti scritti dal
depositario Tommaso di Francesco da Montefano), per la gestione dei beni camerali
e patrimoniali relativi a vari possedimenti (voll. 37, 38 e 39), quasi tutti riferiti ad
anni successivi al 1415.
3. Volume dal 40 al 68 (1405-1421): libri contabili di Pandolfo III, signore di Brescia e
Bergamo (partitari, libri giornali, libri di entrata/uscita ecc.);
4. vol. 69 (1396), vol. 70 (1402-1403), vol. 71 (1408-1409), voll. 72A e 72B (1410-1415): libri
di Pandolfo III, signore del Vicariato di Mondavio e di Senigallia (registri di spese varie con
relative quietanze rilasciate; di entrate per riscossioni di imposte; di entrate/uscite relative
alla gestione del depositario di Senigallia Niccolò Mariani da Cremona). I pagamenti del
registro n. 69 sono eseguiti da Pietro Petroni (depositario del vicariato di Mondavio). Il
registro n. 70, tenuto da Molduccio de’ Boccacci da Meldola, podestà di Senigallia e
referendario del signore dal 1406 al 1424, elenca la rassegna dei pascoli e del bestiame della
città di Senigallia, con gli affitti pagati dagli assegnatari dei pascoli collettivi. I registri n. 71
e 72A contengono le rilevazioni delle entrate e delle uscite della tesoreria signorile di
Senigallia, retta dai depositari Ciriaco di Bartolo e Niccolò Mariani, mentre il registro 72B
contiene il conto relativo al grano proveniente da Senigallia sul quale il depositario di
Senigallia Pietro Petroni ha riscossa la gabella;
5. vol. 73 (libro delle ragioni 1428-1429, tenuto da Pietro di Alberico, depositario del signore a
Fano), voll. 74, 76 e 77 (libri giornali di entrata/uscita 1429-1432, tenuti il primo dal
depositario Agostino da Bergamo e il secondo e il terzo dal depositario Domenico di
Pellegrino), vol. 75 (partitario dare/avere degli incantatori dei dazi e degli ufficiali incaricati
della loro riscossione, 1429-1430, tenuto dal depositario Agostino da Bergamo e poi da
Domenico Pellegrino), vol. 78 (registro di entrata e spesa relativo al grano e conto delle
biade tenuto dal massaro Alessio, 1430-1433): libri di Carlo Malatesti e suoi nipoti
(Galeotto Roberto, Sigismondo Pandolfo e Malatesta Novello, legittimati a succedere a
Pandolfo III con bolla del papa Martino V), da riferire al governo della città di Fano, retto da
Carlo dal 1427 al 1429 (la sua morte avvenne il 14 settembre) e congiuntamente dai nipoti
dal 1429 al 1433;
6. vol. 79 (registro generale entrate e uscite 1433-1434, redatto dal depositario di Fano
Zagarello di Francesco de Boglioni); voll. 80, 81, 82 (libri mastro di entrate e spese tenuti
dal fattore di Caminata Antonio di Coluccio da Scapizzano e libri delle bocche ordinarie e
come signore, aveva dalla città di Fano una larga provvigione calcolata sulla maggior parte dei cespiti della sua rendita.
Sopra ciascuna specie di entrata del Comune (o di altri Comuni), cioè, il signore aveva diritto ai cosiddetti “capisoldi”
(capita solidorum), che erano di suo appannaggio e dai quali venivano sostenute alcune spese che altrimenti avrebbero
dovuto essere imputate al bilancio comunale. Questi capisoldi sono registrati, per esempio, nel volume n. 20, che
contiene anche la rilevazione delle operazioni di riscossione delle provvigioni dovute da diversi Comuni della zona
(Mondavio, Pergola, Mondolfo, ecc.) non già al Comune di Fano, ma direttamente al signore, nella sua veste di Vicario
della Chiesa. In questo libro sono registrati anche gli introiti dei dazi e degli utili avuti dalla compagnia del sale, che
veniva caricato a Venezia, portato a Bologna o imbarcato per via mare sino a Fano, qui depositato e poi smistato per i
vari Comuni marchigiani (Fabriano, Osimo, ecc.), dove veniva venduto per conto della suddetta compagnia. 39
Di Andrea Bettini, depositario del signore a Fano per un lungo periodo, lo Zonghi loda “l’esattezza usata nel
tenere i libri di amministrazione”. Cfr. anche C. Selvelli, “Sulla figura di Pandolfo III Malatesta Signore di Fano”, in
Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Marche, IV, 1943, p.32, il quale giudica, in particolare, “fra
i più belli, meglio scritti e meglio conservati” i registri nn. 21, 22 e 23.
11
straordinarie, 1433/1434, 1434/1435, 1436/1438); vol. 83 (1439-1462, registri delle bocche,
ordinarie e straordinarie, che il fattore generale Pietro di Micheluccio da Saltara deve
sfamare e tenere in casa od ospitare40
); voll. 84, 85, 86 (1434/1435, 1434-1435, 1435-1445,
libri partitari di Dare e Avere tenuti dal depositario del signore e contenenti le registrazioni
delle entrate e delle uscite in periodi successivi, riferite a diversi soggetti che avevano
intrattenuto rapporti con la Camera di Sigismondo Pandolfo); vol. 87 (1449, registro delle
entrate e delle spese della città di Fano, tenuto dal referendario Paolo e consegnato al
depositario Vincenzo di Tommaso); vol. 88 (1452-1453, registro dell’introito ed esito del
grano dei possedimenti e molini del signore); voll. 89, 90 e 91 (1453, 1454, 1456, registri
entrate/uscite tenuti dal fattore di Caminata Cristoforo da Certaldo e dal vice-fattore
Antonio); voll. 92 e 93 (1432-1436, 1449-1462, registri degli introiti dei dazi sopra la tratta
e il passo, con relative licenze, salvacondotti, decreti e bandi emanati dai Signori Malatesti41
in periodi diversi); voll. 94, 95 e 96 (1434-1463, libri delle mostre dei podestà, dei castellani
e dei conestabili delle porte di Fano e delle rocche vicine, tenuti dal cancelliere del Comune
di Fano Pierantonio di Damiano); voll. 97, 98, 99, 100 e 101 (1439-1456, registri dei ruoli
delle tasse speciali poste sopra i cittadini di Fano in soccorso delle imprese belliche di
Sigismondo Pandolfo, con depositari che si succedono (Giacomo di Niccolò di Bricco,
Giovanni di Vianuccio da Fano e Giacomo di Antonio da San Costanzo); vol. 102 (1457-
1459, libro delle paghe dei soldati, tenuto dal depositario di Fano);
7. voll. 103 (vicariato di Mondavio e Orciano, 1442-1443), 104 (vicariato di Mondavio, 1448-
1451), 105 (vicariato di Mondavio, 1453), 106 (vicariato di Mondavio, 1457), 107
42
(vicariato di Senigallia, 1454), 108 (vicariato di Senigallia, 1456-1457) e 109 (vicariato di
Senigallia, 1458-1459): libri contabili di entrate e di spese43
di Sigismondo Pandolfo, vicario
di Mondavio, Orciano e Senigallia, relativi al periodo 1422-1459, tenuti dai depositari del
vicariato di queste terre (Giovanni di Venarino da Sassoferrato, Balduccio da Mondavio,
Giacomo Marcuzzi di Rimini, Lorenzo da Orciano, Tommaso de la Cavalera, Girolamo
Nasello), preposti a riscuotere una parte degli introiti dei Comuni, devoluti al loro signore, e
ad amministrarli secondo la sua volontà;
8. vol. 110 (1415-1416): libro di Malatesta Malatesti, relativo all’amministrazione della tenuta
di Montetorto, di proprietà del signore, con indicazione delle spese sostenute dal fattore per
pagare i salari dei braccianti adoperati nelle attività di coltura e di miglioramento dei terreni;
9. vol. 111 (1454-1455) e volume 112 (1455-1456): libri di Donna Isotta degli Atti, moglie di
Sigismondo Pandolfo, contenenti le registrazioni delle entrate e delle uscite, suddivise per
titoli, relative all’amministrazione della tenuta di Montemarciano.
A completare l’Archivio, infine, c’è il volume n. 113, che in realtà è una raccolta miscellanea
di carte (mandati, bollettini, suppliche, lettere, ricevute di pagamenti, frammenti di libri di conti,
ecc.), riconosciute appartenere all’amministrazione della Camera e della Casa dei Malatesta.
3.2 Un inventario ragionato dei registri malatestiani relativi alla Signoria di Pandolfo III
su Fano
L’intero archivio dei Codici Malatestiani può essere analizzato con un criterio diverso da
quello impiegato dallo Zonghi, andando a suddividere i libri o registri secondo la loro natura e i loro
contenuti. La nostra analisi riguarderà in questo paragrafo la documentazione riferibile al governo
40
In questi libri si elencavano sia i componenti della famiglia del fattore che le persone a vario titolo (aiutanti,
guardie, il notaro, ecc.) assegnate alla sua casa o di passaggio per motivi vari, tutte a carico del signore. 41
Nel volume 92 è riportato anche il registro dei fondighieri, cioè di coloro che, pagando la gabella del passo,
conducevano merci nei loro fondachi (da qui il termine “infondacare”), aperti nella città di Fano, dove le stesse
venivano vendute o trasportate altrove senza bisogno di ulteriori licenze. Cfr. A. Zonghi, op. cit., p. 146. 42
Nel registro n. 107, a carta 89, è scritto un conto di Dare e Avere tra il signore e il depositario (cfr. A. Zonghi,
op. cit., p. 158). 43
Tra queste vanno segnalate le spese per la costruzione della famosa Rocca di Mondavio.
12
dei possedimenti marchigiani di Pandolfo III su Fano, rinviando al paragrafo successivo la
descrizione inventariale e la classificazione dei registri prodotti durante la Signoria bresciana,
oggetto di altri precedenti lavori44
, con l’impiego della stessa metodologia.
I registri da prendere in esame sono in tutto 57 (più il registro n. 9 che sarà oggetto di analisi a
parte nel par. 3.4) e nella suddivisione operata nel precedente paragrafo corrispondono alla seconda
e quarta raccolta indicata dallo Zonghi. Il numero dei registri è più elevato di quello corrispondente
alla numerazione assegnata dallo Zonghi, in quanto alcuni registri sono contenuti in buste
considerate come singole unità archivistiche. Mantenendo il numero identificativo dato dallo
Zonghi, vengono perciò inseriti ulteriori sub-numeri per questi registri contenuti in buste e indicati
complessivamente con il numero del contenitore.
Come sintetizzato nella Tabella 2, si possono individuare 3 tipologie (o serie) di libri:
- libri di natura normativa;
- libri riconducibili all’area del governo della Signoria;
- libri contabili o comunque riferibili all’area amministrativo-contabile della Signoria.
Tabella 2 Serie e sottoserie dell’archivio malatestiano di Fano
Serie Libri e Registri
44
G. Bonfiglio-Dosio, “Il variopinto mondo della cancelleria signorile”, in G. Bonfiglio-Dosio, A. Falcioni (a
cura di), op, cit., e M. Ciambotti, “Il sistema dei registri contabili della cancelleria di Pandolfo III. Il Liber viridis
rationum curie domini (1407-1409)”, in M. Ciambotti, A. Falcioni, op. cit.
13
1) Libri di natura normativa
2) Libri relativi al governo della Signoria
Libri della cancelleria signorile
Libri di carattere organizzativo e
amministrativo
3) Libri dell’area amministrativo-contabile
della Signoria
Registri sintetici riassuntivi
Registri sintetici di
organizzazione sistematica
delle voci contabili e di
verifica
Registri analitici delle entrate
o delle spese della corte
signorile
Libri giornale
Registri di contabilità
preparatoria e speciale
Registri riassuntivi di entrate e
spese rendicontate al signore
Registri della contabilità
periferica
3
4, 5, 6
7, 8
22, 23
21,33
10, 13, 14, 16, 17, 18, 19
29, 30, 31, 32 A, 32 B, 36
11 A, 11 B1, 11 B2, 12, 15, 20, 25, 25 Bis, 26,
28 A, 28 B, 34, 35, 72 B
24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 27
11 B3, 37, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 39, 69, 70, 71,
72 A
La prima serie è costituita da un unico registro di natura normativa: il registro 3, titolato
Capitoli dei dazi e delle gabelle del Comune di Fano (1376-1466), nel quale le norme di
derivazione statutaria vengono aggiornate, riformate o sostituite da decreti del signore, che
sostituiscono o affiancano quelli del consiglio cittadino e sono esplicitamente dichiarati da inserire
nel corpus statutario45
.
La seconda serie è costituita da due raggruppamenti di registri, entrambi riconducibili all’area
del governo. La prima sottoserie comprende i seguenti registri:
Reg. 4 1406-1421 Copiario46
di lettere pervenute alla cancelleria di Pandolfo III (con
aggiunta di quelle pervenute alla cancelleria di Sigismondo
Pandolfo Malatesti nel 1426, 1430, 1437 e 1441)
Reg. 5 1411-1438 Copialettere di decreti, lettere e bandi di Carlo, Pandolfo III e
Malatesta Malatesti
Reg. 6 1421-1430 Copiario di lettere pervenute alla cancelleria di Pandolfo III (in
45
Si rinvia alle considerazioni svolte da Anna Falcioni, retro, nota 46. 46
Le lettere pervenute sono registrate in integrum, secondo la prassi caratteristica degli archivi di antico regime:
P. Delsalle, Une histoire de l’archivistique, Québec, 1998, pp. 163-196.
14
continuazione del registro 4)
L’attività di questo tipo era svolta dal signore attraverso la cancelleria signorile, che risulta
ben strutturata e funzionante secondo prassi consolidate attestate anche in altri Stati coevi. Viene
tenuta accurata registrazione delle lettere in arrivo e in partenza, in particolare delle suppliche e
delle grazie concesse dal signore in veste di vicario pontificio con prassi burocratiche romane,
ampiamente studiate47
. Il registro 4 consente anche di comprendere come la continuità di
funzionamento del governo della Signoria, che trova la sua massima espressione nella
manifestazione della volontà signorile di esentare dall’osservanza della legge ordinaria, fosse
assicurata, in assenza di Pandolfo, dai fratelli, talvolta Galeotto, tal’altra Carlo. Tale prassi
evidenzia la logica e la forza dei legami familiari. Occorre sottolineare anche che la serie è senza
dubbio lacunosa, perché non copre tutto l’arco cronologico della signoria di Pandolfo. Peraltro il
reg. 6 travalica il periodo della sua signoria, segnale forse di una struttura cancelleresca ormai
consolidata e “indipendente” dalla figura del dominus.
La seconda sottoserie attinente alle attività di governo è costituita dai seguenti registri:
Reg. 7 1410-1425 Libro degli ufficiali (liber offitiorum) insediati nelle diverse località
soggette ai Malatesti nelle Marche e nelle strutture fortificate del
vicariato malatestiano
Reg. 8 1406-1409 Libro delle mostre organizzate dai podestà e dai castellani delle rocche
di Fano e del suo comitato
I registri 7 e 8 consentono di ricostruire, da un lato, l’amministrazione del territorio, perché
disegna la rete di podestà, castellani e vicari inviati nelle località marchigiane sedi di strutture
amministrative; dall’altro, l’organizzazione della struttura militare del vicariato fanese48
.
Per quanto riguarda la serie relativa alla contabilità o comunque all’area amministrativo-
contabile della Signoria, la natura dei registri non è così nettamente delineata come per altre realtà,
ad esempio quella bresciana, nella quale si sono visti coinvolti professionisti su scala nazionale, al
contrario di quanto avviene a Fano dove i responsabili della formazione e tenuta delle scritture
contabili sono quasi esclusivamente di provenienza marchigiana.
Si tratta di una serie di registri delle entrate e delle spese, all’interno della quale si possono
individuare alcune sottoserie.
Prima sottoserie contabile: registri sintetici riassuntivi (pluriennali)
Reg. 22 1/09/1406-31/12/1409 Tabulario delle entrate e delle uscite della corte malatestiana
(segnato “A”)
Reg. 23 31/01/1410-29/02/1416 Tabulario delle entrate e delle uscite della corte (segnato “T”)
Questi due registri riassuntivi (ai quali rinviano gli altri registri particolari) si riferiscono alla
corte malatestiana e sono tenuti dal depositario (tesoriere) del signore Andrea Bettini di Firenze
(sostituito dal 14 ottobre 1415 al 1416 dal fratello Lorenzo)49
. Si tratta di libri dei conti generali,
47
Cfr. T. Frenz, I documenti pontifici nel Medioevo e nell’età moderna, edizione italiana a cura di Sergio
Pagano, Città del Vaticano, Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, 1989, pp. 31-32. 48
Si rimanda a A. Falcioni, “Castelli e castellani nel territorio di Fano (1433-1463)”, in A. Turchini (a cura di),
Castel Sismondo, Sigismondo Pandolfo Malatesta e l’arte militare del primo rinascimento, Atti del Convegno di Rimini
(20-22 settembre 2002), Cesena, 2003, pp. 79-103. 49
I volumi n. 22 e n. 23 sono i veri cimeli dell’Archivio Malatestiano, nell’ambito della serie dei libri fanesi. Si
tratta di “Tabulari delle Ragioni” (come indicato nei titoli dei volumi), contenenti le registrazioni delle entrate e delle
uscite nella forma tabulare: in Dare si rileva ciò che il depositario deve dare al signore in quanto riscosso da vari
soggetti e in Avere ciò che lo stesso deve avere a fronte dei diversi pagamenti effettuati a vario titolo (ai fattori, per
esempio, a titolo di provvigione). Alla fine di ogni mese è rilevato il saldo riassuntivo del mese stesso (di segno diverso
15
pluriennali, con le entrate e le spese registrate mensilmente e in modo sistematico, a due colonne e a
Dare/Avere. Le segnature originarie non sono di tipo sequenziale e non consentono, quindi, ipotesi
attendibili sulla completezza della sottoserie, che comunque sembra essere incompleta, a meno di
non immaginare un cambio radicale di funzionamento della depositaria signorile in concomitanza
con il cambio dei responsabili, che avviene proprio nel 1416.
Seconda sottoserie contabile: registri sintetici di organizzazione sistematica delle voci
contabili e di verifica (pluriennali)
Reg. 21 1/09/1406-31/10/1416 Registro delle entrate e delle spese della corte signorile
(segnato “B”)
Reg. 33 5/03/1416-22/08/1426 Libro mastro delle entrate e delle uscite della tesoreria del
signore
La seconda sottoserie comprende alcuni registri di organizzazione sistematica delle poste
contabili, suddivise in due parti: la prima comprende le entrate e la seconda le spese, registrate per
tipologia, capitolo per capitolo, a due colonne, sempre a Dare/Avere.
Terza sottoserie contabile: registri analitici annuali delle entrate o delle spese della corte
signorile
Reg. 10 1/11/1392- 7/04/1393 Registro di spese “grosse” della corte signorile
Reg. 13 28/02/1401- 31/01/1402 Registro di spese della corte signorile
Reg. 14 1402 (da febbraio) Registro di spese della corte signorile
Reg. 16 1404 Registro delle entrate della corte signorile
Reg. 17 1404 Registro delle spese della corte signorile
Reg. 18 1405 Registro delle entrate della corte signorile
Reg. 19 1/07/1409-30/06/1410 Registro generale delle entrate e delle spese della fattoria
signorile (segnato “+”)
La terza sottoserie è costituita dai registri analitici annuali delle entrate o delle spese della
corte signorile, sottoserie che indurrebbe a supporre l’esistenza di alcune lacune così segnalabili:
registri analoghi dovrebbero supporsi per ciascuno degli anni precedenti al 1392, per gli anni
compresi tra il 1393 e il 1400, per il 1403 e per ciascuno degli anni successivi al 1405. Inoltre, la
sottoserie potrebbe continuare, in forma differente, dopo il 1416, in concomitanza con il cambio del
depositario signorile, con i giornali, molto simili nella forma e nella struttura al modello consueto
per questa tipologia documentaria50
. In effetti, questi registri non sono organizzati in ordine
cronologico, ma per categoria51
, a piena pagina e senza usare il sistema Dare/Avere. Non possono,
pertanto, definirsi come giornali, bensì libri mastri. La categoria delle spese “grosse” del registro 10
a seconda che il Bettini ha ricevuto di più o di meno di quanto pagato). E’ facile verificare, quindi, lo stato della
situazione finanziaria dell’intera tesoreria. Lo Zonghi, op. cit., p. 49, considera preziosi questi due volumi, di cui si
apprezza “la nitidezza…dello scritto” e “l’eleganza con cui son disposte a colonna le singole partite di Dare ed Avere,
cosicché si presentano all’occhio propriamente a forma di tavola”. E’ importante segnalare, infine, che una copia delle
Tavole veniva inviata a Brescia, direttamente alla cancelleria di Pandolfo III. 50
In riferimento a quanto illustrato da F. Melis, Storia della ragioneria. Contributo alla conoscenza e
interpretazione delle fonti più significative della storia economica, op. cit. (in particolare p. 669 per la differenza tra
conto e partita); e Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XVI, con una nota di paleografia commerciale a
cura di E. Cecchi, Firenze 1972. 51
Per esempio: “Spese de le fenestre de la sala grande a dì II de novembre 1392” (carte 3-4, verso, registro 10);
“Entrata del dazio del pascholo” e “Dazio del grano e biada” (carta 24 e carta 71, registro 16); “Entrata di dazio di
prigione” (carta 29, registro 18). I pagamenti si riferiscono, in genere, ai lavori di palazzo, agli ufficiali del Comune,
ambasciatori, messi, fonti e spie, munizioni delle fortezze, censi della Chiesa, mentre le entrate sono relative per lo più a
riscossioni di dazi pagati dalla città e dal contado e alle provvigioni pagate dai Comuni limitrofi.
16
(tenuto dal fattore Piero di Boccadio da Bologna) si contrappone a quella delle spese minute,
consentendo di esaminare la composizione della corte (attraverso la registrazione dei salari dei
dipendenti), il suo funzionamento ordinario (con la registrazione degli acquisti di materiali di uso
quotidiano) e straordinario (con la registrazione dei pagamenti fatti per esempio per le riparazioni e
i riattamenti delle costruzioni sia a Fano che nel Castello di Caminate). Gli altri registri risultano
redatti dal depositario del signore Giovanni Bettini da Firenze. L’ultimo registro di questa sottoserie
si riferisce alla fattoria di casa Malatesti tenuta dal fattore Antonio d’Andriuccio da Sassoferrato.
Anche in esso le entrate e le spese sono registrate capitolo per capitolo, a piena pagina e senza le
sezioni Dare/Avere.
Quarta sottoserie contabile: libri giornale
Reg. 29 1/03-31/12/1417 Giornale delle entrate e delle uscite della depositaria del
signore (segnato B)
Reg. 30 2/01-31/12/1420 Giornale delle entrate e delle uscite della depositaria del
signore (segnato E)
Reg. 31 2/01-19/09/1421 Giornale delle entrate e delle uscite della depositaria del
signore (segnato F)
Reg. 32 A 2/10-30/11/1423 Giornale delle entrate e delle uscite della depositaria del
signore
Reg. 32 B 12-30/06/1424 Giornale delle entrate e delle uscite della depositaria del
signore
Reg. 36 1/12/1421-2/01/1426 Giornale delle entrate e delle uscite della corte di Fano,
scritto dal massaro Masio
All’interno di tale sottoserie le lacune sono evidenziate dalle segnature originarie. Come per
la precedente sottoserie si può supporre l’esistenza di analoghi registri giornale del 1418 (segnato
C?), del 1419 (segnato D?) e del 1422. I libri giornale contengono registrazioni divise in due parti
(entrate e uscite), in ordine cronologico, mese per mese, a tutta pagina. Una terza parte del libro
riguarda le “prestantie”. Il depositario è Tommaso di Montefano. Il registro parziale 32 B, riferito al
solo periodo mensile di giugno, suggerisce l’ipotesi che si predisponesse un quaternus per ciascun
mese e che alla fine dell’anno i dodici quaterni venissero poi avvolumati.
Ai registri annuali si affianca il registro 36 tenuto dal massaro Masio da Cesena, con la stessa
forma degli altri e in qualche modo riassuntivo.
Quinta sottoserie contabile: registri di contabilità preparatoria e speciale
Reg. 11 A 18/06/1396-31/05/1400 Pagamenti effettuati per conto della corte signorile con il
denaro proveniente dalle colte e dalle condanne
pecuniarie del Comune di Fano
Reg. 12 1397 Registro delle paghe militari dovute dal Papa, riscosse da
Biagio da Sorbolongo per conto di Pandolfo III, e della
distribuzione delle medesime alla truppa
Reg. 11 B 1 1397 (da 8 luglio) Entrate provenienti dalle condanne del Comune di Fano e
ricevute per la corte signorile da Balduccio d’Andrucciolo
Reg. 11 B 2 1398-1404 Spese sostenute da Balduccio per ordine del signore
Reg. 15 31/01/1403- 7/12/1405 Pagamenti effettuati da Marco Campanelli (a Giovanni
Bettini, depositario a Fano)
Reg. 72 B 1404 Registro del grano proveniente da Senigallia, sul quale si
è riscossa la gabella (depositario Pietro da Mondavio)
17
Reg. 20 1/09/1406- 31/10/1418 Registro dei proventi fiscali versati alla camera del
comune e alla fattoria signorile
Reg. 28 A 1415-1417 Registro del grano comprato per la corte signorile
Reg. 25 1/09/1418- 29/12/1419 Elenco dei debitori della depositeria del signore
Reg. 25 bis 3/09/1416- 13/06/1419 Conto del sale con Pietro Petroni da Mondavio
Reg. 28 B 21/09/1419-16/06/1420 Registro del denaro versato da Nicolò Gambiero da
Pergola, ufficiale sui mulini, a Tommaso da Montefano,
depositario del signore
Reg. 26 1419 Conto di Bernardo, Andrea e Lorenzo Bettini
Reg. 34 1/01/1419- 31/12/1419 Registro delle entrate e delle uscite dei mulini del signore
(segnato E)
Reg. 35 8/01/1422- 31/12/1422 Registro delle entrate e delle uscite dei mulini del signore
La quinta sottoserie è composta da vari registri facenti parte della contabilità preparatoria e
speciale. L’assenza di segnature (solo il registro 34 ha una vecchia segnatura E), non consente di
formulare alcuna ipotesi circa eventuali lacune. I registri della depositaria e della fattoria signorili
appaiono negli stessi anni come entità differenti, almeno stando alle titolature dei registri.
I registri di entrata e uscita della corte signorile, contenuti nell’unità composita della busta 11,
consentono di avere notizie circa le spese della corte e la provenienza del denaro speso, che deriva
sia dalle colte, sia dalle percentuali delle pene pecuniarie assegnate al signore, oltre che dalla
riscossione dei dazi. Il registro 12 documenta gli ingaggi militari, con la relativa distribuzione delle
paghe alla truppa.
Il registro 25, redatto dal tesoriere Andrea Bettini e che serviva a tenere sotto controllo i
debitori della depositeria, è suddiviso in due parti: la prima è a due colonne (Dare e Avere) con
riscontri effettuati e, quindi, con le registrazioni cassate; la seconda è sempre scritta a due colonne
(Dare e Avere) ma in forma di riassunto effettuato dopo il riscontro52
. Le registrazioni del registro
72 B, sono a tutta pagina, senza colonne Dare/Avere, con rinvio citato e riscontrato funzionante al
registro 16 (entrate della corte signorile). Nel registro 20, redatto dal tesoriere Andrea Bettini da
Firenze, le entrate fiscali derivanti da dazi e provvigioni mensili (dei vari vicariati e possedimenti)
sono segnate capitolo per capitolo, a due colonne (Dare/Avere) e con due rinvii identificabili con
riscontri puntuali con i registri sintetici riassuntivi 22 (segnato A) e 23 (segnato T). Sono registrate
anche le entrate relative al grano, al vino e il saldo della “ragione” del sale commercializzato da
un’apposita “compagnia” costituita da Pandolfo III e Chiavello Chiavelli di Fabriano53
.
I pagamenti per il grano comprato per il signore e pagato per mano del ragioniere Giovanni
Ramesino, sono rilevati nel registro 28 A, redatto dal depositario Tommaso di Francesco da
Montefano. Le spese sono ordinate per località e, all’interno di ciascuna località, in ordine
cronologico su due colonne, senza usare il sistema ordinato a Dare/Avere. Nel registro 28 B, redatto
sempre dal depositario Tommaso da Montefano, vengono registrate a tutta pagina, senza le colonne
Dare/Avere, tutte le somme a lui versate dall’ufficiale sui mulini Niccolò Gambiero da Pergola. Tali
somme risultano dai registri 34 e 35, tenuti dallo stesso ufficiale sui mulini Niccolò Gambiero da
Pergola e contenenti registrazioni suddivise in entrate (derivanti dalla vendita del grano dei mulini)
e spese (di gestione dei mulini stessi), scritte a tutta pagina senza Dare/Avere.
52
Da notare che nel volume 25, scritto sempre da Andrea Bettini e recante l’intestazione “Liber debitorum
depositarie inceptus die primo mensis septembris 1418”, ogni partita di Dare (colonna a sinistra) e Avere (colonna a
destra) “è distinta dall’altra, mercè una linea orizzontale che occupa il largo della pagina, e tutte, dalla prima all’ultima,
meno quella del referendario a carta 80, sono cancellate con una linea diagonale, il che forse indica la chiusura
definitiva di ciascun conto, o meglio, il trasporto della partita in altro libro” (A. Zonghi, op. cit., p. 55). 53
I Malatesti acquistavano la carta da Fabriano, perché ne erano grandi consumatori (in particolare, la carta
bambagina che serviva per la cancelleria e l’amministrazione) e vendevano il sale a Fabriano. Cfr. A. Falcioni,
“L’economia di Fano in età malatestiana, op. cit., p. 141.
18
Il registro 25 bis (conto del sale fra il 1416 e il 1419) contiene, registrate su due colonne
(Dare/Avere), le partite intestate agli ufficiali dei dazi appositi nel territorio fanese, con scritture
riscontrate e cassate.
Il registro 26 contiene il “calcolo della ragione” del tesoriere Andrea Bettini e dei suoi fratelli
collaboratori Andrea e Lorenzo, impegnati a curare gli interessi economici del signore Pandolfo III
anche fuori Fano, per esempio riscuotendo il dazio del sale (registro 25 bis) o gestendo il
commercio della lana sulla piazza veneziana. Alcune carte sono firmate dal ragioniere di corte
Giovanni Ramesino (secondo ragioniere della camera, pagato con sei ducati al mese) e dal
“reveditore” Nicolò Feracane54
. A partire dal febbraio 1416, al posto dei fratelli Bettini subentra
nell’ufficio di depositario del signore a Fano il sopra citato Tommaso da Montefano.
Sesta sottoserie contabile: registri riassuntivi di entrate e spese rendicontate al signore
Reg. 24/1 giu.1408 - ago.1409 Riassunti mensili delle entrate e delle spese del depositario
del signore inviati in copia a Pandolfo a Brescia
Reg. 24/2 set.1409 - dic.1410 Riassunti mensili delle entrate e delle spese del depositario
del signore inviati in copia a Pandolfo a Brescia
Reg. 24/3 gen.1411 - mag.1412 Riassunti mensili delle entrate e delle spese del depositario
del signore inviati in copia a Pandolfo a Brescia
Reg. 24/4 apr.1412 - feb.1414 Riassunti mensili delle entrate e delle spese del depositario
del signore inviati in copia a Pandolfo a Brescia
Reg. 24/5 giu.1420 - set.1421 Riassunti mensili delle entrate e delle spese del depositario
del signore inviati in copia a Pandolfo a Brescia
Reg. 24/6 gen.-set.1421 Riassunti mensili delle entrate e delle spese del depositario
del signore inviati in copia a Pandolfo a Brescia
Reg. 24/7 ott.1421 - mag.1423 Riassunti mensili delle entrate e delle spese del depositario
del signore
Reg. 24/8 ott.1421 - feb.1422 Riassunti mensili delle entrate e delle spese del depositario
del signore
Reg. 27 lug. 1424 –giu. 1425 Conto mese per mese di «Maxio factore in corte»
Questa è una sottoserie particolare, in quanto è costituita dai riassunti mensili delle entrate e
delle spese, che erano inviati dal depositario di Fano al signore, quando Pandolfo si trovava a
Brescia. Tali riassunti relativi all’amministrazione e alla gestione dei beni e degli affari del signore
a Fano vennero redatti, a scopo di controllo, anche dopo il ritorno definitivo di Pandolfo a Fano.
L’assenza di segnature originarie non consente di valutare eventuali lacune, ipotizzabili per gli anni
1404-1407.
La busta 24 contiene 8 quaterni, nei quali le entrate e le uscite (entrambe distinte tra ordinarie
e straordinarie) sono ordinate mese per mese e, all’interno di ciascun mese, suddivise in “Intrata”
nella carta di sinistra e “Usita” in quella di destra, senza il sistema Dare/Avere. Le somme finali di
ciascun mese corrispondono a quelle riportate nei registri sintetici riassuntivi 22 e 23. I quaderni
relativi al periodo 1420-1421 (fino a settembre) sono redatti dal nuovo depositario Tommaso da
Montefano, succeduto ad Andrea Bettini, mentre da ottobre 1421 opera il nuovo depositario
Geronimo Vize. Il registro 27 contiene il conto del fattore di corte Masio, con registrazioni
54
La trascrizione è la seguente (carta 5r): “Ego Nicolò Feracane reveditore fui cum ser Iohanne Ramexino
raxonero | a concludere la raxone de Bernardo de Bettino, che se contene in lo presente| foglio cum lo dito Bernardo
presente, ser Molduzo de Bochaci da Meldola, | referendario del signore, cum pato che sempre fosse salvo| lo erore del
calchullo e cusì de mia propria mano lo suscrita”. La dichiarazione del revisore o dei revisori contabili è attestata oltre
che nel registro 26 anche nel registro n. 107 (1454), nella prima carta subito dopo la titolazione (cfr. A. Zonghi, op. cit.,
p. 157). Si osservi che i revisori, preposti all’ufficio di controllo dell’operato del tesoriere, devono “rivedere et saldare i
suoi conti, sindicarlo et absolverlo et condannarlo de le querele” presentate al referendario (A. Falcioni, “L’economia di
Fano in età malatestiana”, op. cit., p. 106).
19
effettuate su due colonne (Dare/Avere) in ordine cronologico, mese per mese e, all’interno di
ciascun mese, ordinate per tipologia (ad esempio, grando, biade, orzo, spelta ecc.) e per località.
Settima sottoserie contabile: registri della contabilità periferica
Reg. 11 B 3 09/11-10-12/1398 Spese effettuate dal gonfaloniere della Pergola
Reg. 37 01/07/1397- gen. 1405 Registro delle entrate e delle uscite della Stacciola
Reg. 38/1 1398 Registro delle entrate e delle uscite della Stacciola
Reg. 38/2 1399-1400 Registro delle entrate e delle uscite della Stacciola
e di Mondolfo
Reg. 38/3 1400 Registro delle entrate e delle uscite della Stacciola
Reg. 38/4 1406 Registro delle entrate e delle uscite della Stacciola
Reg. 39 1422 (dal 10 set.) Registro delle entrate e delle uscite relative ai beni
del signore a Meldola e Polenta
Reg. 69 16-21/02/1383,
29/03- 14/11/1396
Pagamenti effettuati, a nome del signore, da Pietro
Petroni depositario del vicariato di Mondavio (con
varie ricevute)
Reg. 70 1402-1403 Registro degli affitti pagati dagli assegnatari dei
pascoli collettivi della città di Senigallia
Reg. 71 1408 Registro delle entrate della depositaria signorile in
Senigallia (segnato H)
Reg. 72 A 1410-1415 Registro delle entrate e della uscite della tesoreria
signorile in Senigallia
L’ultima sottoserie è costituita dalla contabilità periferica, prodotta in altre località del
territorio fanese, dove esistevano depositari o fattori, che curavano gli interessi di Pandolfo e
registravano i fatti economici in scritture particolari, che poi consegnavano per gli opportuni
riscontri al depositario di Fano. Sono attestati Francesco da Sassoferrato, castellano del Castello
della Stacciola, oggi piccola frazione del Comune di San Costanzo (registri 37 e 38)55
; Matteo da
Sassoferrato, fattore a Meldola e Polenta nel 1422 (reg. 39); Pietro Petroni, depositario a Mondavio
fra il 1383 e il 1396 (reg. 69) e fra il 1416 e il 1419 (registro 25 bis); Pietro da Mondavio,
depositario a Senigallia nel 1404 (registro 72 B); Ciriaco di Bartolo, depositario a Senigallia nel
1408 (reg. 71), Nicolò Mariani da Cremona, depositario a Senigallia fra il 1410 e il 1415 (reg. 72
A).
Alla tesoreria del signore a Fano facevano riferimento le strutture amministrative e contabili
del distretto fanese e perfino la tesoreria del vicariato di Mondavio e Senigallia, che funzionavano
come succursali: il reg. 9 documenta in modo esplicito l’uso di versare la contabilità, per così dire,
“periferica” alla sede centrale, attestato pure dall’esistenza nell’archivio di numerose registrazioni
contabili prodotte dai fattori in modo assai rigoroso (registri 34, 35, 37, 38, 39, 69, 70, 71, 72 A e
B). La natura della documentazione della depositaria di Mondavio e Senigallia è sicuramente
riconducibile all’amministrazione di beni patrimoniali del signore e alla contabilizzazione dei
proventi di origine pubblica ma destinati alla fattoria signorile.
La serie dei registri delle entrate e delle uscite della Stacciola contiene scritture a tutta pagina,
senza Dare/Avere, riferite a tutte le entrate camerali e patrimoniali (pascoli, danni dati, pigioni,
condanne, malefizi, vendite di grano, orzo, spelta, fava, vino, ecc.) che provengono ai Malatesti dal
castello, nonché a tutte le spese sostenute dal castellano. I registri sono per lo più annuali e ciò
induce a supporre alcune lacune riferibili agli anni del periodo 1401-1405 e agli anni successivi al
1406, fino al 1412.
55
Questo castello è noto per essere stato donato, il 1° agosto 1412, direttamente da Pandolfo III al famoso
capitano di ventura Niccolò Mauruzi da Tolentino, per le sue benemerenze e fedeltà.
20
Anche il registro 39 contiene registrazioni a tutta pagina (senza Dare/Avere), riferite ai
raccolti, alle assegnazioni di sementi ai contadini, agli affitti, alle rese delle vigne, al pagamento del
fattore e alle varie spese per grano e vino della fattoria di Meldola e Polenta56
.
Il registro 69, come si è detto sopra, è particolarmente significativo, perché oltre alle
registrazioni contabili - effettuate sempre a tutta pagina, senza le due colonne Dare/Avere - sono
riuniti anche atti giurisdizionali che confermano la compenetrazione tra le strutture comunali e
quelle signorili.
I registri 70 e 71 contengono scritture a tutta pagina, senza le colonne Dare/Avere, con
titolazioni riferite, rispettivamente, ai vari pascoli collettivi delle terre di Senigallia e alle varie
entrate della tesoreria signorile di questa città e del suo contado.
Il registro 72 A appare diviso in due parti: la prima, fino alla carta 30, è costituita da tavole
riassuntive sintetiche e ordinate in senso cronologico (mese per mese); la seconda contiene
registrazioni ordinate per tipologia (grano, orzo, miglio, ecc.) a due colonne Dare/Avere57
.
Un discorso a sé merita una fonte finora abbastanza trascurata negli studi sull’archivio fanese:
la busta miscellanea 113, nella quale si trovano documenti minuti preliminari alla redazione di
qualsiasi registro, materiale che raramente si trova negli archivi e che, viceversa, consente di
studiare tipologie documentarie di solito solo citate ma quasi mai conservate.
Nell’analisi svolta, volutamente non si è fatto riferimento al registro n. 9, che merita un
approfondimento a parte. La trascrizione del suo contenuto in Appendice ci induce a ritenerlo assai
importante, come strumento descrittivo che documenta le vicende dell’intera porzione contabile
dell’archivio fanese. Di questo ci occuperemo ampiamente nel paragrafo 3.4.
3.3 Un inventario ragionato dei registri dell’amministrazione malatestiana di Brescia
(1405-1421)
L’indagine relativa all’organizzazione e alla gestione amministrativa delle terre lombarde
(Brescia e Bergamo) sotto la Signoria di Pandolfo III è stata ampiamente approfondita in dottrina e
ad essa si rinvia per l’opportuna contestualizzazione e per i rinvii bibliografici58
. Qui si riprendono
alcuni aspetti legati all’inventario dei libri contabili presenti all’interno della serie dei Codici
Malatestiani di Fano.
Come segnalato sopra, i registri contabili riferibili alla Camera di Pandolfo Malatesti nel
periodo in cui era signore di Brescia e di Bergamo, sono 29, contrassegnati con i numeri che vanno
da 40 a 68. Sono quasi tutti tenuti nella forma tabulare59
, con le due sezioni del Dare (a sinistra) e
dell’Avere dell’intestato nella stessa pagina e con scritture riferite ad un solo anno o a più anni.
L’oggetto delle rilevazioni può riguardare partite di debito e credito tra il tesoriere e i diversi
soggetti che entravano in rapporto con lui (lo stesso Pandolfo III; gli stipendiati e i salariati della
sua Corte, compresi i conestabili, i soldati, ecc.; i vari prestatori d’opera); oppure partite relative
56
Si leggano i richiami al registro 39 fatti da E. Conti, “La castellania di Clusane d’Iseo nel panorama delle
aziende agricole malatestiane (1414-1416)”, in G. Bonfiglio-Dosio, A. Falcioni (a cura di), op. cit., pp. 430-434. 57
Anche questo registro è denominato “tavola de la raxone”, contenente la rilevazione cronologica di tutte le
somme riscosse e pagate dal depositario per la Camera di Pandolfo nell’arco dei cinque anni. Dopo il riassunto finale di
tutte le somme delle spese di ciascun anno (“sommario dei sommari della spesa”), facente seguito a quello di tutte le
somme delle entrate, inizia un partitario in Dare e Avere, con conti intestati a vario titolo (denari, Grano, Orzo, ecc.),
attraverso i quali il depositario viene addebitato di tutti i soldi e le merci che egli aveva incassato o custodito nei
magazzini del Malatesta e accreditato dei denari spesi e di tutto il resto impiegato da lui (cfr. A. Zonghi, op. cit., p.
128). 58
Si rimanda ai due lavori già citati di M.Ciambotti, A. Falcioni, Liber viridis rationum curie domini. Un registro
contabile della cancelleria di Pandolfo III Malatesti, op. cit, e G. Bonfiglio-Dosio, A. Falcioni (a cura di), La Signoria di
Pandolfo III Malatesti a Brescia, Bergamo e Lecco, op. cit. 59
Circa i contenuti e le caratteristiche del “metodo tabulare lombardo” si rimanda a T. Zerbi, Le origini della
partita doppia, Marzorati, Milano, 1952. Cfr. M. Ciambotti, A. Falcioni, op. cit., pp. 67 e segg.
21
agli introiti dei vari incantatori dei dazi, delle taglie ed imposte, delle condanne e delle multe. Vi
sono, poi, alcuni registri che sono da considerare nella prima parte come libri giornali e nella
seconda parte come partitari di Dare e Avere. Altri ancora sono veri e propri libri giornali, scritti
secondo un ordine strettamente cronologico e senza partite di Dare e Avere.
Utilizziamo lo stesso metodo di classificazione impiegato per la serie dei registri contabili
relativi all’amministrazione malatestiana su Fano, riportando l’eventuale indicazione del titolo
testuale (così come compare sul registro o come si evince da citazioni di altri registri) e il
riferimento agli estremi cronologici. Dalle citazioni o dai rinvii che si leggono nei registri giunti
sino a noi, inoltre, è possibile ricostruire le varie sottoserie di libri che dovevano costituire l’intero
archivio contabile della signoria di Pandolfo III.
Tabella 3 Sottoserie dell’Archivio malatestiano di Fano riferibili all’amministrazione
contabile della signoria di Pandolfo III su Brescia e Bergamo
Sottoserie Libri e Registri
Registri sintetici riassuntivi
Registri sintetici di
organizzazione sistematica
delle voci contabili e di
verifica
Registri analitici delle entrate
o delle spese della corte
signorile
Libri giornale
Registri di contabilità
preparatoria e speciale
43, 58
42, 54, 56, 57
(A) 40, 41, 44, 46
(B) 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53
48,55
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
Prima sottoserie contabile: registri sintetici riassuntivi (pluriennali)
Reg. 43 1407- dicembre 1409 Libro verde dei conti della corte signorile (Liber viridis
rationum curie domini)
Reg. 58 1415 - 1416 Libro nero dei conti della famiglia e della corte del signore
Pandolfo Malatesti (Liber niger rationum familie et curie
magnifici et excelsi domini Pandulfi de Malatestis)
Ad un livello sicuramente superiore rispetto alle scritture contabili appena trattate, si
distinguono i Libri di conti della corte signorile (Libri rationum curie domini). Si tratta di libri
mastri tabulari, scritti in lingua latina e contenenti le registrazioni (in Dare e Avere) dei conti accesi
ai diversi componenti dell’amministrazione e della corte signorile: condottieri militari e genti
d’arme, spenditori, camerari, artigiani, falconieri, ecc. Dal contenuto e dai richiami fatti ad altri
libri, si desume che questi libri mastri costituivano una contabilità di sintesi, a carattere pluriennale,
delle scritture analitiche più specifiche registrate nei libri partitari, dati et recepti, prestanziarum,
debitorum, dei dazi, delle condanne, ecc., tutte riferite a rilevazioni di debiti e crediti verso il
22
personale che intratteneva o aveva intrattenuto rapporti con l’amministrazione malatestiana di
Brescia e Bergamo.
I due registri sembrano avere, però, una struttura diversa. Il primo60
ha una struttura che può
essere considerata divisa in due parti: nella prima sono registrati i conti del Dare e dell’Avere
intestati al cancelliere di corte Giacomo Malaguercia de’ Rugoliosi da Forlì e al tesoriere
straordinario Gioacchino Malagonella da Firenze; nella seconda sono riportate le varie partite del
Dare e dell’Avere sia degli altri soggetti coinvolti nell’amministrazione della corte di Pandolfo (in
particolare, il fattore Lodovico da Montenovo e l’altro cancelliere Francesco de’ Brachi da
Cremona), sia dei vari nobili, familiari, camerari, massari, orefici, ricamatori, pittori, maestri di vari
mestieri, conestabili, soldati, ecc. Il secondo registro, sin dall’inizio, presenta le singole partite
raggruppate per categorie di soggetti ai quali sono intestate (es. Partita sociorum, Partita sociorum
et familiarum, Partita factorum et administratorum, Partita camerariorum seschahorum,
arceriorum, piferorum, cantatorum, falconeriorum, e così via), con relativo indice posto sotto al
titolo del libro61
.
Dai registri nn. 42, 43, 54 e 57 apprendiamo l’esistenza di altri libri di questo genere:
rispettivamente, il Liber rubeus rationum curie domini (1408-1409), il Liber rubeus rationum curie
domini (1412-1413), il Liber rationum curie domini (1415)62
.
Seconda sottoserie contabile: registri sintetici di organizzazione sistematica delle voci
contabili e di verifica (pluriennali)
Reg. 42 1406 - 1409 Libro verde delle prestanze (Liber viridis prestanziarum,
segnato “S”)
Reg. 57 1415 - 1420 Libro azzurro delle prestanze (Liber azurus prestanziarum)
Reg. 54 1412-1414 Libro partitario ufficiali e salariati (liber de partito officialum
et salariatorum)
Reg. 56 1415-1417 Libro partitario verde ufficiali e salariati (liber viridis de
partito officialum et salariatorum)
I libri delle prestanze (o dei creditori) hanno carattere pluriennale e un contenuto riassuntivo
delle varie partite, registrate in altri libri annuali e riferite, in prevalenza, alle “persone che avevano
instaurato con l’amministrazione signorile un rapporto di lavoro o di collaborazione (i vari artisti-
artigiani, le genti d’arme, i condottieri, etc.)” o che avevano prestato somme di denaro a Pandolfo
Malatesti per i bisogni più svariati. Queste persone, nella sostanza, potevano essere considerati
creditori del signore Pandolfo III63
. I registri di questa serie si presentano nella solita forma di
partitari Dare e Avere, scritti in latino a due colonne per carta.
Nel registro n. 42 sono contenute, tra l’altro, le registrazioni del Dare e dell’Avere di:
massaroli (preposti alle munizioni, ovvero ai luoghi ove si conservavano le armi e le munizioni da
guerra); ingegneri; maestri di corazze; maestri della zecca; medici e chirurghi; cancellieri; massari
delle taglie ed esattori vari; cittadini affittanti case da destinare ad abitazione degli uomini addetti
alla corte di Pandolfo; nobili e cittadini bresciani, nonchè banchieri di Venezia e altri cittadini
fanesi, ai quali Pandolfo impose un prestito forzoso per l’acquisto della città di Bergamo64
; cittadini
bresciani, ai quali si impose un mutuo per la costruzione del palazzo del podestà.
60
La trascrizione integrale del registro n. 43 è contenuta in M. Ciambotti, A. Falcioni, op. cit. 61
Cfr. A. Zonghi, op. cit., pp. 109-111. 62
Quest’ultimo ha un contenuto che consente di identificarlo proprio con il registro superstite n. 58. Cfr. G.
Bonfiglio-Dosio, “Il variopinto mondo della cancelleria signorile”, op. cit., p. 50. 63
Ibidem, p. 64. 64
Diverse carte del registro n. 42 contengono il Dare e l’Avere di varie persone (es. il podestà di Brescia
Liverotto Ferretti, il vicario generale Ugolino de’ Pili di Fano, i massari Tonino da Nigoline e Niccolò de’ Feroldi, ecc.)
che avevano ricevuto il denaro di questi prestiti forzosi, girandolo poi alla famiglia del nobile Giovanni de’ Suardi di
23
Anche nel registro n. 57 ci sono molte partite relative a prestiti concessi da mercanti e
banchieri a Pandolfo e a dazi o taglie imposte per svariati fini, in prevalenza collegati a necessità
belliche.
Si può desumere l’esistenza di altri registri appartenenti a questa sottoserie, tutti con
titolazione che richiama la tipologia e il colore della coperta, dai rinvii contenuti in diversi registri:
Liber rubeus prestanziarum 1404 (ex registro 43); Liber niger prestanziarum 1407-1408, Liber
rubeus prestanziarum 1408 e Liber azurus prestanziarum 1408 (tutti citati nel registro n. 42); Liber
viridis prestanziarum 1409 (ex registro n. 43); Liber niger prestanziarum 1410 (ex registro n. 43);
Liber niger prestanziarum 1412-1414 (ex registri nn. 54, 66, 67); Liber viridis prestanziarum 1412
(ex registro n. 54); Liber niger prestanziarum 1415 (ex registro n. 56); Liber azurus prestanziarum
1415 (ex registro n. 57)65
. A questi si deve aggiungere il Liber niger prestantiarum Comunis Brixie
del 1414 (ex registro n. 66), specificamente riferito alle prestanze del Comune di Brescia.
Sempre dalle citazioni contenute nei registri, si può desumere l’esistenza anche dei Libri
debitorum, che sono di segno algebricamente contrario a quello relativo alle prestanze e i cui
caratteri formali, tuttavia, non sono decifrabili con precisione, data l’assenza di registri superstiti. Si
hanno solo delle citazioni riportate nei registri fanesi: Liber pilosus debitorum 1405 (ex registro n.
43); Liber debitorum signato L 1406 e Liber niger debitorum 1407 (ex registri n. 42 e n. 43); Liber
rubeus debitorum 1408-1409 (ex registri nn. 42 e 43); Liber albus debitorum 1410 (ex registro n.
43); Liber viridis debitorum 1412 (ex registro n. 54); Liber albus debitorum 1416 (ex registro n.
57). Vi sono poi rinvii a libri contenenti le registrazioni degli affittuari morosi (Liber debitorum
annorum 1415, 1416 ad affictum intratarum possessionum domini 1415-1416, ex registro n. 57) e di
coloro che non avevano pagato i dazi all’amministrazione della Signoria (Liber albus debitorum
daciorum 1415, ex registro n. 56)66
. Considerando per analogia il ruolo dei libri denominati dello
“Spoglio dei Debitori” nell’ambito dei registri contabili delle amministrazioni del XV e XVI secolo
(per esempio, quelli tenuti presso lo Spedale del Santa Maria della Scala67
), si può presumere che la
funzione di questi libri fosse quella di rilevare (in accredito ai debitori) i crediti della corte signorile
ancora in attesa di saldo, iscritti in addebito nel libro dei conti tenuto dal tesoriere.
I registri 54 e 56 sono libri mastri partitari pluriennali, riassuntivi di scritture registrate in altri
libri. La tipologia è quindi simile a quella che viene descritta nella terza sottoserie (tipo A).
Terza sottoserie contabile (A): registri analitici annuali delle entrate o delle spese della
corte signorile (libri mastri partitari Dare e Avere o libri de partito o de partiti)
Reg. 40 1405 Libro partitario Dare e Avere della corte signorile
Bergamo per l’acquisto di questa città. In effetti, alla carta 217 compare proprio l’addebitamento del Comune di
Bergamo per 43.000 ducati d’oro, pagati in Venezia a titolo di prezzo della città. Una parte di questa cifra (5.000 ducati)
risulta effettivamente accreditata nel conto del tesoriere Malagonella del registro n. 43, nella sezione Avere della carta
n. 27 (retto). Cfr. M. Ciambotti, “Il sistema dei registri contabili della cancelleria di Pandolfo III”, op. cit., p. 92, nota
67, nella quale si richiama la ricostruzione della vicenda effettuata da C. Selvelli, op. cit., pp. 39 e segg.: il Comune di
Bergamo doveva pagare i Suardi per la custodia delle fortezze cittadine da loro tenute, ma non possedeva la somma
necessaria; Pandolfo si offrì di prestarla, ricorrendo a sua volta a prestiti presso nobili, cittadini, banchieri di Venezia,
famiglie di Fano, ecc.; il debito verso i Suardi venne pagato così, a titolo di prestito, da Pandolfo Malatesta, il quale
naturalmente se lo accreditò nei rapporti con il Comune di Bergamo stesso; la consegna delle fortezze della città e del
distretto avvenne nel giugno del 1408, su intimazione del Duca di Milano e tramite formale convenzione tra Giovanni
Suardi e il procuratore di Pandolfo III, Giovanni da Iseo. 65
Occorre rilevare che nell’inventario prodotto da Giorgetta Bonfiglio-Dosio si riscontra una discrasia tra il
numero di Libri prestanziarum censito (6 libri, compresi quelli attualmente conservati) e quello che emergerebbe dalla
lettura dei contenuti e delle citazioni riportate nei registri fanesi. La discrasia è dovuta, probabilmente, ad una diversa
interpretazione circa la durata del periodo di riferimento dei libri oggetto di rinvio. 66
G. Bonfiglio-Dosio, “Il variopinto mondo della cancelleria signorile”, op. cit., p. 65 nota che “la descrizione
non consente di precisare se si trattava di documenti analitici preparatori di scritture contabili sintetiche oppure se erano
saldaconti e quindi di scritture di verifica”. Si può supporre, tuttavia, che abbiano la stessa forma dei libri delle
prestanze, essendo il loro riferimento di contenuto a questi speculare. 67
P. Di Toro, R. Di Pietra, op. cit., pp. 221 e segg.
24
Reg. 41 1406 Libro partitario Dare e Avere rosso della corte signorile
Reg. 44 1409 Libro partitario Dare e Avere della corte signorile
Reg. 46 1411 Libro partitario Dare e Avere giallo famigli e ufficiali
Sono registri sui quali si trovano annotate, in ordine sistematico, sotto il nome degli intestatari
del singolo conto (debitori e creditori), le partite riportate nelle scritture cronologiche (libri giornali)
o in altri libri. Si tratta di libri mastri semplici, annuali, con scritture sistematiche e analitiche (libri
partitari annuali). Generalmente sono in lingua volgare, con scrittura mercantesca, stessa mano o di
mani diverse, e alla titolazione originale è associata l’indicazione del colore della coperta o,
talvolta, di una lettera dell’alfabeto.
I registri di Dare e Avere sono compilati dal tesoriere generale Gioacchino Malagonella di
Firenze, con indicazione in Avere dei singoli creditori (stipendiati e salariati) per le provvigioni o i
salari loro dovuti dalla Camera di Pandolfo III Malatesti e l’addebitamento degli stessi per ciò che
hanno ricevuto a tale titolo.
Le varie partite sono cancellate con una linea diagonale dall’alto in basso, a significare che
probabilmente le scritture sono state riportate in altri libri68
.
Oltre ai registri sopra indicati, la sottoserie potrebbe comprenderne altri, desumibili dalle
citazioni o rinvii in essi contenute (tra parentesi è riportato il registro che contiene la citazione o il
rinvio)69
: il liber de partito anno 1404 (ex 42), il liber de partito signatus Q 1405 (ex 42 e 43), il
liber de partito signatus C 1405 (ex 42), il liber gialdus de partito 1406-1407 (ex 42-43), il liber
niger de partito 1406-1409 (ex 42 e 43), il liber rubeus de partito 1407 (ex 42 e 43), il liber niger
de partito 1407 (ex 42 e 43), il liber celestris de partito 1408 (ex 43), il liber rugius de partito 1409
(ex 43), il liber cilestris de partito 1411 (ex 66), il liber cilestris de partito 1412 (ex 54), il liber
albaxius de partito 1412-1415 (ex 66), il liber albaxius de partito 1416-1418 (ex 57 e 58)70
.
Terza sottoserie contabile (B): registri analitici annuali delle entrate o delle spese della
corte signorile (libri giornal-mastri partitari)
Reg. 45 1409 Giornale di spese di Pandolfo Malatesta e partitario
Dare e Avere (libro bianco)
Reg. 47 1414 Giornale di spesa di Pandolfo Malatesta e partitario
Dare e Avere (libro rosso)71
Reg. 49 1415 Giornale di spese di Pandolfo Malatesta e partitario
Dare e Avere (libro verde de partito segnato S)
Reg. 50 1416 Giornale di spesa di Pandolfo Malatesta e partitario
Dare e Avere (libro verde)
68
Come nota lo Zonghi, op. cit., p. 69, in questo registro “nelle partite di tutti gli ufficiali e salariati non si trova
quasi altro titolo del loro Avere, che quello del salario”. La registrazione di ogni partita segue un ordine cronologico,
iniziando da maggio 1405 fino a dicembre dello stesso anno. Partite interessanti risultano essere quelle riguardanti il
vicario generale di Pandolfo a Fano Ugolino de’ Pili, valente giurista e fidato capitano del signore, e i famosi capitani
“de la gente d’arme” Martino da Faenza e Niccolò da Tolentino. 69
G. Bonfiglio-Dosio, “Il variopinto mondo della cancelleria signorile”, op. cit., pp. 60-61. 70
L’elenco riporta anche registri pluriennali analoghi a quelli da noi inseriti nella seconda sottoserie contabile.
Inoltre, come segnalato in M. Ciambotti, “Il sistema dei registri contabili della cancelleria di Pandolfo III”, op. cit., pp.
83-84, l’elenco può ritenersi incompleto, in quanto desunto solo dalle citazioni e dai rinvii contenuti nei registri. Inoltre,
spesso, le citazioni hanno denominazioni diverse, anche se riferite ad uno stesso libro, riportando la sola indicazione del
colore della coperta o la segnatura della lettera70
: per esempio, il registro n. 42 rinvia ad un “Liber signatus Z”,
identificabile forse con il registro “libro de partite” n. 41, che riporta in coperta la dicitura “1406. Libro dei debitori di
Pandolfo (Z)”; oppure, il registro n. 44 (anno 1409) rinvia al “libro giallo”, in modo da configurarsi come un registro
saldaconti rispetto alle scritture in esso riportate. Cfr. G. Bonfiglio-Dosio, “Il variopinto mondo della cancelleria
signorile”, op. cit., p. 62. 71
Lo Zonghi (a p. 80 del suo Repertorio) titola questo registro come “Libro di partite di entrata e di uscita a
modo di conto corrente tra la Camera e gli aventi interessi con la medesima”.
25
Reg. 51 1417 Giornale di spesa di Pandolfo Malatesta e partitario
Dare e Avere (libro negro de partite segnato B)
Reg. 52 1418 Giornale di spese di Pandolfo Malatesta e partitario
Dare e Avere (libro de partiti bianco signato D)
Reg. 53 1419 Giornale di spese di Pandolfo Malatesta e partitario
Dare e Avere
Questi registri sono libri mastri partitari che si differenziano rispetto a quelli indicati come di
tipo A in quanto hanno una prima parte di registrazioni cronologiche simili a quelle del giornale.
Essi contengono, infatti, per una parte (le prime 30 carte circa), le registrazioni in sequenza
cronologica (mese per mese) delle spese di Pandolfo Malatesti, scritte a due colonne per carta senza
una vera e propria struttura a Dare e Avere; e per la parte restante, il solito partitario scritto a due
colonne per carta, con a sinistra i debiti (deve dare) e a destra i crediti (deve avere) in conti intestati
a diversi soggetti facenti parte del personale politico, amministrativo e di servizio (podestà, vicari,
referendari, ragionieri, notari, ecc.), nonché a banchieri, conestabili, capitani, castellani, dazieri,
massari, fattori ed altri, i cui nomi s’incontrano quasi sempre in ogni mese dell’anno in oggetto, a
motivo dei loro continui rapporti con le cose della corte di Pandolfo. I registri che appartengono a
questa serie riportano registrazioni di spese che poi risultano trascritte nel libro giornale pluriennale
n. 55 (denominato “Giornal bianco” o “Liber expensarum signatus G”) che si configura, quindi,
come una copia posteriore, ordinata e sistematica delle parti di giornale di tali registri, coprendo il
periodo 1414-142172
. Anche in questi registri le singole partite risultano tutte cancellate con una
linea diagonale dall’alto in basso, a significare che le scritture sono state riportate in altri libri.
Quarta sottoserie contabile: libri giornale
Reg. 48 1/1- 28/08/1415 Libro Giornale di entrata e di uscita della Camera di
Pandolfo Malatesti
Reg. 55 1414-1421 Libro Giornale di spese della Camera di Pandolfo
Malatesti (liber expensarum G)
Tra i registri fanesi, quelli classificabili come libri giornale veri e propri sono solo due. Il
primo è redatto in lingua volgare e scrittura mercantesca73
. In esso, mese per mese e giorno per
giorno, le uscite sono registrate nel verso e le entrate nel retro di ciascuna carta, con una modalità
che cambia da un certo punto in poi: infatti, fino alla carta 161, vengono usate le formule “A” e
“Da”, prima del nome, per registrare rispettivamente le uscite e le entrate della Camera di Pandolfo
Malatesta; mentre, dalla carta 162 in avanti, al loro posto, vengono indicate le espressioni “de’
dare” o “de’ avere”, precedute dal nome74
. Il secondo registro si differenzia rispetto al primo (e ad
altri libri giornali citati), sia perché riassume, in modo ordinato e sistematico, le registrazioni di più
anni, registrate in ordine cronologico, per trimestre o per quadrimestre di ogni anno e sempre
disposte per ogni carta su due colonne (senza struttura Dare e Avere), sia per l’uso della lingua
latina, associata al tipo di scrittura minuscola cancelleresca. I titoli delle varie spese sono appena
72
Per esempio, tutte le spese registrate nel registro n. 47 (libro rosso) compaiono, per l’intero anno 1414, nel
detto registro n. 55 alle carte da III a XXX; le spese registrate nel libro verde de partito segnato S (registro n. 49), alle
carte da 2 (verso) a 12 (verso), corrispondono a quelle registrate nel registro 55 alle carte da XXXIIII a LXII, riferite
all’anno 1415; le spese registrate nel liber viridis n. 50 alle carte da 18 a 20 corrispondono a quelle registrate sempre
sul registro 55 alle carte da LXXXII (verso) a LXXXVI, riferite al 1416; e così via. Cfr. G. Bonfiglio-Dosio, “Il
variopinto mondo della cancelleria signorile”, op. cit., pp. 40 e segg. 73
Al registro n. 48 fa rinvio anche il registro partitario n. 49 (Libro verde de partito segnato S) che riporta in
sequenza cronologica le entrate e le spese “che riceverà e pagherà” Gioacchino Malagonella, tesoriere generale di
Pandolfo Malatesti. 74
Tra queste partite di Dare ed Avere, lo Zonghi (op. cit., p. 82) segnala quella intestata al Maestro Gentile da
Fabriano “addebitato di ducati duecento pagatigli per sua provvigione del mese di gennaio”.
26
accennati, in quanto si richiamano sempre i registri partitari nei quali più diffusamente vengono
indicate le causali del loro sostenimento. Perciò, questo registro appare essere la copia sintetica dei
giornali annuali di spesa che si trovano nella prima parte dei sopra citati registri (giornal-mastri) nn.
45, 47, 49, 50, 51, 52, 5375
.
Oltre a questi, la serie dei libri giornali ne comprende altri, desumibili da citazioni e rinvii,
contenuti in diversi registri (di seguito riportati in parentesi) e con una indicazione a volte di tipo
generico (per esempio, “che apare al giornale”), a volte più specifico (riferita, in genere, al colore
della coperta) : i libri giornali (di cui uno giallo) del 1411 (ex registro n. 46), del 1414 ( di cui due
indicati come rosso e azzurro, ex registro n. 47) del 1416 (ex registro n. 50), del 1417 (di cui uno
indicato come nero, ex registro n. 51), del 1418 (ex registri nn. 52 e 65) e del 1419 (ex registro n.
53).
Inoltre, dai rinvii contenuti nei registri nn. 42, 43, 56 e 57, si segnala l’esistenza anche di altri
libri che Bonfiglio-Dosio76
giudica come sottoserie dei libri giornali, relativi:
alle spese del signore: Liber expensarum signatus E (relativo al periodo 1406-1407) e
Liber Expensarum signatus P (relativo all’anno 1408);
alle spese della corte signorile: Liber niger expensarum curie (relativo al periodo
1415-1416).
Deve osservarsi che anche questi libri “expensarum”, tenuti dalla tesorieria, non hanno una
struttura a sezioni divise in Dare e Avere, al pari di altre serie di libri che si presentano come
scritture contabili con annotazione cronologica ed analitica delle spese sostenute per la curia
signorile, preparatorie dei libri giornali, come i libri di entrata e quelli di uscita e i libri dati et
recepti.
Quinta sottoserie contabile: registri di contabilità preparatoria e speciale
Libri dei dazi (libri de dacii) e Libri di altre imposte indirette
Reg. 59
1406
Libro dei dazi (libro de dacii)
Reg. 60 1407 Libro dei dazi (libro de dacii)
Reg. 61 1410 Libro dei dazi (libro de dacii)
Reg. 62 1414 Libro dei dazi (libro de dacii signato P)
Reg. 63 1416 Libro dei dazi (libro de dacii verde segnato V)
Reg. 64 1417 Libro dei dazi (libro nero de dacii)
Reg. 65 1418 Libro dei dazi (libro bianco de dacii signato C)
Libri delle pene pecuniarie (libri condempnationum, multarum et punctationum) e Libri delle
grazie (libri gratiarum)
Reg. 66
1411- 1418
Libro delle pene pecuniarie (Liber condempnationum,
multarum, punctationum et diversarum inventionum
spectantium camere…domini Pandulfi de Malatestis
Brixie ac Pergami et cetera domini generalis et camere
comunis Brixie)
Libri delle taglie (libri tallearum)
Reg. 67
1411-1417
Libro delle taglie (liber tallearum et impositionum
quadrarum civitatis Brixie et nobillium Brixiane)
Reg. 68 1418-1420 Libro verde delle taglie (liber viridis tallearum o libro
75
G. Bonfiglio-Dosio, “Il variopinto mondo della cancelleria signorile”, op. cit. p. 63. 76
Ibidem, p. 63.
27
de la taya)
Questa sottoserie comprende libri che riguardano aspetti particolari della vita di corte e che
contengono scritture analitiche e preparatorie della contabilità di sintesi.
Per quanto riguarda i libri dei dazi, dal contenuto e dai rinvii presenti nei registri77
si può
supporre che si tratti di registri annuali, per cui la loro serie completa dovrebbe consistere
complessivamente in 17 pezzi (dal 1404 al 1420 compreso), designati o con una lettera dell’alfabeto
latino o con il colore della coperta o con entrambi gli elementi. In essi troviamo le registrazioni,
effettuate dal tesoriere di Pandolfo Malatesti, dei conti intestati agli appaltatori dei dazi (“incantatori
de dazi”), ossia le persone incaricate di riscuotere i dazi (del vino, della macina, della carne al
minuto, del prestinaio, ecc.) per conto del Comune di Brescia e degli altri Comuni del distretto. I
dazi costituivano gran parte delle entrate comunali e una porzione di questi introiti spettava alla
Casa del Signore, a titolo di capisoldi. La registrazione è nella solita forma tabulare, con i “deve
dare” e deve avere” su due colonne per carta, in lingua volgare e con scrittura che è di tipo
mercantesco per i primi registri e mista, con parti del tipo minuscolo cancelleresco, per quelli
relativi agli ultimi anni.
I registri nn. 51 e 52 contengono due rinvii a libri che appaiono collegati a quelli dei dazi e
che sembrano riferiti alla riscossione di alcune imposte indirette: il Libro (o Quaderno) del preso
su l’imbotato de la biave (1417) e il libro Bolete forestiere (1418).
I libri delle pene pecuniarie sono registri scritti in volgare e tenuti in forma tabulare a due
colonne, nei quali venivano annotate le pene pecuniarie irrorate a seguito delle sentenze dei
giusdicenti appartenenti alla struttura comunale e a quella signorile. L’unico registro superstite della
serie78
, ci fornisce, nella rubrica, un elenco di questi soggetti, distinguendo quelli appartenenti alla
Camera signorile e quelli della Camera comunale, destinatarie in proporzioni definite delle pene
pecuniarie delle condanne.
Sempre da citazioni esplicite contenute nel registro n. 66 si scopre l’esistenza anche dei Libri
delle grazie. Si fa rinvio, infatti, ad un Registro nigro gratiarum dell’anno 1418, ma non ci sono
elementi che aiutano a capire il collegamento tra le due serie.
I due esemplari di libri delle taglie superstiti nell’Archivio di Fano ci aiutano a comprenderne
i caratteri formali e di contenuto. Si tratta di registri tenuti in forma tabulare, a due colonne, riferiti a
periodi pluriennali e concernenti la riscossione delle taglie, ovvero delle imposte straordinarie
fissate dal signore e ripartite tra gli abitanti delle quadre cittadine (che prendevano il nome dalle
porte di ingresso), dei Comuni e dei nobili del distretto bresciano. Sono in lingua latina e scrittura
minuscola cancelleresca, con la segnatura costituita da una lettera dell’alfabeto latino o dal colore
della coperta. Bonfiglio-Dosio osserva79
che le stesse somme registrate a debito nel registro n. 67,
sotto il nome di ciascun appaltatore incaricato della riscossione del denaro, risultano poi accreditate
agli stessi nel registro delle prestanze n. 42, a chiusura del relativo conto.
Nell’ambito dei registri di contabilità preparatoria devono essere considerate altre tipologie di
libri contabili elementari, la cui esistenza è desumibile solo dalle citazione e dai rinvii contenuti nei
registri di Fano, in quanto non risulta che ne siano conservati alcuno tra i superstiti. Si tratta dei
libri di entrata/uscita e dei libri dati et recepti.
77
Il registro n. 46 fa riferimento a un Libro de dacii L del 1411; il registro n. 53 fa riferimento ad un Libro de
dacii O del 1419. 78
Altri sono citati nei registri nn. 43, 54, 57 e 58: Liber condempnationum signatus A (1408-1409), Liber
albixius condempnationum ( 1412-1415), Liber niger condempnationum (1415). Come rileva G. Bonfiglio-Dosio, op.
cit., p. 68, appaiono inspiegabili le sovrapposizioni cronologiche dei pezzi citati (il registro n. 66 Liber viridis
condempnacionum si riferisce, infatti, al periodo 1411-1418). 79
G. Bonfiglio-Dosio, “Un bilancio degli studi sulla signoria malatestiana: la storiografia otto-novecentesca”, in
G. Bonfiglio-Dosio, A. Falcioni (a cura di), op. cit., p. 23. L’autrice cita lo studio di Carlo Manaresi, “I nobili della
bresciana descritti nel codice malatestiano 42 di Fano”, in AA.VV., Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno
1930, Bettoni, Brescia, 1931, pp. 271-421.
28
I primi contengono rilevazioni analitiche degli incassi e degli esborsi monetari, designati con
la semplice dizione “Entrata” o “Uscita” oppure con l’indicazione aggiuntiva del colore della
coperta. Siccome, in alcuni casi, entrambi i tipi indicati nella citazione o nel rinvio si riferiscono ad
uno stesso anno, non abbiamo possibilità di affermare con sicurezza l’esistenza di un solo registro
oppure di due registri riferiti a quello stesso anno: per esempio, il registro n. 60 fa rinvio ad un libro
“Entrata” e ad uno “Entrata verde”, entrambi riferiti al 1407; il n. 61 rinvia ad un libro “Entrata” e
ad uno “Entrata rosso”, entrambi riferiti al 1410. Altri libri richiamati sono: Entrata del 1406 (ex
registro 59); Uscita rossa del 1411 (ex registro n. 46); Entrata gialla e Uscita gialla, entrambi del
1414 (ex registro n. 47, dove si leggono le espressioni “chome apare al quaderno de l’intrata gialla”
e “messo a uscita gialla”); Entrata gialla e Uscita gialla, entrambi del 1416 (ex registri n. 50 e 63);
Entrata gialla e Uscita Gialla, entrambi del 1417 (ex registri nn. 51 e 64); Entrata bianca e Uscita
bianca, entrambi del 1418 (ex registri nn. 52 e 65); Uscita bianca del 1418 (ex registro n. 53) 80
.
Dai rinvii contenuti nei diversi registri sopra indicati e dal loro titolo, si può dedurre che i libri
dati et recepti dovevano essere un particolare tipo di registri entrata/uscita di cassa, probabilmente
redatti dai maestri delle entrate (magistri intratarum), figure della cancelleria signorile che
prendevano parte attiva nella redazione delle scritture contabili. Con Bonfiglio-Dosio, possiamo
supporre che queste scritture dovevano essere redatte in duplice copia, una da conservare a cura dei
maestri delle entrate ed una da far confluire nell’archivio del signore, oppure in un’unica copia,
direttamente prodotta dai maestri delle entrate e da trasmettere poi all’archivio del signore. Nei
registri riassuntivi pluriennali (ad esempio il n. 43), il tesoriere signorile è addebitato dei fondi “pro
provixione domini” trasmessi su mandato del tesoriere comunale di Brescia Giovanni Benvenuti da
Firenze, il quale risulta quindi accreditato nella sezione Avere del libro “Dati et recepti”, insieme a
molti altri trasferimenti di fondi ai fattori Lodovico da Montenovo e Andrea da Imola e al
cancelliere Francesco Bracci. Questi ultimi vengono addebitati nei rispettivi conti del registro
pluriennale riassuntivo81
.
Gli accavallamenti cronologici riscontrati nelle citazioni impediscono di conoscere con
esattezza il numero e la sequenza delle unità. Tutti i libri citati sono i seguenti (tra parentesi sempre
il numero del registro che contiene il rinvio): Liber dati et recepti signato P 1406 e Liber rubeus
dati et recepti 1411 (entrambi ex registro n. 42), Liber albus dati et recepti 1407-1409 (ex registri
nn. 42 e 43); Liber viridis dati et recepti 1409 e Liber dati et recepti qui est penes magistros
intratarum prelibati domini nostri 1408 (entrambi ex registro n. 43); Liber rubeus dati et recepti
1411-1412-1414-1415-1420 (ex registri nn. 43, 54, 56, 57, 58, 66, 67); Liber viridis novo dati et
recepti 1412-1413-1415-1416 (ex registri nn. 54, 56, 57, 58); Liber viridis dati et recepti 1415-
1418-1420 (ex registri nn.43, 56, 57, 58, 68); Liber albus dati et recepti 1420 (ex registro n. 57);
Liber albus dati et recepti 1411 (ex registro n. 66)82
.
Altre serie di scritture minori, sempre a carattere analitico, riguardano i libri di trasporto del
sale (libri trafegi salis), i libri dei fitti (libri fictorum), i liber extraordinariorum, i libri di bollette
(libri bulletarum), le filze di vari documenti contabili (filza diversarum expensarum, filza
diversarum scripturarum ecc.), nonché diversi tipi di inventari (liber inventariorum, liber
munitionum castelanorum, ecc.) 83
.
3.4 L’inventario dei registri e dei documenti contabili che emerge dal registro n. 9
80
Per un approfondimento della natura e dei contenuti di questi registri si rimanda a M. Ciambotti, “Il sistema
dei registri contabili della cancelleria di Pandolfo III”, op. cit., pp. 89-91 e alle citazioni ivi contenute. 81
Si rimanda a M. Ciambotti, A. Falcioni, op. cit., pp. 171-172. 82
Si osserva che, a parte il primo libro, contrassegnato con la lettera P, tutti gli altri traggono il nome dal colore
della coperta (rosso, verde e bianco). 83
Cfr. M. Ciambotti, “Il sistema dei registri contabili della cancelleria di Pandolfo III”, op. cit., pp. 97-99.
29
Nei paragrafi precedenti si è potuto vedere come la gestione contabile rappresenti sicuramente
uno dei cardini della signoria malatestiana, attestato dalla presenza di un rigoroso sistema di
registrazione e organizzazione delle scritture, sulle quali il controllo era costante e minuzioso.
Il registro n. 9, nel quale il fattore di casa Malatesti Antonio d’Andriuccio da Sassoferrato
fornisce un inventario minuzioso dei documenti consegnati al ragioniere Luchino di Tommaso Lapi,
ci conferma l’importanza attribuita a tutte le registrazioni contabili, anche a quelle più semplici, di
tipo analitico e preparatorio. Attraverso il suo esame dettagliato è possibile ricostruire proprio uno
spaccato di tale contabilità, gestita dal fattore dei Malatesti e successivamente versata al ragioniere.
L’analisi puntuale dell’elenco di Antonio da Sassoferrato, oltre ad evidenziare le tecniche di
descrizione del materiale archivistico adottate da chi lavorava nella gestione della contabilità della
corte, consente di ricostruire le serie che componevano questa porzione di archivio e di farsi un’idea
delle singole unità archivistiche, anche nella loro fisicità e consistenza. Inoltre, è possibile
conoscere i tempi “amministrativi e contabili” scanditi dagli estremi cronologici dei registri e dei
mazzi, che talora coincidono con l’anno solare e tal’altra partono dall’inizio di luglio e terminano a
fine giugno.
Il registro si compone, oltre alla coperta (carta 1), di 18 carte: le prime 12 (dalla carta 2 alla
carta 13) contengono l’elenco dei registri e dei documenti contabili preparatori relativi agli anni
compresi tra il 1397 e il 1408 (un anno per ciascuna carta); dalla carta 17r alla carta 21r sono
elencati i libri contabili relativi al possedimento di Bastia (carta 17r, marzo 1400-1409), ai
gastaldati di Cartoceto e Fogliano (carta 17v e 18, luglio 1397- ottobre 1409 e aprile 1403-
luglio1408) e Mondolfo (carta 19, r, v, luglio 1397- febbraio 1409) e ai possedimenti di Caminata
(carte 20 e 21 r,v, 1398-1408 e marzo 1409-giugno 1410); la carta 21v fa riferimento ad alcune
annotazioni relative a fogli appartenenti all’amministrazione dei beni a Fano.
Le serie relative alla signoria fanese ricostruibili attraverso il registro n. 9 sono le seguenti:
- Libri generali di entrata;
- Libri generali di spesa;
- Bollette dei pasti;
- Libri di beccaria;
- Bollette di beccaria;
- Bollette di speziaria;
- Domande, lettere e bollette varie;
- Libri dell’entrata e della spesa del grano;
- Libri delle “provvende della biada dei cavalli”;
- Libri “bastardelli” della biada comperata e ricevuta;
- Bollette della biada dei cavalli:
- Libri del vino ricevuto;
- Bollette del ferrare dei cavalli.
Consideriamo ora distintamente queste serie di documenti indicandone la tipologia, il periodo
cui sono riferiti e la consistenza in termini di numero di carte indicate nell’inventario.
Libri generali di entrata
anno tipologia consistenza
1397 reg cc. 297
1398 reg cc. 326
1399 reg cc. 334
1400 reg cc. 272
1401 reg cc. 348
1402 reg cc. 397
1403 reg cc. 299
30
1404 reg cc. 298
1405 reg cc. 299
1406 reg cc. 318
1407 reg cc. 325
1408 reg cc. 324
Ne sono citati 12, uno per ciascun anno solare, tutti ponderosi, in carta bambagina e con la
coperta di cartapecora (o di capretto, per l’anno 1408). La continuazione di questa serie dovrebbe
aversi con il registro n. 19 facente parte della serie dei libri di amministrazione malatestiana (v.
retro par. 3.2). Non viene citato il periodo amministrativo di riferimento, anche se dal registro 19 è
ipotizzabile che fossero riferiti al periodo 1/7 di un anno – 30/6 dell’anno successivo84
.
Libri generali di spesa
estremi cronologici tipologia consistenza note
1397 – 15/08/1398 reg cc. 212
16/08/1398 – 24/09/1398 reg cc. 326 unito con il libro della
beccaria
25/09/1398 – 30/06/1399 reg cc. 214
01/07/1399 – 30/06/1400 reg cc. 299
1400 reg cc. 248
1401 reg cc. 218
1402 reg cc. 192
01/07/1403 – 30/06/1404 reg cc. 224
01/07/1404 – 30/06/1405 reg cc. 222
01/07/1405 – 30/06/1406 reg cc. 222
01/07/1406 – 30/06/1407 reg cc. 226
01/07/1407 – 30/09/1407 reg cc. 223
01/10/1407 – 30/06/1408 reg cc. 173
01/07/1408 – 31/01/1409 reg cc. 150
01/02/1409 – 30/06/1409 reg cc. 199
Il caso dei registri di spese (anche questi di carta bambagina e con coperta di cartapecora o di
capretto), è meno lineare della serie precedente. In alcuni casi non c’è corrispondenza esatta fra
anno solare e registri. A parte alcune eccezioni, con la presumibile mancanza di registrazioni per
alcuni mesi all’inizio o alla fine del periodo in alcuni anni, si osserva che il periodo amministrativo
di riferimento inizia con il 1° luglio di un anno e termina il 30 giugno dell’anno successivo. Il
registro relativo all’anno 1398, inoltre, ha un contenuto promiscuo, essendo unito al libro della
beccaria.
Bollette dei pasti
84
Anche P. Di Toro, R. Di Pietra, op. cit., p. 267, rilevano, a proposito dei libri di Entrata e uscita di denaro
presenti nella contabilità dell’Ospedale senese del Santa Maria della Scala (tra XV e XVI secolo), che ogni esercizio, di
durata annuale, di norma ha inizio il 1° luglio e chiude il 30 giugno.
estremi cronologici quantità
01/07/1397 – 30/06/1398 353
01/07/1398 – 30/06/1399 363
01/07/1399 – 30/06/1400 366
01/07/1400 – 30/06/1401 365
31
Le bollette dei pasti dovevano, presumibilmente essere raccolte in mazzi. L’inventario ne
ricorda 12, uno per ciascun periodo amministrativo, che iniziava al 1° di luglio e terminava al 30
giugno (quindi due semestri a cavallo di ciascun anno). Veniva prodotta più o meno una bolletta al
giorno, almeno a giudicare dalle consistenze.
Libri di beccaria
Nell’inventario vengono ricordati 14 libri di beccaria (ovvero di macelleria), di carta
bambagina, con coperta di carta di pecora o di capretto. Non sempre si riscontra corrispondenza fra
unità archivistica e periodo di riferimento, anche se risulta evidente che il periodo amministrativo
anche in questo caso va dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell’anno successivo. Abbastanza
variabile anche la consistenza dei differenti registri, con rilevazioni che per ogni carta riguardano
mediamente 3-4 giorni. Questi registri costituiscono già una documentazione di secondo livello, che
riassumono in forma di registro documenti che nascono su fogli sciolti, le bollette.
Bollette di beccaria
01/07/1401 – 30/06/1402 364
01/07/1402 – 30/06/1403 365
01/07/1403 – 30/06/1404 366
01/07/1404 – 30/06/1405 365
01/07/1405 – 30/06/1406 364
01/07/1406 – 30/06/1407 362
01/07/1407 – 30/06/1408 365
01/07/1408 – 30/06/1409 365
estremi cronologici tipologia consistenza
1397 reg cc. 132
25/09/1398 – 30/06/1399 reg cc. 99
01/07/1399 – 30/06/1400 reg cc. 148
01/07/1400 – 30/06/1401 reg cc. 99
01/07/1401 – 29/06/1402 reg cc. 116
01/07/1402 – 30/06/1403 reg cc. 104
01/07/1403 – 30/06/1404 reg cc. 100
01/07/1404 – 30/06/1405 reg cc. 125
01/07/1405 – 30/06/1406 reg cc. 126
01/07/1406 – 30/06/1407 reg cc. 126
02/07/1407 – 30/09/1407 reg cc. 126
01/10/1407 – 30/06/1408 reg cc. 74
01/07/1408 – 30/01/1409 reg cc. 44
01/02/1409 – 30/06/1409 reg cc. 97
anno quantità
1397 359
1398 514
1399 651
1400 492
1401 595
1402 492
32
Perfettamente corrispondenti agli anni risultano i 12 mazzi di bollette di beccaria, che
costituiscono una documentazione analitica che trova riscontro nei registri della serie precedente,
come ricorda l’inventario: “Item le bolette de la becaria del ditto anno scripte in carta bambaxina et
scontrano cum lo ditto libro de becaria die per die”. Le bollette sono di carta bambagina.
Bollette di speziaria
Risultano 12 mazzi di bollette di speziaria, che si riferiscono ciascuno al solito periodo
amministrativo annuale 1° luglio-30 giugno, “die per die” . Le bollette sono di carta bambagina.
Domande, lettere e bollette
Lacunosa appare la serie delle domande, lettere e bollette, costituita da fogli sciolti. Mancano gli
anni 1398 e 1399 e per il 1407 ci sono due registrazioni distinte, poco comprensibili.
1403 451
1404 466
1405 440
1406 400
1407 337
1408 186
estremi cronologici quantità
03/07/1397 – 30/06/1398 390
01/07/1398 – 30/06/1399 343
01/07/1399 – 30/06/1400 406
02/07/1400 – 29/06/1401 363
01/07/1401 – 30/06/1402 359
01/07/1402 – 30/06/1403 368
01/07/1403 – 30/06/1404 363
01/07/1404 – 30/06/1405 354
01/07/1405 – 30/06/1406 345
01/07/1406 – 30/06/1407 325
01/07/1407 – 30/06/1408 346
01/07/1408 – 30/06/1409 344
anno quantità
1397 4
1400 47
1401 107
1402 43
1403 35
1404 30
1405 30
1406 12
1407 15
1407 29
1408 28
33
Libri dell’entrata e della spesa del grano
Questa serie si presenta poco lineare: c’è una lacuna nel 1399, forse anche derivata da una
cattiva descrizione dell’inventario. Poco omogenea appare anche la periodizzazione dei singoli
registri, anche se l’anno amministrativo in alcuni casi (periodo 1402-1407) risulta sempre compreso
tra luglio di un anno e giugno dell’anno successivo e negli altri anni la non coincidenza sembra
dovuta ad un aumento cospicuo delle registrazioni. Risulta evidente, infatti, che nei periodi luglio
1407 - giugno 1408 e luglio 1408 - giugno 1409 si son dovuti tenere due registri per ciascun
periodo a causa del rilevante numero di registrazioni effettuate (occupanti in tutto 300 carte).
Viene sempre specificato il fatto che le bollette a cui questi registri fanno riferimento sono
quelle del “grano dato ad altry”. I registri sono di carta bambagina, con coperta di carta pecora o di
capretto.
Libri “delle provvende della biada dei cavalli”
estremi cronologici tipologia consistenza
1397 reg cc. 69
15/08/1398 – 30/11/1398 reg cc. 48
01/12/1398 – 30/06/1399 reg cc. 121
27/09/1399 – 30/06/1400 reg cc. 107
08/12/1400 – 30/06/1401 reg cc. 117
01/07/1401 – 30/06/1402 reg cc. 122
05/07/1402 – 27/06/1403 reg cc. 120
02/07/1403 – 30/06/1404 reg cc. 124
01/07/1404 – 30/06/1405 reg cc. 124
02/07/1405 – 26/06/1406 reg cc. 125
01/07/1406 – 30/06/1407 reg cc. 126
05/07/1407 – 26/09/1407 reg cc. 150
01/10/1407 – 28/06/1408 reg cc. 150
04/07/1408 – 31/01/1409 reg cc. 152
01/02/1409 – 30/06/1409 reg cc. 148
estremi cronologici tipologia consistenza
1397 reg cc. 186
1398 reg cc. 306
1399 reg cc. 216
03/04/1399 – 23/06/1400 reg cc. 43
1400 reg cc. 163
1401 reg cc. 141
1402 reg cc. 199
1403 reg cc. 64
1404 reg cc. 102
1405 reg cc. 62
1406 reg cc. 50
08/02/1407 – 30/06/1407 reg cc. 56
1407 reg cc. 188
1408 reg cc. 195
34
La serie delle provviste di biada dei cavalli è costituita da 14 registri, in genere uno per
ciascun anno con due eccezioni: la prima è relativa al periodo aprile 1399 – giugno 1400 e si
riferisce ad un “quaterno” aggiunto, contenente le registrazioni delle provviste di biada date “a la
ciertosa et a la ysolla gualtarescha” (Isola Gualtresca, ovvero l’odierna Isola di Fano); la seconda è
relativa al periodo febbraio- giugno 1407 e non ci sono riferimenti sul motivo del registro aggiunto.
Anche questi registri sono di carta bambagina, con coperta di carta pecora o di capretto.
Libri “bastardelli” della biada comperata e ricevuta
La serie di questi libri di minute, detti “bastardelli” è costituita da registri annuali, di minore
consistenza degli altri e con registrazioni “segnate per abito su el quale è scripto tutta la biava
comperata et per altro modo ricevuta in lo ditto anno”. La serie è però lacunosa, perché l’inventario
non ricorda il registro relativo al 1400 (anno in cui comunque sono presenti sia il libro delle
provviste di biada che il mazzo delle relative bollette). Questi libri sono di carta bambagina.
Bollette della biada dei cavalli
La serie è composta da 12 mazzi di bollette, generalmente riferiti ciascuno a un anno
amministrativo (luglio-giugno), con qualche periodo mancante tra la fine di un mazzo e l’inizio del
successivo. Le bollette sono di carta bambagina.
Libri “bastardelli” del vino ricevuto per la corte
anno tipologia consistenza
1397 reg cc. 30
1398 reg cc. 23
1399 reg cc. 22
1401 reg cc. 11
1402 reg cc. 20
1403 reg cc. 18
1404 reg cc. 22
1405 reg cc. 16
1406 reg cc. 18
1407 reg cc. 14
1408 reg cc. 16
estremi cronologici quantità
15/07/1397 – 2/06/1398 251
01/07/1398 – 30/06/1399 349
08/07/1399 – 08/04/1400 141
01/07/1400 – 13/06/1401 90
14/07/1401 – 25/01/1402 80
13/03/1402 – 07/06/1403 49
08/07/1403 – 21/06/1404 83
08/07/1404 – 30/06/1405 46
06/07/1405 – 22/06/1406 46
01/07/1406 – 13/04/1407 34
31/08/1407 – 28/06/1408 42
01/07/1408 – 29/06/1409 85
35
anno tipologia consistenza
1397 reg cc. 18
1398 reg cc. 13
1400 reg cc. 4
1401 reg cc. 22
1402 reg cc. 24
1403 reg cc. 35
1404 reg cc. 16
1405 reg cc. 22
1406 reg cc. 20
1407 reg cc. 22
Questa serie, composta di piccoli registrini annuali, risulta lacunosa: mancano gli anni 1399 e
1408. Sono di carta bambagina.
Bollette del ferrare dei cavalli
La serie è costituita da 12 mazzi di bollette, di consistenza molto differente, che si riferiscono
ciascuno a un anno “amministrativo” (primi di luglio – fine giugno). Sono di carta bambagina.
L’inventario dei registri e dei documenti contabili del fattore di casa Malatesti è completato
poi con le “ragioni” di alcune proprietà dei Malatesti: possedimento di Bastia, gastaldati di
Cartoceto e Fogliano, vicariato di Mondolfo e i possedimenti di Caminata.
Per la Bastia, sono inventariati un libro generale (di 726 carte) e 278 bollette delle entrate e
delle uscite del grano.
La “ragione” dei gastaldati di Cartoceto e Fogliano è suddivisa per i periodi relativi a ciascun
gastaldo:
- Paolo di Cecco da Sassoferrato (gastaldo di Cartoceto nel periodo 01/07/1397–31/01/1401):
due libri di entrate e di spese (di 58 e di 42 carte) e 15 bollette;
- Corradino di Luca da Cartoceto (gastaldo di Cartoceto nel periodo 01/02/1401-30/04/1403):
un libro di entrate e di spese (di 51 carte) e 17 bollette;
- Gucinello di Giacomo da Osimo (gastaldo di Cartoceto e di Fogliano nel periodo
01/05/1403-7/09/1404): un libro di entrate e di spese (di 168 carte) e 9 bollette;
- Alberto di Francesco da Sassoferrato (gastaldo di Cartoceto e di Fogliano nel periodo
14/09/1404-30/09/1408): un libro di entrate e di spese (di 98 carte) e 89 bollette;
estremi cronologici quantità
Luglio 1397 – giugno 1398 154
Luglio 1398 – giugno 1399 454
Luglio 1399 – giugno 1400 338
Luglio 1400 – giugno 1401 141
Luglio 1401 – giugno 1402 169
Luglio 1402 – giugno 1403 137
Luglio 1403 – giugno 1404 118
Luglio 1404 – giugno 1405 124
Luglio 1405 – giugno 1406 117
Luglio 1406 – giugno 1407 39
Luglio 1407 – giugno 1408 162
Luglio 1408 – giugno 1409 142
36
- Antonio da Osimo (gastaldo di Cartoceto e di Fogliano dal 1° ottobre 1408 e per un anno):
un libro di entrate e di spese (di 64 carte) e 10 bollette;
In aggiunta, per il gastaldato di Fogliano, alla carta 18 dell’inventario vengono citati un libro
generale di entrata e spesa e un mazzo di 62 bollette mensile relativo al periodo da aprile 1403 al
mese di luglio 1408.
Anche la “ragione” del vicariato di Mondolfo è suddivisa per i periodi relativi a ciascun
gastaldo:
- Vanni di Piero di Mondolfo (luglio 1397-1398): 7 quaternetti (di consistenza variabile da 4
a 26 carte) e 47 bollette;
- Antonio di Ventura da Sassoferrato (01/03/1399-20/10/1402): un libro contabile (di 148
carte) e 60 bollette;
- Gucinello di Giacomo da Osimo (21/10/1402-30/04/1403): un libro contabile (di 28 carte) e
4 bollette;
- Vanni di Piero di Mondolfo (01/05/1404-31/03/1408): un libro contabile (di 185 carte), tre
quaderni e 79 bollette;
- Vanni di Piero e Cicco di Piero (01/03/1408-28/02/1409): piccolo libretto contabile (di 44
carte) e 18 bollette.
La “ragione” del possedimento di Caminata è tenuta da Bonaventura di Filippo da
Sassoferrato e consta dei seguenti libri contabili:
- Libro dell’entrata del grano (1398-1408, 123 carte);
- Quaderno del grano ricevuto da “ser Baldo” (22 carte);
- Libro dell’entrata del grano ricevuto (1397-giugno 1409, 34 carte);
- Libro di spesa del grano macinato (1397-giugno 1409, 72 carte);
- Libro di spesa del grano…..e …dato ad altri (1397-1409, 51 carte);
- Libro della spesa per la biada dei cavalli “mandata a Fano per la corte” (da luglio 1397,
presumibilmente a tutto il 1408 o a giugno 1409, 119 carte);
- Libro della spesa del grano e altra biada da Caminata e da altre persone (1397-giugno 1409,
29 carte);
- Quattro piccoli quaderni dell’entrata e uscita del ... ricevuto e … a Caminata (14, 24, 36, 18
carte);
- Tre quaderni dell’entrata del vino ricevuto a Caminata (1397-1408, di 26, 22 e 14 carte);
- Libro bastardello dell’entrata della biada ricevuta (1397-1408, 18 carte);
- 73 bollette del grano e di legumi (da 1397 al 1409 presumibilmente);
- 76 bollette della biada dei cavalli (senza indicazione del periodo, ma presumibilmente 1397-
1409).
Oltre a questi, sono indicati due quaderni della biada portata da Caminata per i cavalli del
signore in occasione del viaggio in Francia nel 1399 (di 40 e 42 carte), scritti da Patrignano; e un
libro del grano e altra biada di Caminata nell’anno 1409.
Alla fine dell’inventario sono indicati anche 18 fogli di carta bambagina (tratti dai libri), dei
quali 2 scritti dal massaro di corte Sante da Montecosaro e gli altri da Molmo della Tacca.
4. Un tentativo di ricostruzione del sistema dei libri contabili nelle amministrazioni
pubbliche centrali e periferiche a cavallo tra XIV e XV secolo.
4.1 La contabilità delle amministrazioni centrali e di quelle periferiche
Dalla ricostruzione dell’intero archivio malatestiano operata nei paragrafi precedenti
(compresa, quindi, anche la parte post-Pandolfo III), è possibile effettuare una riclassificazione
tipologica dei registri contabili che facevano parte del complesso sistema amministrativo signorile
dei due poli di Fano (1385-1456) e di Brescia (1405-1421).
37
Innanzitutto, occorre considerare in modo separato i due livelli di strutture amministrativo-
contabili: quella centrale (nelle due sedi di Fano e Brescia) e quelle periferiche (città e vicariati
dipendenti, gastaldati, tenute e possedimenti, rocche e castelli). I rapporti tra i due livelli operano
come tra una sede amministrativa centrale e le varie succursali che da quella dipendono e alla quale
riportano contabilmente e periodicamente.
A livello dell’amministrazione centrale (a Fano e a Brescia) i libri contabili possono essere
così classificati:
libri contabili della fattoria di Casa Malatesti, a capo della quale c’è il fattore
generale. Costui registra tutti i movimenti di entrata (soldi in prevalenza assegnati
dal tesoriere signorile o derivanti da disposizioni dirette del signore o frutto delle
vendite dei beni della fattoria) e di uscita per le spese sostenute per la gestione della
fattoria;
libri contabili tenuti dal massaro di corte a Fano. Anche costui registra le entrate e le
uscite, ma riferite in modo particolare alla sola corte signorile e per tutto ciò che
occorreva per la vita che in essa si conduceva;
libri contabili specificamente riferibili ad alcuni aspetti della struttura organizzativa e
amministrativa della signoria: l’organizzazione militare, giurisdizionale e fiscale, gli
affitti, l’ufficio del sale;
libri contabili della tesoreria centrale della corte signorile, da cui dipendevano le
strutture periferiche.
Queste serie di registri si possono poi suddividere in relazione alla classificazione tipologica
delle scritture contabili che abbiamo seguito nei paragrafi 3.2 e 3.3. Il risultato è illustrato nella
Tabella 4.
Tabella 4 - Libri contabili dell’Amministrazione malatestiana centrale di Fano e/o di Brescia
libri
contabili
tipologia
delle scritture
Libri della
fattoria di Casa
Malatesta (Fano)
Libri tenuti
dal massaro
di corte
(Fano)
Libri delle
paghe
militari e di
altre attività
varie (Fano
e Brescia)
Libri relativi
a dazi e
imposte
(Fano e
Brescia)
Libri della
depositeria
centrale (Fano e/o
Brescia)
Registri
sintetici
riassuntivi o di
organizzazione
sistematica
delle voci
contabili
Libri dei conti della
corte signorile –
Fano e Brescia
(pluriennali): nn. 22,
23, 43, 58
Libri mastri delle
entrate e delle spese
della depositeria di
Fano (pluriennali):
nn. 21, 33, 84, 85,
86
Libri dei debitori e
dei creditori (o libri
delle prestanze) e
Libri partitari
ufficiali e salariati –
Fano e Brescia
(pluriennali): nn. 25,
42, 54, 56, 57
Registri
analitici delle
Libri generali di
entrata e di spesa:
Libri mastro
entrate e Libri mastri annuali
delle entrate e delle
38
entrate e delle
spese della
corte signorile
nn. 19, citazioni
registro n. 9
spese di corte
– Fano: n. 10
Libri delle
bocche
ordinarie e
straordinarie
– Fano: n. 83
spese della corte –
Fano e Brescia: nn.
13, 14, 16, 17, 18,
40, 41, 44, 45, 46,
47, 49, 50, 51, 52,
53, 73, 79, 87
Libri giornale Libri giornali
pluriennali di
entrata e di
uscita - Fano:
n. 36
Libri giornali
annuali o pluriennali
di spesa della
depositeria di Fano
e di Brescia: nn. 29,
30, 31, 32A, 32B,
48, 55, 74, 76, 77
Registri di
contabilità
preparatoria e
speciale
Libri di beccaria,
Libri del vino
ricevuto, Libri
delle provviste di
biada dei cavalli,
libri dell’entrata e
della spesa del
grano: n. 78,
citazioni registro
n. 9
Libri della
cassa
militare
(registri delle
paghe
militari): nn.
12, 102
Libri delle
mostre ai
Podestà,
Castellani e
Conestabili:
nn. 7, 8,
94,95, 96
Libri dei dazi
(o di altre
provvigioni e
imposte
indirette): nn.
20, 59, 60,
61, 62, 63,
64, 65, 75,
92, 93,97, 98,
99, 100, 101
Libri dati et recepti;
libri di entrata e di
uscita di cassa; libri
contabili particolari:
nn. 11/A, 11B2, 15,
26
Libri bastardelli
della biada
comprata e
ricevuta, libri
bastardelli del
vino ricevuto per
la corte: citazioni
registro n. 9;
Bollette varie
(dei pasti, di
beccaria, di
speziaria, della
biada dei cavalli,
del ferrare dei
cavalli): citazioni
registro n. 9
Libri dei fitti,
Libri relativi
all’ufficio
del sale:
conto del
sale,
trasporto del
sale, ecc.
Fano e
Brescia: n.
25 bis,
citazioni ex
registro 43
Libri delle
pene
pecuniarie,
libri delle
grazie, libri
delle taglie:
nn. 11/B1,
66, 67, 68,
Libri dell’entrata e
della spesa di grano
dei possedimenti e
dei mulini: nn. 28A,
28B, 72B, 34, 35
Registri
riassuntivi di
entrate e spese
rendicontate al
signore
Rendiconto
mensile del
fattore: n. 27
Riassunti mensili
entrate e spese del
depositario di Fano
inviati in copia a
Pandolfo a Brescia:
nn. 24/1, 24/2, 24/3,
24/4, 24/5, 24/6,
24/7, 24/8
39
A livello di contabilità periferica non troviamo la stessa articolazione dei sistemi di scritture
contabili, in quanto i registri, spesso quaderni o raccolte di bollette, sono per lo più tenuti in forma
di semplice rendicontazione delle entrate e delle spese (in prevalenza non in Dare/Avere), distinte
per titoli o per soggetti, oppure di libri giornale, con pochi collegamenti rispetto ad altre scritture.
Nella Tabella 5 si sono, quindi, distinti i libri solo in relazione all’amministrazione periferica di
appartenenza.
Tabella 5 - Libri contabili dell’amministrazione malatestiana periferica di Fano
Libri delle
depositerie vicariali
di Senigallia,
Mondavio e
Pergola
Libri di
amministrazione
dei possedimenti
di Bastia e
Caminata
Libri di
amministrazione
dei possedimenti
di Meldola e
Polenta e altre
tenute
Libri di
amministrazione
dei gastaldati e
dei possedimenti
di Cartoceto,
Fogliano,
Mondolfo e
Saltara
Libri tenuti dai
castellani
Registri sintetici
pluriennali di entrata
e uscita delle
depositerie vicariali:
nn. 72/A
(Senigallia), 104
(Mondavio)
Registri di entrata e
di spesa del fattore
di Caminata: nn.
80, 81, 88, 89, 90,
91
Registri di entrata
e spesa: n. 39
(Meldola e
Polenta)
Libro generale
entrate e spese
gastaldato di
Fogliano:
citazione registro
n. 9
Registri di entrata e
uscita del castello
della Stacciola: nn.
37, 38/1, 38/2,
38/3, 38/4
Registri annuali
delle entrate e delle
spese delle
depositerie vicariali:
nn. 103, 105 e 106
(Mondavio), 107,
108, 109 (Senigallia)
Libro generale
entrate e spese
(Bastia): citazione
registro n. 9
Libro Giornale di
spese:
n. 110 (tenuta di
Montetorto)
Registri annuali
entrate e uscite
dei gastaldati di
Cartoceto e di
Fogliano:
citazioni registro
n. 9
Registri annuali
delle entrate delle
depositerie vicariali:
n. 71(Senigallia)
Libri delle bocche
ordinarie e
straordinarie: n. 82
(Caminata)
Registri di spesa:
nn. 111 e 112
(fattoria di
Montemarciano
Quaderni e
quadernetti
contabili del
gastaldato di
Mondolfo;
citazioni registro
n. 9
Registri annuali
delle spese delle
depositerie vicariali:
11/B3 (Pergola),
69 (Mondavio)
Libri dell’entrata
del grano ricevuto e
libri di spesa del
grano macinato
(Caminata):
citazioni registro n.
9
Bollette varie
(gastaldati di
Cartoceto,
Fogliano,
Mondolfo):
citazioni registro
n. 9
Rassegne dei pascoli
e del bestiame (e
registrazioni affitti)
delle città vicariali
(Mondavio,
Senigallia): n. 70
Libri di entrata
della biada ricevuta
e di spesa per la
biada dei cavalli
per la corte di Fano
(Caminata):
citazioni registro n.
9
Libri del vino
ricevuto
40
(Caminata):
citazioni registro n.
9
Bollette varie: del
grano, dei legumi,
della biada dei
cavalli ecc. (Bastia,
Caminata):
citazioni registro n.
9
Per completezza, occorre ricordare poi le contabilità proprie dei Comuni (Fano, Brescia,
Bergamo), in quanto le strutture comunali, come è stato ben evidenziato retro da Falcioni, pur
dovendo sottostare alle leggi signorili, conservavano l’individualità come entità amministrativa.
Tuttavia, mentre per il Comune di Brescia abbiamo attestati i numerosi rinvii, contenuti nei registri
di corte, al tesoriere comunale Giovanni di Firenze (e ai libri contabili da lui tenuti, come ad
esempio, il libro “dati et recepti” o il libro “debitorum”), per Fano la commistione è assai più
evidente. Ci sono registri (es. il n. 20) nei quali, oltre alle provvigioni riscosse dal signore e distinte
per comuni, sono segnate le entrate dei dazi separate tra quelle della città di Fano e quelle del
“contado”.
4.2 I rapporti con la Tesoreria centrale
Nella Figura 1 è possibile ricostruire i flussi di denaro che entravano ed uscivano dalla
Tesoreria centrale.
Figura 1 Sistema delle relazioni fra i diversi Uffici amministrativi e la Tesoreria centrale
Comuni
Uffici preposti a
riscossione dazi,
provvigioni, taglie,
condanne, ecc.
Ufficiali dei
mulini, ufficio del
sale, ecc.
Tesoreria
centrale
Fattore della curia
signorile
Massaro della
corte
Ufficiali preposti
alle paghe militari
e altri centri di
spesa
Tesorerie
vicariali
41
In sintesi, è possibile individuare la seguente tipologia di rapporti indicati nella figura.
1) Rapporto fra Tesoreria Comunale, Tesoreria signorile e i fattori della curia signorile
Maggiore chiarezza viene dai registri che si riferiscono al dominio bresciano, in particolare
dal registro n. 42. Sono numerosi gli addebiti al tesoriere generale della curia signorile delle
somme a lui dovute dal tesoriere comunale, per versamenti riguardanti le provvigioni
mensili imposte al Comune stesso (in aggiunta alle somme riscosse tramite le strutture
comunali per conto del signore come capisoldi, tributi e dazi). Il tesoriere comunale viene
accreditato delle stesse somme nel Libro “dati et recepti”, tenuto dallo stesso tesoriere
comunale. I Comuni vengono accreditati, invece, nel “Libro debitorum” per le somme da
loro riscosse fiscalmente ma dovute, in tutto o in parte, al signore85
. Anche per Fano si
evidenzia che con i capisoldi incassati sui redditi del Comune si provvedeva a pagare le
spese gravanti lo stesso bilancio comunale86
. Inoltre, è rintracciabile un rapporto diretto tra
la tesoreria comunale e i fattori operanti nella curia signorile. Anche in questo caso, nel
registro 43, i versamenti fatti dal tesoriere comunale bresciano – es. per dazi riscossi nella
città - sono scritti in Dare del conto del fattore (presente nel registro 43), con relativo
accredito dello stesso tesoriere comunale in Avere del Libro “dati et recepti”. Anche con
riferimento ai registri fanesi, come già segnalato retro par. 3.4, alcune delle entrate daziali
comunali erano ripartite tra la camera comunale e la fattoria signorile87
;
2) Rapporto fra le Tesorerie vicariali e quella centrale.
Le tesorerie vicariali (al pari di quelle comunali) costituivano non tanto dei centri di spesa,
quanto dei veri e propri centri di “reddito”. Infatti, la differenza positiva tra le entrate
riscosse nella vicaria e le spese ivi sostenute, o per comando diretto del signore o per la
gestione della vicaria stessa, era trasmessa al tesoriere centrale. Si prenda, ad esempio, il
registro sintetico pluriennale di entrate e spese della vicaria di Senigallia (n. 72), nel quale
emerge una differenza positiva tra le somme entrate nell’arco di cinque anni e il totale delle
spese sostenute nello stesso periodo. Questo “avanzo” di gestione viene trasmesso alla cassa
camerale del signore88
. Inoltre, altre scritture contabili dei registri delle entrate e delle spese
tenuti dai depositari delle vicarie di Senigallia e Mondavio testimoniano che,
periodicamente, sono rilevati versamenti dalle depositerie periferiche a quella centrale89
. Si
85
Cfr. M. Ciambotti, A. Falcioni, op. cit., pp. 117-123 e pp. 171-172. 86
A. Falcioni, “L’economia di Fano in età malatestiana”, op. cit., p. 105 e p. 151, nota 89, fa riferimento al
registro n. 29 dal quale risulta proprio questa cessione di diritti da parte del Comune di Fano a favore di Pandolfo III, in
cambio del sostenimento delle spese di gestione e manutenzione del territorio. 87
I registri 11A, 11B1 e B2, tenuti dal fattore Balduccio d’Andriucciolo e relativi alla riscossione delle entrate
dalle colte e dalle condanne del Comune di Fano e ricevute per la corte signorile, evidenziano che i soldi provenivano
direttamente dalla cassa comunale come capisoldi sugi introiti comunali. In questi registri ci sono anche alcune spese di
corte per lavori murari e di decorazioni nella casa di Caminata, dove nel 1398-1399 si trovava a dipingere un tal
maestro Pace da Faenza; e per il passaggio a Fano di personaggi illustri (Chiavelli, Signore di Fabriano, Onofrio
Smeducci signore di San Severino, Carlo Malatesti ecc.). 88
Cfr. A. Zonghi, op. cit., pp. 127-18. 89
Per esempio, nei registri 107 e 108 (Depositeria di Senigallia), tra le spese, sono rilevati i “denari pagati che
vanno in depositeria de Fano”, dati per le esigenze del signore. Nel registro 108, questa voce costituisce un titolo di
spesa. Cfr. A. Zonghi, op. cit., pp. 157-159.
42
osservi che i tesorieri vicariali erano preposti a riscuotere per conto del signore una parte
degli introiti dei Comuni devoluti al signore e ad amministrarli secondo la volontà del
signore medesimo90
;
3) Rapporto fra gli Uffici fiscali decentrati e la Tesoreria centrale
Gli uffici preposti alla riscossione dei dazi, delle provvigioni, delle taglie, delle imposte
sulla vendita del sale, del ricavato della vendita del grano o quanto altro (es. fitti) registrano
le loro entrate nella sezione Avere di appositi libri contabili (es. Libri “talearum”,
“condempnationibus”, “debitorum”, “fictorum”, “trafegi salis domini”), mentre il Tesoriere
signorile è addebitato delle stesse somme riscosse. Nel caso degli ufficiali dei mulini, le
entrate derivanti dalla vendita del grano sono al netto delle trattenute per il salario degli
stessi e dei loro familiari e per le spese sostenute per la gestione91
. Analogo carattere
possiede il rapporto con i castellani, testimoniato dai registri 37 e 38;
4) Rapporto tra la fattoria della curia signorile o il massaro di corte e la Depositeria
centrale
I registri riferibili all’amministrazione fanese ci testimoniano che i fattori e i massari erano
responsabili di un centro di spesa nel quale tutte le necessità di denaro per le innumerevoli
spese di gestione della fattoria (acquisto sementi e altre materie prime, acquisto materiali di
consumo, manutenzione case, strade e campi, salari operai e contadini) erano coperte dalle
somme di denaro provenienti dal Depositario signorile di Fano o “ricevute per
comandamento del signore” o derivanti dalla vendita dei beni prodotti nella fattoria stessa
(grano, vino, olio, frutta, animali, ecc.)92
. Anche in questo caso, la parte rimanente dei ricavi
derivanti da tali vendite veniva trasmessa alla depositeria signorile. I registri superstiti di
Fano relativi a tali rapporti sono sia libri mastri che libri giornale;
5) Rapporto tra gli ufficiali preposti alle paghe militari e la Depositeria centrale
Già si è detto del sistema di approvvigionamento di denaro evidenziato dal registro n. 12
(1397) relativo agli ingaggi militari. Le somme con le quali si pagano le milizie al servizio
di Pandolfo III provengono direttamente dal papato, tramite il banchiere romano Lando
Moriconi. In altri casi, i registri sia fanesi che bresciani documentano che le somme
distribuite ai soldati provengono direttamente dalla depositeria centrale.
4.3 Le relazioni tra le scritture contabili: una visione d’insieme
L’esame sin qui svolto ha consentito di evidenziare, da un lato, l’assetto organizzativo e le
relazioni tra i diversi uffici amministrativi dell’apparato della corte signorile, a livello centrale e
periferico, e dall’altro lato la complessità del sistema di registrazioni contabili presente negli uffici
stessi sia a Fano che a Brescia, in riferimento alle attività svolte nei due territori. L’archivio di
Brescia denota un livello di maggiore raffinatezza contabile, con registri scritti per lo più in latino,
ad attestare la presenza di personale amministrativo più qualificato rispetto a quello impiegato a
90
Ibidem, pp. 154-155, con riferimento al registro n. 103 (1442-1443). 91
Un esempio di tale rapporto è dato dai registri n. 34 e 35 tenuti da Niccolò Gambiero da Pergola, ufficiale dei
mulini del signore a Fano (si veda supra par. 3.2). Una parte delle somme riscosse dalla vendita del grano è destinata
alle spese di gestione dei mulini, compreso il suo salario, quello degli altri operai e dei “molinari”, il compenso
dell’ufficiale preposto alla pesa, l’affitto della casa dove abita e del magazzino utilizzato per lo stoccaggio del grano, le
spese di manutenzione dei mulini. Nel registro 28B, tenuto dal tesoriere Tommaso di Francesco da Montefano, sono
rilevate le somme a lui versate proprio dall’ufficiale sui mulini Niccolò Gambiero, mentre nel registro 28A vengono
riassunti tutti i pagamenti per acquisti di grano fatti dallo stesso depositario per mano del ragioniere Giovanni
Ramesino. Cfr. A. Zonghi, op. cit., pp. 56-57 e 62-63. 92
Si veda, per esempio, il registro n. 19 (1409-1410), citato da A. Zonghi, op. cit., pp. 42-43.
43
Fano. Le differenze sono attestate ovviamente dai contenuti dei registri superstiti e dai richiami in
essi contenuti riferiti ai registri collegati.
Il lavoro di classificazione delle registrazioni contabili operato nei paragrafi precedenti in
base ai livelli amministrativi coinvolti, che ha consentito di individuare più sottoserie contabili
dell’intero archivio, si può ora concludere con uno sforzo di visione d’insieme del complesso
sistema di rilevazioni, andando a considerare le relazioni tra i vari tipi di registri presenti nelle due
sezioni di archivio riferite a Fano e a Brescia, anche alla luce dell’inventario contenuto nel registro
n. 9. In entrambe le sedi, il perno di tutto il sistema di registrazioni contabili della tesoreria signorile
appare essere costituito dai Libri tabulari di entrata e di uscita (Fano) o Libri dei conti della corte
signorile (Brescia), aventi natura di libri mastri riassuntivi e pluriennali, con ordinamento delle
scritture sistematico, contenenti le registrazioni mensili degli addebitamenti ed accreditamenti a due
colonne in sezioni Dare e Avere. Queste “tavole della ragione” tenute rispettivamente dal
depositario Andrea Bettini e dal Tesoriere Gioacchino Malagonella, entrambi di origine fiorentina,
non contengono distinzioni tipologiche (per categorie di entrata o di spesa) e risultano collegati in
modo diretto o indiretto a tutti gli altri registri dell’amministrazione signorile (e in parte di quella
comunale). Sulla base quindi dell’inventario ragionato proposto retro nei paragrafi 3.2 e 3.3 e
dell’inventario contenuto nel registro n. 9, si possono ricostruire le relazioni tra le varie classi di
libri contabili esistenti nell’Amministrazione malatestiana di Fano e di Brescia secondo gli schemi
indicati nelle figure 2 e 3.
44
Figura 2 - Sistema delle relazioni tra i libri contabili dell’amministrazione malatestiana
centrale a Fano
Tabulari di entrata e di
uscita (registri pluriennali
senza distinzioni tipologiche)
Libri mastri Uffici relativi a varie attività
(fitti, sale, paghe militari, imposte, dazi,
ecc.)
Registri analitici di entrata e di spesa di
corte (libri mastri annuali)
Registri pluriennali delle entrate e delle
spese distinte per tipologia
Libri Giornali (cronologici,
annuali e pluriennali)
Bollette e fogli sciolti
Registri di entrata e di uscita di cassa
Libri generali di entrata e di spesa della
fattoria (annuali) e Libri
speciali (Beccaria, speziaria,
grano, vino, biada dei cavalli)
Bastardelli di cassa
(annuali o pluriennali)
45
Figura 3 - Sistema delle relazioni tra i libri contabili dell’amministrazione malatestiana
centrale a Brescia
A livello di contabilità periferica, specie quella riferita alle depositerie vicariali, riassunta
supra nella Tabella 5, si riscontra un’impostazione similare, con la presenza di registri sintetici
pluriennali di entrata/uscita, libri mastri annuali, libri giornale, registri di contabilità preparatoria e
speciale, bollette e documenti contabili “di prima nota”.
La tipologia di relazioni più significative che emerge dal quadro delineato può essere
sintetizzata nel modo che segue, anche sulla scorta delle indicazioni già emerse retro nei paragrafi
3.2 e 3.3:
1) Relazioni tra libri mastri partitari annuali e libri giornale. I primi, riferibili in larga parte
alla porzione di archivio bresciano, hanno ordinamento scritturale su base sistematica, con
conti a sezioni contrapposte Dare/Avere (due colonne nella stessa pagina) intestati a
soggetti debitori e creditori e rilevazioni di tipo analitico. Sono per lo più registri annuali
con le varie partite di addebito e accredito cancellate con linee diagonali, a significare la
Libri dei conti della corte signorile
(mastri tabulari pluriennali)
Libri mastri partitari entrate e spese della
corte (annuali)
Libri delle prestanze (creditori) e Libri dei
debitori (mastri tabulari annuali)
Libri Giornali (cronologici,
annuali e pluriennali)
Bollette e filze di documenti contabili
Registri di entrata e di uscita di cassa - Libri dati
et recepti
Libri mastri Uffici relativi a varie
attività (riscossione dazi e
altre imposte, pene pecuniarie,
taglie, grazie, fitti, sale, paghe militari
ecc.)
46
loro trascrizione nei libri dei conti pluriennali. I libri giornale, come noto, hanno
ordinamento scritturale di tipo cronologico, con registrazioni analitiche divise in due parti
(entrate ed uscite), scritte in modo consecutivo (mese per mese e giorno per giorno) e
collegate agli addebiti/accrediti rilevati nei libri mastri. Possono essere anche pluriennali
(come quelli dell’amministrazione bresciana);
2) Relazioni tra libri mastri annuali e Tabulari o libri dei conti della corte signorile. I
Tabulari delle entrate e delle uscite della corte di Fano e i Libri dei conti della corte di
Brescia si qualificano come registri principali pluriennali, ad ordinamento sistematico
(registrazioni mese per mese), con conti a due colonne, nella stessa pagina, di addebito e
accredito al tesoriere e agli altri soggetti, raggruppati o no per categorie e sempre
richiamati in un apposito indice (rubrica). Si presume che il collegamento tra questi
registri e i mastri annuali (di corte o dei vari uffici responsabili delle attività
amministrative della signoria) fosse di ripresa dei conti e chiusura in contropartita delle
scritture analitiche presenti in questi ultimi;
3) Relazioni tra i Tabulari o libri dei conti della corte signorile, i libri delle prestanze (o
quelli dei creditori) e i registri di entrata e uscita di cassa. La relazione fa riferimento al
fatto che i pagamenti o le riscossioni avvenissero in contanti oppure a distanza nel tempo.
Le operazioni di addebito e accredito, infatti, potevano sfociare in entrate e uscite di
denaro contante registrate negli appositi registri, generalmente annuali, di entrata e uscita
di cassa, oppure in annotazioni consecutive di partite (creditorie o debitorie) sospese in
appositi registri ausiliari denominati “libri prestanziarum” o “libri debitorum”, partitari
Dare/Avere, annuali o pluriennali, di natura sintetica. Si è già menzionata, a tal riguardo,
la similarità con registri presenti in altre amministrazioni (es. lo Spoglio dei debitori nella
contabilità dello Spedale di S. Maria in Siena nel XV e XVI secolo). Anche i prestiti fatti
da soggetti terzi a vantaggio del signore erano oggetto di tali annotazioni (con entrata di
cassa e corrispondente annotazione nel libro delle prestanze). Un discorso a parte merita i
Bastardelli di cassa, solitamente annuali, ma anche pluriennali, che riportavano
annotazioni di entrata/uscita monetaria di tipo speciale (per la biada comprata e ricevuta, il
vino ricevuto per la corte, ecc.) e riferibili a sedi diverse dalla corte centrale, propedeutici
ai registri generali di entrata ed uscita di cassa della corte. Si tratta, quindi, di registri
ausiliari, a carattere sempre parziale, in quanto dedicati a seguire vicende amministrative
di carattere specifico per contenuto o per sede di riferimento, con regolamento monetario
immediato.
5. Osservazioni conclusive
A conclusione della nostra analisi emerge un interrogativo: le differenze riscontrate tra gli
assetti amministrativi e la documentazione contabile riferita alle corti di Brescia e di Fano, possono
qualificarsi come manifestazione di un’evoluzione delle modalità organizzative e contabili seguite
in una medesima realtà amministrativa (quella della signoria pandolfesca) oppure sono il frutto di
prassi, propensioni e dotazioni organiche di personale diverse?
Tali differenze sinteticamente riguardano:
1) il personale contabile impiegato nell’amministrazione signorile. A Brescia troviamo
professionisti di lunga esperienza e di rilevanza nazionale, mentre a Fano prevalgono
figure di provenienza prevalentemente marchigiana;
2) le caratteristiche del sistema contabile impiegato. Quello bresciano appare sicuramente
di struttura più complessa e meglio organizzata (a giudicare anche dagli innumerevoli e
variegati richiami presenti nei registri), mentre la contabilità fanese risulta meno
specializzata e rigorosa, modellata su schemi più semplici a livello delle serie di registri.
Inoltre, come rimarcato da Anna Falcioni, il sistema contabile costruito a Fano appare
avere anche una minor consapevolezza della gestione archivistica, evidenziata dalla quasi
47
totale assenza di segnature originarie e dalla scarsa attenzione per la serialità dei registri,
resa invece più manifesta nei registri bresciani dall’uso del colore delle coperte, oltre che
dalle segnature. Infine, le registrazioni contabili fanesi presentano anche diverse lacune e
scarsa sistematicità. Anche il cambio nella titolarità della depositeria di Fano, avvenuto
nel 1416, quando Tommaso da Montefano subentra ai fratelli Bettini (il tesoriere Andrea e
i due fratelli collaboratori Bernardo e Lorenzo), non apporta sostanziali cambiamenti, se
non un’apparente maggiore rigorosità nella tenuta dei registri di entrata e uscita (come
segnalato retro da Anna Falcioni con riferimento alla serie dei libri giornale dal registro
29 al 32);
3) l’uso della lingua latina. A Brescia la lingua latina è utilizzata in modo più esteso: tutti i
libri contabili di livello più elevato (prima e seconda sottoserie contabile), oltre a una parte
dei libri giornale e ai libri delle pene e delle taglie, sono scritti in latino. A Fano, i libri
contabili sono quasi tutti scritti in volgare (fanno eccezione solo alcuni libri giornale e
alcuni libri di contabilità speciale).
Queste differenze fanno propendere maggiormente per la seconda risposta al nostro
interrogativo. Le due sedi di Fano e di Brescia, in parte coeve (per il periodo 1404-1421), si
contraddistinguono, infatti, assai diversamente per prassi, caratteri organizzativi, apparato
amministrativo, qualità del personale impiegato93
.
E’ possibile, tuttavia, rintracciare nelle esperienze amministrativo-contabili proprie di Brescia
e di Fano alcuni elementi che ci aiutano ad evidenziare segnali di un percorso evolutivo che ne
contraddistinguono lo sviluppo.
In primis, a Brescia si evidenziano alcuni cambiamenti seguiti al passaggio da figura
straordinaria a titolare a tutti gli effetti della carica di tesoriere di Gioacchino Malagonella da
Firenze, a partire dal 1411 e fino al termine della signoria. G. Bonfiglio-Dosio (2000, p. 75) osserva
che tale passaggio pare aver prodotto “una ricaduta sulla tipologia documentaria e sui percorsi
formativi delle scritture contabili fanesi”. In particolare, i libri contabili del secondo decennio
presentano “titolazioni tramite indicazione del colore della coperta”, rispetto alla “titolazione dei
pezzi tramite segnatura con lettera alfabetica” diffusa negli anni precedenti. Poi, soprattutto, “il
rapporto tra libro giornale e mastro diventa più chiaro e lineare, allineato in sostanza con le
consuetudini mercantili correnti”. Non è possibile dire altrettanto con riferimento, invece, al cambio
di titolarità nella tesoreria di Fano nel 1416 (tranne il giudizio sopra ricordato di apparente
maggiore rigorosità nella tenuta dei registri dopo questa data), a motivo dell’incompletezza che
caratterizza le principali sottoserie del libri contabili della tesoreria stessa.
Inoltre, un’ipotesi di possibile sviluppo evolutivo emerge considerando la presenza o meno
della distinzione per tipologia (o categoria) di entrate o di spese nei libri mastri tabulari annuali o
pluriennali di Brescia e di Fano.
A Brescia, i libri dei conti della corte signorile superstiti (registri n. 43 e n. 58), riferiti a
periodi differenti (rispettivamente, 1407-1409 e 1415-1416), hanno un modo diverso di organizzare
i conti accesi ai debitori/creditori: il registro n. 43 riferisce le registrazioni ai singoli soggetti senza
raggrupparli in categorie; il registro n. 58 raggruppa le partite per categorie di soggetti ai quali le
stesse sono imputate (con tanto di indice). Se consideriamo, invece, i mastri della seconda sottoserie
contabile, detti “delle prestanze” (registri n. 42 e 57), riferiti anch’essi a periodi diversi
(rispettivamente, 1406-1409 e 1415-1420) non risultano differenze di organizzazione delle partite:
93
Differenze rilevanti non si riscontrano, invece, per quanto riguarda la vivacità culturale delle due sedi. Come
evidenzia A. Falcioni, “Pandolfo III Malatesti, un signore condottiero del Tre-Quattrocento”, in M. Ciambotti, A.
Falcioni (a cura di), op. cit., pp. 38-59, la raffinata corte signorile bresciana divenne un vero e proprio “centro
propulsore delle arti”, apportando una ventata di rinnovamento simile a quella in essere presso la corte di Fano. Ciò è
sicuramente testimoniato dai contenuti della fitta serie di inventari, libri contabili e capitoli di spese riferiti alla sede di
Brescia, che mettono in luce la permanenza di importanti artisti, gli investimenti in diversi lavori di restauro,
ricostruzioni e abbellimento della città e del palazzo signorile, gli acquisti di ricchi arredi, oggetti, libri e vestiari, la
presenza di una zecca, ecc.
48
non ci sono, infatti, distinzioni per categorie di soggetti o per materie. Così è anche per i registri
analitici annuali (terza sottoserie).
Per quanto riguarda Fano, invece, si osserva una prevalente impostazione delle registrazioni
contabili per tipologia o categorie di riferimento. Ad eccezione dei due registri tabulari pluriennali
sintetici e riassuntivi (nn. 22 e 23), gli altri libri contabili della seconda e terza sottoserie,
appartenenti ad un arco temporale assai ampio (dal 1392 al 1426), presentano le registrazioni delle
entrate e delle spese organizzate per categoria, senza sostanziali differenze da periodo a periodo e a
prescindere dall’uso delle sezioni contrapposte in due colonne a tutta pagina Dare/Avere94
. L’unico
elemento di perplessità riguarda la serie superstite dei libri giornali che inizia proprio con il 1417
(primo anno dopo il cambio di titolarità della tesoreria signorile) e che si caratterizza per le
registrazioni in ordine cronologico, in successione mensile, a tutta pagina e senza uso di sezioni
contrapposte Dare/Avere. La perplessità si riferisce al fatto che non risultano, come nella sede
bresciana, libri giornali superstiti anteriori (attestati dai numerosi rinvii contenuti nei mastri
partitari) e all’ipotesi già avanzata retro par. 3.2 che la serie dei libri giornali potesse essere una
continuazione, in forma differente, dei registri analitici di entrata o di spesa che danno corpo alla
terza sottoserie. Non ci sono, in effetti, indizi tali da poter suffragare questa ipotesi.
La compresenza nei libri mastri partitari fanesi di registrazioni contabili ordinate per tipologia
di entrata e/o di spesa (o per località) e dell’uso delle sezioni contrapposte Dare/Avere in una stessa
pagina caratterizza unicamente alcuni registri: quelli della seconda sottoserie contabile (nn. 21 e 33)
e alcuni registri di contabilità preparatoria o di rendicontazione anche periferica (nn. 20, 27, 72A),
tutti successivi al 1406. Se si pensa che, nell’ambito della terza sottoserie contabile, fino al 1405
non si utilizza il sistema Dare/Avere, che invece caratterizza il registro n. 19 appartenente alla
stessa serie e riferito al periodo 1409-1410, si può forse avanzare l’ipotesi dell’acquisizione nel
tempo di una maggiore consapevolezza nell’utilizzo della partita doppia, per lo meno in quelle
registrazioni contabili ordinate per categorie.
I dubbi e i punti interrogativi sollevati in queste osservazioni conclusive ci riportano
all’auspicio con cui si concludeva il lavoro sul registro n. 43 della serie malatestiana bresciana95
e
che possiamo estendere a tutta la serie di registri contabili conservati nella sezione di Fano
dell’Archivio di Stato: che possano essere condotti ulteriori lavori di trascrizione e di studio di altri
libri contabili, nelle varie tipologie individuate, in modo da ampliare le conoscenze circa i loro
contenuti formali e sostanziali e le relazioni tra loro intercorrenti.
94
Anche per ciò che concerne l’inventario di registrazioni contabili contenuto nel registro n. 9, non emergono
elementi indicativi di una evoluzione della tecnica contabile nell’arco temporale interessato (dal 1397 al 1408/1409). 95
Cfr. M. Ciambotti, “Il sistema dei registri contabili della cancelleria di Pandolfo III. Il Liber viridis rationum
curie domini (1407-1409)”, in M. Ciambotti, A. Falcioni, op. cit., p. 173.