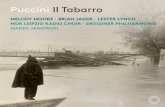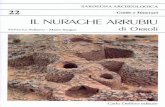Mακεδονικὴ Δυναστεία καὶ Mεγαλοκομνηνοί. Σχόλια σχετικὰ με τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα στὰ "Θαύματα τοῦ
2006-Il titolo divino ὁ ἦν καὶ ὁ ὢν καὶ ὁ ἐρχόμενος nell’Apocalisse....
Transcript of 2006-Il titolo divino ὁ ἦν καὶ ὁ ὢν καὶ ὁ ἐρχόμενος nell’Apocalisse....
IL TITOLO DIVINO oJ w·n kai« oJ h™n kai« oJ e˙rco/menoß NELL’APOCALISSE
Forma, origine e conseguenze per il sistema verbale
A. Niccacci
Il titolo che l’Apocalisse attribuisce a Dio Padre richiama l’attenzione per la sua forma grammaticale (§ 1) e per la sua origine e significato (§ 2). Mi sembra inoltre che la sua struttura temporale possa fornire una chiave inter-pretativa per comprendere un po’ meglio il sistema verbale dell’Apocalisse notoriamente problematico (§ 3)1.
È per me un piacere presentare questo piccolo contributo in onore di p. Lino Cignelli che fu uno dei professori che hanno influito sull’orienta-mento della mia vita, in particolare per quanto riguarda l’interesse per il greco biblico2.
1. Forma grammaticale
Il titolo, sempre riferito a Dio Padre, compare in forma triplice in 1,4.8 (presente - passato - futuro: oJ w]n kai; oJ h\n kai; oJ ejrcovmeno") e 4,8 (passato
1 Non intendo fornire una bibliografia completa dell’argomento. Dopo la prima citazione, i commentari utilizzati saranno indicati con il solo nome dell’autore e, dove necessario, del volume: R.H. Charles, A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John, with In-troduction, Notes and Indices, also the Greek Text and English Translation, vol. I-II, Edinburgh 1920; E.B. Allo, Saint Jean. L’Apocalypse, 2 ed., Paris 1921; H.B. Swete, The Apocalypse of St. John. The Greek Text with Introduction, Notes and Indices, London 1922; D.E. Aune, Revelation 1-5, Dallas 1997; Revelation 6-16, Nashville 1998; Revelation 17-22, Nashville 1998; P. Prigent, L’Apocalypse de Saint Jean. Édition revue et augmentée, Genève 2000.2 Tra i confratelli che sono stati importanti per la mia formazione mi piace ricordare anche il compianto p. Angelo Lancellotti, che mi spinse a realizzare il primo lavoro esegetico, Il Vangelo oggi: Il Vangelo dello Spirito secondo Giovanni, vol. V, Assisi 1973, e p. Giovanni Boccali che mi insegnò ebraico biblico e Antico Testamento. Conservo anco-ra i quaderni con la traduzione di opere bibliche e patristiche e piccoli studi risalenti alla prima metà degli anni ’60, in particolare l’Orazione per la fuga di S. Gregorio Nazianzeno, l’Apologetica crisostomiana nel Panegirico De S. Babyla, l’Expositio Epistolae ad Galatas di S. Agostino e la Lettera dello Pseudo-Barnaba, lavoretti che feci sotto la guida di p. Cignelli. Non posso dimenticare poi mio zio p. Angelo Niccacci che mi avviò all’amore per la filosofia, in particolare francescana, anche se poi il mio tempo fu preso prevalentemente dalla Bibbia. Conservo ancora piccole ricerche giovanili su Seneca e la salvezza dell’individuo, sul De reductione omnium artium ad theologiam di S. Bonaventura e su Giovanni Duns Scoto.
123456789
10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
A. NICCACCI2
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
- presente - futuro: oJ h\n kai; oJ w]n kai; oJ ejrcovmeno"), in forma duplice in 11,17 e 16,5 (presente - passato: oJ w]n kai; oJ h\n).
Dal punto di vista grammaticale il titolo divino presenta almeno due peculiarità: prima, in un caso l’articolo introduce una forma finita del verbo (oJ h\n), la quale perciò è trattata come forma nominale esattamente come i due participi che l’accompagnano (oJ w[n e oJ ejrcovmeno"); seconda, in 1,4, pur essendo retto dalla preposizione ajpov, il titolo è al nominativo: “(Grazia a voi e pace) da «Il Che-è e il Egli-era e il Che-viene/sta per venire/verrà»”.
Il fatto che il titolo non è declinato suggerisce che sia una formula fissa, usata come nome proprio. Infatti nel NT si trovano nomi propri retti da articolo definito e anche nomi propri che conservano la loro forma indipen-dente al nominativo anche quando sono retti da preposizione3.
Poiché l’autore di Apocalisse passa da una forma triplice a una duplice in modo del tutto naturale, anche se probabilmente non senza collegamento con il contesto (cf. infra, nota 26), sembra che non ci sia motivo sufficiente per affermare, come fanno alcuni, che la forma tradizionale fosse duplice e che egli l’abbia ampliata in base a una tendenza tripartita propria degli scrittori apocalittici4. Effettivamente l’autore di Apocalisse presenta più di una volta una formulazione triplice, accanto però a una inferiore duplice o anche a una superiore5.
3 Per J.H. Moulton - W.F. Howard, A Grammar of New Testament Greek. Vol. II: Accidence and Word-Formation with an Appendix on Semitisms in the New Testament, Edinburgh 1919-1920, 154, il titolo divino “is deliberately left in nom[inative] after ajpov «in order to preserve the im-mutability and absoluteness of the divine name from declension» (Moffat)… A further tour de force makes «the He was» serve as correlative to the present oJ w[n, there being no participle to express the continuous past”. Similmente A.D. Callahan, “The Language of the Apoca-lypse”, HTR 88 (1995) 453-470, nota “the grammatically immutable epithet for the divine name in Rev 1:4 and 1:5 and the slogan about Antipas in Rev 2:13”, e afferma al riguardo: “The epithets of God, of Christ, and of the martyrs have become indeclinable nouns of the seer’s idiolect” (p. 468). Si vedano anche F.M. Abel, Grammaire du Grec Biblique, suivie d’un choix de papyrus, Paris 1927, 42, e J.H. Moulton - N. Turner, A Grammar of New Testament Greek. Vol. III: Syntax, Edinburgh 1963, 230.4 Su questa tendenza basti citare Aune, 30-32.5 Oltre a Ap 1,4.8.9.17; 2,2.3.5; 4,9.11; 8,7; 10,6 e 17,8 citati in Aune, 25, nota 5.a-a, come esempi di formulazione triplice, titoli di personaggi importanti compaiono altrove con un numero diverso di membri. Ad esempio per Gesù compare in 1,5 una formulazione triplice: oJ mavrtu" oJ pistov", oJ prwtovtoko" tw'n nekrw'n kai; oJ a[rcwn tw'n basilevwn th'" gh'" “il Testimone fedele, il Primogenito dei morti e il Principe dei re della terra”; in 1,17-18 una formulazione con un numero maggiore di membri disposti in ordine chiastico (presente - passato - presente): a) ejgwv eijmi oJ prw'to" kai; oJ e[scato" kai; oJ zw'n, b) kai; ejgenovmhn nekro;" kai; ijdou; zw'n eijmi eij" tou;" aijw'na" tw'n aijwvnwn a’) kai; e[cw ta;" klei'" tou' qanavtou kai; tou' a/{dou “a) Io sono il Primo e l’Ultimo e il Vivente. b) E fui morto, a’) ma
IL TITOLO DIVINO oJ w·n kai« oJ h™n kai« oJ e˙rco/menoß NELL’APOCALISSE 3
123456789
10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
È stato notato che il tipo di formula triplice che nomina passato, pre-sente e futuro, simile a quella che compare nel titolo divino di Apocalisse, è ben attestato nel mondo greco-romano in riferimento alla profezia o alla sapienza per indicare la capacità di annunciare o di comprendere gli eventi passati, presenti e futuri, e quindi tutta la realtà, mentre è rara nella lette-ratura giudaica6. La formula triplice è attestata anche nei titoli degli dèi, in modo simile ad Apocalisse, nella letteratura giudeo-ellenistica e anche greca a partire da Omero7.
2. Origine e significato
Si pone dunque il problema dell’origine del titolo divino di Apocalisse, se sia cioè greco-ellenistica o piuttosto biblico-giudaica, con particolare rife-rimento a Es 3,14. Riguardo al mondo greco-ellenistico la situazione è la seguente: mentre il titolo di Apocalisse presenta per il passato una forma finita del verbo, oJ h\n, il participio oJ w[n per il presente e oJ ejrcovmeno" per il futuro, nella tradizione greco-ellenistica e anche giudeo-ellenistica i titoli divini presentano sempre il participio: per il presente oJ w[n “l’esistente”, o
ecco sono vivo per i secoli dei secoli e ho le chiavi della morte e dell’ade”; in 2,8 compare invece una formulazione duplice: oJ prw'to" kai; oJ e[scato", o}" ejgevneto nekro;" kai; e[zhsen “il Primo e l’Ultimo, che fu morto ma ritornò in vita”. Una formula analoga a quella usata per Dio Padre compare, a scopo evidentemente di derisione, per la Bestia in 17,8: To; qhrivon o} ei\de" h\n (= passato) kai; oujk e[stin (= presente negativo) kai; mevllei ajnabaivnein ejk th'" ajbuvssou kai; eij" ajpwvleian uJpavgei (= futuro prossimo + presente) // h\n (= passato) kai; oujk e[stin (= presente negativo) kai; parevstai(= futuro). “La Bestia che hai visto era e non è e sta per salire dall’abisso e va alla rovina // era e non è e sarà presente”; e in 17,11: o} h\n kai; oujk e[stin (= passato + presente) “il quale era e non è”.6 Testi e bibliografia si trovano in Aune, 112-114. In Siracide compare una fraseologia simile riferita a Dio: ajpaggevllwn ta; parelhluqovta kai; ta; ejsovmena / kai; ajpokaluvptwn i[cnh ajpokruvfwn “che annuncia le cose passate e le future / e rivela tracce di quelle nascoste” (Sir 42,19), e anche riferita al profeta Isaia: e{w" tou' aijw'no" uJpevdeixen ta; ejsovmena / kai; ta; ajpovkrufa pri;n h] paragenevsqai aujtav “Sino alla fine manifestò le cose future / e quelle nascoste prima che accadessero” (48,25). Da parte sua A. Hultgård, “«The One Who Was, Who Is and Who Shall Be». An Indo-European Formula of Divine Omnipotence”, OrSuec 51-52 (2002-2003) 199-210, mostra che la formulazione triplice compare nell’am-biente ampio indo-europeo, comprendente non solo la Grecia ma anche l’India, l’Asia e la Scandinavia, un’idea che è sviluppata da M. Philonenko, “Celui cui est, qui étai et qui vient (Apocalypse de Jean 1,4)”, in: Ch. Grappe - J.-C. Ingelaere (edd.), Le Temps et les Temps dans les littératures juives et chrétiennes au tournant de notre ère, Leiden - Boston 2006, 199-207. Con questo però non si può negare l’origine biblica della formula in Apocalisse (cf. infra, § 2).7 Cf. Aune, 30-32, e anche il mio saggio “«Colui che è, che era e che viene»”, in: M. Adinolfi - A. Niccacci (edd.), L’Apocalisse. Seminario interdisciplinare dello Studium Biblicum Franci-scanum (Gerusalemme), Iskenderun, 5-10 febbraio 1996, Modena 1996, 10-12.
A. NICCACCI4
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
anche il neutro to; o[n “l’essere”, per il passato oJ prowvn “colui che è esistito prima”, oppure to; gegonov" “ciò che è stato”, e per il futuro oJ ejsovmeno" “colui che sarà”8.
Da questo confronto emergono due elementi che a mio parere sug-geriscono l’origine biblico-giudaica del titolo di Apocalisse: da un lato, l’utilizzo della forma verbale finita segnala un collegamento con il testo ebraico di Es 3,14 e con la tradizione giudaica legata a questo passo, a differenza dalla traduzione greca dei Settanta del medesimo (§ 2.1); dall’altro, l’utilizzo di oJ ejrcovmeno" per il futuro invece di oJ ejsovmeno" si accorda con il fatto che in ebraico il participio del verbo hyh non è utilizzato (§ 2.2).
2.1. Es 3,14
La risposta di Dio in Es 3,14 è la chiave interpretativa del dialogo con Mosè9. Il punto cruciale è infatti che “il Dio di tuo Padre”, cioè di Mosè (3,6), deve essere riconosciuto e creduto come “il Dio dei vostri Padri”, cioè degli Israeliti (3,13); per realizzare questo Mosè deve presentare agli Israeliti Dio come “il Signore (YHWH) Dio dei vostri Padri” (3,15); e Dio si rivela come “il Signore (YHWH)” per il fatto che “Egli sarà” per gli Israeliti schiavi in Egitto “Colui che era” con i Padri forestieri nella terra di Canaan (3,14)10.
8 Cf. Aune, 31-32.9 Si veda al riguardo il mio articolo “Esodo 3,14a: «Io sarò quello che ero» e un parallelo egiziano”, LA 35 (1985) 7-26. Il senso della rivelazione divina in Es 3,6-15 non è diversa da quella che si trova in Es 6,2-8; al contrario, le due, se ben interpretate, si completano a vicenda, come ho cercato di mostrare in “La separazione di Israele nello spazio e nel tem-po: Gli spostamenti geografici con particolare riferimento ai motivi esodici”, in: C. Termini (ed.), Atti del XIII Congresso di Studi Veterotestamentari (Foligno, 8-10 Settembre 2003), Ricerche Storico Bibliche 17 (2005) 113-134, pp. 123-124, nota 21.10 Questa lettura del brano dovrebbe convincere che 3,14 non è un’interpolazione tar-diva, come sostengono, ad esempio, L. Phillips - A. Phillips, “The Origin of «I Am» in Exodus 3.14”, JSOT 78 (1998) 81-84, e H. Irsigler, “Von der Namensfrage zum Gotte-sverständnis. Exodus 3,13-15 im Kontext der Glaubensgeschichte Israels”, BN 96 (1999) 56-89. Riguardo a questi autori osserverei anche che l’espressione MRkDl h‰yVhRa aøl di Os 1,9 significa semplicemente “non sarò vostro”, parallelo a “voi non siete mio popolo”, e ha ben poco a che fare con Es 3,14. Inoltre la risposta di Dio in Es 3,14a non può essere intesa alla stregua delle espressioni idem per idem, come propongono G.S. Ogden, “Idem per Idem: Its Use and Meaning”, JSOT 53 (1992) 107-120, e C.G. Den Hertog, “The Prophetic Dimension of the Divine Name: On Exodus 3.14a and Its Context”, CBQ 64 (2002) 213-228.
IL TITOLO DIVINO oJ w·n kai« oJ h™n kai« oJ e˙rco/menoß NELL’APOCALISSE 5
123456789
10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
La dinamica del dialogo può essere rappresentata nel modo seguente:
ES 3: MISSIONE DI MOSÈ YHWH IL DIO DEI PADRI
(3,6) (Dio dice a Mosè) ÔKyIbDa yEhølTa yIkOnDa “Io sono IL DIO DI TUO PADRE
bOqSoÅy yEhølaw qDjVxˆy yEhølTa MDh∂rVbAa yEhølTaIL DIO DI ABRAMO, IL DIO DI ISACCO E IL DIO DI GIACOBBE”.
(3,10) “E perciò va hDkVl hD;tAo◊w hOo√rAÚp_lRa ÔKSjDlVvRa◊w perché voglio mandarti dal faraone!(3,13) (Mosè dirà agli Israeliti) MRkyElSa yˆnAjDlVv mi ha mandato a voi”.
MRkyEtwøbSa yEhølTa “IL DIO DEI VOSTRI PADRI
(Israeliti a Mosè) wømVÚv_hAm “Qual è il suo nome?”.(3,14) (Dio a Mosè) h‰yVhRa rRvSa h‰yVhRa “EGLI SARÀ COLUI CHE ERA”.
(Mosè dirà agli Israeliti – parla Dio) MRkyElSa yˆnAjDlVv mi ha mandato a voi”
h‰yVhRa “EGLI-SARÀ
(3,15) (Idem) MRkyElSa yˆnAjDlVv mi ha mandato a voi.
MRkyEtObSa yEhølTa hÎwh◊y “YHWH DIO DEI VOSTRI PADRI
bOqSoÅy yEhølaw qDjVxy yEhølTa MDh∂rVbAa yEhølTaIL DIO DI ABRAMO, IL DIO DI ISACCO E IL DIO DI GIACOBBE”.
MDlOoVl yImVÚv_h‰zrO;d rOdVl yîrVkz h‰z◊w
Questo è il mio nome in eterno,
questo è il mio ricordo di generazione in generazione”.
Il Dio dell’esodo si rivela identico al Dio dei Patriarchi mediante un gioco di parole sul suo nome personale YHWH sulla base del verbo hyh “essere”. Così il Nome del Signore diventa significativo per la situazione del popolo in Egitto, in quanto lo rende capace di riscoprire la propria identità e il legame con i Padri e con le promesse fatte a loro.
Chiaramente il verbo hyh “essere” non è inteso qui, né altrove nella Bibbia ebraica, in senso ontologico, come esistenza per se stessa, ma come “essere” con, accanto a qualcuno per aiutarlo. Dio non intende affermare che egli è l’Ente per eccellenza ma piuttosto che, come dice lui stesso a
A. NICCACCI6
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
Mosè: “Ho visto bene l’afflizione del mio popolo che è in Egitto e il loro grido ho udito a causa dei loro oppressori, poiché ho conosciuto le loro pene. E perciò sono sceso per liberarlo dalla mano dell’Egitto e farlo salire da quella terra…” (3,7-8; cf. 2,24-25).
Inoltre la risposta di Dio h‰yVhRa rRvSa h‰yVhRa non può essere tradotta al presente; infatti per un’affermazione al presente sarebbe utilizzata una pro-posizione senza verbo del tipo hÎwh◊y yˆnSa “Io sono YHWH/il Signore” (Gen 15,7, ecc.)11. D’altra parte, lo yiqtol è utilizzato in ebraico per esprimere il futuro quando è legato all’asse del futuro e per esprimere abitudine, ri-petizione o descrizione quando è legato all’asse del passato, nel qual caso equivale all’imperfetto. Ora, il contesto di Es 3,14 e la dinamica del dialogo suggeriscono, come indicato sopra, che il primo h‰yVhRa sia legato all’asse del futuro; inoltre, essendo uno yiqtol che occupa la prima posizione nella frase, ha valore volitivo (“Io sarò”, nel senso di: “Io prometto di essere”, “mi im-pegno ad essere” con gli Israeliti in Egitto), mentre il secondo h‰yVhRa è legato all’asse del passato (“Colui che ero” con i Padri nella Terra di Canaan)12.
In rapporto al titolo divino che stiamo studiando è necessario osservare il modo come la LXX rende il TM di 3,14:
(a) h‰yVhRa rRvSa h‰yVhRa ejgwv eijmi oJ w[n(b) MRkyElSa yˆnAjDlVv h‰yVhRa oJ w]n ajpevstalkevn me pro;" uJma'".
In tutti e tre i casi la LXX rende h‰yVhRa con una forma di presente; nel secondo e terzo caso lo rende con un participio presente con articolo sia quando è retto dalla particella rRvSa (a) che quando sta da solo (b). Così la LXX, da un lato annulla la dinamica temporale delle forme verbali, dall’al-tro interpreta la frase in un senso ontologico che è normale per la mentalità greca ma che è estraneo a quella semitica.
Diversamente i Targumim interpretano Es 3,14 in senso dinamico, espli-citando per lo più due dimensioni temporali, passato e presente, in rapporto alla creazione e alla liberazione dall’Egitto. La formulazione più vicina a quella triplice di Apocalisse si legge nel Targum dello Pseudo-Jonathan di
11 Per un’affermazione al presente l’ebraico utilizza una proposizione nominale con parti-cipio. Il verbo hyh non compare per indicare il presente per il motivo che il participio di questo verbo non è usato (cf. infra, § 2.2 e nota 19). Il verbo hyh compare invece quando si vuole indicare il passato e il futuro; cf. il mio articolo “Sullo stato sintattico del verbo Häyâ”, LA 40 (1990) 9-23, in particolare il § 3.12 Si vedano al riguardo il mio articolo “A Neglected Point of Hebrew Syntax: Yiqtol and Position in the Sentence”, LA 37 (1987) 7-19, e la mia recensione di W. Groß - H. Irsigler - T. Seidl (edd.), Text, Methode und Grammatik. Wolfgang Richter zum 65. Geburtstag, St. Ottilien 1991, in LA 44 (1994) 667-692, pp. 669-670.
IL TITOLO DIVINO oJ w·n kai« oJ h™n kai« oJ e˙rco/menoß NELL’APOCALISSE 7
123456789
10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
Dt 32,39 che, verso la fine del cantico di Mosè, echeggia Es 3,14 mediante una formulazione a tre dimensioni temporali, presente, passato e futuro: ywhml dytod awh anaw tywhw yywhd awh ana “Io sono Colui che è e che fu e io sono Colui che sarà”13.
Da parte sua, il Midrash Rabba elenca sei diverse interpretazioni di Es 3,14, la seconda delle quali è la più vicina alla formulazione tripli-ce del titolo di Apocalisse: awøbDl dyItDoRl a…wh yˆnSaÅw ,wDvVkAo a…wh yˆnSaÅw ,yIty◊ˆyhRv yˆnSa MyImDoVÚp vølDv «h‰yVhRa» b…wtD;k JKDkVl “Io sono Colui che fu e io sono ora e io sono Colui che verrà. Per questo h‰yVhRa è scritto tre volte”. Ancora più perti-nente, in quanto evidenzia bene il collegamento con i Patriarchi nel sen-so che ho proposto sopra, è l’interpretazione del Midrash Haggadol: Kmo hyha Kk bqoyw qjxy Mhrba Mo ytyyhv Mvk “Come fui con Abramo, Isac-co e Giacobbe sarò con te”14.
Risulta perciò che l’Apocalisse ha desunto il titolo divino – come in generale il suo linguaggio, immagini e concezioni – dall’AT, in particolare da Es 3,14 e dalle interpretazioni che ne sono derivate in ambiente giudai-co e cristiano primitivo, forse specialmente liturgico15. Da questo ambiente deriva la formulazione duplice e triplice del titolo divino di Apocalisse, compresa la parte con la forma verbale finita, oJ h\n, che rispecchia l’uso del verbo finito h‰yVhRa con funzione nominale16.
13 Un’analisi dei testi targumici si trova in M. McNamara, The New Testament and the Palestin-ian Targum to the Pentateuch, Roma 1966, 97-112.14 Ho esaminato questi e altri testi in “Esodo 3,14a: «Io sarò quello che ero» e un parallelo egiziano”, 19-25.15 Dato che la datazione della letteratura giudaica è discussa, Aune, 33 ha forse ragione di affermare, diversamente da McNamara, che una derivazione diretta del titolo di Apocalisse dai Targumim sia poco convincente, e che la fonte di entrambi sia piuttosto da ricercare nella tradizione liturgica del I sec., cosa del resto che anche McNamara, The New Testament and the Palestinian Targum to the Pentateuch, 112, ipotizzava come possibile alternativa. Ad ogni modo, più che di derivazione diretta o indiretta sarà meglio parlare di sviluppi analoghi provenienti dallo stesso ambiente di fede e di cultura.16 In Es 3,14 il terzo h‰yVhRa è usato come soggetto del verbo: MRkyElSa yˆnAjDlVv h‰yVhRa “Io-sarò mi ha mandato a voi”. Tra i pochi autori che notano questo fatto ricordo C.G. Ozanne, “The Language of the Apocalypse”, TynBul 16 (1965) 3-9, il quale a proposito di 1,4 scrive: “It is instructive to notice that in Exodus 3: 14, to which our text alludes and on which it elaborates, the Hebrew verb ’ehyeh ‘I AM’ is constructed as an indeclinable appellative in subject relationship to åelä˙anî, ‘hath sent me’. Though not strictly a Hebraism, this scruple in the Apocalypse against inflecting the divine name is typical of a Jewish writer, to whom the Tetragrammaton was too sacred to be uttered, let alone inflected” (p. 7). D’altra parte, l’AT presenta diversi nomi propri formati con yiqtol o con qatal, sempre però senza articolo (cf. H. Ewald, Ausführliches Lehrbuch der Hebräischen Sprache des Alten Bundes, 8 ed., Göttingen 1870, § 273). Nomi o titoli formati con forme finite del verbo, usate quindi con funzione nominale, sono attestati anche in antico egiziano, come ho mostrato nell’articolo “Sul detto 76 dei ‘Sarcofagi’ (CT II 1-17)”, LA 28 (1978) 5-23.
A. NICCACCI8
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
Dall’ambiente giudaico derivano anche le formazioni con articolo e participio oJ w[n e oJ ejrcovmeno". Non credo che esse restino non declinate perché l’articolo rappresenta la particella relativa d 17, ma piuttosto perché esse vengono trattate come nomi propri (cf. supra, § 1, nota 3).
Non direi però che l’ambiente ellenistico e giudeo-ellenistico non ha influito sul titolo divino di Apocalisse, in particolare sulla parte del presente oJ w[n, che compare nella traduzione della LXX ed era titolo corrente di Dio in quell’ambiente (cf. supra, § 2). Un influsso ellenistico si manifesta anche nel cambio di prospettiva: da esistenza di Dio di tipo dinamico-relazionale (“essere” con) in Es 3,14, a esistenza di tipo ontologico in Apocalisse18.
2.2. “Colui che viene”
A differenza delle prime due, la terza parte del titolo di Apocalisse, oJ ejrcovmeno", che designa il futuro prossimo, non deriva dall’ambiente el-lenistico, che usa a questo scopo oJ ejsovmeno" (cf. supra, § 2), né da quello giudaico, che usa anch’esso una voce del verbo “essere”, non del verbo “venire” (cf. supra, § 2.1, note 6 e 13).
La scelta di oJ ejrcovmeno" è significativa per vari motivi. Anzitutto essa concorda con il fatto che in ebraico il participio del verbo hyh è pratica-mente non utilizzato19, mentre si differenzia, almeno in parte, dall’uso del-
17 Secondo McNamara, The New Testament and the Palestinian Targum to the Pentateuch, “the relative particle d + ywh the participle… is… the exact equivalent of oJ w[n. tywh… with the relative particle d… is the exact equivalent of oJ h\n. ywhml dyto would correspond to ejsovmeno" rather than to ejrcovmeno"” (p. 111). In verità le grammatiche portano esempi, anche nel greco classico, di oJ usato come pronome (cf. ad esempio A.T. Robertson, A Gram-mar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research, New York 1919, 734-735), ma allora avremmo allora nel titolo di Apocalisse un pronome coordinato a due articoli.18 Titoli simili a quelli di Apocalisse si trovano anche nell’Egitto ellenistico. Ad esempio, alla dea Iside intesa come personificazione della natura nel suo significato più profondo, i cui segreti nessun mortale riesce a svelare, si attribuiva la seguente affermazione: ejgwv eijmi pa'n to; gegono;" kai; o]n kai; ejsovmenon kai; to;n ejmo;n pevplon oujdeiv" pw qnhto;" ajpakavluyen “I am all that has been, and is, and shall be, and my robe no mortal has yet uncovered” (Plutarchus, Moralia V (351 C-438 E), vol. V, repr. London 1962, 24/25). Nella casa natale di Beethoven a Bonn è esposta la foto di un foglietto manoscritto che il grande musicista teneva sul suo tavolo di lavoro, nel quale aveva ricopiato tre frasi del tipo appena citato: “Ich bin, was ist” / “Ich bin alles, was ist, war und seyn wird, Kein sterblicher Mensch hat meinen Schleyer aufgehoben” / “Er ist einzig von ihm selbst, u. diesem Einzigen sind alle Dingen ihr Daseyn schuldig”. Erano frasi molto popolari negli ambienti intellettuali del tempo, influenzati dai frammassoni e dagli illuminati che basavano la loro religiosità naturale sulla speculazione egiziana e pensavano che anche Mosè avesse desunto la concezione di Dio (Es 3,14) dalla sua formazione egiziana. Su questo argomento si può consultare J. Assmann, Moses der Ägypter. Entzifferung einer Gedächtnisspur, Darmstadt 1998, 173-210.19 Compare solo in Es 9,3: ÔK◊nVqImV;b hÎywøh hÎwh◊y_dÅy h´…nIh – ijdou; cei;r kurivou ejpevstai ejn toi'"
IL TITOLO DIVINO oJ w·n kai« oJ h™n kai« oJ e˙rco/menoß NELL’APOCALISSE 9
123456789
10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
l’AT greco, in cui il participio ejsovmeno" è attestato undici volte20. Inoltre oJ ejrcovmeno" riflette la tensione escatologica di Apocalisse verso il ritorno del Figlio dell’Uomo sulle nubi del cielo secondo l’annuncio dei profeti21. Come scrive Charles,
“it is clear that he [i.e. l’autore di Apocalisse ] uses ejrcovmeno", instead of ejsovmeno", with a definite reference to the contents of the Book and especially to the coming of Christ, i. 7, ii. 5, 16, iii. 11, xxii. 7, 12, etc., in whose coming God Himself comes also”22.
In effetti, mentre le prime due parti del titolo divino di Apocalisse, oJ w[n e oJ h\n, sono dette solo di Dio Padre, oJ ejrcovmeno" è detto di Gesù. Perciò oJ ejrcovmeno" è importante non solo perché completa la dimensione tem-porale triplice (presente, passato e futuro), ma anche perché rappresenta la parte del titolo che accomuna Gesù al Padre23.
A ciò si aggiunge il fatto che oJ ejrcovmeno" è il titolo messianico che tutti e quattro gli Evangelisti attribuiscono a Gesù in occasione del suo ingresso a Gerusalemme (Mt 21,9; 23,39; Mc 11,9; Lc 13,35; 19,38; Gv 12,13) ri-prendendo l’acclamazione di Sal 118/117,26. Ma è soprattutto il Vangelo di Giovanni che approfondisce il senso del titolo oJ ejrcovmeno" mediante le parole di Gesù stesso a Nicodemo: ÔO a[nwqen ejrcovmeno" ejpavnw pavntwn ejstivn: … oJ ejk tou' oujranou' ejrcovmeno" ejpavnw pavntwn ejstivn “Colui che viene dall’alto è sopra di tutti … Colui che viene dal cielo è sopra di tutti” (Gv 3,31); e anche nella confessione di Marta: su; ei\ oJ cristo;" oJ uiJo;" tou' qeou' oJ eij" to;n kovsmon ejrcovmeno" “Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che viene nel mondo” (11,27)24. Nota giustamente Massingberd Ford25:
kthvnesivn sou “Ecco la mano del Signore sta per posarsi sul tuo bestiame”. In Qo 2,22 e in Ne 6,6 compare il participio della radice simile hwh.
20 Nel NT ejsovmeno" compare una volta (Lc 22,49).21 Ap 1,7 collega insieme le profezie di Dn 7,13 e di Zc 12,10, come avviene in Mt 24,30; 26,64; Mc 13,26; 14,62; cf. Charles, I, 17-18; Aune, 52-56.22 Charles, I, 10.23 Viceversa, parti del titolo triplice to; a[lfa kai; to; w\, oJ prw'to" kai; oJ e[scato", hJ ajrch; kai; to; tevlo" che compare in 22,13 riferito a Gesù, sono attribuite al Padre in 1,8 (to; a[lfa kai; to; w °) e in 21,6 (to; a[lfa kai; to; w\, hJ ajrch; kai; to; tevlo").24 L’esclamazione della gente che ha visto il segno della moltiplicazione dei pani in Gv 6,14, ou|tov" ejstin ajlhqw'" oJ profhvth" oJ ejrcovmeno" eij" to;n kovsmon “Questi è veramente il Profeta che deve venire/viene nel mondo!”, collega due titoli messianici: oJ profhvth", inteso probabilmente come il nuovo Mosè promesso in Dt 18,15-18, dato che la gente ricorda il miracolo della manna, e oJ ejrcovmeno"; cf. il mio commento in Il Vangelo oggi, V, 71.25 J. Massingberd Ford, “«He That Cometh» and the Divine Name (Apocalypse 1, 4. 8; 4, 8)”, JSJ 1 (1970) 144-147, p. 146.
A. NICCACCI10
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
“I suggest, therefore, that, against this Johannine background, we are to understand the presence of oJ ejrcovmeno" in the divine Name in the Apocalypse; it is not merely an accommodation of Exodus 3, 14 and Deu-teronomy 32, 39 but a bold assertion of the divinity of «He That Cometh» by joining (oJ ejrcovmeno") his title to the divine Name”.
Per cui – tornando alla formulazione del titolo divino di Apocalisse, tri-plice in 1,4.8 e in 4,8, duplice in 11,17 e 16,5 – direi che non esiste differenza notevole tra le due, anche se la formulazione triplice include esplicitamente il Cristo, mentre quella duplice si riferisce direttamente a Dio Padre26. Se poi, come credo, “i sette Spiriti” che sono davanti al trono di Dio si identificano con “lo Spirito” Santo, allora il saluto di 1,4 è trinitario27.
Il titolo triplice di Apocalisse è perciò la designazione più completa di Dio in quanto, da un lato, riprendendo Es 3,14 e sulla linea della tradizione giudaica, collega il Dio dei Padri con il Dio dell’Esodo; dall’altro, aggiun-gendo l’elemento della venuta escatologica, collega il Dio dell’AT con il Dio del NT che mediante Gesù Cristo porta a compimento la storia della salvezza sino alla fine dei tempi.
3. Conseguenze per il sistema verbale dell’Apocalisse
Possiamo affermare che la formulazione triplice del titolo divino di Apo-calisse utilizza i tre assi temporali che descrivono lo sviluppo della storia – presente, passato e futuro – allo scopo di descrivere in termini umani l’essere e l’agire di Dio. È un tentativo di delineare il tempo di Dio con i parametri del tempo degli uomini. In qualche modo il Veggente viene reso partecipe del tempo, dello spazio e del mondo di Dio pur restando nel tem-po, nello spazio e nel mondo degli uomini28. Questo fatto si ripercuote nel
26 Secondo Massingberd Ford, “«He That Cometh»”, 146-147, la formulazione triplice compare in passi legati alla figura del Figlio dell’Uomo (e/o dell’Agnello e della “Radice di David”), mentre quella duplice compare in 11,17 e 16,6, dove non c’è riferimento al Figlio dell’Uomo.27 Così Allo, 6.8-9, e anche il mio saggio “«Lo Spirito e la Sposa dicono: Vieni!»”, in: Adi-nolfi - Niccacci (edd.), L’Apocalisse, 26-29. Di opinione diversa sono, tra gli altri, Charles, I, 11-13 e Aune, 33-35.28 L’episodio della Donna e del Drago (Ap 12) presenta problemi di luogo (spostamenti cie-lo-terra) piuttosto che di tempo. La scena si apre con la Donna gloriosa in cielo che incinta gridava, mentre il Drago stava davanti a lei per divorare il figlio; la Donna partorì un figlio maschio che fu portato presso Dio, mentre la Donna fuggì nel deserto – e dunque qui la Donna scende in terra – per esservi nutrita per 1260 giorni. Poi la scena si interrompe per raccontare la guerra in cielo: Michele e i suoi angeli gettarono il Drago e i suoi angeli dal
IL TITOLO DIVINO oJ w·n kai« oJ h™n kai« oJ e˙rco/menoß NELL’APOCALISSE 11
123456789
10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
suo scritto, nel senso che il tempo e lo spazio delle visioni che egli racconta sembrano delinearsi in modo alternante secondo la forma divina e secondo quella umana, e questa alternanza si riflette nella lingua utilizzata, in par-ticolare nel sistema verbale. Credo che su questa base si può comprendere la prospettiva dello scritto e le strutture linguistiche in esso utilizzate in modo migliore che non sulla base di altre ipotesi che sono state avanzate (cf. infra, § 3.3).
3.1. Ap 7,14-17; Ap 4
Per introdurci in argomento consideriamo la descrizione che uno dei Ve-gliardi fa al Veggente della “folla grande che nessuno poteva contare” (7,9)29 in 7,14-17. La descrizione utilizza prima il passato (a), poi il presente (b), quindi il futuro (c)30:
(a) ou|toiv eijsin oiJ ejrcovmenoi ejk th'" qlivyew" th'" megavlh" kai; e[plunan ta;" stola;" aujtw'n kai; ejleuvkanan aujta;" ejn tw/' ai{mati tou' ajrnivou “Questi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno rese bianche nel sangue dell’Agnello”
(b) dia; tou'tov eijsin ejnwvpion tou' qrovnou tou' qeou' kai; latreuvousin aujtw/' hJmevra" kai; nukto;" ejn tw/' naw/' aujtou' – Per questo sono davanti al trono di Dio e rendono culto a lui giorno e notte nel suo santuario
cielo sulla terra (12,7-12). Il racconto riprende con il Drago che inseguì la Donna, la quale con ali di aquila era fuggita nel deserto e lì veniva nutrita; il serpente vomitò un fiume per travolgerla ma la terra lo inghiottì; allora il serpente si adirò e fece guerra “contro i restanti della stirpe di lei che osservano i comandi di Dio e hanno la testimonianza di Gesù, e stette sulla riva del mare” (12,13-18). Come intendere allora la visione iniziale della Donna glorio-sa in cielo? Sembra l’icona conclusiva di tutta la vicenda, cioè la glorificazione della Donna Madre. E tuttavia l’icona iniziale gloriosa resta legata alla storia successiva di persecuzione, senza dubbio perché la passione di Cristo continua nella vita della Chiesa. Direi perciò che tra le diverse interpretazioni che sono state proposte di questo episodio fortemente evocativo (cf. Allo, 167-179, Aune, 667-674.712, e il mio articolo “La grande prostituta e la sposa dell’Agnello”, in: L. Padovese [ed.], VI Simposio di Efeso su S. Giovanni Apostolo, Roma 1996, 137-154, pp. 139-141) non si può escludere quella che ritiene che la Donna Madre sia in-sieme Maria e la Chiesa lungo i secoli. Ricordiamo che la figura di Maria Donna e Madre come la nuova Eva è attestata in due episodi del Vangelo di Giovanni che si richiamano a vicenda, alle nozze di Cana e sotto la Croce; cf. il mio articolo “Maria nel Vangelo secondo Giovanni”, in: G. Lauriola (ed.), Da Cristo a Maria, Alberobello (BA) 2005, 109-120.29 Il carattere semitico dell’originale, o}n ajriqmh'sai aujto;n oujdei;" ejduvnato, con uso pleo-nastico di aujtov" dopo il pronome relativo, è ben descritto in L. Cignelli - R. Pierri, Sintassi de greco biblico (Lxx e NT). Quaderno I.A: Le concordanze, Jerusalem 2003, 57. 30 Cf. E. Bosetti, “L’Agnello Pastore in 1Pietro e Apocalisse. Quando la liturgia interpella la vita”, in: E. Bosetti - A. Colacrai (edd.), Apokalypsis. Percorsi nell’Apocalisse in onore di Ugo Vanni, Assisi 2005, 277-307, p. 301.
A. NICCACCI12
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
(c) kai; oJ kaqhvmeno" ejpi; tou' qrovnou skhnwvsei ejp∆ aujtouv"… – e Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro…” (7,14-15).
In questo testo il passaggio dal passato al presente è comprensibile, in quanto esprime due informazioni successive; ma come spiegare il passaggio al futuro? Forse che Dio non stende già ora la sua tenda su di loro? Si può confrontare un passo parallelo in cui si descrive la Gerusalemme nuova, cioè quella che sarà il risultato della fusione del modello celeste della Città disceso dal cielo con la città terrena, fusione che rinnova la realtà della Città Santa e la porta a compimento31. Si noterà che il culto descritto come presente in 7,15 è descritto come futuro in 22,3:
kai; oJ qrovno" tou' qeou' kai; tou' ajrnivou ejn aujth/' e[stai, kai; oiJ dou'loi aujtou' latreuvsousin aujtw/' kai; o[yontai to; provswpon aujtou', kai; to; o[noma aujtou' ejpi; tw'n metwvpwn aujtw'n – “E il trono di Dio e dell’Agnello sarà in essa, e i suoi servi gli renderanno culto e vedranno il suo volto, mentre il suo nome sarà sulle loro fronti”.
Ap 4 è un altro passo, legato anch’esso al trono di Dio, in cui si verifi-cano passaggi temporali ancora più complessi di quelli incontrati finora:
– (asse del passato) meta; tau'ta ei\don “Dopo questo vidi” (4,1), all’ao-risto come al solito per introdurre le visioni (4,1); poi kai; ijdouv “ed ecco” che introduce la descrizione della visione prima con l’imperfetto: kai; ijdou; qrovno" e[keito “ed ecco un trono stava” (4,2-4), poi con frasi nominali senza verbo finito (4,2-4) che indicano contemporaneità e quindi sono da rendere in italiano con l’imperfetto;
– (asse del presente) Kai; ejk tou' qrovnou ejkporeuvontai “E dal trono escono” lampi, voci e tuoni (4,5), al presente, continuato da una serie di proposizioni senza verbo finito che indicano contemporaneità (4,5-8a), da tradurre anch’esse al presente (4,5-8a); poi gevmousin ojfqalmw'n, kai; ajnavpausin oujk e[cousin hJmevra" kai; nukto;" levgonte" – “sono pieni di occhi e non hanno riposo giorno e notte dicendo” (4,8bc), ancora al pre-sente per descrivere come i Quattro Animali sono e cosa fanno;
– (asse del futuro) Kai; o{tan dwvsousin ta; zw/'a dovxan … pesou'ntai oiJ ei[kosi tevssare" presbuvteroi … proskunhvsousin … kai; balou'sin… – “E quando gli Animali daranno gloria … i Ventiquattro Vegliardi ca-dranno … si prostreranno … e getteranno…” (4,9-10), al futuro.
Non c’è motivo per analizzare i futuri di 4,9-10 come una resa letterale o meccanica dello yiqtol ebraico usato per il passato con funzione di imper-
31 Cf. il mio articolo “La grande prostituta e la sposa dell’Agnello”, 144-152.
IL TITOLO DIVINO oJ w·n kai« oJ h™n kai« oJ e˙rco/menoß NELL’APOCALISSE 13
123456789
10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
fetto (nel senso cioè di “davano … cadevano … si prostravano … e gettavano…”), poiché l’autore sa bene utilizzare l’imperfetto quando vuole. Se dunque si interpretano le forme di futuro nel loro senso proprio, allora 4,1-8 risulta essere il quadro entro cui si colloca l’informazione principale, e cioè la prostrazione e la lode da parte della corte celeste a Colui che è seduto in trono, presentate come azioni future e probabilmente ripetute32.
Come in 7,14-17, la visione di Ap 4 comincia dunque con forme del passato (4,1-4), con aoristo per la linea principale del racconto, imperfetto e proposizioni senza verbo finito con funzione descrittiva (linea secondaria del racconto); passa poi all’asse del presente (4,5-8), per una presentazione in diretta, con forme di presente e con proposizioni senza verbo finito (linea principale nel discorso diretto); passa infine all’asse del futuro, con forme di futuro (linea principale nel discorso diretto). Il che significa che il racconto da narrazione di tipo storico, con forme di passato, diventa descrizione del-la scena come presente e poi annuncio di eventi futuri33 secondo il modello del discorso diretto.
L’esame di altri esempi potrà aiutarci a comprendere meglio la prospet-tiva dell’autore.
3.2. Ap 10,6-7; Ap 11; Ap 18-19
Transizioni temporali con passaggio rapido da forme di un asse temporale a forme di un asse temporale diverso si notano frequentemente in Apocalisse.
32 Su questo passo le opinione degli studiosi divergono fortemente. Moulton - Turner, A Grammar, III, 86, come anche A. Lancellotti, Sintassi ebraica nel greco dell’Apocalisse. I. Uso delle forme verbali, Assisi 1964, 65, sostengono che i futuri hanno il valore di imperfetto, come già la Vulgata (et cum darent illa animalia…). Così traduce anche Prigent, 170.180, mentre Aune, 269 traduce al presente e sostiene che la congiunzione o¢tan non indica ripetizione bensì azione singola (p. 307). Al futuro traducono Swete, 73, Allo, 59 e anche E. Corsini, Apocalisse di Gesù Cristo secondo Giovanni, Torino 2002. A differenza di Swete e di Allo, Corsini ritiene che la congiunzione annunci sì un evento futuro ma unico, che per lui si realizza in 5,8 (pp. 132-133). Un’opinione simile è sostenuta da G. Mussies, The Morphology of Koine Greek as Used in the Apocalypse of St. John. A Study in Bilingualism, Leiden 1971, nella discussione di Ap 4,9-11 (pp. 342-347).33 Più o meno su questa linea si pone Mussies, The Morphology of Koine Greek. Egli infatti così commenta i passaggi dal passato al presente, di cui porta anche esempi dai papiri egiziani, e poi quelli dal passato al futuro nei racconti di visione di Apocalisse: “These shifts indi-cate that he [i.e. l’autore] is no longer telling what he saw in the past, but rather what he is seeing again before his eyes, and as such these present indicatives give the idea of lively representation… Such use of tenses seems quite natural for an author who has to recount visions actually seen, or pretended to have been seen, in the past, but which at the same time predict future events” (pp. 334.335).
A. NICCACCI14
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
I casi più problematici sono quelli in cui da una predizione con verbo al futuro si passa repentinamente all’aoristo. Un esempio è il giuramento del-l’angelo in 10,6-7 che, appunto, passa dal futuro (a) all’aoristo (b):
– (a) kai; w[mosen … o{ti crovno" oujkevti e[stai … ajll∆ … o{tan mevllh/ salpivzein – “e giurò… che non ci sarà più tempo/ritardo … ma … quan-do [l’angelo] starà per suonare la tromba,
– (b) kai; ejtelevsqh to; musthvrion tou' qeou', wJ" eujhggevlisen tou;" eJautou' douvlou" tou;" profhvta" – [kai ÷ di apodosi] si è compiuto il mistero di Dio come annunciò ai suoi servi i profeti”.
L’aoristo ejtelevsqh viene spesso tradotto con il futuro, talvolta con il futuro anteriore34, cosa di per sé ipotizzabile sul modello del qatal ebrai-co che può indicare appunto anteriorità nel futuro35. Forse però l’aoristo ejtelevsqh è usato per esprimere una decisione di Dio presa dall’eternità, qui come in 15,1:
– Kai; ei\don … ajggevlou" eJpta; e[conta" plhga;" eJpta; ta;" ejscavta", o{ti ejn aujtai'" ejtelevsqh oJ qumo;" tou' qeou' – “E vidi … sette angeli aventi sette flagelli, gli ultimi, poiché con essi si è compiuta l’ira di Dio”.
Il verbo ejtelevsqh compare anche qui all’aoristo – benché le sette cop-pe con i flagelli che devono compiere l’ira di Dio siano versate solo più tardi (Ap 16) – per indicare che il fatto realizza una decisione eterna di Dio.
Un altro passo notoriamente problematico dal punto di vista delle forme verbali, in particolare dell’aoristo, è la visione dei Due Testimo-ni (Ap 11). Inizia con il futuro per la promessa: Kai; dwvsw toi'" dusi;n mavrtusivn mou kai; profhteuvsousin “E darò ai miei Due Testimoni e profetizzeranno (= darò il potere di profetizzare)” (11,3); prosegue con il presente per descrivere i due personaggi (11,4-6), quindi di nuovo con il futuro per comunicare la loro uccisione da parte della Bestia (11,7). Le conseguenze del fatto sono poi descritte con la proposizione senza verbo
34 Al riguardo le opinioni sono discordanti. Charles, I, 265, ipotizza che ejtelevsqh sia un ebraismo nel senso di traduzione servile di un weqatalti (cosa che Lancellotti, Sintassi ebraica nel greco dell’Apocalisse, 56, giustamente rifiuta), oppure che sia un aoristo di anticipazione (opinione che segue, tra gli altri, Swete, 129). Per Robertson, A Grammar of the Greek New Testament, l’aoristo è usato in riferimento al futuro: “It is a vivid transference of the action to the future (like the present e[rcomai in Jo. 14:3) by the timeless aorist” (p. 846). Sull’aoristo con valore di futuro anteriore si veda in particolare B.M. Fanning, Verbal Aspect in New Testa-ment Greek, Oxford 1990, 269-274.35 Ho citato alcuni esempi di qatal con valore di futuro anteriore in Lettura sintattica della prosa ebraico-biblica. Principi e applicazioni, Jerusalem 1991, 209.238.
IL TITOLO DIVINO oJ w·n kai« oJ h™n kai« oJ e˙rco/menoß NELL’APOCALISSE 15
123456789
10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
finito, il presente e il futuro con motivazione al passato (11,8-10). Infine, ed è questo l’aspetto problematico, la risurrezione dei Testimoni, la loro assunzione in cielo e il terremoto che l’accompagna sono raccontati al passato (11,11-13).
Su queste “fluttuazioni” temporali Allo osserva:
“A notre avis, ce n’est pas une négligence de style, ni l’effet du manque de familiarité avec la langue grecque; c’est le mouvement de la pensée, extrêmement rapide et vivante, qui explique le tout… Le mouvement de la pensée et du récit explique assez bien ces fluctuations, pour qu’il ne soit pas besoin de recourir à des confusions grammaticales. Les récits du prophète sont toujours passionnés. Il sait qu’il rapporte une vision passée, qui a trait au présent et à l’avenir à la fois; mais, par instants, tout se met à vivre devant ses yeux à mesure qu’il écrit. Ce phénomène n’est pas moins sensible en plusieurs autres visions”36.
Se il cambio dal futuro (11,3) al presente (11,4-6) si spiega come passag-gio dall’annuncio di un fatto futuro alla sua descrizione in diretta, il cambio dal presente e futuro (11,7-10) al passato (11,11-13) può avere lo scopo di qualificare il fatto come già deciso nel piano eterno di Dio e quindi in qualche modo come già avvenuto, per cui si parla comunemente di “aoristo profetico”, o simile37.
Con questo non intendo affermare, come si fa spesso, che in questi casi l’aoristo acquisti valore di futuro o che vada tradotto al futuro; direi piut-tosto che mediante l’aoristo un evento futuro viene presentato come passa-to per indicare che esso realizza un decreto eterno di Dio. Diversamente, qui come nei testi esaminati sopra, si annullerebbe la dinamica temporale voluta dall’autore. Egli infatti intende comunicare diversi aspetti, appunto spostando l’asse temporale, e vuole che il lettore lo segua in questo percor-so collocandosi idealmente nelle diverse prospettive che le forme verbali suggeriscono.
36 Allo, CLII-CLIII. Si veda anche la discussione di Lancellotti, Sintassi ebraica nel greco del-l’Apocalisse, 39-43.37 Cf., ad esempio, Fanning, Verbal Aspect, 274. Diversamente, in base alla convinzione che il sistema verbale greco non sia basato sul tempo ma sull’aspetto, S.E. Porter, Verbal Aspect in the Greek of the New Testament, with Reference to Tense and Mood, New York ecc. 1989, afferma: “The narrative [i.e. Ap 11,1ss] proceeds with a series of Future verbs and conditionals, then shifts to Present verbs, and then to Aorists (vv 11ff.), while the sphere of temporal reference remains the same. A plausible explanation is that the Future and conditional statements are used to establish a vision-quality of the narrative, and once this is established certain assertions are made about the two witnesses. In any case temporal reference cannot be the deciding factor in tense usage of these verbs” (p. 236).
A. NICCACCI16
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
Un esempio ancora più complesso si trova in Ap 18-19:
– La caduta di Babilonia è annunciata con forme di passato in 18,2 (cf. 14,8): e[pesen e[pesen Babulw;n hJ megavlh, kai; ejgevneto katoikhthvrion daimonivwn “È caduta, è caduta Babilonia la grande! Ed è divenuta abita-zione di demoni”; e anche il motivo della caduta è indicato con forme di passato in 18,3 e 18,5 , ma poi con un presente in 18,7c: o{ti ejn th/' kardiva/ aujth'" levgei “poiché nel suo cuore essa dice”.
– L’annuncio della rovina della città ritorna in 18,8-10, ma ora con forme di futuro: dia; tou'to ejn mia/' hJmevra/ h{xousin aiJ plhgai; aujth'" … “per questo in un solo giorno verranno le sue piaghe…” (18,8), e le conseguenze del fatto sono indicate prima al futuro: Kai; klauvsousin kai; kovyontai ejp∆ aujth;n oiJ basilei'" th'" gh'"… – “E piangeranno e faran-no lamento su di essa i re della terra…” (18,9), poi al presente: Kai; oiJ e[mporoi th'" gh'" … klaivousin kai; penqou'sin ejp∆ aujthvn… – “E i mer-canti della terra … piangono e gemono su di essa…” (18,11-13).
– L’annuncio riprende con due forme di passato in connessione con un futuro: kai; hJ ojpwvra … ajph'lqen ajpo; sou', kai; pavnta ta; lipara; kai; ta; lampra; ajpwvleto ajpo; sou' (= aoristi) // kai; oujkevti ouj mh; aujta; euJrhvsousin (= futuro negativo) – “E il frutto… si è allontanato da te, e tutte le cose opulenti e magnifiche sono perite da te // e più non le trove-ranno” (18,14)38; poi di nuovo sono indicate le conseguenze, ora al futuro: OiJ e[mporoi touvtwn … ajpo; makrovqen sthvsontai … klaivonte"… – “I mercanti di queste cose … da lontano staranno … piangendo…” (18,15).
– L’annuncio della rovina della città ritorna come motivo del pianto dei mercanti con forme di passato in 18,17-19 e ancora nel resto di Ap 18.
38 Questa associazione di passato e futuro in parallelo, “sono perite da te // e più non le troveranno”, costituisce un esempio di merismo, una figura stilistica frequente nella lette-ratura biblica e che assume forme diverse, consistente nel fatto che si nominano gli estremi per indicare la totalità, ad esempio: cielo // terra, nord // sud, ecc. Un altro esempio di merismo, con passaggio da forme verbali di futuro a forme verbali di passato, si trova in Ap 20: Satana liberato dalla prigione uscirà, con verbi al futuro: luqhvsetai … kai; ejxe-leuvsetai planh'sai ta; e[qnh “sarà sciolto … e uscirà per ingannare le nazioni…” (20,7-8), poi al passato con una serie di aoristi: kai; ajnevbhsan … kai; ejkuvkleusan … kai; katevbh pu'r ejk tou' oujranou' kai; katevfagen aujtouv". kai; oJ diavbolo" … ejblhvqh eij" th;n livmnhn tou' purov" “e (le nazioni) salirono … e circondarono … e/ma un fuoco scese dal cielo e li divorò, e il diavolo … fu gettato nello stagno di fuoco”, e quindi di nuovo al futuro: kai; basanisqhvsontai “saranno tormentati” (20,9-10). Ne risulta un merismo temporale di tipo futuro // passato // futuro, a indicare che la condanna è eterna. Un tipo analogo di merismo temporale spiega il parallelismo tra forme verbali di passato e forme verbali di futuro nella poesia ebraica, senza supporre, come fanno per lo più gli studiosi, che nella poesia le forme verbali perdano il loro valore normale che hanno nella prosa. Si veda al riguardo il mio contributo “Biblical Hebrew Verbal System in Poetry”, in S.E. Fassberg – A. Hurwitz (edd), Biblical Hebrew in Its Northwest Semitic Setting. Typological and Historical Perspectives, Jerusalem – Winona Lake 2006, 247-268, §§ 2.1; 3, pp. 253-255; 265-267.
IL TITOLO DIVINO oJ w·n kai« oJ h™n kai« oJ e˙rco/menoß NELL’APOCALISSE 17
123456789
10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
Abbiamo perciò:
– (1) annuncio della rovina della città al passato (18,2) • (1.1) motivo al passato (18,3.5), poi al presente (18,7c);– (2) secondo annuncio della rovina della città al futuro (18,8) • (2.2) conseguenze al futuro (18,9), poi al presente (18,11-13);– (3) terzo annuncio della rovina della città al passato // futuro (18,14) • (3.2) conseguenze al futuro (18,15) • (3.1) motivo al passato (18,17-19) • (3.2) conseguenze all’imperativo (18,20a: Eujfraivnou “rallegrati!”) • (3.1) motivo al passato (18,20b)– (4) quarto annuncio con gesto simbolico al passato (18,21ab) – • (4.2) rovina della città al futuro (18,21c - 18,23b) • (4.1) motivo al passato (18,23c-24)39.
Una formula oujai; oujaiv “guai, guai!” rivolta direttamente o indiretta-mente alla città ricorre tre volte accompagnata da una motivazione con o{ti e forme verbali sempre al passato (18,10.16-17.19), e così presenta la rovina della città come già avvenuta o almeno già decisa.
Le acclamazioni della grande folla in Ap 19 evocano ancora l’evento della caduta di Babilonia prima come passato (19,2, con aoristi), poi come presente o come destinato a durare (19,3). Seguono tre alleluia che evoca-no la fine della città (19,1-5), poi un altro che annuncia come già avvenuti il regno di Dio e le nozze dell’Agnello con la Sposa pronta (19,6-8). Si prepara così il passaggio alla realizzazione del Regno di Dio e alla nuova Gerusalemme Sposa dell’Agnello (Ap 20-22).
3.3. Valutazione
Dall’esame che stiamo facendo credo che si debba concludere che queste fluttuazioni di asse temporale non possono essere spiegate come incapacità da parte dello scrittore; diversamente si dovrebbe parlare non di semplice incapacità ma di pura follia. La spiegazione comunemente seguita è che si tratta di una trasposizione servile o meccanica in greco di un sottofondo semitico.
39 Mussies, The Morphology of Koine Greek, 338-339, afferma che l’aoristo e[pesen si può in-tendere come “proleptic past” in 14,8 – come propone Lancellotti, Sintassi ebraica nel greco dell’Apocalisse, 50 –, non però in 18,2. Secondo Mussies, Ap 18 non segue un ordine crono-logico ma prima racconta il passato, poi descrive il presente in forma diretta, infine mostra il carattere profetico delle visioni (in modo simile a 7,14-17; cf. supra, nota 32).
A. NICCACCI18
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
Per comprenderci dobbiamo ricordare che l’ebraico non ha la ricchez-za di forme verbali del greco40. Ad esempio, lo yiqtol indica il futuro nel discorso diretto (linea principale della comunicazione) ma nella narrazione indica un’azione ripetuta o abituale nel passato come l’imperfetto del greco e delle lingue neo latine (linea secondaria della comunicazione); il qatal è utilizzato per il passato nel discorso diretto (linea principale della comuni-cazione), mentre nella narrazione indica, secondo i casi, contemporaneità o anteriorità (linea secondaria della comunicazione); la proposizione senza verbo finito, con o senza participio, indica il presente nel discorso diretto (linea principale della comunicazione), ma nella narrazione indica contem-poraneità e corrisponde all’imperfetto del greco e delle lingue neo latine (linea secondaria della comunicazione)41.
Ora, come già accennato, secondo parecchi studiosi l’uso “anomalo” dell’aoristo e dell’imperfetto per un evento futuro sarebbe frutto di una traduzione meccanica o servile di un soggiacente yiqtol semitico. Analoga-mente l’uso del presente e di proposizioni nominali senza verbo finito, con o senza participio, che compaiono accanto all’imperfetto per descrivere un evento passato, sarebbe frutto di una traduzione meccanica o servile della proposizione nominale semitica nell’asse del passato42.
40 Si veda, ad esempio, l’esposizione di Lancellotti, Sintassi ebraica nel greco dell’Apocalisse, 31-44 (“I «tempi» in greco e in ebraico”). L’autore esamina la lingua di Apocalisse trattando i se-guenti argomenti: “Soggiacente forma ebraica Qatal” (pp. 44-57); “Soggiacente forma ebrai-ca Jiqtol” (pp. 58-71); “Il participio greco e il participio semitico” (pp. 72-78); “Il participio «nominale»” (pp. 79-93); “Uso «verbale» del participio” (pp. 94-106); “L’infinito” (pp. 107-112). Si veda anche la tavola riassuntiva delle corrispondenze tra greco e aramaico/ebraico che presenta S. Thompson, The Apocalypse and Semitic Syntax, Cambridge ecc. 1985, 53.41 Questa descrizione si basa sul sistema verbale dell’ebraico biblico che ho delineato in Sintassi del verbo ebraico nella prosa biblica classica, Jerusalem 1986; in traduzione inglese aggiornata: The Syntax of the Verb in Classical Hebrew Prose, Sheffield 1990; e in traduzione spagnola ancora aggior-nata: Sintaxis del Hebreo Bíblico, 2 ed., Estella (Navarra) 2002. Per quanto riguarda il greco biblico in rapporto all’ebraico biblico si possono consultare i miei saggi “Dall’aoristo all’imperfetto o dal primo piano allo sfondo. Un paragone tra sintassi greca e sintassi ebraica”, LA 42 (1992) 85-108; “Marked Syntactical Structures in Biblical Greek in Comparison with Biblical Hebrew”, LA 43 (1993) 9-69; “La narrativa di Mc 1”, in: M. Adinolfi - P. Kaswalder (edd.), Entrarono a Cafarnao. Lettura interdisciplinare di Mc 1. Studi in onore di P. Virginio Ravanelli, Jerusalem 1997, 59-71.42 Non sono in grado di fare un quadro della ricerca sul greco del NT e in particolare di Apo-calisse. Mi contento di citare alcuni articoli che hanno cercato di farlo. Ozanne, “The Language of the Apocalypse”, ritiene che l’autore di Apocalisse adotta una lingua che ha paralleli nel-l’ebraico biblico non per incapacità o altro ma per uno scopo preciso: “The author, it seems, wished to identify himself with the writers of the Old Testament Scriptures, and to impress on his readers the character of his vision as the last of the prophetic books” (p. 4); S.E. Porter, “The Language of the Apocalypse in Recent Discussion”, NTS 35 (1989) 582-603, critica Thompson, The Apocalypse and Semitic Syntax, in particolare la concezione che la lingua di Apocalisse sia un “Jewish Greek”, sostenendo che essa è in molti casi nient’altro che un “vulgar Greek of the 1st
IL TITOLO DIVINO oJ w·n kai« oJ h™n kai« oJ e˙rco/menoß NELL’APOCALISSE 19
123456789
10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
Al proposito osserverei che, da un lato non tutti gli usi e le sfumature che gli studiosi attribuiscono alle forme verbali ebraiche sono giustificati dal punto di vista di una corretta analisi linguistico-testuale del sistema verbale43; d’altro lato si suppone nello scrittore di Apocalisse un’incapacità o cattiva conoscenza del greco che non è facilmente conciliabile con la sua riconosciuta abilità di linguaggio e di comunicazione44. Ritengo che la mag-gior parte delle soluzioni basate su un supposto sottofondo semitico, ebraico o aramaico che sia, non siano altro che scappatoie ingenue e di comodo. Per arrivare a una lettura rispettosa del testo si dovrà cercare di capire la prospettiva dell’autore sulla base del sistema verbale della lingua utilizzata, piuttosto che imporre la propria prospettiva di interpreti anche a costo di far violenza al sistema verbale stesso.
Tornando all’argomento della nostra ricerca, possiamo concludere che gli spostamenti di asse temporale che abbiamo notato in vari testi di Apo-
century” (p. 600); G.H.R. Horsley, “The Fiction of ‘Jewish Greek’”, in: New Documents Il-lustrating Early Christianity, Volume 5: Linguistic Essays, Macquarie University 1989, 5-40, nega anch’egli l’esistenza di un “Jewish Greek”; Callahan, “The Language of the Apocalypse” critica le più comuni spiegazioni delle peculiarità della lingua di Apocalisse (greco giudaico, prodotto di ignoranza, sottofondo ebraico o aramaico) e afferma che si tratta di “an idiolect, the peculiar language of one author, unattested anywhere else in antiquity… His idiom is apocalyptic… The language, however, is the koine of provincial elites everywhere in the East, the language not of the province, but of the empire” (pp. 458.469). Non tratta invece diret-tamente l’argomento della nostra ricerca G. Walser, The Greek of the Ancient Synagogue. An In-vestigation on the Greek of the Septuagint, Pseudepigrapha and the New Testament, Stockholm 2001.43 Mi riferisco al metodo di analisi linguistico-testuale proposto da H. Weinrich, Tempus. Le funzioni dei tempi nel testo, Bologna 1978 (nuova ed. 2004), metodo che ho applicato al sistema verbale dell’ebraico biblico (cf. supra, nota 40). Questo metodo consente anche di definire in modo accurato categorie discusse come tempo e aspetto. Detto in breve, le forme verbali ed eventuali altre costruzioni non verbali che sono utilizzate in una determinata lingua per indicare il livello principale della comunicazione nei tre assi temporali (passato, presente, futuro) sono tempi verbali, nel senso che indicano già da sole – anche senza indicazioni espli-cite, come gli avverbi temporali – la collocazione di ognuna delle informazioni nel proprio asse temporale e i rapporti reciproci tra di esse. Invece le forme verbali e altre costruzioni non verbali utilizzate per il livello secondario della comunicazione esprimono l’aspetto, cioè contemporaneità, anteriorità o prospezione verso il futuro, unicità o ripetizione. Ritengo che queste siano le categorie che hanno diritto di essere considerate nell’analisi del sistema verbale di una lingua, sia antica che moderna. In greco, come in ebraico biblico, non è possibile ana-lizzare correttamente il sistema verbale solamente o principalmente dal punto di vista della categoria dell’aspetto sul modello, ad esempio, di Porter, Verbal Aspect (cf. supra, nota 36).44 Come nota giustamente Callahan, “The Language of the Apocalypse”, “the seer clearly knows how to follow the rules of the language game when he wants to. The style and diction of the author cannot be adequately explained as unsuccessful bilingualism. The hypothesis of a Hebrew Vorlage neither accounts for the deliberate character of so many of the pe-culiarities nor explains why most of the grammatical rules violated are flawlessly observed elsewhere in the work” (p. 457).
A. NICCACCI20
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
calisse si spiegano come cambio di prospettiva da parte del Veggente: dal-l’asse del passato per raccontare la visione come già avvenuta, all’asse del presente per descriverla in diretta e infine all’asse del futuro per annunciare qualcosa che avverrà e che la visione simboleggia45.
Non è proprio il caso di chiamare in causa l’incapacità dell’autore, o un greco giudaico, o una lingua ebraica o aramaica soggiacente, o un bilingui-smo imperfetto, né di supporre aggiunte redazionali. Piuttosto il Veggente delinea una situazione che ha visto nel passato, che descrive come presente e che anche annuncia come futura. Pur conservando il loro valore normale, le forme verbali non indicano una successione temporale; indicano piutto-sto una convergenza dei tre assi temporali. Possiamo dire che è un tentativo di descrivere il tempo di Dio secondo il modello del tempo degli uomini46.
In effetti l’Apocalisse non racconta eventi della storia umana ma visio-ni, cioè una realtà che convive con il Dio che è nello stesso tempo “Colui che è, che era e che viene”. Una realtà che il Veggente descrive in termini analoghi, secondo un analogo modello di esistenza.
Alviero NiccacciStudium Biblicum Franciscanum, Jerusalem
45 Più o meno su questa linea si pone Mussies, The Morphology of Koine Greek. Egli infatti così commenta i passaggi dal passato al presente, di cui porta anche esempi dai papiri egiziani, e poi i passaggi dal passato al futuro nei racconti di visione di Apocalisse: “These shifts in-dicate that he [i.e. l’autore] is no longer telling what he saw in the past, but rather what he is seeing again before his eyes, and as such these present indicatives give the idea of lively representation… Such use of tenses seems quite natural for an author who has to recount visions actually seen, or pretended to have been seen, in the past, but which at the same time predict future events” (pp. 334.335).46 Durante la revisione del presente contributo mi sono imbattuto in un articolo di G. Biguz-zi, “A Figurative and Narrative Language Grammar of Revelation”, NT 45 (2003) 382-402, che esamina con sensibilità le peculiarità delle immagini, delle tecniche narrative e di quello che viene detto “John’s surreal and oneiric world”. L’autore considera anche alcuni casi di “anomalous sequences of verbal tenses” (pp. 391-392), in particolare in 11,1-13 e Ap 8, e conclude: “In all these tense anomalies John probably wants to say that the times of God are other than our times and that the future fulfilling of God’s will is so sure that it can be expressed through the Greek tenses of the past” (p. 392; e nella nota 18 cita autori medievali che avevano già adottato una soluzione simile). Riguardo poi a Ap 12 (cf. supra, nota 28) ritiene giustamente che quella di 12,6 e quella di 12,14 non sono due fughe ma che la prima è anticipazione della seconda; solo che non direi che l’anticipazione sia “useless”, né che sia “unnecessary” quella di 21,2 rispetto a 21,10 (pp. 395-396; riguardo agli ultimi due passi rimando al mio articolo “La grande prostituta e la sposa dell’Agnello”, 144-147).