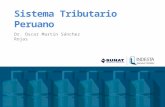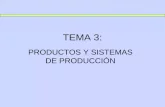Ruscelli e il sistema dei privilegi a Venezia
Transcript of Ruscelli e il sistema dei privilegi a Venezia
193
ANGELA NUOVO
RUSCELLI E IL SISTEMA DEI PRIVILEGI A VENEZIA
Già da decenni la critica è giunta a definire figure come quella di Ru-scelli collaboratori e mediatori editoriali, abbandonando la vecchia e-tichetta di ‘poligrafi’. Ruscelli appartiene a una pattuglia di personag-gi che più volte sono stati studiati come una nuova categoria profes-sionale.1 A contraddistinguerli è il fatto che, oltre a vivere grazie ad alcuni mezzi tipici dei letterati del tempo, ovvero far parte di clientele e di reti, o ricevere incarichi anche estemporanei di varia natura come segretari, maestri, agenti per la costruzione delle collezioni signorili (artistiche o bibliografiche, come nel caso di Ruscelli),2 essi trovano nell’industria della stampa lagunare una fonte di sostentamento, oltre che lo strumento principale per raggiungere autorevolezza e fama. Benché di collaboratori editoriali la stampa veneziana, con i suoi ritmi, ebbe bisogno fin dagli esordi, si affaccia ora una nuova generazione che non serve i torchi, ma si serve di essi per la propria ascesa sociale. Tra i loquaci testimoni di questa stagione, Ruscelli è certamente tra i più consapevoli e competenti, sia per le sue capacità filologiche e lin-guistiche, che per le sue ambizioni imprenditoriali e organizzative. Resta inconsueta anche la lucidità con cui fu in grado di guardare al mondo della produzione tipografica, raccontarlo occasionalmente nei suoi scritti e utilizzarlo ai propri fini.
Non è certo comune in quest’epoca che un letterato discetti e opini pubblicamente sui modi della produzione editoriale. Fragorosa è la proposta avanzata nel 1559 ai grandi editori veneziani affinché si u-nissero in un’unica società ricalcando il modello societario attuato per la produzione del libro giuridico. Secondo Ruscelli infatti tale modello era ottimale anche per la produzione di altri generi testuali, come gli
1 QUONDAM 1983, QUONDAM 1977, DI FILIPPO BAREGGI 1988. 2 Dal 1563 Ruscelli riceveva una provvisione annua di 300 scudi da Alfonso
d’Este anche per occuparsi delle acquisizioni librarie della biblioteca ducale (RUSCELLI 2010: xciv).
ANGELA NUOVO
194
antichi testi latini e greci, la letteratura in volgare, la medicina e la ma-tematica. L’idea di Ruscelli era che una società di grandi dimensioni, senza problemi di capitali, avrebbe potuto lavorare con quella tran-quillità e costanza che avrebbe permesso la pubblicazione di stampe di «perfetta corretione, bellezza della carte, delle lettere, e d’ogni altra cosa».3 Girolamo Ruscelli esortava a fondare tale associazione una se-rie di editori veneziani con cui aveva già lavorato: erano Melchiorre Sessa (che stampava specificatamente questa sua opera), Vincenzo Valgrisi, Giordano Ziletti, Luigi Valvassore, Andrea Arrivabene, Lo-dovico Avanzi. In seconda istanza, ipotesi assai più promettente, l’invito era rivolto ai massimi editori veneziani: «potrebbe ancor’es-sere che peraventura si aggiungesse gli onorati M. Gabriel Giolito, M. Tomasso e Giovan Maria Giunti, gli Scotti, gli Asoli et altri miei ami-cissimi, e che insieme tutti facessero una onoratissima compagnia. Et essendo essi persone, che hanno forze, che hanno i maneggi in corso, e che tengono mano in tutte le librarie d’Italia, e in moltissime ancor fuor d’Italia …».4 Questi ultimi erano già, in effetti, partners nella Società del-la Corona, una grande compagnia editoriale fondata per la stampa dei libri giuridici, una società di investitori costruita sul modello delle grandi società lionesi che in quegli stessi anni annoveravano tra i loro partecipanti sempre membri della potentissima famiglia dei Giunti.5 Giustamente la proposta ruscelliana è stata messa in relazione alla na-scita dell’Accademia Veneziana o della Fama, che proprio in quegli anni iniziava la sua attività con gran fasto, ma debole struttura finan-ziaria.6
Nonostante la probabile inopportunità della proposta, Ruscelli ve-deva con chiarezza il futuro della stampa veneziana, sempre più o-rientata alla stipula di cartelli editoriali forti, tendenzialmente mono-polistici. Non era l’unico evidentemente portato a chiedersi se la crea-
3 Girolamo Ruscelli, Del modo di comporre in versi nella lingua italiana, trattato,
In Vinetia, appresso Gio. Battista et Melchior Sessa fratelli, 1559 (lettera Ai lettori, c. a8r-c3r). L’intero testo è pubblicato in RUSCELLI 2011: 201-216.
4 RUSCELLI 2011: 214-215. 5 NUOVO-COPPENS 2005: 86-91. 6 PROCACCIOLI 2011: xvii. Sull’Accademia Veneziana della Fama, si consulti-
no ROSE 1969, PAGAN 1973-1974, BOLZONI 1981, SERRAI 1991.
RUSCELLI E IL SISTEMA DEI PRIVILEGI A VENEZIA
195
zione di società editoriali, usuali e ripetute da decenni nell’editoria giuridica, non potesse recare migliore qualità anche negli altri settori dell’editoria veneziana, dove la concorrenza doveva essere soffocante e causare una continua tendenza al ribasso. Tuttavia, se queste società non nacquero o comunque non resistettero nel tempo, questo significa che il mercato non le rendeva convenienti.
Girolamo Ruscelli fu certamente abile nell’intessere una rete di rapporti, con ambienti diversi e personaggi illustri e potenti, rete che traspare dalle dediche a stampa e dalle lettere che ci sono rimaste.7 Ma esaminare la sua attività contestualizzandola alla luce di questa rete di rapporti, instabile e transitoria per un personaggio che mai perseguì (od ottenne) un impiego fisso, non esaurisce l’orizzonte della ricerca sulla sua densissima presenza tipografica. È un’analisi in cui si dà troppa importanza alle variabili, senza tenere in considerazione suffi-ciente le costanti. E per costanti intendo le condizioni generali della stampa a Venezia; soprattutto la legislazione sulla stampa vigente ai tempi di Ruscelli, e da lui ben conosciuta e costantemente impiegata (e talvolta piegata) ai propri fini.
Ricordo le coordinate fondamentali della stampa a Venezia. Innan-zi tutto la produzione. Con non meno di 10.500 edizioni nel XV secolo e 64.000 nel XVI,8 tenendo conto solo delle edizioni giunte fino a noi, l’Italia ha un ruolo principale nella prima età della stampa. Il dominio di Venezia sulla stampa italiana si afferma dal primo decennio dall’introduzione della stampa per rimanere tale sostanzialmente fino al tardo Settecento. Ma il numero delle edizioni stampate a Venezia aumenta notevolmente proprio nell’età di Ruscelli. La produzione an-nuale compie un salto quantitativo verso un nuovo standard mante-nuto per tutto il secolo, che si attesta intorno alle 400 edizioni annue, e che viene meno solo per la peste del 1577 e le grandi carestie del 1591 e 1592. Per quanto i repertori bibliografici oggi disponibili ci consen-tano di vedere, il culmine si raggiunge nel 1584, con 474 edizioni regi-strate, oggi superstiti. L’incremento considerevole della produzione
7 Pubblicate integralmente in RUSCELLI 2011 e RUSCELLI 2010. 8 Dati tratti da ISTC (Incunabula Short Title Catalogue,
http://www.bl.uk/catalogues/istc/) ed EDIT16 (Censimento nazionale delle edi-zioni italiane del XVI secolo, http://edit16.iccu.sbn.it/).
ANGELA NUOVO
196
nella seconda metà del secolo è fenomeno che si manifesta in tutta Eu-ropa, ed è legato sia al perfezionamento delle tecniche commerciali che all’attivismo tipografico delle diverse confessioni religiose.9
Il sistema dei privilegi a Venezia La ricostruzione della struttura ed evoluzione del mercato librario nell’Italia del Rinascimento va sorretta anche dall’analisi della legisla-zione dell’epoca. Su questo versante, l’attenzione è stata finora soprat-tutto volta al problema del controllo della stampa e della censura reli-giosa. Ma un complesso di interventi legislativi atti a incidere sul mondo del libro inizia molto prima della Controriforma. Per quanto vere e proprie leggi in materia di stampa fossero emanate solo nel se-colo XVII (la prima, organica, a Venezia è del 1603), vari interventi le-gislativi e la stessa capacità degli editori di utilizzare e piegare ai pro-pri interessi gli istituti giuridici dell’epoca riuscirono a dare forma e struttura al mercato.
È comunemente riconosciuto che Venezia assurge al ruolo di capi-tale della stampa italiana sostanzialmente grazie a due fattori: la sua straordinaria rete commerciale e una cultura imprenditoriale diffusa. A questi due fattori occorre però aggiungerne un terzo, non meno cruciale: una legislazione efficace, sia per quello che regola, che per quello che lascia libero, permettendo al mercato di auto-regolarsi. Dal punto di vista giuridico, gli editori italiani nel primo periodo della lo-ro attività, erano liberi dalle regole di corporazione, e soggetti soltanto alla magistratura ordinaria. Assenza di regole, libertà totale di inizia-tiva, e quindi aspra concorrenza sono tipici di nuove aree di impresa; tali condizioni, inevitabilmente, fanno sopravvivere i più forti. Ma una concorrenza senza nessuna regola era impossibile nel mondo del libro a stampa, perché si trattava di una manifattura che implicava un inve-stimento iniziale da recuperare con il tempo, correndo anche notevoli rischi.
9 Una visione d’insieme aggiornata in PETTEGREE 2010.
RUSCELLI E IL SISTEMA DEI PRIVILEGI A VENEZIA
197
Alla ricerca di forme di protezione delle loro imprese, e con notevole creatività, gli uomini del libro diedero forma alle leggi esistenti per i loro bisogni e obiettivi. Ciò è particolarmente evidente nel settore della tutela dell’editoria e del commercio, dove gli stampa-tori fecero uso sistematico dell’istituto giuridico del privilegio.10
Il privilegio fu perciò il principale strumento giuridico che deter-minò lo sviluppo del mercato librario, con i suoi successi e le sue stor-ture. In diversi Stati europei, la fine del secolo XV è il periodo in cui emergono i privilegi librari. Ma solo a Venezia abbiamo una serie di interventi legislativi che, durante il XVI secolo, dà forma al sistema dei privilegi in un senso decisamente anti-monopolistico. Il privilegio era una gratia, una concessione, e quindi l’esatto contrario del riconosci-mento di un diritto, compreso il diritto di proteggere il proprio investimento economico contro la concorrenza. L’aspetto più caratteristico di un privilegio non è concedere il potere di agire (il che rientra nel diritto comune), ma rendere questo potere esclusivo, ne-gandolo a chiunque altro. Così la base giuridica del privilegio è lo “ius prohibendi” o “excludendi”. Un privilegio implica per tutta la sua du-rata tre divieti fondamentali. Il primo, stampare lo stesso testo protet-to dal privilegio; il secondo, importare lo stesso testo, altrove stampato, nello stato in cui il privilegio ha vigore e infine vendere lo stesso testo stampato da altri. Le tre proibizioni sono quindi rivolte a tre diversi operatori: la prima agli stampatori ed editori, la seconda ai grossisti importatori, la terza ai semplici librai con bottega. In questo modo, gli interessi dei titolari del privilegio sono difesi interamente.
Naturalmente, la proibizione più importante è quella che colpisce la produzione del libro: si proibisce di stampare quella stessa opera, per un periodo di tempo definito (solitamente, 10 anni). Ma foriere di ulteriori conseguenze sono le altre due proibizioni, quelle commercia-li; esse sono particolarmente importanti a Venezia, non solo capitale tipografica italiana ma, come fu detto, fiera libraria permanente. Se un
10 NUOVO-COPPENS 2005: 172-217, donde si ricava anche la bibliografia pre-
cedente sull’argomento. Il sito Primary Sources on Copyright 1450-1900 (http://www.copyrighthistory.org) mette a disposizione tutti i principali docu-menti relativi ai privilegi a Venezia e altrove, anche in formato immagine, e con eccellenti commenti.
ANGELA NUOVO
198
libro non poteva essere commerciato a Venezia, non poteva avere un vero mercato, perché non poteva entrare negli assortimenti dei grandi librai all’ingrosso che avevano quasi tutti sede a Venezia. Né poteva comparire nelle botteghe dei librai della Serenissima che erano, natu-ralmente, le meglio assortite d’Italia e funzionavano spesso come luo-ghi di vendita sia al dettaglio che all’ingrosso, tra librai. Così fino alla prima metà del XVI secolo chi otteneva un privilegio a Venezia, nono-stante la limitata giurisdizione territoriale della Repubblica, di fatto controllava tutto il mercato italiano. Fin dall’inizio, non solo gli editori ma anche gli autori e i curatori ricorsero a questo istituto, e la legisla-zione non faceva alcuna differenza tra questi diversi operatori del mondo del libro. La percentuale degli autori che chiesero il privilegio per una propria opera fu, nel periodo dalle origini al 1527, intorno al trenta per cento.11
Dal punto di vista commerciale un privilegio non significava altro che una garanzia temporanea di mercato protetto, che ogni amministrazione poteva concedere solo all’interno dei suoi confini. Le pene previste per i trasgressori consistevano sostanzialmente nel se-questro delle copie pubblicate in violazione di privilegio, più una multa.
I privilegi si potevano richiedere solo per la pubblicazione di opere nuove, totalmente inedite. Non era permesso chiedere un privilegio per tutti i testi già pubblicati, e per i testi cosiddetti ‘comuni’, ovvero i testi liturgici, degli autori antichi e medievali, considerati un patrimo-nio cui tutti gli stampatori potevano attingere. Privilegi erano però possibili per commenti e traduzioni, quando erano effettivamente di nuova composizione. Questo ‘requisito della novità’ ha di per sé stimolato la ricerca e la pubblicazione di nuove opere, e di nuove tradu-zioni e volgarizzamenti delle opere antiche, determinando la nascita del concetto di novità così tipico della storia dell’editoria, ma soprattutto spingendo molto evidentemente l’editoria veneziana in questa direzio-ne, che era poi, sostanzialmente, la direzione del volgare. In quest’epoca infatti, non ha senso contrapporre prime edizioni e ristampe (che tecni-camente non sono mai tali) perché quel che conta, per un’opera privile-
11 Mio conteggio sulla serie dei privilegi pubblicati in FULIN 1882.
RUSCELLI E IL SISTEMA DEI PRIVILEGI A VENEZIA
199
giata, è la durata temporale della grazia. All’interno di tale periodo il titolare poteva, a seconda della richiesta, stampare l’opera una sola o più volte.12
I privilegi erano concessi a Venezia sulla base di considerazioni e-conomiche, così edizioni con una tiratura di meno di 400 copie non potevano essere fatte oggetto di protezione. La procedura di richiesta era impegnativa e costosa. Per questo motivo i privilegi erano richiesti solo per una minoranza di libri di spiccato valore commerciale. Tra il 1527 e il 1550 su circa 5.000 libri pubblicati a Venezia, solo 842 erano protetti da privilegio, circa il 17%, una percentuale alta in confronto a quella della Francia che nello stesso periodo raggiunge solo il 5%.13 Gli editori che richiedevano più spesso il privilegio sono perciò gli e-ditori più innovativi, ma non necessariamente gli editori della fascia più redditizia del mercato; editori come i Giunti, ad esempio, non fu-rono in prima linea nella richiesta dei privilegi perché preferirono ri-manere nel mercato del libro liturgico, giuridico o dei grandi autori medievali. Perfino in una città come Milano dove tutto il settore della stampa ebbe a soffrire nella prima metà del Cinquecento una notevole depressione, circa il 14% delle 312 edizioni stampate tra il 1527 e il 1550 sono protette dal privilegio.14
Dato che a Venezia fu proprio l’unico istituto giuridico esistente at-to a proteggere gli investimenti tipografici a richiedere la pubblicazio-ne di testi sempre nuovi, questo fece la fortuna degli autori in grado di sfornare, al ritmo di un’editoria in espansione, testi tutti nuovi, o per
12 Il modus operandi di Gabriele Giolito era, ad esempio, il seguente. Dopo l’ottenimento del privilegio, che Giolito richiedeva sistematicamente, l’opera veniva stampata una o più volte anche in tempi molto stretti, se la richiesta del pubblico era buona (ad esempio, delle Trasformationi di Dolce si giunse a fare tre diverse edizioni nello stesso anno della princeps, NUOVO-COPPENS 2005: 236-243). Un certo rallentamento delle vendite seguiva inevitabilmente negli anni succes-sivi, in un mercato dove le novità si bruciavano più velocemente che in qualun-que altro settore. Non raramente però, poco prima dello scadere del privilegio l’opera veniva riedita, proprio per sfruttare fino all’ultimo le prerogative della grazia. Vedi, ivi, anche pp. 261-269 (Il privilegio e il concetto di edizione).
13 Il calcolo dei privilegi veneziani è di chi scrive, mentre per la situazione francese mi sono avvalsa di ARMSTRONG 1990.
14 Ringrazio Paola Arrigoni per avermi fornito queste cifre.
ANGELA NUOVO
200
lo meno tutti inediti dato che molti di essi sono oggi definiti come ri-scritture, o compilazioni, o cripto-traduzioni, di testi già esistenti. Esi-steva naturalmente un controllo sul livello di novità dei testi, e le leggi sui privilegi si sforzano di definire sempre meglio tale novità. Ma via via che si spostava la soglia della percezione della novità, ad essa si adeguavano le tecniche di compilazione. L’accusa di plagio e di crip-to-traduzione che spesso questi collaboratori editoriali si rivolgono l’un l’altro non è dunque solo il disvelamento di un imbarazzante rea-to letterario ma l’accusa di un vero e proprio illecito, dato che il privi-legio era sempre concesso con la clausola che la stampa in questione osservasse tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione della Re-pubblica: in primis, il requisito della novità.
I criteri a cui si ispirò la politica veneziana dei privilegi furono de-terminanti per il rigoglioso sviluppo della stampa cittadina. Fu sem-pre applicato il principio di mettere tutti gli operatori sullo stesso pia-no, purché attivi a Venezia, e non permettere a nessuno di costruirsi, con la forza delle leggi, una posizione dominante. Anche grazie a que-sta politica, la Serenissima attrasse uno straordinario numero di stam-patori da ogni dove. Le concessioni furono sempre estremamente de-finite, per singole opere, e limitate nel tempo (da 10 a 25 anni). Di re-gola il privilegio veniva negato ad opere che si intendeva stampare fuori dal territorio della Serenissima,15 benché ci siano state eccezioni. Tra queste, celebre è la concessione all’Ariosto per il Furioso, per altro stampato con un’amplissima collezione di privilegi a coprire i vari Stati italiani;16 altrettanto celebre è la concessione alla Biblia Regia poli-glotta stampata da Plantin: in questo caso il privilegio veneziano fu ottenuto grazie all’intercessione dell’ambasciatore di Filippo II e all’eccezionalità del progetto. Ma il privilegio fu negato anche ad au-tori illustri, perché le loro opere non sarebbero state stampate a Vene-
15 Nel 1519 fu chiesto al Senato Veneto dal duca di Urbino che fosse concesso
il privilegio al proprio medico Francesco Manenti per la sua edizione di Ippo-crate. Il privilegio fu concesso « hac tamen conditionem, quod antedictus magi-ster obligatus sit hic Venetiis facere imprimi opera praedicta» (FULIN 1882, privi-legio n. 220). L’edizione fu pubblicata invece a Roma, quindi non ebbe il privile-gio veneziano ma solo quello papale (EDIT16, CNCE 22511).
16 NUOVO 2003: 196.
RUSCELLI E IL SISTEMA DEI PRIVILEGI A VENEZIA
201
zia.17 Questo era un modo molto efficace di proteggere la stampa loca-le e di far sì che un numero crescente di operatori fossero attirati a la-vorare in laguna.
In questa politica anti-monopolistica furono molto importanti le prime leggi emanate nel 1517 e poi nel 1534 e vigenti all’epoca di Ru-scelli.18 Esse posero rimedio all’incetta di privilegi che alcuni stampa-tori avevano attuato senza poi realizzare le edizioni la cui stampa a-vevano ottenuto fosse impedita ai concorrenti. Avevano cioè abusato dello ius prohibendi. Veniva quindi stabilito il termine di decadenza per mancata attuazione entro un anno dalla concessione del privile-gio. Si ribadì altresì che solo le opere nuove potevano essere fatte og-getto di questa protezione. Dagli anni Quaranta in poi, in effetti, l’aumento evidente di volgarizzamenti di opere antiche (latine e gre-che) e di nuove opere volgari è la risposta al requisito della novità in-dispensabile per ottenere la protezione. Ne scaturisce la produzione continua di testi e traduzioni nuove, in un contesto di incessante spe-rimentazione della lingua volgare, mai prima tanto massicciamente proposta dall’editoria in alcun paese europeo.
Nella seconda metà del secolo XVI, che vede la ridistribuzione dell’iniziativa imprenditoriale tipografica in Italia, quello veneziano non fu più l’unico mercato da tenere sotto controllo per un imprendi-tore. Data la frammentazione politica, la reale protezione italiana dell’edizione (lasciando da parte le opere che ambivano addirittura a una protezione europea) scaturiva solo dal completo mosaico dei pri-vilegi ottenuti dai vari stati italiani. Un privilegio chiesto ad una certa amministrazione, in un certo stato, significa sia il desiderio di non ve-
17 Si legga ad esempio la vicenda della pubblicazione delle opere postume di
Pietro Bembo. Carlo Gualteruzzi, che ne doveva curare la stampa a Roma, non riusciva a capire perché fosse impossibile ottenere da Venezia il privilegio, e in-sisteva nell’intendere che un simile riconoscimento a Bembo fosse dovuto (NUOVO-COPPENS 2005: 195-198). Non capiva cioè che il privilegio a Venezia non era più quella grazia eccezionale concessa a un singolo suddito per i suoi meriti, tipica dei sistemi cortigiani, ma era diventato la leva usata dalla Repubblica per la regolamentazione della concorrenza editoriale e per la protezione della stam-pa locale.
18 Le si legga nel sito Primary Sources on Copyright 1450-1900.
ANGELA NUOVO
202
dere la propria edizione riprodotta in quel territorio, che l’aspettativa e la capacità di coprire commercialmente quel territorio. Dunque, ogni privilegio richiesto in un certo stato fuori da Venezia, fosse a Ferrara, a Mantova, a Milano, a Pesaro, e così via, significa che l’editore poteva assicurarsi (direttamente attraverso una sua filiale o indirettamente tramite librai corrispondenti e da lui riforniti) una presenza commer-ciale consistente in quello stato.19
Gli editori che riuscivano a ottenere una protezione concertata da diversi Stati si situavano nella fascia alta del mercato, obbligati come erano ad intessere pazienti relazioni con vari cortigiani, mediatori di ogni richiesta di grazia. La necessità di disporre di un’area di smercio che corrispondesse all’effettiva portata del mercato linguistico e cultu-rale sarà un problema che affliggerà il mondo dell’editoria italiana fi-no all’Unità d’Italia, più tardi anche sotto forma di mancata tutela giu-ridica della proprietà letteraria. Ma anche nel Cinquecento, la mancata concessione del privilegio in uno degli Stati italiani poteva fornire il destro per una rovinosa concorrenza.
In generale, i privilegi concessi dagli stati minori ad uso e consumo degli editori attivi a Venezia proteggono i meri interessi economici di questi operatori, danneggiando di conseguenza la stampa locale. Con-cedendo privilegi ad opere stampate altrove, i vari Signori infatti raf-forzavano la stampa veneziana. Si accontentavano cioè di incassare la tariffa che la procedura di richiesta imponeva, una somma tutt’altro che simbolica soprattutto per gli editori più prolifici.20 Soltanto in un secondo tempo, e il punto di svolta è per molti aspetti l’attività dello stampatore ducale Lorenzo Torrentino a Firenze, gli stati minori (in-tendo tipograficamente) cambieranno almeno parzialmente politica e
19 Basterà qui ricordare le filiali di Giolito in varie città italiane, alcune delle
quali, come Ferrara e Napoli, di valore strategico evidente anche nella sua pro-duzione.
20 Ad esempio, il privilegio del Ducato di Mantova per il Manuale dei confes-sori di Cola da Guglionesi (EDIT16, CNCE 3670), tredicesimo fiore della Ghir-landa spirituale di Giolito, costò nel 1569 uno scudo d’oro e tre soldi (NUOVO-COPPENS 2005: 259-260).
RUSCELLI E IL SISTEMA DEI PRIVILEGI A VENEZIA
203
inizieranno a cercare di promuovere la stampa locale mettendola in condizione di competere con gli stampatori veneziani.21
Da quanto rapidamente scritto, si potrà capire come il sistema dei privilegi delinei una sorta di storia parallela dell’editoria, non neces-sariamente coincidente con i dati (ad esempio, città, nome dell’editore, data di stampa, autore) sui quali costruiamo i data-base bibliografici e su di essi la storia del libro. La casistica delle concessioni e la geografia delle protezioni territoriali può presentarsi in modo estremamente complesso. Ma i privilegi sono fondamentali per capire la storia della tradizione dei testi a stampa. A tale complessità corrisponde una ge-nerale, internazionale, noncuranza del dato, sistematicamente ignora-to e biffato in tutti i cataloghi e in tutti i database di libri antichi, e non sono pochi, disponibili oggi. EDIT16, la nostra grande fonte, non fa purtroppo eccezione. Nella rilevazione sistematica dei privilegi oggi all’Archivio di stato di Venezia, siamo ancora più o meno al punto dove ci ha lasciato Renato Fulin nel 1882.22 Oggi è possibile raccogliere le notizie sull’effettiva presenza dei privilegi stampati sulle edizioni solo tramite la digitalizzazione dei frontespizi, o all’esame diretto del-le stesse edizioni.
I privilegi delle opere di Ruscelli Per cominciare, possiamo affermare che la maggior parte delle edizio-ni uscite sotto il controllo o in accordo con Ruscelli sono dotate di pri-vilegio, in percentuale assolutamente inconsueta a quella generale e
21 E anche in questa politica, come il caso dello stampatore ducale Lorenzo
Torrentino dimostra, faranno largo ricorso all’istituto del privilegio (NUOVO 2006).
22 A Fulin si deve il primo rilevamento dei privilegi di stampa concessi dalla Repubblica a partire dal primo (1486) all’anno 1526 (256 registrazioni, spesso comprendenti più titoli). Esistono solo due altre pubblicazioni che includono ri-levanti serie di privilegi del secolo XVI: una per i privilegi musicali (AGEE 1982) e una per i privilegi di Giolito (NUOVO-COPPENS 2005: 393-449). In entrambi i casi, le concessioni, pubblicate nella loro integrità, comprendono molti altri titoli ed editori.
ANGELA NUOVO
204
abituale a Venezia. Tali edizioni dunque nascono con forti aspettative di mercato e chi le pubblica dispone di risorse da investire nel costoso procedimento della richiesta. La panoramica dei privilegi ruscelliani per anno (fig. 1) mostra il caratteristico andamento di tutte le imprese umane, la crescita all’inizio, il culmine negli anni centrali della vita e infine il declino. L’apice del suo impegno anche nella richiesta dei pri-vilegi si colloca all’anno 1554. I privilegi in connessione con gli editori presso cui le opere, scritte o curate dal nostro, vengono pubblicate mostrano che, qualunque fosse l’editore, l’opera è protetta il più spes-so possibile. A volte il privilegio è chiesto dall’editore (come sempre nel caso di Valgrisi) e altre volte da Ruscelli, come accade sia per ope-re da lui curate come I ragionamenti di Agostino Nifo o il Trattato di Erizzo o di Sebastiano Fausto,23 che per opere di cui è autore a tutti gli effetti. L’impressione generale è che quando le edizioni ruscelliane e-rano stampate da grandi editori, che di routine chiedevano privilegi, come potevano essere Valgrisi o Ziletti, la richiesta del privilegio, con tutti i suoi oneri, e la susseguente proprietà del testo erano loro. Ne sono interessante indizio due opere, le uniche di Ruscelli che siano state pubblicate con il privilegio del papa: la clamorosa edizione del Decamerone,24 alla base della rivalità con Dolce, e l’importante antolo-gia di lettere di principi.25 In entrambi i casi, la protezione contempo-ranea a Roma e a Venezia erano alla portata di entrambi gli editori, tra l’altro in affari tra loro, visto che Giordano Ziletti era genero di Valgri-si avendone sposato la figlia Diana in data precedente al 1566. Nella città dei papi, infatti, Giordano Ziletti fu attivo come libraio almeno dal 1548, ma tuttavia, nonostante la doppia residenza e quindi le pro-babili relazioni presso la Curia, il doppio privilegio non è affatto pro-tezione abituale per le edizioni zilettiane e quindi qui sta a significare un particolare impegno organizzativo.
Ma quando Ruscelli stampava con il suo socio Pietrasanta o con al-tri puri tipografi come Griffio, Sigismondo Bordogna, i Guerra o Co-min da Trino, esecutori su commissione, o al massimo soci, tutta l’operazione editoriale si svolgeva sotto il suo controllo e, grazie alla
23 Rispettivamente, Bibliografia Ruscelli (= IACONO 2011) 21, 23, 24. 24 Bibliografia Ruscelli, 6. 25 Bibliografia Ruscelli, 43.
RUSCELLI E IL SISTEMA DEI PRIVILEGI A VENEZIA
205
richiesta e all’ottenimento del privilegio, a sua spesa e guadagno. Il privilegio non veniva concesso all’autore in quanto tale, ma a chi, pos-sedendo l’opera fisicamente (ovvero possedendo il manoscritto), af-frontava le spese della realizzazione tipografica. Poteva essere un ere-de, il curatore, l’editore, e perfino l’autore: non faceva differenza. Non si proteggeva un’astratta paternità dell’opera la cui consapevolezza non manca certo negli autori ma che in quest’epoca è ben lungi dall’essere approdata al riconoscimento come diritto individuale e proprietà immateriale. Quello che si protegge è l’investimento dell’e-dizione a stampa, da chiunque sia stata finanziata, dunque un mero investimento economico quantificabile. In questo modo, Ruscelli di-ventava proprietario della sua opera e poteva negoziare con diversi stampatori o editori le condizioni migliori per la sua realizzazione tipo-grafica. Si è parlato di Ruscelli come di un autore free-lance nell’editoria veneziana; questa condizione gli era garantita dal sistema dei privilegi. A paragone, si può constatare che quasi tutte le opere che Dolce allestì, in varie vesti, per Gabriele Giolito, furono privilegiate su richiesta dell’editore, che ne rimase quindi il proprietario per tutta la durata del privilegio.26
La fase più intensa della politica dei privilegi di Ruscelli è natu-ralmente quella intrapresa nella breve stagione, dal 1553 al 1555, in cui insieme a Pietrasanta e a personaggi minori, Ruscelli costituirà una società con un accordo di cui, è bene ribadirlo, non sappiamo quasi nulla.27 Mi sembra però chiaro il progetto editoriale che Ruscelli intende realizzare con Pietrasanta: affermarsi come editore delle proprie opere, e quindi goderne integralmente il successo, coinvolgendo un gruppo di autori che mostrano fiducia nel suo progetto. Era un’iniziativa in con-correnza diretta contro Giolito; non solo però un’impresa di disturbo, qualcosa di più, almeno stando alla felice riuscita di non pochi di questi titoli. Si tratta comunque di concorrenza frontale, come possiamo de-sumere dai generi di testi e dai libri pubblicati. E si tratta anche di un’impresa parassitaria, che cerca di approfittare del successo rag-giunto dalle edizioni di Giolito ponendosi nella scia e cercando di con-
26 Si confronti la serie dei privilegi di Giolito, in NUOVO-COPPENS 2005: 393-449.
27 TROVATO 1991: 252-255.
ANGELA NUOVO
206
fondere l’acquirente. Non esiste infatti altra giustificazione alla replica di un vistoso elemento illustrativo come il frontespizio silografico che orna alcune delle edizioni in 4° di Pietrasanta, copiato senza nessuna innovazione dal famoso ‘intaglio’ ariostesco del Giolito, sotto privile-gio dal 16 dicembre 1542, per 10 anni (e quindi ormai uscito dalla pro-tezione).28 Fino a quel momento, Giolito aveva pubblicato almeno 11 edizioni del Furioso (e avrebbe per altro continuato a usare quel fron-tespizio fino al 1559) e una stima prudente ci fa concludere che abbia potuto pubblicare questo frontespizio almeno in 10.000 copie, ma più probabilmente saranno state di più.29 Grandi numeri, insomma. Le i-mitazioni ruscelliane sono del 1554, e questo frontespizio viene utiliz-zato per tre opere prosastiche, quindi con una certa incongruità con l’uso giolitino, ma certamente allo scopo di confondere il cliente. Per le opere di Nifo, Erizzo, Fausto e Zanchi,30 è giusto ricordarlo, il de-tentore del privilegi è direttamente Ruscelli.
La politica dei privilegi della società Ruscelli-Pietrasanta-Giglio mira innanzi tutto a bloccare l’iniziativa tipografica a Venezia. La dici-tura ‘con privilegio’ sul frontespizio dimostra l’esistenza del privilegio veneziano e vale come notifica ai concorrenti. Come si è detto, il privi-legio non poteva esser chiesto per opere già pubblicate, e così queste escono senza protezione: ad esempio, le Satire di Ariosto e Alaman-ni.31 L’estensione dei privilegi fuori da Venezia inizia ad apparire nel 1554, per il Trattato di Erizzo e il Tempio della divina Giovanna d’Aragona,32 un’edizione importante quest’ultima, pubblicata dopo una lunga gestazione, alla protezione della quale certamente non di-fettava l’aiuto e la mediazione di personaggi illustri. Esiste addirittura una versione del frontespizio che porta, al posto del marchio della Vir-tù di Plinio Pietrasanta, quello di Cristoforo Madruzzo, di lì a poco governatore di Milano, dedicatario dell’edizione e traccia implicita del
28 NUOVO-COPPENS 2005: 223, 29 Purtroppo non sappiamo quali fossero le tirature delle edizioni giolitine
ma una valutazione intorno alle mille copie per titoli molto richiesti mi pare prudente.
30 Bibliografia Ruscelli, 20. 31 Bibliografia Ruscelli, 17. 32 Bibliografia Ruscelli, 29.
RUSCELLI E IL SISTEMA DEI PRIVILEGI A VENEZIA
207
fatto che uno dei privilegi ottenuti potesse essere stato rilasciato dal Senato di Milano. Sappiamo che in questo caso il privilegio a Venezia fu richiesto dal libraio Giacomo Giglio, che evidentemente si sobbarcò la maggior parte delle spese. Tanto affanno però si dimostrò inutile perché questa edizione non incontrò un vero successo.
Altro e ben diverso discorso occorre fare per i Secreti di Alessio Piemontese, l’opera di maggiore successo di cui Ruscelli curò la pub-blicazione. Lasciando da parte i problemi riguardanti l’autorialità del testo,33 è certo che tutta l’operazione restò sotto il controllo di Ruscelli. Egli ottenne il privilegio per quest’opera il 12 settembre 1555. La pri-ma edizione, firmata in quello stesso anno dal libraio Sigismondo Bordogna, diede origine ad una delle più ricche tradizioni a stampa di un testo italiano non letterario. Solo le edizioni italiane nel XVI secolo furono ventotto, più una lunga serie in Europa in varie lingue, come si può vedere nella bibliografia di Antonella Gregori.34 Ma analizziamo la storia di questo successo dal punto di vista dei privilegi. La princeps aveva un privilegio, della durata di 15 anni, rilasciato dal Senato vene-to e da altri (non menzionati) Signori italiani. Ma il libraio editore che aveva accettato di farsene carico non era stato in grado, probabilmen-te, di emettere una tiratura sufficiente, o aveva comunque lasciato in-soddisfatto Ruscelli. Ecco quindi l’edizione di Comin da Trino, di ben altro impegno, nel 1557, anch’essa edizione pubblicata per concessio-ne di Ruscelli, dato che inalbera i privilegi (fig. 2).
La tradizione dei Secreti ci permette di constatare quanto potesse essere forte la proibizione intimata da un privilegio. Infatti, nonostan-te un successo immediato e clamoroso con 15 edizioni europee perve-nute nei primi 5 anni, nessuna di esse fu realizzata a Venezia. La proi-
33 Ma è forse importante sottolineare che, nella supplica (pubblicata in TRO-
VATO 1991: 266 n. 96), Ruscelli dichiara di aver comprato il manoscritto latino dell’opera intitolata Secreti di Domino Alessio Piemontese e di averla quindi tradotta. Sarebbe ben strano che Ruscelli mentisse (e a quale scopo?) in una sede ufficiale quale una richiesta al Senato Veneto. È chiaro poi che l’intervento di cura del testo sarà andato ben oltre la semplice traduzione, implicando tutti quegli accorgimenti atti a far diventare l’opera leggibile e utilizzabile da un am-pio pubblico.
34 Bibliografia Ruscelli, pp. 247-299.
ANGELA NUOVO
208
bizione funzionava. Fino al 1563 ci furono, a Venezia, solo le due edi-zioni ruscelliane, mentre se ne ebbero cinque a Milano, due a Lucca, quattro a Pesaro (Bartolomeo Cesano),35 e infine due a Roma, in una geografia tipografica completamente inaspettata e, per molti aspetti, marginale. Questi erano certo gli Stati che non avevano concesso a Ruscelli alcun privilegio, e dove quindi si poteva liberamente stampa-re il testo. Naturalmente, nell’analisi occorre tenere conto che la tradi-zione di questi testi pratici, che i lettori, o meglio i praticanti, portava-no con sé per consultarli alla bisogna, è quasi impossibile da ricostrui-re in modo completo. Gli esemplari sono andati in gran parte distrutti. Ma, allo stato presente della ricerca bibliografica, resta assodato che a Venezia, la città dove sarebbe stato più facile ristampare l’opera, nes-suno si azzardò a farlo. Le tracce di una certa controversia si avverto-no quando si consideri che l’edizione milanese di Antoni esibisce il privilegio del Senato di Milano per 10 anni dal 1558,36 e l’edizione pe-sarese di Bartolomeo Cesano include, dal 1559, il privilegio del duca di Urbino,37 giocando sulla presenza di aggiunte, prime e seconde par-ti e così via: sono gli artifici tipici dell’editoria veneziana per aggirare gli altrui privilegi, ormai alla portata di tutti. Così, non solo queste amministrazioni concedevano il privilegio ad opere già stampate al-trove, cosa proibita a Venezia, ma danneggiavano ulteriormente il commercio delle edizioni veneziane escludendole dallo smercio nel loro territorio, come recita chiaramente il frontespizio dell’edizione Cesano.38
35 Cesano, uno stampatore che aveva iniziato la sua attività a Venezia, sape-va molto bene come muoversi in queste operazioni di ripresa dei più lucrosi ti-toli lagunari. Nel 1559 replicò a Pesaro l’edizione giolitina della Retorica di Bar-tolomeo Cavalcanti (EDIT16 CNCE 10434), per la quale Giolito non era riuscito ad ottenere il privilegio dal Duca di Urbino, privilegio che viceversa campeggia sul frontespizio del volume di Cesano (EDIT16, CNCE 10432). NUOVO-COPPENS 2005: 244-246.
36 EDIT16, CNCE 29195. 37 EDIT16, CNCE 47661. Le edizioni, con i loro diversi privilegi, sono accura-
tamente descritte in FERGUSON 1931. 38 «Con Privilegio dell’Illustriss. & Eccellentis. Signor Duca d’Urbino, che ni-
uno possa quest’opera stampare, né altrove stampata vendere per tutto il Do-minio di sua Eccellenza».
RUSCELLI E IL SISTEMA DEI PRIVILEGI A VENEZIA
209
In conclusione, l’analisi dei privilegi fornisce dati rivelatori a chi voglia ricostruire le carriere di autori, come Ruscelli, la cui conoscenza del mondo editoriale e delle sue regole era certamente molto maggio-re di quella dei veri grandi autori del periodo (il caso Tasso lo dimo-stra benissimo). Quella dell’ottenimento dei privilegi era una inces-sante preoccupazione degli editori ma anche di autori che come Ru-scelli nella stampa investivano e di essa, almeno in parte, vivevano. L’ottenimento del privilegio era l’essenziale viatico alla riuscita eco-nomica della pubblicazione di ogni testo nuovo, inedito, e che speras-se in un buon accoglimento da parte del pubblico. Quando Luigi Gro-to ci dipinge Ruscelli malato terminale, nell’aprile del 1566, ridotto pelle ed ossa, di un solo progetto riferisce di aver discusso con lui: la richiesta del privilegio per una sua opera, la Chiromantia. Ruscelli di-mostra di sapere che per tale testo non si sarebbe potuto ottenere il privilegio perché proibito dalle regole del Concilio di Trento e reso odioso dal clima culturale alimentato dal grande predicatore Gabriele Fiamma.39 Fino all’ultimo, Ruscelli dava prova di una perfetta cogni-zione delle leggi vigenti e dei rapporti di forza che governavano il mondo editoriale.
39 «Ruscelli dice che per le costituzioni che ha ordinato il Concilio in Trento,
e per le prediche che ha fatto il Fiamma in Vinegia, non crede che noi siam per impetrare il privilegio di stampar la Chiromantia» (lettera di Luigi Groto a Gio-vanni Maria Bonardi del 29 aprile 1566, in RUSCELLI 2010: xcvii-xcix).
ANGELA NUOVO
210
Fig. 1. Lo schema mostra, all’interno del totale delle edizioni riconducibili a Ruscelli, il numero di quelle uscite con privilegio.
RUSCELLI E IL SISTEMA DEI PRIVILEGI A VENEZIA
211
Fig. 2. Frontespizio di De’ secreti del reverendo donno Alessio Piemontese, In Venetia, per Comin da Trino, 1557 (EDIT16, CNCE 66849).
212
REGESTO BIBLIOGRAFICO
AGEE 1982
Richard J. A., The Privilege and Venetian Music-Printing in the Sixteenth Century, Ph. D. thesis, Princeton, Princeton University, 1982
ARMSTRONG 1990 Elisabeth A., Before Copyright. The French book-privilege system 1498-1526, Cambridge, Cambridge University Press, 1990
BOLZONI 1981 Lina B., L’Accademia Veneziana: splendore e decadenza di una utopia enci-clopedica, in Università, Accademie e Società scientifiche in Italia e in Germania dal Cinquecento al Settecento, a cura di Laetitia Boehm e Ezio Raimondi, Bologna, Il Mulino, 1981, pp. 117-167
DI FILIPPO BAREGGI 1988 Claudia Di F.B., Il mestiere di scrivere. Lavoro intellettuale e mercato li-brario a Venezia nel Cinquecento, Roma, Bulzoni, 1988
FERGUSON 1931 John F., The Secrets of Alexis, «Proceedings of the Royal Society of Medicine. Section of the History of Medicine», 24, 1931, pp. 225-246
FULIN 1882 Renato F., Documenti per servire alla storia della tipografia veneziana, «Archivio Veneto», 22, 1882, pp. 82-212 e 390-405
IACONO 2011 Antonella I., Bibliografia di Girolamo Ruscelli. Le edizioni del Cinquecen-to. In appendice Antonella Gregori, Saggio di censimento delle edizioni dei Secreti, Introduzione di Paolo Procaccioli, Manziana, Vecchiarelli, 2011
NUOVO 2003 Angela N., Il commercio librario nell’Italia del Rinascimento, Milano, Franco Angeli, 2003
NUOVO 2006 Angela N., Stampa e potere: sondaggi cinquecenteschi, «Bibliologia. An International Journal of Bibliography, Library Science, History of Typography and the Book», 1, 2006, pp. 53-85
RUSCELLI E IL SISTEMA DEI PRIVILEGI A VENEZIA
213
NUOVO-COPPENS 2005 Angela N. – Christian C., I Giolito e la stampa nell’Italia del XVI secolo, Genève, Droz, 2005
PAGAN 1973-1974 Pietro P., Sulla Accademia Venetiana o della Fama, «Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», 132, 1973-1974, pp. 359-392
PETTEGREE 2010 Andrew P., The Book in the Renaissance, New Haven and London, Yale University Press, 2010
PROCACCIOLI 2011 Paolo P., Introduzione a IACONO 2011
QUONDAM 1977 Amedeo Q., «Mercanzia d’onore»/«mercanzia d’utile». Produzione libra-ria e lavoro intellettuale a Venezia nel Cinquecento, in Libri, editori e pub-blico nell’Europa moderna. Guida storica e critica, a cura di Armando Petrucci, Roma-Bari, Laterza, 1977, pp. 51-104
QUONDAM 1983 Amedeo Q., La letteratura in tipografia, in Letteratura italiana, dir. da Alberto Asor Rosa, vol. II, Produzione e consumo, Torino, Einaudi, 1983, pp. 555-686
ROSE 1969 Paul Lawrence R., The Accademia Veneziana. Science and culture in Renaissance Venice, «Studi Veneziani», 11, 1969, pp. 191-242
RUSCELLI 2010 Girolamo R., Lettere, a cura di Chiara Gizzi e Paolo Procaccioli, Man-ziana, Vecchiarelli, 2010
RUSCELLI 2011 Girolamo R., Le dediche e gli ‘avvisi ai lettori’, a cura di Antonella Iaco-no e Paolo Marini, Manziana, Vecchiarelli, 2011
SERRAI 1991 Alfredo S., Storia della Bibliografia, 2: Le Enciclopedie rinascimentali (II). Bibliografi universali, a cura di Maria Cochetti, Roma, Bulzoni, 1991, pp. 598-614
TROVATO 1991 Paolo T., Con ogni diligenza corretto. La stampa e le revisioni editoriali dei testi letterari italiani (1470-1570), Bologna, Il Mulino, 1991