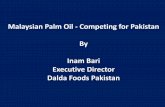Qualità della normazione regionale e tutela dei diritti sociali
Prima della Puglia. Terra di Bari e il sistema regionale in età moderna
Transcript of Prima della Puglia. Terra di Bari e il sistema regionale in età moderna
Biagio Salvemini, Prima della Puglia. Terra di Bari ed il sistema regionalein età moderna, in Storia d’Italia. La Puglia, a cura di Luigi Masella eBiagio Salvemini, Torino, Einaudi, 1989, pp. 3-218
IPROLOGO. LA NASCITA DI UNA 'PERIFERIA INTERNA'.
La Puglia centrale e il mare.
Landolfo Rufolo, il protagonista della novella IV, giornataII, del Decameron, era uno di quegli “uomini ricchi e procacciantiin atto di mercatantia”che abitavano la costa di Amalfi, quandodecise di 'battere' la fortuna invece di accontentarsi del giàmolto che ricavava da una pratica mercantile cauta: “comperò ungrandissimo legno e quello tutto, di suoi denari, caricò di variemercatantie, ed andonne con esse in Cipri”. Ma lì erano giàapprodate molte altre navi cariche delle sue stesse merci, ed eglidovette svendere tutto ricavandone il necessario a comprare “unlegnetto sottile da corseggiare”, col quale andò a lungodepredando turchi, ma finì depredato da genovesi. Teniamo per ilmomento in mente tutto questo e vediamo come Landolfo giunge allieto fine delle sue vicende: lasciatosi l'avventuroso epericoloso Oriente alle spalle, egli sbarca a Brindisi, vestito distracci ma con un sacco pieno di gioie al collo, e di lì “marinamarina si conduce infino a Trani, dove trovati de' suoi cittadinili quali erano drappieri [...] fu da loro rivestito [...] ed oltrea questo, prestatogli il cavallo e datagli compagnia, infino aRavello li rimandarono”.
Era, questo risalire la Puglia lungo il mare, un itinerariomedievale consueto, una via facile per chi tornava dall'Oriente,anche perché la costa adriatica della parte centrale della regioneera una delle pochissime meridionali non paludose e malariche edera sede di civiltà urbana e mercantile rigogliosa. Il geografomusulmano Edrisi nel XII secolo, o i pellegrini di ritorno dallaTerra Santa capeggiati da un Anselmo Adorno di Bruges nelQuattrocento, ce ne hanno consegnato descrizioni efficaci,lasciando immersi nell'oscurità i radi e spopolati centri dellaMurgia interna, inseriti in vasti organismi feudali1. Verso1 Cfr. per tutti, su queste questioni, le numerose indicazioni e la bibliografiacontenute nei primi quattro capitoli di M. PETRIGNANI e F. PORSIA, Bari, Roma-Bari 1982. Per la terminologia riferita alla geografia storica dell'area cfr. P.F. PALUMBO, Puglia una e trina, in « Studi storici medievali», 1983, n. 3, PP.359-63.
1
l'interno si sarà forse avventurato di tanto in tanto l'altropersonaggio della Puglia di Boccaccio, quel Donno Gianni daBarletta che, dati i mezzi scarsi a sua disposizione, deveesercitare furbizia e saper vivere in orizzonti sociali egeografici più meschini, e fa il prete ed insieme il vaticale,portando con una cavalla “mercatantia in qua ed in là per le fieredi Puglia” (giornata IX, novella X). Ma è solo un'ipotesi. Sta difatto che, alla fine della vicenda, Donno Gianni e il compare dalui gabbato vanno assieme non più in là che alla fiera di Bitonto,grande centro oleario situato in quel sistema insediativo giàtipico della Puglia preromana, fatto di coppie di centricorrispondenti, quello originario alcuni chilometri all'interno,l'altro sulla costa a commercializzare i prodotti del primo. Ilmare era l'orizzonte delle città della Puglia centrale, e questoaveva finito quasi sempre per invertire ruoli e gerarchieoriginarie della maglia insediativa a favore delle città portuali.
Laddove poi, all'altezza di Bari, il sistema delle “cittàcorrispondenti” subiva uno strappo vistoso e la conca disegnatadalla modesta orografia murgiana ospitava una folla di centriminori, l'egemonia del centro costiero sul suo entroterraimmediato era nelle cose ed emergeva nei vincoli giuridici epolitici, nell'organizzazione ecclesiastica, nei nessi economiciche subordinavano a Bari i suoi “casali”.
2. La grande crisi tre-quattrocentesca e le nuove gerarchie territoriali.
Era, quest'ultima, una anomalia per il momento senzaconseguenze sugli equilibri economici dell'area; anzi, laparticolare collocazione della 'città' non riuscì ad impedire chela grande Bari del tempo di Edrisi diventasse un centro modestonella Puglia di Anselmo Adorno, nel quadro di processi cheandavano modificando incisivamente il volto della regione. Lagrande crisi tre-quattrocentesca e i disordini, le guerre, laconfusione politico-amministrativa che l'accompagnano spopolano einselvatichiscono in particolare la Puglia centrale,determinandouna riorganizzazione, al tempo stesso, dell'economia agricola edella maglia urbana. Le Wunstungen di Terra di Bari, a differenzadi quelle di altre aree meridionali inserite nel commercio ingrande come la Capitanata e la Sicilia, non sembrano toccare inodi principali della rete insediativa, che a metà Quattrocentopresenta sostanzialmente la stessa composizione e densità dellafine del Duecento, ma massiccio è lo svuotamento degli
2
insediamenti di livello gerarchico basso che le città avevanopropagginato nelle campagne2. “Or come va il mondo e se mutano lecose del mondo - afferma Bisanzio Lupis, vissuto a Giovinazzo traQuattro e Cinquecento - prima servevano [i trappeti] intro loliveto, poi se mutarono intorno la Cità, hora son redutti entro laCità”, cosicché della vecchia situazione economica ed insediativanon restano che vestigia: “in testimonio de casali, trovarite nelpiano nostro tante cisterne, tante fosse, forni, laghi, torri inpiedi”, e nel centro cittadino “non ha casa che non habia fosse[...] dove se reducevano le frumenta de casali”3. Essendo “le cosedel mondo” ormai e definitivamente mutate, al tempo in cui icasali erano i luoghi della produzione e della trasformazione delprodotto e le città quelli della distribuzione e del consumo, erasubentrato il tempo dell'accorpamento delle funzioni. Il processodi strutturazione della città come costruito e abitato, di controal non costruito e disabitato della campagna appare, a fineQuattrocento, ormai concluso.
Assieme alla selezione e semplificazione ulteriore dellamaglia urbana, va avanti una modificazione e un irrigidimentodelle gerarchie territoriali all'interno della stessa fasciacostiera, che redistribuisce gli elementi di 'urbanità' edirezionalità interni all'area e li colloca in gran parte sullacosta all'estremo nord della provincia, con propaggini brevi versol'interno. A questo mondo di raggio piccolo ma legato dai trafficiai centri motori della civiltà europea, fa riferimento l'immagineconsueta del tardo medioevo pugliese quale “età di grandefiorimento e per la sua politica libertà, e per la prosperitàeconomica, e per il progresso civile”, alla quale sarebbesucceduto “un lungo periodo di sosta, se non di regresso politico,civile e sociale, durato quasi due secoli e mezzo, prima diriprendersi, nella seconda metà del secolo XVIII, il cammino inavanti, là donde il secolo XV si era fermato4“. Non che vi fossero
2 R. LICINIO, Uomini e terre nella Puglia medievale. Dagli Svevi agli Aragonesi,Bari 1983, pp. 6o-6i e 149 57; M. A. VISCEGLIA, Tenitorio, feudo e poterelocale. Terra d'Otranto tra medioevo ed età moderna, Napoli 1988, P. 50.3 Cronache di Giovinazzo di Messer Bisanzio Lupis... per cura di Giuseppe DeNinno, Giovinazzo 1880, PP. 77 e 36. «Vestigia» dei casali sono visibili ancoraoggi; vedi, ad esempio, V. VALENTE, Gli antichi casali di Molfetta, Molfetta1981.4 F. CARABELLESE, La Puglia nel secolo XV da fonti inedite, Bari 1901, p. 63.Fra i numerosi lavori prodotti dalla robusta storiografia pugliese fra Otto eNovecento collocati sulla stessa linea cfr., oltre ai numerosi altri diCarabellese, V. VITALE, Trani dagli Angioini agli Spagnoli. Contributo alla
3
assenti elementi di dipendenza 'coloniale': la collocazione di unafetta amplissima della Puglia in una divisione internazionale dellavoro che assegnava ad essa il ruolo di fornitrice di grano, olioe lana in cambio di manufatti era ben visibile già prima dellagrande crisi tre-quattrocentesca, ma era una dipendenza diqualità diversa da quella di età moderna. Il mondo col quale laPuglia tardo-medievale era connessa si articolava ancora in unamolteplicità di unità politiche ed economiche che intrattenevanofra loro rapporti variegati, ad egemonie non rigide e prefissate.Capitale tedesco, flotta mercantile veneziana, rete bancariafiorentina, produzione agricola pugliese avevano ciascuna unproprio spazio di autonomia5, e lo stesso ruolo di Napoli qualecentro direttivo e di controllo era ben lungi da quello oppressivoda essa assunto nel Cinquecento. Il gioco del dare e dell'averefra centri e periferie era ancora complesso, e a tirare le sommenon si hanno risultati scontati. Risorse, personale, istituzioni,tecniche elaborate nei mondi 'centrali' lasciavano segni vistosisul volto delle città costiere, e il loro panorama sociale sipresentava come un mosaico variopinto di colonie - quella cheaccoglie a Trani Lamberto Rufolo vi era stata dedotta alla finedel Duecento ed era insediata in una “ruga Ravellensium” -organizzate e ben conscie della propria origine ed autonomia, matutt'altro che impenetrabili nei confronti dell'elemento locale e,per ciò stesso, prive di ambizioni monopolistiche6.
Così gli spazi in cui mercanti, affaristi, armatori pugliesiriescono a inserirsi sono più consistenti di quanto appaia nellatradizione interpretativa che fa capo alla thèse di Yver7: fra le 50navi che tra il marzo del 1303 e l'aprile del 1304 salpano daBarletta, ben 16 sono registrate in quello stesso porto, e una
storia civile e commerciale di Puglia nei secoli XV e XVI, Bari 1912.5 A. LEONE, Il versante adriatico del Regno nell'ultimo quarto del sec. XV:Trani, 1484-1488, in «Archivio storico per le province napoletane», 1981, inparticolare pp. 221-22; cfr. anche, dello stesso autore, Caratteri dell'economia mercantile pugliese (1467-1488), in «Annalidell'Istituto italiano per gli studi storici », 1979-80, PP. 105-28. Inparticolare sul ruolo dei Veneziani vedi ora m. JACOVIELLO, Sui trafficiveneziani nel Mezzogiorno d'Italia durante la seconda metà del secolo XV, in«Atti dell'Accademia pontaniana», 1986, pp. 159-179, e VISCEGLIA, Territoriocit., pp. 143 sgg6 R. COLAPIETRA, Profilo storico-urbanistico di Trani dalle origini alla finedell'Ottocento, Bari 1981, p. 20.7 Per una critica all'impostazione di Yver cfr., ad esempio, M. POPOVIC-RADENKOVIC, Le relazioni Commerciali fra Dubrovnik (Ragusa) e la Puglia nelperiodo angioino (1266-,442), in «Archivio storico per le province napoletane»,1958, PP. 73-104; 1959, PP. 153-2o6.
4
realtà non diversa ci restituisce il registro del portolanopugliese per l'anno 1486-87, in cui un ruolo attivissimo sembranoavere soprattutto navi e mercanti tranesi, sia pure nel quadro diuna strategia disegnata dai Medici8. E fra Trani che funge da,stanza di compensazione per le transazioni di un'ampia arearegionale e da sede privilegiata delle rappresentanze politiche esocietarie, il grande porto cerealicolo di Barletta e il grandecentro di produzione olearia di Bitonto circola un flusso robustodi merci e capitali, organizzato da un gruppo di imprenditorilocali e forestieri, spesso legati da alleanze matrimoniali o davincoli di affari, siano questi ultimi formalizzati in società divasto respiro o pattuiti oralmente in vista della compravendita diuna partita di stoffe in fiera9. La vita economica di questi centrine ricava un tono alto che li distingue nettamente dagli altriinsediamenti costieri e soprattutto da quelli dell'interno. Ladipendenza dai 'centri' dell'economia mondiale lascia ancoramargini per un'articolazione di dipendenze interne all'area: spazidi autonomia imprenditoriale e gerarchizzazione della strutturainsediativa erano due facce della stessa realtà provinciale.
3. La 'dipendenza di età moderna'.
All'uscita dal tunnel dei decenni tormentati da guerre,occupazioni militari, incertezza economica e politica fra Quattroe Cinquecento, la qualità della dipendenza, i caratteri dellaperifericità dell'area sembrano modificarsi significativamente, inrelazione strettissima con i mutamenti del clima politico edeconomico internazionale. La tensione dei rapporti interstatali siva facendo spasmodica, nel mentre grandi città dell'Europarinascimentale, avide di derrate alimentari e materie prime, edipendenti per il loro approvvigionamento dalla precariapercorribilità di vie terrestri e rotte marine, vengonopericolosamente spinte verso una crescita ulteriore anche dal8 N. Nicolini, Sul traffico navale barlettano dal marzo 1303 all'aprile 1304, inM. PAONE (a cura di), Studi di storia pugliese in onore di Giuseppe Chiarelli,vol. I, Galatina 1972, pp. 607-32; C. SALVATI (a cura di), Copia QuaterniBernardi de Anghono Mag. Actorum penes Mag. Portulanum Apulie de TractisExtractis... a Partibus Civit. Manfridonie, Baroli etc. A. V. Ind. (1486-1487),in Fonti Aragonesi, a cura degli Archivisti Napoletani, vol. VI, Napoli 1968,pp. 1-79. Cfr., per quanto riguarda quest'ultimo documento, l'utilizzazionefattane da T. PEDIO, Il consolato veneto a Molfetta dal XV al XVIII secolo, in«Studi storici meridionali », 1981, in particolare PP. 38-399 Sulle fiere e i circuiti mercantili pugliesi cfr. A. GROHMANN, Le fiere delRegno di Napoli in età aragonese, Napoli 1969, pp. 127 sgg
5
concentrarvisi delle funzioni della statualità moderna e competonospasmodicamente per sovrappiù incapaci di tenere il passo dellacrescita demografica globale10.
In particolare per un'area come la nostra, diventata marea difrontiera dell'organismo imperiale spagnolo e produttrice disovrappiù di valore marginale sempre più alto, la subordinazionedei giochi economici ai giochi politici si accentua pesantemente ele linee di forza dei rapporti di dominio e subordinazione, finoallora gravitanti confusamente verso poli vicini e lontani, vannoordinatamente convergendo verso pochi grandi centri direzionali.Col disfarsi dei grandi 'stati' feudali, in una parte larghissimadella Puglia centrale feudi, vescovati e autorità cittadineritagliano le proprie dimensioni territoriali su quelle degli agridi singoli insediamenti, e lo stato assoluto meridionale,ponendosi come interlocutore diretto di ciascuno di essi,ricaccia la lotta politica locale, a lungo centrata sui rapportidi dominio fra centri di potere territoriale, all'interno dellemura urbane, nelle quali essa andrà irrimediabilmenteimbozzolendo. Le stesse funzioni finanziarie, amministrative,giurisdizionali facenti capo all'apparato centrale statale, unavolta disperse fra una molteplicità di centri della stessaprovincia, concorrono a confonderne le gerarchie interne11.Contestualmente la sua subalternità economica si accresce, ilruolo direzionale di Napoli diventa prevaricante, il gioco dibilanciamento reciproco delle presenze imprenditoriali forestieresi semplifica drasticamente, lasciando emergere ruoli di comandodefiniti e contrattati, sulla testa della provincia, fra lecapitali; e quanti non riescono a ricollocarsi nel nuovo quadro -gli Ebrei in primo luogo - ne vengono espunti12.
Non a caso la città provinciale più colpita, quella che vive10 Cfr. M. AYMARD, Venise, Raguse et le commerce du blé pendant la seconde moitié du XVII siècle, Paris 1966.11 Su queste questioni - oltre la traccia e le indicazioni di G. GALASSO, Puglia:tra provincializzazione e modernità (secc. XVI-XVIII), in C. D. FONSECA (a curadi), Civiltà e culture di Puglia, vol. IV: La Puglia tra barocco e rococò,Milano 1982, PP. 373-86 - cfr. A. SPAGNOLETTI, «L'incostanza delle umane cose».Il patriziato di Terra di Bari tra egemonia e crisi (XVI-XVIII secolo), Bari1981, e, su un altro versante e con diversa angolazione, L. DONVITO, Societàmeridionale e istituzioni ecclesiastiche nel Cinque e Seicento, Milano 1987. Peril caso di Terra d'Otranto, in parte diverso, cfr. VISCEGLIA, Territorio cit.12 V. BONAZZOLI, Gli Ebrei nel Regno di Napoli all'epoca della loro espulsione,in «Archivio storico ita1 979, PP. 495-559; 1981, pp. 183-287; e più inparticolare per la nostra area, C. COLAFEMMINA, Presenza e attività di Ebrei aMolfetta nei secoli XII-XVIII, in Atti del Convegno di studio su «Momenti distoria molfettese», Bari 1987, pp. 23-47.
6
il trapasso nel nuovo clima come declino demografico,destrutturazione, discesa verso la condizione di “ciudad perdida ymedio deshabidada y arruynada”13 degli anni '80 del Cinquecento, èTrani, il centro direzionale del Quattrocento provinciale. Ma, piùin generale, è la condizione di città marittima che perdespecificità nel restringersi degli spazi di autonomiaimprenditoriale. Le gerarchie insediative fondate sul momentodella commercializzazione, essendo questo sempre più eterodiretto,perdono di consistenza, i proventi dell'intermediazionecommerciale scivolano sui centri costieri concentrandosi a Napolie nei mercati di sbocco, e il ruolo della Puglia centrale qualeproduttrice di derrate consumate lontano tende a emergere nellasua essenzialità, provocando un'imponente ascesa assoluta erelativa delle città dell'interno cerealicolo. Agli occhi degliosservatori torri e castelli caratterizzano ormai le coste14 piùche porti e magazzini, non perché i traffici siano scomparsi, maperché la loro rilevanza per la società locale, la loro capacitàdi produrvi ceti specializzati e accumulazione di ricchezza apparedrasticamente ridotta.
Più in generale, una volta giunti a capo di tutto questo, èl'intera geografia urbana dell'area a diventare confusa,illeggibile, priva di poli e gerarchie. A metà Cinquecento nellaDescrittione di Leandro Alberti la costa, risalita come sempre da suda nord, serve ormai solo per ordinare l'esposizione come la rigadi un foglio guida la scrittura, e l'esaltazione retorica degliinsediamenti che vi giacciono è smentita dalle immagini ricorrentidei porti interrati e delle navi che vi si fracassano sotto icolpi della tramontana. Anche per “i luoghi posti fra terra”, cheinvece “giaceno senza ordine”, Alberti non sa trovare altrocriterio per il procedere della descrizione che quello di tornarea risalire la provincia più all'interno, zigzagando fra i centrimurgiani e quelli della cimosa costiera, a partire dalla zona acavallo fra Terra d'Otranto e Terra di Bari, i cui abitanti dagliolii “portati in qua e in là per l'Italia et etiandio fuori [...]cavano gran guadagno”, fino ai confini della Capitanata, dove gliAndriesi sono “molto trafiganti a mercatantare, onde ne riportanoassai guadagni”15. Se vi sia un bandolo della matassa e dove lo sipossa rintracciare è ormai questione oscura, e tale rimarrà per13 COLAPIETRA, Profilo storico-urbanistico di Trani cit., p. 39.14 Naturalmente le Costruzioni difensive che andavano sorgendo sulla costa pugliese si inserivano in un quadro Militare e politico più vasto,suggerito, fra gli altri, da R. CISTERNINO, Torri costiere e torrieri del Regnodi Napoli, Roma 1977.
7
secoli, lungo i quali viaggiatori ed osservatori, pur con varioapprofondimento e perspicacia e con vario giudizio di merito,riproporranno l'immagine di una provincia, per così dire, senzacapoluoghi. Lo stesso Galanti, contrapponendo all'internocerealicolo-pastoral-feudale, le cui città giacciono in“estesissimi demani senza villaggio alcuno”, quella costaolivicola che “è la parte più pregevole del Regno, perchéracchiude una catena di città di certo rango”, dovrà poiaggiungere di non riuscire a trovare tra queste ultime “niunacittà di certa grandezza”16.
Il modello insediativo che gli osservatori hanno in testa,quello articolato in poche città 'terziarie' e vasti contadipunteggiati di villaggi subordinati economicamente eamministrativamente alle prime, si rivela impotente a interpretareuna realtà di borghi che, nel mentre si ingigantiscono anche peril concentrarvisi degli abitanti dei campi, vanno perdendoelementi di 'urbanità' e nessi direzionali e gerarchici fra diessi. La sproporzione vistosa fra la notevole dimensionedemografica dei centri e la modestia degli effetti urbani da essigenerati fa, di questo, un mondo alquanto enigmatico di cittàsenza contadi e contadi senza città, nel quale diventaimproponibile concettualmente l'opposizione-integrazione,fecondissima e tipica della civiltà europea, fra i due mondieconomici, politici, mentali, della città da un lato, dellacampagna dall'altro, dal momento che i 'contadini' sono tutti'cittadini' e, viceversa, una parte larghissima di 'cittadini' ècostituita da 'contadini'. Il rapporto città-campagna si degradaqui a dialettica fra cose, tra ambienti fisici opposti, quellocostruito ed abitato ergendosi di botto, con un ammasso diedifici alto e compatto costretto nella cerchia breve delle mura,sui campi pressoché disabitati. La città non si caratterizza comespazio sociale liberato dal “sudiciume campestre”17, ma comeraggrumarsi di quest'ultimo in superfici straordinariamenteristrette assediate dal deserto coltivato. Il quale ultimo,d'altronde, non si dispone in fasce concentriche di colturecostruite - secondo il modello di campagna periurbana 'normale'
15 L. ALBERTI, Descrittione di tutta Italia..., Bologna 1550, in particolare pp.218 e 220.16 Cfr. l'Introduzione all'edizione a cura di F. ASSANTE e D. DEMARCO di Delladescrizione geografica e politica delle Sicilie, Napoli 1969, vol. 1, p. XXX17 Del quale l'umanista Ambrogio Leone affermava, all'inizio del Cinquecento, chela sua città, Nola, si era sbarazzata (A. LEPRE, Storia del Mezzogiornod'Italia, vol. I: La lunga durata e la crisi (1500-1656), Napoli 1986, p. 95).
8
alla Von Thunen - sulle esigenze di consumo della città, ma ècostituito, al di là di quel residuo risicato di una condizionediversa che è il “ristretto”, da paesaggi monotoni in cui siproduce a perdita d'occhio una sola derrata, quella destinata algrande commercio. La differenza rispetto alle forme diinsediamento dell'altra provincia meridionale in cui si affollanocentri di taglia consistente, Terra di Lavoro, è, dal nostro puntodi vista, esemplare: lì le città si sfrangiano in insediamenticontermini con funzioni varie, e uno di essi, specializzandosinella fornitura di servizi urbani secondari e terziari, respingein fuori la società campestre e propone una differenziazionesociale fra città e campagna proprio nel mentre, spargendo caseper i campi intorno, la sdrammatizza sotto il profilo fisico epaesaggistico; qui la cesura nettissima fra il paesaggio fisicodella città e quello della campagna si rovescia nella lorotendenziale indistinzione economico-sociale18.
La Puglia centrale, da secoli segnata da un'incisiva presenzaurbana, si immerge riell'età moderna come una delle aree piùrurali di una delle 4 campagne d'Europa, il Mezzogiorno. Percomprenderla occorrerà uscire dalle mura che racchiudono unaurbanità ormai stravolta e rinsecchita, analizzarne la società apartire dalle forme, dai tempi, dai luoghi dell'agricoltura.
4. Un regionalismo rurale.
Il fatto è, però, che la ruralità di questa ed altre areemeridionali produttrici di derrate per il mercato internazionale,e di altre analoghe aree mediterranee, è particolare quanto leforme dell'insediamento, e di conseguenza è assai difficoltosa lacollocazione di esse nei sistemi di centralità e marginalitàdell'Europa moderna.
L'operazione storiografica più consueta, quella che le tieneassieme alle aree mercantili dell'Europa orientale sotto una solaetichetta - perifericità, marginalità, sottosviluppo et similia -mi pare sostanzialmente infeconda. I 'centri' del mondo estraggonomerci dalla Polonia entrando in rapporto quasi esclusivamente congli apparati del potere locale, rafforzandone l'influenza, lacapacità di dominio; sui circuiti granari dell'est viaggianoquantità imponenti di derrate, ma quantità scarse di valorioccidentali, di forme della politica, di stimoli all'imitazione edalla competizione. I rapporti mercantili, lungi dallo scompaginare
18 Cfr. le cifre e le indicazioni ibid, cap.9
le logiche sistemiche del feudalesimo locale - a partire dairapporti di produzione fondati sul servaggio - le rafforzano,rendendo euristicamente efficace quella “teoria economica”speculare rispetto all'economia politica classica, proposta daKula in riferimento alla Polonia di età moderna.
Un esercizio di questa natura risulterebbe improponibile peril Mezzogiorno. Le merci che quest'ultimo scambia con le areeforti dell'Europa moderna circolano assieme alle influenzeculturali e politiche, alle esperienze istituzionali, alle formedi organizzazione dell'economia, con effetti che investono, oltreai gruppi di comando, la società alta e bassa di fasce consistentidel territorio. Gli stimoli del mercato internazionale e irapporti di forza sul piano politico-militare inducono quilibertà e mercificazione del lavoro, monetizzazione diffusa deirapporti di scambio, risposte 'positive' della produzione aiprezzi, in misura spesso maggiore che nelle campagne dei mondi'centrali', le cui città, anche per ragioni di consenso, tendono anon manomettere gli equilibri agricoli interni quando possonopremere su quelli delle periferie.
Anche perché tutto questo non può in alcun modo essere presoper precorrimento di sviluppo. La estroversione mercantile diqueste aree in condizioni di antico regime non dà certo ad essevantaggi in termini di felicità collettiva rispetto ai mondicontadini 'normali' che le circondano, alle forme di produzione ecircolazione volte prevalentemente a raggiungere l'autosufficienzadelle comunità, la sicurezza annonaria, l'equilibrio sociale, lariproduzione semplice; al contrario esse diventano spesso soggettea forme di precarietà lacerante, allogano vere e proprie 'societàdel malessere' che umanizzano in maniera distruttiva il paesaggio,con il sistema a campi ed erba organizzato in grandi unitàproduttive e l'insediamento accentrato dove si ammucchiano masserurali in rapporto saltuario e superficiale con l'ambiente, inpreda a una forte mobilità territoriale e a una demografia ferocee sprecona, fatta di altissimi tassi di mortalità che tallonanoaltissimi tassi di natalità. Integrazione piena nel circuito dellaciviltà europea e subordinazione alle esigenze dei centri motoridi quella civiltà si intrecciano sulle superfici di contatto delMezzogiorno col mercato internazionale, danno ad esse un tonoparticolare, definiscono le loro permanenze territoriali e, nelcontempo, i percorsi di ricerca da seguire nel tentativo diricostruirle.
Che occorra aggiungere un'altra casella a quelle individuate
10
da Wallerstein, etichettando realtà di questo tipo come 'periferieinterne', da distinguere dalle 'periferie esterne' della servitùdella gleba e della rifeudalizzazione?
Nel caso che questa ulteriore partizione tipologica risultasseutile, essa finirebbe comunque per contenere un ventaglio ampio disituazioni, determinato dall'ambiguità profonda insita nellacollocazione di queste aree, da quel loro percorrere la storiamoderna in bilico fra spinte a una dipendenza supina e distruttivae stimoli positivi prodotti dal contatto con valori e ceti deimondi 'centrali'. Spesso i due momenti si intrecciano, a volte unatendenza prevale sull'altra, in rapporto al groviglio dicondizioni soggettive e oggettive che segna ciascuna realtà.
Nell'ambito stesso della parte orientale di quella che erastata la Apulia romana, nel suo complesso una sorta di marcamercantile del Mezzogiorno, i confini amministrativi normanni,lungi dal ripartire artificiosamente un continuum territoriale,individuano lungo l'età moderna porzioni di territorio dotate dilogiche radicalmente diverse. La Capitanata costituisce un casoestremo di rapporto debole fra uomo e ambiente, di scarsaconsistenza dei nessi interni alla società provocata da unamercantilizzazione spinta ed eterodiretta. E' probabilmente suquesto sfondo che andrebbero riconsiderati gli esiti che lì ebbela crisi tre-quattrocentesca: la catastrofica distruzione diinsediamenti da un lato, dall'altro - in qualche modo connesso alprimo fenomeno - il gigantesco esperimento realizzato dallo Statoaragonese nel corpo della società della Puglia piana senzascendere a compromessi con gli interessi colpiti, dellaformalizzazione amministrativa dell'antico flusso dellatransumanza fra la montagna abruzzese e il Tavoliere, secondomoduli già realizzati in aree simili e che in nulla avrebberocontribuito a mettere in comunicazione feconda la “cultura deltratturo” con quella della “via agreste”19. Ne sarebbe risultata,secondo un osservatore cinquecentesco dallo sguardo acuto, una“provincia assai giovevole alle altre del regno, ma in quanto a sé[...] la più inutile che vi sia”: essa “è malissimo abitata” e pergiunta da “uomini inetti alle armi et alle fatiche”; “di non buonaarea, priva di alberi e di legna, poverissima di acqua”,“infettata” d'estate “da grandissimi caldi et innumerabili moschee gran copia di serpi”; e però, “dall'altro canto produce [...]19 V. BONAZZOLI, L'economia agraria nella società della Puglia cerealicolo-pastorale nel XVIII secolo, in «Annali dell'Istituto italiano per gli studistorici», 1973-75, P. 146. Ma cfr., su questi temi, gli ormai classici lavoridella Klapish-Zuber.
11
grano, orzo, et altre biade in tanta quantità che veramente si puòchiamare il granaio non solo di Napoli e del Regno, ma di moltecittà d'Italia, vi si fa il sale et il salnitro [...] e nutriscela maggior parte del bestiame del Regno, che da' luoghi montuosi efreddi discende al piano”20. Al centro di questa provincia Foggia,sede della Dogana della mena delle pecore, si afferma come poloburocratico-mercantile fra i più importanti del Mezzogiornogarantendo, in un certo senso, l'“inutilità” di questa terra a sestessa, sanzionando l'estraneità della scarsa popolazione rispettoai luoghi che abita, consegnati in larga parte, da un lato,all'internazionale mercantile del grano e della lana, dall'altroai pastori abruzzesi.
Al lato opposto, in Terra d'Otranto, ampie fasce diagricoltura contadina 'normale' e un certo controllo sulterritorio da parte della rete dei poteri feudali ed aristocraticiriescono a coesistere con la mercantilizzazione; un grande porto'coloniale' come Gallipoli, rivolto per rotte ed egemonie ai maridel Nord, sostiene l'altro polo pugliese, Lecce, rimasta a lungofra le maggiori città del Mezzogiorno continentale dopo Napoli,quella che più avanza pretese di urbanità di antico regime21, conle sue scenografie barocche, i suoi cerimoniali, i palazzi in cuila feudalità provinciale fa mostra di sé e spende i redditiricavati dalla commercializzazione a lunga distanza di decime eterraggi.
Stretta fra queste due aree diversissime entrambe dotate dipolarità forti, Terra di Bari, con le sue polarità deboli e il suopaesaggio variegato, sembra presentare caratteri distintivi menoevidenti, un'identità che riesce a definirsi in negativo, per ciòche essa non è e per ciò che ha di diverso rispetto alle provinceoltre i suoi confini. Lo stesso giudizio di Porzio, così comequello dell'Alberti, finisce per essere poco incisivo, generico,anche se entusiasta: Terra di Bari, “benché sia picciolaprovincia, per bontà del terreno e per moltitudine di terre non èinferiore a nessun'altra del Regno, e forse d'Italia. Abonda digrano, d'olio, di zafferano, di bambagia, di vino, di salnitro, disale e di mandorle in tanta copia che vi si veggono boschi diquegli alberi. Per le quali cose vi concorrono assai mercanti”22.
20 C. PORZIO, Relazione del Regno di Napoli al Marchese di Mondesciar Viceré diNapoli tra il 1577 e il 1579, in ID., LA congiura dei baroni del Regno di Napolicontro il Re Ferdinando Primo e gli altri scritti, a cura di E. Pontieri, Napoli1964, p. 326.21 Cfr. M. FAGIOLO e V. CAZZATO, Lecce, Roma-Bari 1984, P. 70 e passim,22 PORZIO, Relazione cit., p - 3 24.
12
E purtuttavia è in particolare intorno a questa “picciolaprovincia” che si organizzeranno gerarchie, egemonie, polaritànuove che tenderanno a risarcire le lacerazioni storiche interneal territorio della Apulia romana. Il senno di poi spinge arintracciare la 'genealogia'23 del regionalismo pugliesecontemporaneo nelle logiche territoriali rurali di Terra di Bariin età moderna, anche se queste appaiono implicite, noncostituiscono programmi, attraversano in maniera limitata ladialettica dei poteri locali. Espropriata in larga parte laprovincia di autonomia direzionale e ridotta di conseguenza lacapacità dei suoi ceti dominanti di segnarne incisivamente gliequilibri interni, occorrerà inseguirne la territorialità inparticolare sul piano delle strutture, cercarla nel momentoeconomico, del quale la mercantilizzazione e la monetizzazionedegli scambi va delineando una qualche rudimentale autonomia daglialtri momenti della vita associata.
Guardate da vicino, l'articolazione colturale, la varietà delpaesaggio agrario e sociale che coesistono con l'estroversionemercantile 'dipendente', configurano forme di funzionalità fraaree interne alla provincia, individuano un sistema territoriale,a suo modo una 'regione', che si configura nella crisidell'urbanità tardo-medievale e dell'autonomia dei ceti dominantilocali ed è destinata a sciogliersi nella più ampia regionecontemporanea costituitasi, lo vedremo, attorno al riemergere dinodi urbani baresi e alla ritrovata capacità dei ceti dominantilocali di pensare, progettare e costruire il territorio.
Il succedersi cronologico di questi due regionalismi diconsistenza, qualità, dimensioni diverse non è certo traducibilein nesso causale, rigidamente genetico; purtuttavia l'uno permettedi 'comprendere' meglio l'altro, costruisce ambiti problematici incui i percorsi molteplici di queste vicende riescono, in qualchemodo, a dare senso.
II.
UN SISTEMA REGIONALE DI ETA' MODERNA.
I. I vuoti murgiani e i segni dell'uomo.
23 Il riferimento è a Nietzsche e alla lettura che ne dà Foucault in Microfisicadel potere, Torino 1977, pp- 29-54.
13
Nell'immagine consegnataci da cronisti, geografi, viaggiatori,da Domenico da Gravina in poi, l'amplissima area interna collinaredi Terra di Bari sembra organicamente integrarsi nella fasciacerealicolo-pastorale che dai piedi del Gargano e dell'Appenninodauno scende, senza soluzioni di continuità, sulla conca diTaranto.
La natura calcarea del suolo, a differenza del riempimentoalluvionale del Tavoliere, impedisce l'impaludamento anche negliavvallamenti ma rende più drammatici gli effetti della scarsezzadelle precipitazioni annullando in pratica le acque superficialistabili, e contribuisce a tenere l'insediamento rado e concentratoquanto nella Puglia piana, ricalcato in buona parte sulla rete amaglie larghissime delle risorgive24. E qui pure, come nelTavoliere, basta inoltrarsi qualche miglio fuori dai centriabitati perché ci si trovi in un “deserto” in cui un albero è unelemento del paesaggio cosi raro da poter fungere da emergenzatopografica25, e il viandante proceda in silenzi rotti solo daqualche serpe che “striscia tra il fieno” ad “accrescerne lospavento”26.
Di quando in quando la pietra ovunque affiorante prendeall'improvviso forma, disegna edifici spesso imponenti, che nonindicano un propagginarsi di funzioni residenziali dai grandiborghi nei campi, ma ribadiscono l'opposizione fra 'pieni' urbanie 'vuoti' agricoli, con la schiacciante preminenza delle funzionieconomiche lì ospitate. In un certo senso, anzi, era stato ilrattrappirsi sul territorio dell'insediamento a determinarel'esigenza di presidi produttivi abitati in maniera noncontinuativa da quanti sono addetti a estrarre risorse dal“deserto”.
Man mano che ci si allontana dalla città, la dimensione delleaziende cerealicole cresce fino a raggiungere economie di scalache consentono la piena utilizzazione di attrezzature produttivecome animali da lavoro, stalle, fosse per la conservazione deigrani, e d'altronde la lontananza della città impedisce che questavenga utilizzata come struttura di servizio alla produzione. E' aquesto punto che il semplice seminativo prende la forma della
24 Cfr. lo studio ufficiale su Le acque potabili della provincia di Bari (Bari1865). Cfr., più in generale, 0. BALDACCI, Puglia, Torino 1972'; D. NOVEMBRE,Puglia. Popolazione e Territorio, Lecce 1979.25 Cfr. P. DI BARI, Confinazione di Altamura nel 1659, in «Altamura», 1970, p.66.26 L. DE SAMUELE CAGNAZZI, Sulle campagne di Puglia, in « Atti del Real Istitutodi Incoraggiamento di Napoli», 1811, P. 345.
14
“masseria”27, organismo spesso di centinaia di ettari tripartiti interra “di portata”, adoperata per la semina secondo una rotazionequadriennale o triennale, “mezzana”, circa un quintodell'estensione complessiva destinata al pascolo degli animali dalavoro, e “commodi”, nei quali si perpetua la memoria dei casalispazzati via nell'incalzarsi di crisi' naturali' e 'artificiali'fra la fine del XIII e l'inizio del XVI secolo.
Quelli fatti costruire dal principe di Minervino a cinquemiglia dalla città verso la fiumara “in tempo che si facevano ilcampo per commodità de' massari”, comprendono, secondo un apprezzoseicentesco, “molino, panetteria, ferraria, taverna, magazzeni,stallone capace per 60 animali [...] , habitationi con tutte altrecommodità”28. Non manca quasi mai la chiesetta, per impedire che ilavoratori abbandonino la masseria per le funzioni sacre festive,e mura e torri merlate e caditoi in funzione difensiva, allequali, con l'addolcirsi dei tempi, andrà subentrando il 'casino'per la villeggiatura padronale. Infine, a ridosso degli edifici,la geometria fitta e irregolare di padule, giardini, ortali,agrumeti, chiusi di piccola agricoltura per l'autoconsumo deimassari e la produzione di salario in natura.
L'altro organismo complesso degli spazi vuoti murgiani èespresso dall'altra faccia dell'economia della Puglia bareseinterna, quella pastorale. Da novembre a maggio, disseminandosiper la fascia dal mare di Barletta a Minervino e poi incuneandosiverso sud-est lungo varie direttrici, decine di migliaia di pecoreabruzzesi organizzate dalla Dogana di Foggia pascolano accanto adaltrettante pecore locali, mentre il fianco occidentale, inparticolare il territorio di Altamura, è legato alla montagnalucana da una transumanza non fiscalizzata. Pastori e pecoreabruzzesi, lucane e pugliesi hanno la loro base operativa negli“jazzi”. Dal fondo di una piega del suolo che garantisca unaqualche disponibilità idrica sorvegliata dai pagliaroni deipastori, questi grossi manufatti in pietra risalgono un pendioriparato dai venti settentrionali con alti muri a secco chechiudono, a pro delle diverse operazioni serali, spazi all'apertodelimitati da 'parieti' più basse, e si congiungono nel 'lamione'
27 Vedi, fra gli altri, D. BORRI (a cura di), Contributi allo studio delpaesaggio urbano e rurale in età moderna: le masserie di Puglia, Bari 1983. Piùin generale, cfr. gli scritti raccolti da c. COLAMONICO in La casa rurale nellaPuglia, Firenze 1970.28 Cfr. Descrizione di Minervino di Honofrio Tango, Regio Ingegniero e Tavolario,Napoli, I° settembre 1668, in BN Bari, f. D'Addosio, 11-32, in particolare C.29r.
15
che custodisce gli animali di notte e delimita a monte l'interoedificio29.
Nei “deserti” murgiani lo sguardo dei viaggiatori non sembratrovare altro su cui posarsi. E purtuttavia, a guardare meglio,non vi sono assenti forme significative di “costruzione dellacampagna”, minute e diffuse anche se scarsamente elaborate al dilà di un livello strettamente funzionale. Masserie e jazzi sonosolo emergenze di una rete fitta e praticamente continua dimanufatti - piscine e pozzi, paghai e parietoni e specchie -recenti o antichi a sufficienza da emergere nei toponimi,organizzati in una grammatica elementare di pietre appiattite suun paesaggio ossessivamente pietroso, ma del tutto perspicua, senon a noi o ai viandanti letterati, ai protagonisti della vitaeconomica del tempo. Per costoro “una pietra grossa assisa interra”30 lancia un segnale subito percepibile, una “specchiadisfatta”31 è immediatamente distinguibile da una in ordine e lasua funzione quasi sempre evidente. Le “molte specchie pocodistanti l'una dall'altra”, rinvenute verso Ruvo dalla commissioneche nel 1659 tenta di dirimere le liti di confine intorno alterritorio altamurano, “dinotano territorio d'Altamura. E appressodella specchia una conca nelli canali del quondam Nunzio Melodia,a' quali canali va per diretta linea verso Ruvo uno paritone [...1 con molte specchie e titoli denotantino la divisione tra ilterritorio di Ruo et Altamura”. Dalla parte opposta, la divisionefra il territorio di Altamura e quello di Gravina è “mostrata” da“una quantità di pietre mobili” poste “sopra uno serritello”,mentre, a segnare il territorio di Corato, c'è un “paritone [...]che tira a linea retta verso detta terra”, da distinguersi,insieme agli altri consimili, dai “pareti delli parchi” che“serrano”, in una forma murgiana di enclosures, seminativi edifese a pascolo e saranno un elemento centrale nelle rivolte del179932.
L'intrico di segni sul paesaggio allude a vicende tipiche diantico regime, al tentativo spesso vano di definire in manierainoppugnabile l'intrico di diritti attaccati alla terra e soggetti29 Numerosi, anche se tutti in stato di degrado pìú o meno avanzato, sono ancoraoggi gli «jazzi» visibili sulla Murgia interna. Vedine qualcuno nelle tavole 11-12 di G. ANGELINi e c. CARLONE, Atlante storico della Puglia, 2: La Provinciadi Bari, Cavallino di Lecce 1987.30 Apprezzo di Gioia del Colle del 1612 in BN Bari, f. D'Addosio, 1-134, c.XVIIIr.31 DI BARI, Confinazione cit., p. 69. Per le citazioni seguenti, cfr. ibid., pp.65-69.32 Cfr. A. LUCARELLI, La Puglia nel Risorgimento, vol. Il, Bari 1934, P. 126.
16
alla prevaricazione dei potenti, e di risolvere la contraddizionefra una pastorizia locale che si muove entro gli spazi ampi deigrandi 'stati' feudali, e la dimensione ridotta delle partizioniterritoriali politico-amministrative realizzatesi con la crisiquattrocentesca della grande feudalità. D'altro canto esso sembraalludere ad un rapporto fra uomo e ambiente che non è solo disfruttamento indiscriminato, di rifiuto. Se i giganteschi borghicontadini esprimono anche la volontà decisa degli agricoltori, adispetto di perdite economiche considerevoli, di sottrarsi quantopiù a lungo possibile al contatto diretto con una natura aspra eavara, la capanna di pietra invece che di giunchi o il pernottaredelle pecore negli jazzi invece che all'aperto sono la metafora diuna 'pesantezza' della presenza umana nelle campagne vuote- cheinduce a complicare le ipotesi di lavoro lungo le quali muoversi.
In particolare nell'area interna sud-orientale gli uominisembrano riuscire a trovare un equilibrio accettabile con unambiente nel quale l'incolto predominante non è solo pietraiaprodotta da secoli di umanizzazione distruttiva: già la sua variadenominazione nei catasti - terre macchiose, boschi, boschimacchiosi, erbaggi, pascoli, demanio incolto33 segnala, alcontrario, una umanizzazione più cauta e defilata.
Ad Acquaviva nel 1611 “vi sono grani ed orzi” non più che “asufficientia di detta terra”; in compenso anche frutta ed olio visono “in quantità sufficiente”, e legumi, “fogliami” e vino,insieme agli animali da carne e alle loro pelli lavorate da“infiniti” scarpari e conciatori, sono oggetto di scambi vivacicon “tutti li luoghi convicini”. Sorgenti d'acqua più o menosalmastra “servono per li animali, per li panni, per conciarie dipelle”, e giusto fuori le mura della città scorre “uno fiumesotterraneo di grandissima abundanza, nella quale hanno fattomolti incegni per tirar l'acqua” ed irrigare “gli orti che stannopresso le mura di essa terra, et è acqua fresca, leggiera etbuona”. Più in là, “territori” che “per la grandezza et qualità”offrono la possibilità per ulteriori “industrie di ogni sorte di33 G. POLI, Appunti per un'interpretazione del paesaggio agrario puglieseattraverso i catasti onciari, in Il Mezzogiorno settecentesco attraverso icatasti onciari, vol. Il: Territorio e società, a cura di M. Mafrici, Napoli1986, P. 307. A metà Settecento l'incolto copre la metà circa dell'agro diCasamassima (ivi); dai catasti di primo Ottocento si ottiene un risultato simileper i territori di Acquaviva, Cassano, Gioia, Noci, mentre ad Alberobello sigiunge al 63 per cento (ASBA, Registro riassuntivo dei catasti provvisori). Vedianche, per la situazione di primo Ottocento, D.DEMARCO, La proprietà fondiariain provincia di Bari al tramonto del secolo XVIII, in Tetra di Bari all'auroradel Risorgimento (1794 -1799), Bari1970, PP. 205-94.
17
animali” e “ancora industrie di vittuaglie”, e poi il bosco cheoffre ai cittadini galla e legna a volontà, sia pure dietro ilpagamento della fida, e “una bellissima et abundantissima caccia”riservata ai signori. Così “habitanti [...] al generale vivenocommodamente, e tale che non vi si scorge povertà notabile, oltreche vi sono alcuni, ma pochi, che possedono grosse facultà”34".
La vicina Gioia, secondo il legato fiorentino in Napoli, cherelaziona in merito al Granduca di Toscana nel primo Seicento,“merita di essere così chiamata per il nobbile, et fruttiferoterritorio, poiché non [v'è] luogo non dico in detta proventia, maforsi in tutto il Regno, ove sia maggiore [... 1 comodità di faretanti grani et bestiami di ogni sorte, al che non manca altro cheintrodurvi fatiganti...”35". Intanto, per quelli che già virisiedono, tutto sembra essere a sufficienza, le acque abbondano eil grande bosco sarà ancora a fine Settecento in grado di“annidare crassatori”36.
Si tratta, comunque, di un'area lasciata in bianco dalle mappedel commercio a lunga distanza e che - lo vedremo - ha un ruolomarginale negli equilibri complessivi della provincia. Ben piùteso diventa il rapporto fra uomo e ambiente nella Murgia centro-settentrionale, laddove, come a Gravina, le piazze [...] sonotutte vacue sotto” per le “infinite” fosse da grano, e quattro“hostarie” e otto taverne37 sono affollate di mercanti e vaticaliche muovono, nel circuito del commercio a lunga distanza, grandiquantità di sovrappiù cerealicolo.
Qui pure, nel quadro di una orografia modesta e monotona mapur sempre efficace, è possibile rintracciare una varietà disituazioni. Le due massime aree di produzione cerealicola dellaprovincia, le terre nere lungo il corso terminale dell'Ofanto,appendice organica della Puglia piana, e le altre che occupano ilfondovalle a nord-ovest di Gravina, fra lo scoscendimentoall'estremo lembo occidentale della Murgia ed i pendii più dolciche annunciano l'Appennino lucano, presentano caratteristichevicine a quelle del Tavoliere, con vaste superfici fungibili, a34 Le citazioni sono tratte da un apprezzo del 1611 pubblicato da A. LUCARELLI,Acquaviva delle Fonti all'inizio del secolo XVII. (Relazione inedita di untestimone oculare), Bari 192 1, passim.35 Citato in A. DONVITO, L'abolizione della feudalità e la formazione dellapiccola e grande proprietà terriera a Gioia del Colle, in m. GIRARDI (a curadi), Gioia. Una città nella storia e civiltà di Puglia, Fasano 1986, p. 362.36 GALANTI, Relazione sulla Puglia Peucezia, in ID., Della descrizione cit., vol.II, P. 563.37 Apprezzo della città di Gravina di Virgilio De Marino. 16o8. Trascrizione enote a cura di F. Amodio, Palo del Colle 1979, PP. 20 e 32.
18
seconda delle convenienze e delle opportunità, per la pastorizia ol'agricoltura. Ma non è questa la situazione prevalente. Loscontro secolare e a tratti violento fra i due grandi centricontigui di Gravina e Altamura simboleggia in qualche modo ilcontrasto fra due diverse 'ragioni' murgiane: la Gravinacerealicolo-pastorale manda le sue pecore sulle pietraieconfinanti con quelle di Matera e Altamura, estraendo dai suoicampi in piano sovrappiù cerealicoli di gran lunga maggiori diquelli di ogni altro centro della Murgia interna e indirizzandoliverso Napoli lungo itinerari, quelli ionici, orgogliosamenteindipendenti rispetto a quelli che fanno capo al grande portogranario di Barletta38; la Altamura pastorale-cerealicola, alcentro di un immenso territorio che riesce a spianarsi per spaziconsistenti solo nelle “matine”, occupa i suoi larghi dossi condecine di migliaia di pecore e capre39, che spingono i contadini infondo alle “lame”, nei “canali seminatoriali” in cui si raccolgonole terre rosse dilavate dalle pendici.
Di gran lunga più tipico e diffuso, quest'ultimo paesaggio sipresenta fisicamente inadatto a far da cornice ai sogni arcadici,alle proposte e ai tentativi di promozione di un'agricoltura dipiccole aziende contadine stanziali, spesso avanzate per la Pugliapiana. Le vaste superfici pertinenti alla Dogana di Foggia che daAndria, Barletta e Corato giungono fino a Castel del Monte, e38 Cfr. i dati sui grani disponibili nei centri cerealicoli della provincia,probabilmente nel 1539, in G. CONIGLIO, il Regno di Napoli al tempo di Carlo V,Napoli 1951, P. 123. Il De Marino (Apprezzo cit., p. 17) afferma che il'caricaturo' di Gravina è «la Scanzana», sullo Ionio, e che da Taranto giunge aGravina quotidianamente pesce fresco. Anche il feudatario della vicinaSanteramo, quando nel primo Seicento comincia a praticare il circuito delcommercio a lunga distanza invece di vendere i propri grani ai centri dellaconca barese, li imbarca a Taranto (cfr. la tesi di laurea di A.F. AQUILINO, ilfeudo di Santeramo fra 14 metà del XVI e il secondo decennio del XVI secolo,Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bari, a.a. 19771978). Qualcheelemento sull'importanza del porto di Taranto fra Cinquecento e Seicento in G.CONIGLIO, Il Viceregno di Napoli nel sec. XVII, Roma 1955, p - 33.39 Oltre 80000 nel 1496: cfr. G. DE GENNARO, Produzione e commercio delle lane inPuglia dall'epoca federiciana al periodo spagnolo, in «Archivio storicopugliese», 1972, p. 67. Nel secondo decennio dell'Ottocento l'incolto occupa il67,7 per cento del territorio di Altamura e il seminativo il 26,2; di contro, aGravina le cifre corrispondenti sono rispettivamente il 35,6 e il 62,4 per cento(cfr. ASBA, Registro riassuntivo dei catasti provvisori cit.). Su Altamura cfr.Ordinanza del Commissario demaniale della provincia di Bari Consigliere GiuseppeMiraglia per la verifica del demanio di Altamura preceduta dalla storiadell'agro, Bari 1861. Da una relazione primo-ottocentesca di Andrea Modula, delCommissariato civile del Tavoliere, in P. DI CICCO (a cura di), Il Tavoliere diPuglia nella prima metà del XIX secolo, Foggia 1966, PP. 47-48.
19
dall'altro lato, fino al territorio di Canosa, sembrano agliamministratori fiscali difficili financo per le pecore.
De' frequenti e poco interrotti strati di calcarei, delleterre in pendio e spesso elevate in modo che, soggette all'urtode' venti impetuosi, veggono aduggiare la vegetazione ed inaridirele piante al momento stesso in cui si sviluppano, de' macignirotti dalla mano dell'uomo per piantarvi in mezzo degli alberi, inqualche punto degli strati di argilla rossa, che fra i tufi e lepietre tiene luogo di terreno vegetabile: ecco i caratteri cheprincipalmente presentano le terre della locazione di Andria.Formata da diversi colli pietrosi è solo nelle valli che questiproducono, e nelle poche pianure che contiene, che può rinvenirsidella terra atta ad esser posta a profitto.
Lì in fondo colture defaticanti come quelle dei cereali sonopossibili, e in una certa misura anche proficue. Misurati tramiteil rapporto seme-prodotto, i rendimenti della Murgia delle lame edei dossi, quella più tipica e diffusa, sono relativamenteelevati40, sia per il concentrarsi nella terra seminata deiprincipi nutritivi dilavati dalle colline circostanti, sia perchéqui pastorizia e agricoltura, non dovendo competere per gli stessiterreni, tendono a forme di integrazione pur sempre superficialima significative: mentre nel Tavoliere l'abbondante sterco ovinoviene usato quasi esclusivamente come combustibile41 nei contrattialtamurani sette-ottocenteschi sarà possibile trovare, fra leclausole delle cessioni di terre a pascolo, lo scambio fra illetame, ceduto dal locatario per ingrasso dei seminativi dellocatore, e la paglia, ceduta da quest'ultimo al primo per cibodegli animali e giacigli42. D'altro canto misurati sul rapportosuperficie globale - prodotto, i rendimenti scendonoprecipitosamente43 data la grande quantità di terra destinabilesolo a una pastorizia costretta a una mobilità parossistica dallapovertà delle associazioni floristiche annidate nelle crepe della
40 Cfr. M. T. PACE TANZARELLA, Produzione e rese nella coltura dei cereali adAltamura nei secoli XVVII-XIX, in «Archivio storico pugliese», 1980, pp. 289-324.41 Cfr., ad esempio, L. GRANATA, Economia rustica per lo Regno di Napoli, vol.Il, Napoli 1830, P- 17142 Cfr. le tesi di laurea discusse presso la facoltà di Lettere e filosofiadell'Università di Bari di G. SPADAVECCHIA, I patti agrari ad Altamura dal 177Oal 1820, a.a. 1969-70, e C. MASTROPASQUA, I contratti agrari ed il movimentodella proprietà fondiaria ad Altamura dal 1821 al 1850, a.a. 1970-71.43 Di notevole interesse i calcoli dello Jatta riportati da F. DE FELICE,L'agricoltura in Terra di Bari dal 188o al 19 r4, Milano 197 1, pp. 62 e nota,97.
20
pietra.Da tutto questo discende l'altro carattere distintivo del
paesaggio agrario murgiano, il suo alto grado di rigidità. Leterre esauste della Puglia piana, una volta consegnate allapastorizia, tendono a ricostruire, sia pure lentamente, unacapacità produttiva che poi restituiscono, una volta riconvertiteall'agricoltura, sotto la forma di rendimenti nell'immediato piùelevati della media44, e l'incolto, eludendo il vincolismo doganalecon o senza l'assenso del potere centrale, riesce in una visionedi lungo periodo a fungere da ammortizzatore della domanda nellefasi acute del ciclo, permettendo rapide espansioni demografiche eproduttive. Al contrario la cerealicoltura delle “lame” murgiane,non potendo né arrampicarsi proficuamente sui pendii dilavati, néspingere i ringrani per oltre tre-cinque anni di seguito45 senzaesaurire il poco suolo disponibile, ha solo a disposizione, perrispondere alla pressione della domanda, il patrimonio di altaproduttività potenziale accumulato dai secoli nei suoli delle areeboschive.
Ma questa pure è una via senza uscita. Sottoposto allaaggressione causata dalla fame di grano, la quale alimenta a suavolta la fame di navi che lo trasportino, cioè di legname46 ilbosco della Murgia centro-settentrionale è ridotto già nel secondoCinquecento nella condizione di risorsa drammaticamente scarsa,che rende lucroso speculare sulla fame di combustibile deicontadini. Nel mentre il capitolo di San Nicola di Bari fa venireda Venezia le tavole per le baracche da costruire nel recintodella basilica per la grande fiera di dicembre47 il duca diGravina, che possiede a tre miglia dall'abitato una “selva defesa”di querce e lentischi, già in parte “scampagnata” e coltivata e inparte occupata da tre jazzi,48 “ha cominciato a sfoderare dettaselva et vendere le dette legna dal che ne ha cavato molto lucroper la vendita facile che si fa di quelle per causa che dettacittà di Gravina non have altri luochi dove siano legna”, a parte“la defesa della università dove si possono fare solo le legna44 Cfr., ad esempio, C. DE CESARE, Intorno alla ricchezza pugliese, Bari 1853, P.95; m., Delle condizioni economiche e morali delle classi agricole nelle treprovincie di Puglia, Napoli 1859, p. 102.45 Che pure è pratica frequente nell'Ottocento (Cfr. GRANATA, Economia rusticacit., pp. 153-54).46 Si tratta, naturalmente, di un processo generale (cfr., ad esempio, F.BRAUDEL, Civiltà ed imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II, Torino 1965PP. 146-49), che ha però un impatto particolarmente incisivo sulla nostra area.47 Cfr. Archivio della basilica di San Nicola, Bari, b. Fiere 15oo-1879.48 DE MARINO, Apprezzo cit., pp. 56-57.
21
morte et portarsi in collo nella quale si campano infiniti poverihuomini et donne49. Solo le catastrofi demografiche sembranofrenare il processo e ristabilire un equilibrio. A Minervino,apprezzata alcuni anni dopo quel contagio del 1656 che vi avevafatto, stando alla tipica amplificazione del tavolario, 3000morti, il bosco dell'università distante appena due migliadall'abitato sembra rispondere in pieno ai bisogni deisopravvissuti, dei quali “ogn'uno può mandare a tagliare conformeli loro bisogni”50. Di converso nulla del genere lo stessotavolario può registrare per la vicina “terra” lucana diSpinazzola, dove non vi è stato contagio e “vivono più casate percasa”51; e quando la spinta demografica torna ad investire laprovincia, anche l'ultimo grande bosco rimasto alla Murgia centro-settentrionale, quello di Ruvo, sul quale i locali avevano dasempre esercitato gli usi civici del far legna, viene brutalmenteaggredito: “folto ed impenetrabile” ancora all'inizio degli anni'30 del Settecento, esso viene sottoposto dai signori locali, iCarafa d'Andria, ad “un taglio così barbaro” che “al cadere delsecolo XVIII era rimasto denudato in modo che aveva perduto quasil'aspetto di bosco”, nel mentre “se si trovavano i poveri alegnare o tagliar spine, erano crudelmente bastonati dagliarmigeri baronali a cavallo addetti alla custodia di esso”52.
Un inseguirsi in circolo di spinte che si alimentano a vicendariduce su superfici sempre più estese le associazioni vegetativealla condizione di gariga o, addirittura, di steppa, allarga iconfini della pietraia, conduce un suolo geologicamente eclimaticamente infelice a livelli di degrado da cui non è piùpossibile il recupero naturale anche quando la pressione umana siallenta53. La Murgia nuda non riesce a giustificare, da sola,quella certa incisività e stanzialità della presenza umana
49 Ibid., p. 61.50 Cfr. il citato apprezzo in BN Bari, f. D'Addosio, 11-32, in particolare c.15r.51 L'apprezzo di Spinazzola, sempre del 1668, è alle cc. 31r-46v dello stessodocumento della nota precedente.La citazione riportata nel testo è tratta dalla e. 32V. Spinazzola vienecollocata amministrativamente in Terra di Bari solo nell'Ottocento borbonico,ciononostante la si è presa in considerazione perché ritenuta parte integrantedella regione barese.52 G. JATTA, Cenno storico sull'antichissima città di Ruvo nella Peucezia, Napoli1844, pp. 219-20.53 Suggestioni e spunti su queste questioni, oltre che in E. SERENI, Storia delpaesaggio agrario italiano, Bari1974, in G. HAUSSMANN, La terra e l'uomo, Torino1964.
22
ipotizzabile sulla base indiziaria della molteplicità dei segnilasciati dall'uomo sul paesaggio.
Essa, però, non è la sola conformazione del paesaggio dellaprovincia interna centro-settentrionale. Seminativo e incoltotrovano un limite spesso invalicabile quando giungono in vistadell'abitato, che interpone fra le mura e i campi nudi un“ristretto” relativamente ampio e, quel che è più da notare, nonfrastagliato nelle mille forme e colori della policoltura daautoconsumo presente nell'area sud-orientale. Non che manchino,nella Murgia coinvolta nel commercio a lunga distanza, giardini efrutteti e orti, ma il vigneto domina i “ristretti” fino al puntoda poter spesso pretendere alla dignità di partner minore delgrano. Con grande rilievo esso è menzionato, dopo i pascoli e icampi a grano, nel catalogo delle ricchezze di Altamura a metàCinquecento contenuto nella relazione Guardini”54, e Gravina,secondo la Descrittione del Mazzella, “fa per arme [...] alquantespiche di grano, e rappi d'uva per accennare quanto il suoterritorio di questi due frutti sia abbondante [...] , onde alcunicredono, ch'ella traesse il nome”55. In effetti, a fugare ognidubbio in proposito, un'iscrizione sulla porta di San Tommasospiega così, al viaggiatore che si avvicina da est, l'etimo deltoponimo della città: “Grana dat, et vina, urbs nobis opulentaGravina56.
Nel territorio di detta città - dice il De Marino nel 1608 -in qualsivoglia luoco et possessione se sia et che sia del padronedella città o della ecclesia è permesso ad ogni persona de posserepiantare vigne ancora che non voglia lo patrone del territorio etquelli che piantano dette vigne sono obligati a pagare vinticavalli per rasola, et per tale causa molte persone di detta cittàche non hanno altro che fare per guadagnare Re spese le lorogiornate piantano le dette vigne et poi piantate le solenovendere57
In questo modo, in una fascia fra uno e tre miglia “circumcirca la città”, il vigneto è giunto a coprire circa mille ettari,e dei suoi “vini (eccellentissimi) di ogni sorte et in grandissima
54 «Il vero esercito delli huomini di questa città di Altamura è massari dipecore, vacche, porci e de grani, delle quali cose abbondano incredibilmente.Hanno ancora assai vino nel loro territorio » (G. MASI, Altamura farnesiana,Bari 1959, P. 35).55 S. MAZZELLA, Descrittione del Regno di Napoli, Napoli 1601, p. 208.56 G. B. PACICHELLI, Il Regno di Napoli in prospettiva diviso in dodici province,Napoli 1703, P. 215.57 DE MARINO, Apprezzo cit., PP. 35-36.
23
abundanza [...] si provedono molti luoghi circonvicini”, oltre aquanti occasionalmente o stabilmente dimorano in città e possonoscegliere fra taverne e osterie e “altri luoghi dove si vende vinoal minuto oltre quelli che lo vendeno nelle loro case che cossi sicostuma in detta città che ciascheduno può vendere lo vino in casasua”58.
Le cifre della distribuzione delle colture non sempre sembranosostenere questi entusiasmi; ma, a questo punto del procederedell'analisi, esse riuscirebbero poco perspicue. L'interpretazionedi una contabilità di ettari impone di ripercorrere il cammino finqui fatto secondo un'altra prospettiva. Quadri del paesaggio equadri sociali - è questo il nodo proposto dallo stesso tabulariodi Gravina - non possono che essere studiati assieme, neltentativo di decifrare la trama fitta dei reciproci rimandi.
2. La società cerealicolo-pastorale.
“Questa città è divisa in doi razza, l'una si chiama massari oplebe [... Il l'altra letterati, i ricchi et gentiluomini”, la cui“condotta [...] è di soperchiare h poveri, farsi padroni senzadubio di non essere castigati o di non perdere tale preminentia”59.Agli occhi del Guardini il paesaggio sociale dell'Altamura di metàCinquecento si presenta non meno aspro e semplice di quellofisico.
Ma, così come la pietraia murgiana, vista più da vicino, sirivela a suo modo variegata e ricca di segni, la società lìinsediata presenta una sua articolazione, una sua complessità.
I due settori dominanti, pastorizia e cerealicoltura,raccolgono attorno a sé gruppi sociali fra loro nettamentedistinti e articolati al loro interno.
Il pastore è, qui come nel Mezzogiorno in generale, pastore dipecore: gli animali grossi, anche per la povertà dei pascoli e lecondizioni climatiche, sono relativamente pochi e, a parte isomari e i cavalli dei vaticali, la loro proprietà è nelle manipressoché esclusivamente di enti ecclesiastici, baroni, grossimassari60. In particolare gli animali da lavoro, la cui scarsezza
58 Ibid, pp. 32-3359 MASI, Altamura cit., P, 35.60 Cfr. i dati in proposito tratti dal catasto onciario di Minervino in L. DALPANE, Studi sui catasti onciari del Regno di Napoli, I: Minervino Murge (1743),Bari 1936, e quelli tratti dagli onciari di Palo, Binetto, Sammichele eSpinazzola in v. Ricchioni, Saggio sull'estensione e distribuzione della
24
costituisce un altro vincolo importante all'elasticità dellaproduzione di cereali, vengono allevati all'interno della masseriae curati da personale del tutto integrato nel mondo degliagricoltori.
Scarsamente integrato nel mondo dell'agricoltura è invece chibada agli ovini, i quali sono presenti non solo nei grandi spazimurgiani ma anche nell'incolto che s'incunea fin sulla costa e,stagionalmente, ovunque le rotazioni del seminativo offronopascoli adatti alle modeste esigenze della pecora locale:diffusissimo è nei codici diplomatici e nei documenti di etàmoderna il lamento per la presenza nel proprio territorio di“animali damnificanti” altrui, in particolare di quelli dei“molestissimi ospiti Abruzzesi”61, e scontri fra pastori suidiritti di pascolo e fra pastori e agricoltori in particolaresull'ingresso delle temutissime capre negli uliveti sonoall'ordine del giorno. Financo a Molfetta, il cui libro rossovanta un privilegio concesso da Carlo VIII nel 1485 che nepreservava il territorio dalle pecore abruzzesi e forestiere ingenerale perché “tucto fructifero et coltivato”62, la questione sitrascinerà ancora per secoli. Ancora più importante è la presenzadelle pecore sulla costa meridionale della provincia. Per tutto ilQuattrocento e il Cinquecento la discesa degli animali dai montiche serrano gli oliveti di Monopoli movimenta la vita locale63, equi, come nella Polignano del Seicento, le masserie di pecore nonsembrano avere un profilo economico e gestionale diverso da quelledi Gravina64: grandi dimensioni aziendali, concentrazioneproprietaria nelle mani di enti o individui titolari di difesepascolatorie murgiane che prendono in fitto erbaggi montuosi“statonici”, conduzione tramite massari locatori degli animali oche rispondono direttamente alla proprietà, caratterizzano ovunqueproprietà fondiaria privata nel Mezzogiorno avanti le riforme francesi, Città diCastello e Bari 1946. Tutti i dati relativi agli onciari di questi centririferiti in seguito s'intendono ripresi da questi due lavori. Spesso sono statisottoposti a rielaborazione per renderli confrontabili con quelli riferiti inaltri studi.61 JATTA, Cenno Storico Cit., p. 208.62 D. MAGRONE, Libro rosso. Privilegi dell'Università di Molfetta, vol. III,Trani 1905, P. 139. Cfr. sulla questione L. PALUMBO, Cenni sull'estensione edistribuzione dei beni ecclesiastici a Molfetta nella seconda metà delCinquecento, in «Rassegna pugliese di tecnica vinicola e agraria», 1969, n. 5,in particolare pp. 12-13.63 Cfr. F. MUCIACCIA, Il libro rosso della città di Monopoli, Bari 1906, passim.64 L. MASELLA, Per una storia dei contratti agrari in Terra di Bari tra XVII eXVIII secolo, in AA.VV., Economia e classi sociali nella Puglia moderna, Napoli1974, PP. 134 sgg
25
il settore. Ma, con il chiudersi degli interstizi del paesaggioagricolo costiero sotto la pressione della domanda di derrate perl'esportazione e della popolazione crescente, la pastorizia diqueste aree si va riducendo fino a interessare solo le pochissimeunità lavorative per centro registrate nei catasti di metàSettecento65, e le greggi diventano sempre più piccole, giungono adimensioni inferiori a quelle adeguate ai bisogni di una famiglianucleare, configurando situazioni di marginalità sociale. Inun'inchiesta del 1838 le 3500 pecore di Fasano sono suddivise ingreggi che variano da 50 a 150 capi ciascuno, le 200 di Cellammaresono raggruppate in tre greggi di 80, 70 e 50 capi affidate ognunaa due pastori, le 500 di Giovinazzo in cinque greggi, le 580 diNoia in quattro greggi di quattro diversi proprietari, le 1141 diSannicandro in greggi di circa 50 capi, le 900 di Cisternino ingreggi che arrivano a un massimo di 60 capi66. Aziende di questedimensioni spesso non assorbono il lavoro di un maschio adulto,che deve in conseguenza cercare integrazioni nel lavoro agricoloaffidando momentaneamente gli animali agli altri componenti dellafamiglia, e in generale le opere, i giorni, gli spazi di questapastorizia appaiono reinquadrarsi in quelli di un'agricolturaormai assolutamente dominante. A Cisternino, ad esempio, non visono terre propriamente addette al pascolo, è perciò che dalnovembre a tutto aprile [gli ovini] si portano al pascolo intenimento di Fasano, da maggio a giugno si tengono in questotenimento pascolando nelle strade divisi in piccolo numero, sifidano pure al pascolo de' monti di proprietà del Comune, chepresentano l'estensione di circa 1000 moggia. Finita lamietitura, cioè da luglio ad ottobre, pascolano per l'interotenimento67.
Così la Murgia va diventando man mano il luogo di elezionepressoché esclusivo della pastorizia, sotto il profiloquantitativo come sotto quello economico. E' lì che letradizionali pecore “comuni”, produttrici di buona quantità equalità di latte e carne ma di una qualità scadente di lana,quella “moscia” lunga, cominciano già dal Seicento a esseresostituite dalle più pregiate ed esigenti pecore “gentili”68,
65 Cfr. oltre, p. 68, la documentazione della tabella 4.66 ASBA, f. Agricoltura industria e commercio, b. 104, fs. « Statistica deglianimali pecorini dell'anno183867 Ibid.68 Cenni in merito in BONAZZOLI, L'economia agraria cit., pp. 156 sgg. Ma cfr.ora sulla pastorizia in generale j. MARINO, Pastoral Economics in the Kingdom ofNaples, in corso di pubblicazione.
26
produttrici di lana destinata a un circuito mercantile ampioquanto quello cerealicolo, che incontra i pastori nelle fiere:prima di lasciare le pietraie murgiane, animali e larie dellaprossima tosatura vengono contrattate in quelle di Gravina eAltamura, che continuano a funzionare in particolare sulladirettrice della transumanza verso e dalla Basilicata nonostantel'amministrazione della Dogana, a norma di una prammatica del1651, tenti di impedire la compravendita dei prodotti dellapastorizia al di fuori della fiera foggiana di maggio, allo scopodi sostenere i prezzi spuntati dai potenti e preziosi locatiabruzzesi69. Il fatto è che anche gli interessi provinciali nelsettore hanno una loro consistenza, della quale lo Stato stessoprende atto rendendo le disposizioni meno vincolistiche epermettendo agli allevatori non inquadrati nella Dogana di venderedopo la contrattazione dei prodotti dei locati70. Le pecoremurgiane continuano ad essere raccolte in grandi greggi in largaparte concentrati nelle mani di enti ecclesiastici e baroni,condotti in economia o fittati a massari di pecore, fin suirilievi ai margini della conca barese: dei 2832 capi registratinel catasto di Palo del 1633-3471 il 60 per cento è organizzato indue greggi di proprietà di due chierici e gli altri in sei greggiminori, e a un pugno di nobili ed ecclesiastici appartengono i3865 capi registrati nell'onciario dello stesso centro; a Binettotutti i 1000 capi dell'onciario appartengono al feudatario delluogo, a Minervino il duca di Calabritto possiede a metàSettecento 7500 degli 8238 capi, a Spinazzola, alla stessa data,su 12864 ovini complessivi 5263 appartengono a un esponente dellanobiltà locale, 180o a un nobile forestiero, 2877 a chiese eluoghi pii; infine a Gravina, nel 1739, il duca e gli entiecclesiastici possiedono il 76 per cento dei circa 32 80o capilocali, e i rimanenti sono distribuiti fra diciannove piccoli emedi proprietari.72
In questa pastorizia m grande, a parte l'ambigua figura delmassaro di pecore, i pastori sono simili a salariati più di ognialtra figura di questa società: oltre a non possedere i mezzi di69 Cfr., sulla questione, As Foggia, f. Dogana, b. 20 e 21.70 Ibid., in particolare b. 8o, fs. 3969.71 Cfr. R. VITARELLI, L'economia di Palo del Colle nella prima metà del 16ooattraverso il «Catasto antico» (r633-34), in «Bari economica», 1987, n. 3, inparticolare P. 59.72 Vedi gli atti che impegnano massari e proprietari di pecore di Gravina a « noncontrattare, vendere, o alienare la lana, che nella prossima carosa perveniràdal di loro rispettivo numero di pecore senza la debita licenza della R. Dogana»(As Foggia, f. Dogana, b. 20, fs. 3969).
27
produzione specifici del loro settore, essi possiedono ben di radoimmobili urbani e rurali, e dopo la segregazione estiva neivillaggi montani, con cui realizzano solo rapporti di piccolotraffico spesso lucrosi per i locali, tornano a segregarsi neglijazzi, interagendo con la società urbano-rurale solosaltuariamente. D'altro canto, essendo la domanda di lavoro nelsettore relativamente bassa e meno variabile di quella dellamasseria cerealicola, essa si traduce in un numero di addettinettamente minoritario nei confronti dei contadini anche dove, intermini di superfici a destinazione pastorale, H settore sembraavere un peso preponderante: a Minervino, ad esempio, a fronte diun 74 per cento di addetti all'agricoltura sul totale deicapofuochi in condizione professionale, i lavoratoridell'allevamento sono a metà Settecento il 7,1 per cento, adAcquaviva nel primo Ottocento le percentuali sono rispettivamenteil 65,9 e il 4,3 per cento, a Santeramo l'onciario dà il 79 e l'11per cento; e perfino ad Altamura si ha, sempre nell'onciario, il56,5 per cento di capofuochi agricoltori e il 21,8 di pastori73. Edel resto, calcolando prudenzialmente un addetto per ogni centoanimali74 se le 80000 pecore che Altamura sembra avesse a fineQuattrocento, quando la città contava all'incirca 480o abitanti,dovevano richiedere 80o pastori fra adulti e ragazzi, cioèprobabilmente più addetti di quanti ne assorbisse lacerealicoltura, le 54 000 pecore che Giustiniani assegna allastessa Altamura occupano certamente a fine Settecento una frazionepiccola della manodopera di un centro di circa 18000 abitanti75.
Più frastagliato si presenta il panorama sociale dell'altrosettore fondamentale. Nelle condizioni di antico regime la fortepolarizzazione del possesso fondiario spesso connessa a un livelloalto di commercializzazione della produzione agricola, se da unlato tende a semplificare i diritti e le forme di gestione dellaterra, dall'altro complica il quadro delle figure socialicoinvolte nel processo produttivo. Così come ce la configurano inotai, la “massaria grossa”, cellula produttiva fondamentale della73 Per Acquaviva Cfr. L. PALUMBO, Atti di vita economica e sociale in Acquavivadelle Fonti nei secoli XVII-XIX Bari 1981, tab. p. 91; per Santeramo e Altamuravedi la tesi di laurea elaborata presso la facoltà di Lettere e Filosofiadell'Università di Bari di N. CAPUANO, Demografia dei comuni delle Murge altedi Nord-Ovest del'700, a.a. 1979-80.74 Ma le valutazioni in proposito sono molto incerte: cfr. comunque G. DELILLE,Agricoltura e demografia nel regno di Napoli nei secoli XVIII e XIX, Napoli1977, in particolare p. 105; e MARINO, Pastoral Economics cit.75 L. GIUSTINIANI, Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli... tomo I,Napoli 1797, pp. 125-36.
28
Murgia mercantilizzata, in larga parte in possesso feudale edecclesiastico ed esclusa dalla libera disponibilità delle terre didemanio feudale coltivabili dietro corresponsione di terraggi edecime, viene ceduta in fitto, di solito per periodi brevi e incambio di un canone in larga parte in denaro, a un “massaro”.Lasciamo per il momento da parte quest'ultima figura e le sueforme contrattuali, su cui occorrerà tornare per studiarnel'incidenza sulle dinamiche della nostra regione economica, eguardiamo alla domanda di manodopera subalterna espressadall'azienda cerealicola.
I lavoratori del latifondo murgiano possono suddividersiin tre gruppi fondamentali, ulteriormente variegati al propriointerno: salariati fissi (“annaroli” o assunti per più anni),avventizi (“mesaroli” e “giornatieri”), mietitori. Se il rapportofra le giornate lavorative erogate dai salariati fissi e quelleerogate da avventizi e mietitori può essere calcolato a circa 1 a1, in termini di unità lavorative 9 rapporto è fortementesquilibrato dalla stagionalità del calendario dei lavori dellacerealicoltura, che crea l'intreccio tipico del latifondomonocolturale fra un mercato delle braccia a tratti spasmodico euna disoccupazione diffusa e protratta per lunghi periodi nelcorso dell'annata76. Così i “foresi” come quel Francesco Lucarellidi Binetto, che nel 1769, barattando la sicurezza del lavoro conla rinuncia ad ogni forma di miglioramento sociale, affitta i suoi“servigi personali” come “campagniuolo” in una masseria di Gravinaper sei anni continui in cambio di vitto, alloggio, abiti, curemediche e 5 stoppelli e mezzo di grano l'anno77 costituiscono unaminoranza dei lavoratori agricoli il 24 per cento circa a Gravinaa metà Settecento78. Al tempo stesso essi si collocano al livello76 E' inesplicabile solo per gli ignoranti della scienza economica - affermaCarlo De Cesare - come in una regione che manca di braccia proporzionate allasua agricoltura ed al suo terreno, in una regione grandemente agricola efertilissima, una scarsa popolazione non trovi lavoro e da campare la vita »(Delle condizioni cit., P. 77). Su questi problemi, oltre alla letteraturaagronomica sette-ottocentesca e ai lavori di Lepre e Zotta ampiamente utilizzatipiù avanti, cfr. in particolare D. SQUEO, Frumentocoltura e allevamento in Terradi Bari a metà Settecento. L'azienda di Sant'Alessio nell'agro di Trani, in IlMezzogiorno settecentesco attraverso i catasti onciari, vol. Il cit., pp. 605-14.77 ASBA, notaio Altimare Francesco, atto 3 settembre 1769.78 A. SQUEO, Per la definiZiOne di ceto rurale: l'ipotesi d'una lettura comparata(Gravina di Puglia - 1754), in “Politica e Mezzogiorno”, 1983, n. 3-4, tab. p.17. Ma l'intero scritto, come tutti gli altri dell'autore, è ricco di spuntifelici che qui si è cercato di utilizzare. C'è da tener conto, comunque, che ilsignificato di termini come « forese », « bracciale », « zappatore », «
29
infimo della scala sociale di un mondo di subalterni che non è unmucchio indistinto di sofferenza e miseria: rispetto agli altricontadini i “foresi” hanno fuochi meno numerosi, posseggono menocase e terre, hanno in generale, se non altro perché tornano incittà ogni quindici giorni, un rapporto scarso con la societàurbana, con i suoi piccoli traffici, le occasioni di alleanzefamiliari, le erogazioni assistenziali degli enti pubblici edecclesiastici, le protezioni dei potenti, le solidarietà e gliscambi interni al ceto; insomma sono gli agricoltori più simili aipastori. Salendo man mano nella scala sociale, dagli “zappatori”ai “bracciali” ai “putatori” fino al vertice ristretto degli“ortolani”, il rapporto con l'abitato si fa più intenso senza peròmai attraversare il modello tipico delle situazioni 'norniali' dilatifondo commercializzato: non è dato qui di trovare facilmenteil contadino del tutto privo di terra, né il “versuriere” spessorecentemente immigrato che, assicuratasi una parte del ciboproducendoselo nei ritagli di tempo spesi su un fazzoletto diterra ai margini del latifondo, frequenta le piazze per trovarvilavoro nelle masserie o, nelle fasi di stanca del calendariocerealicolo, nei mille traffici dell'economia del vicolo o inquella delle strade intercomunali; quel lavoratore agricolo tipicodel Tavoliere che, dice Cimaglia, se “voglia onestamente dar davivere alla sua famiglia [...] uopo è [... 1 che unisca due o tremestieri”79 e sarà oltre che contadino e bracciante, carrettierecome a San Severo, o pescatore o artigiano di ogni possibiledenominazione, a seconda dei momenti e delle opportunità. Le massedi “zappatori” e “bracciali” murgiani, che forniscono, insieme ailoro figli in qualità di garzoni destinati ai lavori menoqualificati, il grosso della manodopera avventizia delle masserie,hanno un profilo socio-professionale e, per così dire,insediativo, molto più definito, un rapporto con la terra, nelsenso di lavoro agricolo e di luogo geografico, reso più intensodal possesso a vario titolo di terreno agricolo, frantumato ma nonpolverizzato, e diffusissimo, nel quale si intrecciano quasisempre seminatoriale e vigneto.
Qualche dato di raffronto con la situazione eletta a terminecomparativo di questa analisi è indispensabile. Nel “catastoprovvisorio” di primo Ottocento in Capitanata il vigneto occupa il2 per cento della superficie censita, per una media di ha 0,049 ad
lavoratore » ecc. muta da catasto a catasto. 79 N. CIMAGLIA, Della natura e sorte della coltura delle biade in Capitanata,Napoli 1790, P. 33. Cfr. anche G. ROSATI, Le industrie di Puglia, Foggia i 8o8,in particolare p. 299.
30
abitante, contro il 7,92 per cento della superficie censita e ha0, 122 per abitante in Terra di Bari80; inoltre mentre nell'altraprovincia il vigneto è proporzionalmente più diffuso nelle areemeno investite dal commercio cerealicolo a lunga distanza, quelleappenniniche e garganiche, la Murgia centro-settentrionale ha lastessa superficie vitata per abitante della media provinciale euna media più elevata di quella della costa olivicola. Le indaginiancora inedite condotte da Lorenzo Palumbo sui catasti diCapitanata di metà Settecento articolano questi dati in manierasignificativa: in Capitanata il vigneto, oltre che di gran lungameno diffuso che in Terra di Bari, si presenta o polverizzato inuna miriade d'aziende di peso economico inconsistente nelle zoneappenniniche e garganiche o, nel territorio dei grandi centricerealicoli, accorpato in aziende di estensione mediarelativamente consistente - oltre due ettari e mezzo - posseduteda una piccola minoranza di galantuomini ed ecclesiastici. InTerra di Bari, invece, l'azienda viticola tipica ha superficie piùpiccola che a Manfredonia, Foggia o Cerignola, ma più grande che aTroia, Sannicandro Garganico e Rodi Garganico, e il suo possessoriguarda una percentuale molto elevata dei lavoratori dellacerealicoltura mercantilizzata.
Naturalmente il fenomeno si presenta non dovunque e non semprecon la stessa intensità. Sulla base dei catasti onciari - gliunici disponibili, dato che solo qualche catasto cinque-seicentesco murgiano è giunto fino a noi, e solo quello del 1633-34 di una realtà di transizione come Palo è stato studiato, conrisultati che suggeriscono l'estensibilità al passato dei dati deicatasti settecenteschi - la situazione estrema del nostro punto divista è quella di Minervino, dove nessuna famiglia contadina,stando ai dati di Dal Pane, possiede un solo metro quadro dei 5368ha di seminativo censiti e concentrati nelle mani di trentapossidenti, nel mentre quasi tutte - l'85 per cento dei fuochicontadini - possiedono un frammento dei 342 ha di vignetodisseminato di olivi che stringono d'attorno l'abitato. A Gravina,dove non abbiamo dati per categorie sociali, il 67 per cento dellefamiglie di “cittadini” possiede vigneti, e di queste il 73 percento in appezzamenti inferiori a mezzo ettaro; il 36 per centopossiede seminatori, il 74 per cento delle quali in appezzamenti
80 Elaborazioni su S. RUSSO, Materiali per la storia del paesaggio agrario dellaCapitanata nel XIX secolo, in A. MASSAFRA (a cura di), Problemi di storia dellecampagne meridionali nell'età moderna e contemporanea, Bari 1981, tabella a P.468; ASBA, Registro riassuntivo dei catasti onciari.
31
inferiori a due ettari81. Più ricca l'informazione disponibile peraltri centri. A Spinazzola dei 511 fuochi di “bracciali” e“foresi” che costituiscono il 66,5 per cento del totale, l'85,3 hapossessi fondiari che corrispondono solo al 13,44 per cento dellasuperficie accatastata; le percentuali per tipo di coltura sonoperò del tutto diverse fra loro: dei 5976,5 ha di seminativo soloil 12 per cento appartiene ai contadini, dei 346 ha di vigneto benil 52 per cento. A Palo e Binetto, al margine opposto dell'area,ormai a ridosso di Bari, la concentrazione fondiaria non è menoforte e altrettanto diffuso e sminuzzato è il possesso contadino,che però, in corrispondenza a una maggiore articolazione delpaesaggio agrario, appare più distribuito fra le varie colture.Infine, spostandosi verso la Murgia sud-orientale, a San Michele ea Gioia82 la concentrazione fondiaria diminuisce nettamente, ilpossesso riguarda la totalità pressoché assoluta delle famigliecontadine e tende a configurare aziende autoconsumatrici autonome.
Giocando con le medie e tenendo ben presenti le avvertenzeusuali in questi casi, vediamo come si configura il possessocontadino 'tipico' nelle varie situazioni (cfr. tab. I)83. I datisembrano ridimensionare il ruolo del vigneto soprattutto per laMurgia produttrice di grano per il mercato.
Tabella I.
Estensione del possesso medio contadino in ha.
Murgia interna Murgia esterna Murgia sud-orientale
Minervino Spinazzola Binetto Palo S. Michele Gioia81 Cfr. la tesi di laurea elaborata presso la facoltà di Giurisprudenzadell'Università di Bari di A. SQUEO, Società civile, paesaggio urbano ed agrarionella Gravina del XVIII secolo, a.a. 1981-82.82 Per Gioia cfr. G. DE GENNARO, Aspetti e problemi della proprietà contadina inTerra di Bari nel secolo XVIII, in Rapporti tra proprietà impresa e mano d'operanell'agricoltura italiana dal IX secolo all'Unità, Verona 1984, PP. 481-9483 Naturalmente occorrerebbe avere, nell'ambito del possesso contadino, unadistribuzione delle superfici addette alle singole colture per classid'ampiezza, allo scopo di individuare il livello di rappresentatività dellamedia; non pare comunque che i coefficienti di dispersione siano elevati. I datidi Palo andrebbero confrontati con quelli ricavati dal catasto del 1633 da A.SQUEO, Massari e foritani nel42 Puglia barese attraverso un catasto seicentesco:Palo del Colle, 1633, in «Studi storici meridionali», 1987, n. 3, p. 282; tenutoconto dei diversi criteri di redazione dei due documenti fiscali, i datisembrano molto vicini a quelli ricavabili dall'onciario.
32
Vigneto 0,5 0,41 1,27 1,07 0,57 1Semin. sem. - 1,64 0,95 0,73 2,54 0,39Semin. arb. - - 0,26 0,4 - -Oliveto - - 0,09 0,12 - -Frutteto - - 0,04 0,05 - -“Terre” - - - - - 1,93Incolto - - - -
- 0,38Totale 0,5 2,15 2,61 2,37 3,49 3,32
Calcolando una produttività media di 15 hl. di mosto per ha84
e un consumo pro capite di una caraffa il giorno a testa85 bendifficilmente si può credere che centri con una dotazione divigneti oscillante fra un terzo di ettaro e mezzo ettaro perfuoco, come la Gravina di De Marino, possano “provvedere moltiluoghi convicini”86 e del resto la virtuale assenza di centri chene siano del tutto sprovvisti, il protezionismo degli statutipatri a favore dei produttori locali, la deperibilità del prodottostesso a causa dei cattivi metodi di trasformazione, la selvaggiadiversificazione delle unità di misura, i coefficienti dicorrelazione fra i prezzi di località vicine nettamente più bassidi quelli del grano e dell'olio87, sono tutti elementi che fannopensare, per questo settore, a un circuito mercantile di raggiobreve, confuso e irregolare.
Dunque il microfono vitato rappresenterebbe qui pure per lafamiglia contadina un apporto energetico che, insieme a quellofornito dal grano del minuscolo seminatoriale, ci si può procuraresenza ricorrere al mercato? Le cose stanno solo in parte così, eci sono vari indizi che inducono a considerare il vigneto unacarta importante che il contadino cerealicultore può giocare sulmercato monetario nei momenti non infrequenti di bisogno. In primoluogo ci sono vari modi per realizzare un sovrappiù vendibileanche in una situazione di produttività bassa. Oltre al proprio
84 Cfr. L. PALUMBO, La viticoltura nel Regno di Napoli in età moderna (conparticolare riguardo alla Puglia), di prossima pubblicazione; DEMARINO, Apprezzo cit., p. 68.85 Cfr. V. RICCHIONI, La 'statistica' del Reame di Napoli del 1811. Relazionisulla Puglia, Trani 1942, P. 11386 DE MARINO, Apprezzo cit., p. 36.87 Cenni a tutto questo in B. SALVEMINI, Quadri territoriali e mercatiinternazionali. Terra di Bari nell'età della Restaurazione, in «Società estoria», 1982, n. 18, pp. 858 sgg
33
fondo il contadino ne coltiva spesso un altro preso in fitto88“, eil vino autoprodotto, che rappresenta probabilmenteun'integrazione energetica importante nei lavori invernali sullatifondo, retribuiti quasi interamente in denaro e comunque nonanche in vino come per la mietitura, può essere soprattutto nellefasi di lavoro meno intenso sostituito dall'“acquata” o essostesso abbondantemente annacquato89“: qui come altrove90
l'elasticità del consumo di vino è molto elevata e può tendere adannullarsi non solo in assenza di disponibilità fisica delprodotto, ma anche quando c'è la necessità di monetizzare quelloche si ha. In secondo luogo le oscillazioni annuali dellaproduzione sono molto alte e bizzarramente distribuite dallagrandine o da altri accidenti su un territorio anche ristretto,sicché la famiglia contadina può trovarsi di anno in anno nellacondizione di acquirente o venditrice nei confronti della famigliadella porta accanto, non avere per nulla vino o avere problemi diconservazione dato l'alto costo di botti e barili. Insomma, in unambiente fortemente monetizzato come quello della Murgia centro-settentrionale, il microfondo vitato spinge il contadino sulmercato, a contatto col cantiniere e l'incettatore o colconsumatore finale nella vendita in casa, in particolare in unafase dell'annata agricola - quello successivo alla vendemmia - incui ha bisogno di acquistare la semente per il microfondo acereali e i lavori della masseria sono in fase di stanca.
Oltre all'uso mercantile del vino c'è l'uso mercantile dellaterra vitata: soggetto a una mobilità proprietaria altissima91 ilvigneto viene venduto o acquistato a seconda delle esigenze edelle fasi della vita famigliare; vi si poggiano censi passivi chepossono non essere solo sintomo di bisogno immediato ma anche88 Cfr. MASELLA, Per una storia dei contratti agrari cit., passim.89 L'« acquata: vino leggero ottenuto ricoprendo d'acqua le vinacce dopo laspremitura », di bassa gradazione alcolica ad alta deperibilità, ma ampiamenteconsumato dal popolo (cfr. nota del curatore a P. 70 di DE MARINO, Apprezzocit.), è contabilizzata dal tabulario di Gravina a parte dal vino, a un prezzocorrispondente alla metà di quello del vino stesso. La pratica dell'annacquaturaera largamente praticata per il vino da corrispondere come integrazionesalariale nelle masserie. Cfr., ad esempio, CENTRO STUDI DI BISCEGLIE, Registrocontabilità Tupputi, p. 285, dove si dice che le 19,14 some di vino acquistatenel giugno 1795 sono diventate 2 6,2 3, « per acqua menata nel vino mandato allemasserie ».90 Cfr., per tutti, F. BRAUDEL, Capitalismo e civiltà materiale, Torino 1977, p.172.91 L. MASELLA, Mercato fondiario e prezzi della terra nella Puglia barese traXVII e XVIII secolo, in «Mélanges de l'Ecole Française de Rome, Moyen áge -Temps modernes», 1976, n. 1, in particolare pp. 290-91.
34
strumento per conquistare una libertà di scelta, per acquisirealtri immobili o migliorare quelli posseduti o riscattare debiti;e il vigneto altrui viene gestito secondo forme contrattuali - daquella dei gravinesi che “per guadagnare le loro giornate piantanole vigne e poi piantate le soleno vendere” al contratto adpastinandum92, - che lasciano ancora spazi all'iniziativa delcoltivatore. Così questo aspetto apparentemente secondario delpaesaggio agrario murgiano assume un ruolo rilevante negliequilibri economici dei lavoratori del grano, non come possibilerifugio nell'economia naturale dell'autoconsumo quando le nubi siaddensano sull'enigmatico mercato monetario dominato dal grano,ma, al contrario, come integrazione monetaria da realizzare in unrapporto stretto con la città. In un certo senso il vignetocontadino, in questo contesto, non 'ruralizza' ma 'urbanizza' icontadini del latifondo; non li fissa sui campi troppo piccoli eche cambiano di mano troppe volte perché vi si possa costruire unacasa e abitarvi, ma li proietta in piazza, a realizzarecompravendite.
Il rapporto funzionale tra masseria murgiana e “ristretto”vitato è leggibile in maniera più diretta sollecitando i daticatastali e traducendoli in giornate lavorative. Il vigneto, perunità di superficie, ha bisogno di giornate lavorative quattrovolte più numerose di quelle del seminatoriale - cento circa perettaro contro venticinque circa - e per di più di qualità e costomaggiore93 cosicché i vigneti di Minervino o Spinazzola richiedonocomplessivamente una quantità di lavoro calcolabile, per dare unordine di grandezza, fra un quarto e un quinto di quello assorbitodal seminativo, ed una porzione ancora più elevata del monte-salari; un'integrazione tanto più utile in quanto il calendarioagricolo della vite realizza, con quello del grano, un gioco adincastro che permette di trattenere nei borghi al centro dellatifondo una porzione relativamente alta delle unità di lavoronecessarie nelle fasi acute della cerealicoltura e, al tempostesso, distribuendo la massa
del lavoro disponibile su una parte consistente dell'annataagricola, di contenere la disoccupazione stagionale: vendemmia epigiatura fra settembre e ottobre, zappatura invernale epropagginatura a novembre-dicembre, zappatura primaverile,92 DE MARINO, Apprezzo cit., PP. 35-36; PALUMBO, La viticoltura nel Regno diNapoli cit.93 Cfr. PALUMBO, La viticoltura nel Regno di Napoli cit.; SQUEO, FrumentoculturaCit.; DE CESARE, Delle condizioni cit., pp. 83 Sgg.; DELILLE, Agricoltura edemografia cit., pp. 116 sgg.
35
mondatura e fasciatura delle viti a maggio, zappatura estiva aluglio impiegano nel vigneto braccia che non trovano lavoro nellemasserie, e viceversa, quando la domanda di lavoro espressa daqueste ultime si fa spasmodica, in particolare a gennaio, aprile egiugno, il vigneto ha bisogno di poche cure94. La Murgia riescecosì a contenere i fenomeni di precarietà insediativa e dimobilità parossistica del lavoro entro limiti molto più contenutidi quelli di altri ambienti a latifondo agricolo commercializzato.
La fase dell'annata agricola in cui il gioco sembra nonriuscire è quella della mietitura, come si sa uno dei colli dibottiglia fondamentali delle società di antico regime, un momentoche provoca attorno alle aree di cerealicoltura specializzatamigrazioni imponenti e tensioni acutissime.
Anche da questo lato agiscono in Terra di Bari meccanismi chetendono ad attutire gli effetti laceranti di una precoce e intensaspecializzazione e commercializzazione, e che però riguardano nonpiù solo le zone produttrici di cereali ma l'intera realtàprovinciale.
3. L'agricoltura e la società dell'albero.
La grande distesa della Murgia cerealicolo-pastorale schiacciaa ridosso del mare, in un contrasto violento di colori e forme,una fascia sottile di paesaggio. La massa calcarea che forma ilsuolo della provincia, prima di immergersi, restituisce spessovicino alla battigia le acque ingoiate dai puli e dalle grottesotterranee dell'entroterra senza provocare episodi significatividi impaludamento, e costruisce uno dei rarissimi tratti costieridel Mezzogiorno d'Italia non repulsivi per l'insediamento umano.Qui un festone di giganteschi centri a ridosso l'uno dell'altrosfida il pericolo dei corsari, e mura e bastioni contengono afatica un'edilizia che si protende verso l'alto prima distraripare nei “borghi” a richiedere un'altra cinta muraria,assediata a sua volta dai boschi di un'agricoltura dell'alberofatta oggetto della meraviglia e dell'entusiasmo di una teorialunghissima di viaggiatori. Un mutamento spesso repentino dicolori, colture, tipi umani segna il confine fra una Puglia dimolta terra e uomini radi, di suoli nudi e riarsi calpestati dacentinaia di migliaia di pecore, di milites e braccianti, e unaPuglia di poca terra e molti uomini, di alberi e giardini, di
94 Cfr. SQUEO, Frumentocultura cit.; PALUMBO, Aspetti di vita economica e socialecit., pp. 120-39.
36
contadini che ingigantiscono il “ristretto” fino a farlocoincidere in molti casi con l'intero agro disponibile, che cavano“frutto dai sassi medesimi”95 e, per concimarli, pongono al bracciodei “loro figli ancor teneri [...] una cesta [...] che al ritornopoi in casa devono riportare piena di letame di asini, di muli edi cavalli”96.
Anche in questo caso, per capire occorre in primo luogodistinguere. Al margine settentrionale della costa della provinciagli agri di Trani e Barletta, parte integrante della Murgiacerealicola, partecipano in una qualche maniera anche di certicaratteri dell'altra area: l'agricoltura dell'albero vi èpraticamente assente, ma la viticoltura, che sembra essersidiffusa nel tardo Medioevo fino a mettere in discussionel'indipendenza annonaria della zona97, continua in età moderna adinteressare una parte molto consistente dell'agro - ben il 21,1per cento delle terre censite nell'onciario di Trani98 e, superandola funzione fondamentale ma pur sempre sussidiaria tipica delvigneto della Murgia interna, si organizza in aziende capaci di unrapporto più regolare col mercato e cerca addirittura sbocchi nelmercato internazionale99.
Al centro di quest'area costiera, in quella “conca di Bari”disegnata dall'orografia, e nella Premurgia all'interno dellalinea di costa fra Mola e Monopoli, la situazione si fa piùincerta non solo per la scarsa informazione disponibile, ma forseanche perché gli assetti colturali sono meno netti. Dai catasti,da quello cinquecentesco di Bari studiato da Poli100 fino al
95 L'espressione, di un documento del 1774 relativo a Molfetta, è Citata in L.PALUMBO, Prezzi e salari in Terra di Bari (153o-186o), Bari 1979,p. 86.96 Da un documento su Mola del 1783 citato in M. ASSENNATO, Eroi dellatrasformazione agricola del Mezzogiorno tra Settecento e Ottocento, di prossimapubblicazione.97 LICINIO, Uomini e terre cit., PP. 42 e 60-61.98 Cfr. G. POLI, Per lo studio del paesaggio agrario in Terra di Bari: il caso diTrani e Bitonto, in ID. (a cura di), Ricerche su Terra di Bari tra Sei eSettecento, Molfetta 1986, pp. 86-87; per Barletta cfr. la descrizione dell'agrodella città contenuta nel manoscritto del Pecorari del 1787 utilizzato daBONAZZOLI, L'economia agraria cit., pp. 147 sgg.
99 Trani esporta nel 174 1 ben 9899 some di vino (cfr. COLAPIETRA, Profilostorico-urbanistico di Trani cit., p. 50), e ancora ai primi dell'Ottocentofrequenti sono gli arrivi da quel porto a Venezia di navi che trasportano vino:AS Venezia, Console del Regno delle Due Sicilie, registro n. 92.100 G. POLI, Società e struttura professionale ne114 costa barese delCinquecento, in Atti del convegno di studio su «momenti di storia molfettese»
37
murattiano, ci viene l'immagine di un territorio che non vuolerinunziare del tutto alla sua indipendenza annonaria e che neicosiddetti “casali di Bari” si caratterizza per una utilizzazionedel suolo parossisticamente intensiva ma non monocolturale:all'inizio dell'Ottocento nell'agro barese l'oliveto rappresentaappena il 6,9 per cento del territorio censito, a fronte del 63,3del “seminativo arborato”101, e ancora nel 1829 non tutti glioliveti del circondario di Bari si presenteranno come “chiusure,cioè con alberi folti, ma più della metà con vigneti, o con alberirari”102.
Dalla stessa indagine del 1829 a Putignano e Noci, nellaPremurgia meridionale, non risulta vi siano “terreni consacratialla sola coltivazione degli olivi, ma questi con altri alberifruttiferi sono sparsi ne' vigneti e ne' terreni addetti allasemina de' cereali”: una situazione simile solo in apparenza aquella della conca barese, dato che in questo caso la policolturasi esprime in una agronomia mediocre e confusa, nella quale siperpetua una volontà di autoconsumo non dissimile da quella dellacontigua Murgia orientale. Non che manchi qui la produzione per ilmercato. Nelle campagne di Conversano sono numerosi gli organismidenominati “masserie”, ma queste hanno dimensioni nettamenteinferiori rispetto a quelle murgiane e assetti colturali molto piùvariegati, che impediscono la produzione di sovrappiù di ampiedimensioni, capaci di attivare flussi consistenti e regolari versodestinazioni lontane103. Coerentemente con tutto ciò, in unaprovincia in cui i contratti agrari si presentano precocementesemplificati e monetizzati, sopravvivono a lungo in quest'areaforme contrattuali ibride, che coinvolgono la famiglia contadina enon il lavoratore singolo, che distinguono la titolarità dei“frutti di sotto” rispetto a quella dei “frutti di sopra” eprevedono consistenti integrazioni in natura dei canoni104“, nelmentre le masse contadine tentano di soddisfare il pur sempreinevitabile bisogno di moneta più che con la mercantilizzazionedei prodotti di loro pertinenza, con lavoro salariato erogatolontano, in incalzanti migrazioni stagionali in ogni direzione epiù volte l'anno. Così un osservatore settecentesco non si
cit., pp. 63-88.101 ASBA, Registro riassuntivo dei catasti provvisori cit.102 ASBA, f. Agricoltura industria commercio, b. 163, fs 163.103 Cfr. la tesi di laurea elaborata presso la facoltà di Lettere e Filosofiadell'Università di Bari di V. VENERUCCI, Le campagne di Conversano nel '700,a.a. 1971-72.104 Ibid.
38
meraviglia affatto se l'“ampio vigneto”di Castellana, cheall'inizio dell'Ottocento avrebbe coperto quasi il 30 per centodell'agro, faccia tanto poco vino, dappoiché essendo lo stessosituato in terreni magri ed essendo pieno di alberi di vari frutti[...] cosicché sembra un giardino, non può rendere molto vino[...] , né si pon troppa cura a fare colla scelta delle uve, deivini veramente squisiti; anzi molti possessori, ove la qualità delterreno il comporta, seminano nello stesso delle vettovaglie,donde molto detrimento soffrono le viti [...] . Quando iCastellanesi - continua il nostro - si saran sottratti dagliaggravii e dalle miserie nelle quali gemono; quando si avrannorinfrancato il debito privato di presso duc. 40000 che fanno convari particolari forestieri [...] in guisa che non debbono esserepiù obbligati li nostri contadini di portarsi nella Puglia amietere gli altrui seminati, e nelle città di Monopoli, Ostuni eTaranto per raccorre ulive non proprie, allora da per se stessiindurranno nel loro paese il buon coltivo ai campi edimprenderanno la piantagione ed una migliore potagione ai loroulivi105.
Ma, come vedremo, non sembra che la Premurgia meridionaleriuscirà ad uscire da questo circolo, che è alimentato daldisordine colturale e lo alimenta, nella direzione prefigurata dalnostro osservatore.
Meno incerte sono le testimonianze riguardanti le due areecostiere residue, quelle a nord e a sud di Bari. Ma anche qui leselve degli olivi106“ che rendonó il “Monopolis [...] ager cismontes per totam maris oram [... omnis fere [...] oleaginus”107
vanno distinte da quelle molfettesi o terlizzesi. In primo luogoesse si organizzano in aziende di dimensioni medie più consistentiche sulla costa settentrionale, gestite a volte in economia daesponenti della feudalità locale. D'altro canto esse sono diverseper aspetto fisico e forme dello sfruttamento. A partire dallaparte meridionale del territorio di Mola, e continuando perPolignano, Monopoli, Fasano, Conversano - afferma uncorrispondente di Galanti da Terlizzi - il paesaggio olivicolo èormai quello di Terra d'Otranto, che si distingue da quello dellaPuglia barese a) per la maggiore dimensione degli alberi e laqualità inferiore del prodotto; b) per una meno assidua cura105 Citato in A. CORMIO, Le classi subalterne in Terra di Bari nella crisidell'antico regime, in « Quaderni storici», 1972, n. 21, pp. 974-75.106 ALBERTI, Descrittione cit., p. 216.107 RENDELLA, Tractatus de pascuis, defensis, forestis, et aquis.... Napoli 1726,p. 146. L'autore, umanista monopolitano, è vissuto fra il 1553 e il 1630
39
agronomica - la potatura non s'esegue ogni anno e le arature sonouna o due l'anno, invece che tre o quattro - che si accompagna aun uso del suolo sotto gli olivi “per pascolo di bestiame grosso eminuto”; c) per il modo della raccolta, che si effettua non sullapianta ma per terra, man mano che le olive cadono, e per ladiversa tecnica di conservazione delle olive prima dellaspremitura108. Conferma tutto ciò il fatto che, a fronte dei 74alberi per ettaro olivetato che a Molfetta si riscontrano già ametà Cinquecento109 a Polignano attorno al 1730, dopo un'efficaceopera di intensificazione colturale promossa dal nuovo feudatariolocale, gli olivi per ettaro sono 52110, e d'altro canto per lunghiperiodi nel territorio di Polignano prosperano masserie di pecoree capre che non trovano spazio alcuno sulla costa settentrionale,dove anzi l'assenza pressoché totale di pascolo riduce ladisponibilità di animali da lavoro al punto da imporre a volte lasostituzione dell'aratro con la zappa grande111.
Sarebbe dunque quest'ultima l'area ad alta specializzazioneolearia della provincia, un rettangolo con uno dei lati lunghicoincidenti con il tratto costiero che, a partire da un punto ametà strada fra Bisceglie e Trani, scende verso Bari per unatrentina di km, e i cui lati minori si spingono verso l'internoper 7- 10 km all'incirca. Vediamo di precisarne meglio i contorni.A nordovest lo stacco fra il territorio di Trani e quello diBisceglie è nettissimo112: nel primo a metà Settecento l'oliveto-mandorleto rappresenta appena l'1,45 per cento dell'agro censito,mentre un catasto, probabilmente del 1561, assegna il 53,4 percento del secondo all'oliveto mandorleto, il 20,77 a vigneto eappena il 7,9 a seminativo; a Molfetta, sempre nel 1561,l'oliveto-mandorleto giunge addirittura al 72 per cento delterritorio contro l'11,56 del vigneto e 11,69 del seminativo, ecifre non dissimili da queste - i numerosi indizi disponibilivanno tutti in questa direzione - misurano le colture dell'agro di
108 Archivio privato dei Conti Galanti, Santa Croce del Sannio, lettera del 6giugno 1789, firma indecifrabile.109 PALUMBO, Cenni sull'estensione e distribuzione cit., tabella p. 16.110 ASNA, f. Attuari diversi, fs. 188.111 PALUMBO, Cenni sull'estensione e distribuzione cit., p. 12.112 I dati relativi a Bisceglie sono contenuti in un lavoro di di G. Poliprossima pubblicazione Trani, Molfetta e Bitonto cfr. POLI, Per lo studia delpaesaggio agrario Cit.; ID., Distribuzione della proprietà fondiaria a Molfettanel 1561: osservazioni e dati, in Momenti e figure di storia pugliese. Studi inmemoria di Michele Viterbo (Peucezia), Galatina 1981, tab. p. 234. PerGiovinazzo cfr. L. PALUMBO, Notizie sulla proprietà fondiaria ecclesiastica aGiovinazzo nel XVI secolo, in «Archivio storico pugliese », 1975, pp. 113-23.
40
Giovinazzo. Meno specializzato appare nel suo complesso l'agro diBitonto, per secoli il centro di produzione olearia più importantee rinomato della provincia: le cifre dell'onciario, che sembranoin sostanza molto vicine a quelle ricavabili da un frammento dalcatasto del 1586 e dal catasto del 16 11, sono per l'uliveto il48,87 per cento, per il vigneto il 15,29, per il seminativo il24,89. Si tratta però di un agro di dimensioni ben maggiori diquelli dei centri costieri, e molto diversificato al suo interno:gli oliveti ricoprono pressoché interamente la parte di territorioche giunge al mare col “caricaturo” di Santo Spirito, in unrapporto di continuità con quelli di Giovinazzo, nel mentre ilseminativo con pezzi d'incolto diventa prevalente nella parte sud,a ridosso di Palo, dove l'ambiente costiero comincia a sfumare inquello murgiano e l'oliveto a metà Settecento copre solo il 12,94per cento del suolo, e ad est verso Modugno che, già dentro laconca barese, ne presenta in maniera esemplare le caratteristichee all'inizio dell'Ottocento avrà il 59,9 per cento dell'agrodestinato a seminativo arborato, il 14,1 a vigneto e il 24,6 aoliveto113. A ovest di Bitonto, infine, il territorio di Terlizzi,la quale pure suscita vive preoccupazioni a Molfetta per lecapacità concorrenziali del suo olio114“, presenta nel secondoCinquecento ampie chiazze di seminativo nudo115 che però devonoessere state presto colmate se già nel 1643 esso apparecaratterizzato da oliveti, vigneti e mandorleti116. Nel secondoSettecento, come è noto, la campagna terlizzese sarebbe diventatauna bandiera del movimento riformatore117 e nel 1835, a unosservatore che passerà dal territorio di Terlizzi a quello diRuvo, qualche chilometro verso l'interno ma già in pieno climamurgiano, sembrerà di attraversare il “solco” che “divide ilparadiso terrestre da un deserto”118.113 ASBA, Registro riassuntivo dei catasti provvisori cit.114 G. DE GENNARO, Rassegna storica economica e sociale intorno a Molfetta nelXVI secolo, Trani 1951, p. 21.115 G. MASI, Organizzazione ecclesiastica e ceti rurali in Puglia nella secondametà del Cinquecento, Bari 1957, pp. 67 sgg116 R. COLAPIETRA, Genovesi in Puglia nel Cinque e Seicento, in «Archivio storicopugliese», 1982, P. 52.117 Cfr., ad esempio, la Lettera dell'abate Alberto Fortis alla signoraElisabetta Carminer Turra, contenente notizie della città di Terlizzi nellaprovincia di Bari, in Illuministi italiani, tomo VII, a cura di G. GIARRIZZO, G.TORCELLAN e F. VENTURI, Milano-Napoli 1965, pp. 327 sgg.118 G. QUATTRORECCHI, Cenni intorno a' mali dell'agricoltura, dell'industria edel commercio nella provincia di Bari, e dei mezzi principali onde riparare alloro decadimento, in « Giornale di commercio arti industrie manifatture evarietà » I° settembre1835, p. 26.
41
Al primo posto fra gli elementi di forza del “paradisoterrestre” olivicolo gran parte degli osservatori colloca iparticolari rapporti produttivi fondati sull'azienda contadina, icui caratteri normativi e gestionali di età moderna vannoconfigurandosi insieme a una definizione precocemente semplificatae monetizzata dei diritti nei confronti della terra. Giàall'inizio del periodo qui considerato, decime e terraggi, daattestazione di subordinazione nei confronti del signoreecclesiastico o feudale, vanno scivolando, caso a caso, verso lacondizione di gravami su possessi perpetui o di canone su terre dicui si ha l'uso momentaneo, nel mentre la stessa titolarità deldiritto si fa oggetto di scambio, come nel caso della cessione aMolfetta, nel 1536, dei terraggi sui possessi dell'Università a ununico fittuario, che corrisponde un canone in moneta119. E ilprocesso viene accelerato dagli stessi grandi titolari di diritti:a partire dagli anni '60 del Cinquecento la Chiesa, nel quadro delriassestamento e della riorganizzazione post-tridentina che laporterà ad assumere un ruolo di assoluta preminenza nellaproprietà fondiaria di quest'area, va riconvertendo i tradizionalipatti agrari che inchiodavano una parte consistente delle sueterre a censi perpetui e canoni fissi a lunga scadenza, falcidiatidall'inflazione. La compravendita frequente tramite monetadell'uso perenne e incondizionato della terra o della concessionea breve e brevissimo termine entro patti di salvaguardia delvalore della proprietà, vanno così sostituendo le tradizionaliconcessioni perpetue, e queste ultime confluiscono con le vecchieoperazioni miglioratarie, perdendo le clausole consuetudinarie agaranzia della stabilità del possesso contadino tipiche, adesempio, del contratto ad pastinandum, e assumono il voltodell'enfiteusi: il legame di lungo periodo del contadino allaterra, da valore sociale ampiamente riconosciuto e strumentoideale per la gestione corretta dell'economia agricola, diventaman mano strumento eccezionale al quale ricorrere quando, sotto lostimolo della domanda, si vuol dare l'assalto all'incolto e alseminativo nudo e trasformarlo senza ricorrere a rischiosiinvestimenti da parte della proprietà.
Col che gli indici di concentrazione del possesso fondiarionon si presenteranno meno forti che nel “deserto” murgiano: aGiovinazzo a metà Settecento i fuochi degli occupati in119 G. POLI, Appunti per una tipologia dei contratti agrari nella fascia costieradi Terra di Bari, in MASSAFRA (a cura di), Problemi di storia delle campagnemeridionali cit., P. 326. Su queste questioni cfr. soprattutto i lavori giàcitati e gli altri citati in seguito di L. Palumbo.
42
agricoltura, compresi i massari, costituiscono il 66,3 per centodi quelli complessivi, ma posseggono solo il 14,6 per cento dellasuperficie agraria; a Molfetta alla stessa data circa la metàdella popolazione attiva ha la qualifica di “bracciale”, ma adessa risulta intestato il 9,4 per cento della superficiefondiaria. Di converso, ancora come nella Murgia interna, unapercentuale elevata di contadini - il 76 per cento dei foresi ebracciali a Giovinazzo, il 70 per cento dei bracciali a Molfetta -possiede frammenti di terra, della dimensione media di 1,7 ettaricirca nel primo centro, di meno di un ettaro nel secondo.120
La differenza vera rispetto alla situazione murgiana sta nellaqualità e nella funzione economica dei microfondi costieri. Latabella 2 ci mostra come sono ripartiti per colture i 540 haattribuiti dall'onciario ai 579 fuochi di bracciali possidentimolfettesi in confronto alla ripartizione dell'intero agro. Loscarto rispetto alle percentuali complessive delle colturepraticate sui propri campi dai bracciali a favore di quelle amaggiore intensità di lavoro è certo significativo, ma nonmodifica un dato di fondo, già del tutto evidente nei catasticinquecenteschi di Molfetta e Bisceglie: il fatto che lamicroproprietà contadina non produce, come nella Murgia interna,altro rispetto al settore specializzato coinvolto nel commercio alunga distanza. La limitatezza degli agri ridimensiona lo scartofra le due colonne della tabella 2, e i dati catastali, riletticon criterio diverso, restituiscono l'immagine di un mondo dicontadini che sono pressoché esclusivamente olivicoltori: se su 15famiglie di addetti all'agricoltura molfettesi ben 10 posseggonooliveti e mandorleti, solo 1 su 8 possiede seminativi, 1 su 10giardini frutteti e cocevine, 1 su 25 vigneti.
Al microfondo olivetato il bracciale aggiunge spesso,partecipando alle aste periodiche per la locazione delle proprietàecclesiastiche o rivolgendosi altrove, altri frammenti di terragestiti sulla base di rapporti contrattuali di solito a brevetermine e quasi sempre configurabili come fitti in denaro, ericopre l'agro di minuscole aziende, spesso frantumate in piùlotti dispersi per ogni dove, che rappresentano le cellulefondamentali dell'economia olivicola esportatrice, così come le“massarie grosse” murgiane lo sono per la cerealicoltura. Non chesiano assenti produttori di tipo diverso. A Giovinazzo i 10massari censiti dall'onciario possiedono quasi solo terre120 Per i dati di Giovinazzo Cfr. DE GENNARO, Aspetti e problemi cit.; per quellirelativi a Molfetta, G. TULLIO, Molfetta nell'età moderna, Ginevra1983, pp. 135599.
43
olivetate, e unendo ai 4,8 ettari a testa di proprietà fondiariaanimali da lavoro, attrezzi, immobili urbani e capitali sicollocano in una fascia sociale distinta dal normale lavoroagricolo, a volte proiettata verso i ceti superiori attraverso ilvarco peggio difeso, quello dell'ottenimento per un membro dellafamiglia della condizione di sacerdote attraverso l'impiego diquantità anche notevoli di risorse strappate alla terra; ma ingenerale la condizione professionale e, ancora più in alto, quella“civile” appaiono un obiettivo arduo: sempre a Giovinazzo ilmassaro Michele Illuzzi di 61 anni, possessore fra l'altro di 8buoi aratori, ha un figlio anche lui massaro, ma due altri con laqualifica di bracciale, Nicola Carlucci, anch'egli possessore di 8buoi aratori, ha lui pure un figlio bracciale, e due ne ha
Tabella 2.
Ripartizione percentuale per colture del possesso fondiariodei bracciali in confronto con quella dell'agro di Molfettanel1754.
Possesso Agro difondiario Molfettadei “bracciali”
Oliveto-mandorleto 59 72Vigneto 11 5Seminativo 13 15Cocevina, giardino, frutteto 17 8Totale 100 100
Oronzo Bonvino, che possiede, oltre alla terra, 11 buoiaratori e una giumenta121.
Non sta qui, comunque, la specificità di questa figurarispetto a quella murgiana denominata allo stesso modo. Il massaroolivicolo - certo un elemento di articolazione e movimentointeressante della società costiera - ha una importanza economicadi gran lunga inferiore rispetto al suo collega cerealicolo: sisporge al di là della terra da lui posseduta più che come gestoredi terra altrui, come locatore di attrezzi e animali da lavoro aun'economia di appezzamenti troppo piccoli per ammortizzarne il
121 DE GENNARO, Aspetti e problemi cit., p. 492.44
costo; anche quando coltiva campi non suoi appare spesso privo delruolo 'imprenditoriale' che segna - lo vedremo - il suo omonimocerealicoltore, e a volte appare degradato a tramite con la terradi una proprietà che, laica o ecclesiastica, può esseredifficilmente definita, senza molti distinguo, 'assenteista'. Latecnica agronomica è in questi ambienti cultura comune122 piano dicomunicazione fra laici ed ecclesiastici, contadini eprofessionisti, e permette a tutti di avere, dalle diversecollocazioni, un rapporto con un'agricoltura di pratiche secolari,sempre uguali a se stesse ma a loro modo raffinate; tanto più cheessa si svolge a un tiro di schioppo dalle mura della città e, inassenza di immobili rustici consistenti del genere di quelli dellamasseria cerealicola, si organizza momento per momento dallapiazza urbana. Un proprietario, laico o ecclesiastico, può avere aun dato momento una parte dei suoi appezzamenti gestiti ineconomia tramite un massaro perché non trova locatari che glicorrispondano i canoni richiesti o perché vuole garantirsi unadisponibilità aggiuntiva di derrate da commercializzare, e spostala soglia fra l'uno e l'altro modo di gestione a seconda dei tempie delle convenienze; e se evidente è la preferenza per la cessionein fitto di piccoli appezzamenti, che permette di ridurre i rìschie massimizzare il lavoro incorporato nella terra, il controlloproprietario sulle forme di gestione appare ben più attivo chenella cerealicoltura organizzata in masseria, organismo grande,complesso e lontano dalla città e pertanto gestibile solo dafigure specialistiche relativamente forti e autonome, quelle deimassari murgiani. Insomma, queste figure intermediedell'olivicoltura specializzata sono forse il segno che i canalidi mobilità fra i ceti non sono del tutto ostruiti, ma nonconnotano l'ordine economico, e tanto meno prefigurano alternativead esso sul piano dei valori e dei rapporti di produzione: finquando restano tali esse appaiono schiacciate fra una proprietà'interventista' e un lavoro autonomo pervasivo erogato nellamicroazienda.
Questo confrontarsi diretto di microazienda e mercatointernazionale è reso possibile, in primo luogo, da un rapportofra sovrappiù vendibile e prodotto autoconsumato che nell'olivetoè molto più alto che nel vigneto. Abbiamo visto per l'areamurgiana come per il consumo teorico di vino di una famigliacontadina media occorra poco meno di un ettaro di vigneto. Per
122 L. PALUMBO, Appunti sul mondo rurale dell'Italia meridionale (secc. XV-XVII),in Rapporti tra Proprietà impresa e mano d'opera cit., p. 232.
45
Molfetta un “Quinterno de' vini” del 1573 sembra pienamenteconfermare queste cifre: i 353 produttori di vino molfettesi chehanno a disposizione 2537 some, ne immettono sul mercato cittadinosolo il 30 per cento e trattengono per sé il resto, corrispondenteall'ncirca - adottando il coefficiente di 4,5 membri ad unitàfamiliare - a 300 caraffe a testa123. La situazione si rovescia perl'olio, per il quale, secondo un'inchiesta governativa del 1717, aGiovinazzo i produttori hanno messo sul mercato l'83 per centodelle 2637 salme di “ogli nati in questo territorio” l'annoprecedente, e solo le 450 residue, corrispondenti all'incirca aduna salma per produttore, risultano “rimesse in casa delliparticolari per loro proprio consumo124“. Ma anche questo rapportoappare eccessivo, probabilmente aumentato dalle esigenze dei dueenti ecclesiastici presenti fra gli intestatari di partite d'olioe dalla volontà di non “rivelare” tutto l'olio disponibile. Laparte relativa a Conversano dello stesso documento125, che riportaper ogni produttore il totale prodotto, la parte riservataall'autoconsumo, quella già venduta e quella ancora disponibileper la vendita, ci permette di collocare in maniera molto piùrealistica l'olio autoconsumato dalla famiglia contadina fra i 20e i 40 kg l'anno: una quantità per produrre la quale basta qualchealbero, meno di un decimo di ettaro, sulla base del calcoloprudenziale di una produttività media, nell'area piùspecializzata, di 3-4 quintali di olio per ettaro126.
Se dunque il rapporto col mercato del microfondo viticoloesiste ma è saltuario, affidato alle punte alte di produttività,quello del microfondo olivicolo è strutturale, organico. Alcontadino che coltivi un ettaro le oscillazioni amplissime diproduttività, che a Molfetta nel Seicento possono portare laproduzione per ettaro da 1 a 10 quintali di olio127“, lascianocomunque un margine commercializzabile senza che egli abbia lanecessità di comprimere i suoi consumi. Tutto questo può nonbastare, dal momento che questo contadino misura la produttività123 Elaborazioni da L. PALUMBO, Produzione e commercio del vino a Molfetta neltardo Cinquecento, in « Rassegna pugliese di tecnica vinicola ed agraria »,1969, n. I, pp - 3 - 10.124 125 BN Napoli, sezione Manoscritti, vol. XI-A-29, CC. 257r-258v. Il documento è stato già in parte utilizzato da A. DI VITTORIO, Gli Austriaci eil Regno di Napoli 1707-1734- Ideologia epolitica di sviluppo, Napoli 1973, P.458, nota.126 Cfr. IBN Napoli, Manoscritti, vol. XI-A-29, CC. 28or-285r.127 Elaborazione sulla tabella a P. 42 di L. PALUMBO, L'olivicoltura a Molfettanel XVII secolo, in « Rivista di storia dell'agricoltura», 1974, n. 1.
46
della sua terra non in termini fisici ma economici. Lamicroazienda olivicola vive in un ambiente in cui istituzioni,comportamenti, ceti che hanno risorse finanziarie e capacità dicontrollo sugli sbocchi mercantili devono continuamente misurarela propria avidità di guadagni speculativi con la necessità di nonsoffocarne la sorgente ultima, l'azienda contadina stessa, creandoper essa spazi per un margine fra costi e ricavi in modi e formesu cui occorrerà tornare partitamente più avanti, quando verràaffrontato il nodo delle città costiere. Il punto che èindispensabile sottolineare fin d'ora è che questa contabilitàaziendale, in qualunque modo la si voglia redigere, dà risultatiparadossali e comunque non permette in alcun modo di configurareil microfondo contadino come un'azienda dotata di una qualcheautonomia. L'organismo produttivo protagonista indiscussodell'economia dell'albero ne è al tempo stesso l'anello debole;esso rimane per secoli al centro dell'olivicoltura barese senzamai uscire da una condizione di precarietà più o meno grave.
Alla radice della precarietà del microfondo oleario vi èl'intreccio fra la sua dimensione media inadeguata a produrre unreddito che soddisfi i bisogni della famiglia contadina, el'incertezza e variabilità del reddito medesimo legata allairregolare biennalità del prodotto che, compensata solo in piccolaparte dalla biennalità alternata dei pochi mandorli sparsi fra gliolivi rende il contadino strutturalmente dipendente daanticipazioni finanziarie onerose. Egli tenta di far fronte allesituazioni difficili che ciclicamente gli si presentano in varieforme: il microfondo preso in locazione, specie se il concedente èun'istituzione ecclesiastica che ha di solito un atteggiamento piùmorbido nei confronti dei fittuari, viene aggredito con pratichedistruttive, trasformando la potatura in produzione di legna daardere o subaffittandolo ai rovinosi e temutissimi pastoriabruzzesi, nel mentre la terra propria, spesso eccessivamenteinfoltita di olivi nel tentativo di spingere al massimo laproduttività, viene, con danno degli olivi stessi, seminata sottogli alberi, per assicurarsi una parte almeno del grano che,dovendo essere acquistato e trasportato da lontano, ha un costorelativamente elevato ed è una delle cause primedell'indebitamento. Di qui l'impressione ingannevole di unamaggiore efficienza e intensità dell'agricoltura dellamicroazienda rispetto a quella delle aziende di maggioridimensioni. Nei suoi 36 ettari divisi in 17 appezzamenti, ilmassaro cinquecentesco joanne Scaturro di Molfetta produce, oltre
47
all'olio, vino, legumi, ortaggi, cereali128, e all'altro capo delnostro arco cronologico, a fine Settecento, Domenico Tupputi vacomprando a Bisceglie numerosi appezzamenti di “olivi e terravacua”, nei quali, invece di limitarsi a riempire i vuoti conaltri olivi, fa piantare con notevole dispendio finanziarioinsalate e piselli, pomodori e meloni, fave e “bambagia”129:l'articolazione colturale permette loro di distribuire i rischi edi difendersi dalla inevitabile “stanchezza della terra” megliodel contadino costretto a forme di coltura ad altissime intensitàdi lavoro dalla ristrettezza del suo appezzamento e dallanecessità di inseguire spasmodicamente, a causadell'indebitamento, guadagni monetari con una produzioneimmediatamente monetizzabile. Guardati più da vicino, i processidi specializzazione ed intensificazione colturale indotti dalmercato internazionale di antico regime in un'area come quella quistudiata possono alimentare non sviluppo ma precarietà, ed essernea loro volta alimentati.
La vitalità secolare del microfondo olivicolo, incomprensibilese lo si osserva al di fuori del contesto, può trovare unaspiegazione centrando l'attenzione su coloro che lo coltivano,sulla composizione del loro reddito. Ed a guardare le cose daquesto lato l'articolazione di fondo della società rurale, chesembra poco perspicua se si assume come criterio discriminantel'alternativa proprietà coltivatrice - proprietà assenteista,riemerge con chiarezza attorno alla distinzione fra i pochi cheriescono a ricavare dalla propria terra o da quella presa in fittotutto il loro reddito, e la massa dei contadini per i quali ipochi e incerti ducati ricavati dalla vendita dell'olio prodottonella propria azienda rappresentano solo una delle voci, spessonon la più rilevante, di un reddito che per le suecaratteristiche complessive li inchioda, lessicalmente e neifatti, a una condizione di “bracciali”. Per costoro lamicroazienda assume il significato di una fonte certa di domandadi braccia a retribuzione differita e incerta, che vicendevolmentesi integra e si sostiene al mercato generale del lavoro, fonte di
128 POLI, Società e struttura professionale cit., P. 75. Le ipotesi avanzate inqueste pagine trovano un qualche fondamento in questo lavoro di Poli e nei saggicitati dello stesso Poli e di L. Palumbo. Di quest'ultimo cfr. anche Notizie suibeni fondiari del Capitolo di Molfetta dall'età della Controriforma al periodounitario, in «Archivio storico pugliese», 1969, pp. 1-18, e Vicende agrarie eorganizzazione ecclesiastica a Molfetta nel XVI e nel XVII secolo, ivi, 1970,pp. 89-113.129 Centro studi di Bisceglie, Registro contabilità Tupputi cit.
48
domanda di braccia incerta a retribuzione certa e spesso - lovedremo - anticipata. Normalmente il salario risulterebbeinsufficiente a sostenere da solo la famiglia contadina, e diconverso senza di esso il contadino non riuscirebbe a reggerel'azienda; ma l'equilibrio fra le due fonti di reddito muta dasoggetto a soggetto e da fase a fase: la perdita del possesso è unfatto socialmente non traumatico, che coinvolge nei momentidifficili una quota elevata dei lavoratori della terra senza chequesto implichi un mutamento di condizione sociale, e che sipresenta spesso non irreparabile. Di qui l'improponibilità diun'impostazione d'ascendenza riformatrice che contrapponga ildisperato bracciante murgiano all'industrioso e intraprendentecontadino costiero. Per quest'ultimo come per il primo, ilrapporto con la proprietà è superficiale, strumentale, scarsamentecomplicato dalle implicazioni affettive, di status ecc. tipichedelle situazioni contadine 'normali'; non c'è alcunaidentificazione fra unità produttiva e unità familiare e illavoro agricolo si configura come un fatto individuale; l'età almatrimonio è precoce e comunque non condizionata dall'accesso allaproprietà; profondo è il legame con la città, nella cui piazzasoltanto è possibile combinare le mille transazioni necessariealla produzione di un reddito così complesso.
Se dunque una parte così consistente di questo reddito è ilrisultato di lavoro in conto terzi, occorre individuare il modo ei luoghi in cui esso viene erogato, occorre trovare fonti didomanda di braccia imponenti capaci di impiegare, per una partedell'annata agricola, la massa dei contadini olivicoli. Laquestione da affrontare subito a questo riguardo è, ancora unavolta, quella del calendario agricolo. Il momento di tensione piùelevata è qui la raccolta delle olive. Svolgendosi però a distanzaminima dai centri abitati e in condizioni climatiche e ambientalirelativamente favorevoli - in autunno fra i boschi di olivi inveceche, come nella mietitura, nei campi nudi sotto il sole di giugno- e richiedendo agilità e pazienza più che forza. la raccoltaviene risolta con una mobilitazione generale della manodoperafemminile e minorile integrata da migrazioni di raggio breve130“,che nella zona costiera settentrionale coinvolgono con ogniprobabilità i bracciali della Murgia cerealicola contermine e inquella meridionale attingono al serbatoio di manodopera 'molle', abasso costo e facilmente spostabile, costituito dalla Premurgia130 Significativamente, all'inizio del Seicento, l'Università di Molfetta sipreoccupa di facilitare in ogni modo l'arrivo di lavoratori forestieri per laraccolta: AC Molfetta, Conclusioni decurionali, 14 settembre 1611.
49
meridionale. Dei 135 individui coinvolti negli 82 contratticinque-seicenteschi di “locazione d'opere” per la raccolta diolive studiati da Massa, i ragazzi sono 32, le ragazze 9, le donneadulte 60, i maschi adulti solo 34131.
In generale il contadino olivicoltore tipico non sembra cheoffra lavoro a terzi al momento della raccolta, ma raccoglie leolive sul proprio microfondo per poi impegnarsi per lunghi mesi -da tre a sei a seconda della consistenza del raccolto e del numerodei trappeti in azione - nella macinatura delle olive, o nellaripresa delle colture per il nuovo ciclo agrario.
Nel quale, però, egli troverà vuoti più ampi di quelli cheincontra il bracciale murgiano. Lo scarto in termini di domandaunitaria di lavoro fra vigneto e oliveto è nettamente inferioreallo scarto fra vigneto e seminativo, e, per di più, i rispettivicalendari agricoli si sovrappongono in buona parte; di conseguenzail ruolo equilibratore svolto dal vigneto sulle Murge cerealicoleè qui marginale, ed anzi esso in una certa misura accentua ladistanza fra picchi e avvallamenti della domanda complessiva dibraccia. Questa si presenta così, a seconda delle fasi dell'annataagricola, o intensa e concorrenziale con quella espressa dallamicroazienda, cosicché i contadini, con grande scorno di chi tentadi estendere alla Puglia la riforma tridentina, sono costretti “logiorno di lavoro [...] a faticar alla giornata a servir altri etli giorni festivi de la domenica santa et altri giorni solenni etfestivi [...] a faticar sopra le robbe loro”132 oppure praticamentenulla, in coincidenza con le fasi morte dei lavori dellamicroazienda, in particolare nei mesi estivi, troppo lunghi perchési possa sopravvivere, in attesa dell'olio nuovo, autoconsumandola frutta di qualche albero ai margini dell'oliveto, sul ricavatodelle mandorle vendute ad agosto, sul salario dimezzato che moglie figli possono procurarsi alla vendemmia.
Anche in questo caso, a rimanere all'interno dell'areasubregionale in esame, i conti non tornano. Man mano che siguardano le cose più da vicino, azienda contadina olivicola e“massaria grossa” cerealicola, capisaldi di mondi apparentementeestranei, appaiono pienamente comprensibili solo in un'analisi chele tenga assieme.
131 C. MASSA, I salari agricoli in Teffa di Bari (1447-1733), in «Attidell'Accademia Pontaniana», a. XLII, serie Il, vol. XVII, memoria n, I, Napoli19 12, P. 7.132 G. PINTO, Riforma Tridentina in Puglia. III. Le visite pastorali (1564-1591)di A. Puteo Arcivescovo di Bari, Bari 1968, p. 24.
50
4. Le cuciture del sistema.
Dal lato della produzione, masseria cerealicola e minifondoolivicolo si legano tramite un flusso ampio di lavoro,sostanzialmente a senso unico, dal secondo verso la prima,collocato fra maggio e giugno, quando la domanda di braccia nellatifondo si fa spasmodica e va ad incontrare sulla costaun'offerta di braccia altrettanto intensa causata da un vuotopressoché assoluto del calendario olivicolo.
Non che manchino tracce di flussi minori: a parte quelli discarsa entità che portano bracciali cerealicoltori a raccogliereolive o manodopera specializzata olivicola a “sporgare” ipochissimi olivi di Montemilone o quelli più numerosi diAcquaviva133, i contratti seicenteschi di “prestazione d'opera”raccolti da Massa comprendono casi di massari, “gualani” e“gualanicchi” reclutati sulla costa, di “uomini in campagna” cheaccettano di escludersi dalla rete di relazioni dei grandi centriolivicoli in cambio di vitto e alloggio, a volte di un paio discarpe, e di una manciata di ducati. Nulla comunque diparagonabile alla discesa, in un flusso parallelo a quello dipecore e pastori, delle migliaia di contadini Abruzzesi verso ilavori invernali nel Tavoliere134, a tentare di soddisfare una famedi braccia insaziabile, che costringe “approssimandosi l'ottobre,ciascun massaio” a spedire “sopra le pubbliche strade i suoi capid'officio, per condurre all'aratro qualunque povero uomos'incontri vagando, per chiedere da vivere, sia egli di suomestiere ciabattino, ferraio, falegname, carpentiere, oaltrimenti”135. La società murgiana sembra conservare al suointerno, ben più che la Puglia piana, risorse di lavoro cherispondono flessibilmente agli alti e bassi del calendarioagricolo, e la costa olivicola è capace, ben più che la montagnaabruzzese, di offrire occasioni di lavoro ai propri contadini.
Anche qui, però, la mietitura suscita movimenti massicci dimanodopera, che permettono al grano del latifondo di essereraccolto e all'olivicoltore di integrare in maniera consistente ilreddito della sua microazienda, e che vengono regolati e
133 Cfr. l'appendice documentaria a c. MASSA, Bari nel secolo XVII.... Bari 19o3,in particolare PP. 72-75; PALUMBO, Aspetti di vita economica e sociale cit., p.115.134 Vedi le memorie di Antonio Mosca di Barete, inviata al Galanti nel giugno1790, e quella dei Marchese de Torres a nome della « società patriotticadell'Aquila», in Bp Bari, Carte Galanti.135 CIMAGLIA, Della natura e sorte cit., p. 29.
51
organizzati nel contratto notarile di “anteneria”, il documentofondamentale per cercare di penetrare nel mondo delle migrazionistagionali136.
Stipulato di solito in autunno nei luoghi di reclutamento dei“messores”fra massaro da una parte e “anteniere” dall'altra - unlavoratore agricolo, quest'ufficio, di affidabilità riconosciutain qualche modo ufficialmente dalla sua comunità - il contrattoimpegna il secondo dei due contraenti a reclutare un determinatonumero di mietitori e a presentarsi con essi alla masseria a unadata stabilita, fra la fine del maggio e i primi del giugnoseguenti, in cambio di un compenso per “anteneria” proporzionaleal numero dei lavoratori coinvolti, fissando la caparra consegnataal momento della stipula, il compenso in denaro dei lavoratoristessi (a cottimo fino a tutto il Settecento, poi a giornata), ilcompenso in natura e una sequela di clausole più o meno fisse, conle penalità previste per la mancata osservanza di quanto pattuito.Il contratto fra massaro e “anteniere” dà spesso origine a unapioggia di altri tra l'“anteniere” e i singoli lavoratori, iquali, al momento di ricevere la loro quota di caparra,136 Queste pagine sono fondate sui seguenti contratti: ASBA, Sez. Trani, notaioMarino de lo Vicario, rogante in Molfetta, atti 12 febbraio 1572, nove atti fral'anteniere e mietitori tra il 24 gennaio e il 9 febbraio 1573, 13 marzo 1573,22 dicembre 1573, più sei altri atti fra antenieri e mietitori, 13 gennaio 1579,28 gennaio 1579, 31 dicembre 1579; notaio Cassiodoro Perreca, rogante inBisceglie, atti 7 aprile 1571, 27 dicembre 1573; notaio Giacomo Quarantana,rogante in Bisceglie, atto 29 gennaio 1573; notaio Giovanni Giuliani, rogante inBisceglie, atto 18 gennaio 158o; notaio Pompeo de Bufis, rogante in Bisceglie,atto 8 ? 1601; AS Potenza notai roganti in Melfi: G. A. Pinto, atti 24 maggio1572, 18 giugno 158o; Marco de Amatis, atti 23 giugno 1587, 2 dicembre 1588, 5dicembre 1588, 9 gennaio 1589, 24 gennaio 1589, 6 marzo 1589, 11 marzo 1589, 27maggio 1589, 11 giugno 1590, 12 giugno 1590, 22 dicembre 1590, 7 gennaio 1592,1l gennaio 1592, 13 dicembre 1592, 29 dicembre 1592, 29 gennaio 1594; 9 febbraio1594; i quattro contratti di notai roganti in Castellana relativi agli anni1567, 1569, 1623, 1628 pubblicati in appendice a m. LA, Mietitura e mietitori aCastellana. Fonti archivistiche (secc. XVI-XVII), in «Fogli per Castellana»,1973, PP- 129149; i tre contratti relativi agli anni 1599, 1 6oo e 16 11pubblicati in F. S. VISTA, Note storiche sulla città di Barletta, vol. XI,Barletta 1911, PP. 77-87; ASBA, notai roganti in Gravina: Giacomo Molinari, atti24 aprile 1616, 3 dicembre 1617, 11 dicembre 16 17, 14 dicembre 1617, io gennaio1629, 28 novembre 1634; Francesco Caccio, atti 12 aprile 1623, 28 novembre 1630;Vitantonio Adabo, atti 26 novembre 1631; Giovanni Battista Molinari, atti 18 gennaio 163 8, 2 6 novembre 1640, 24 dicembre 1640, 11 marzo1651; Angelo Scalesio, atti 22 dicembre 1648, 29 dicembre 1656, 8 gennaio 1663, 25 maggio 1664; Nicola Santoro, atti 3 settembre 168o, 16 ottobre168o, 10 dicembre 1683; Giacomo deAntoniis, atti 25 gennaio 1688, 26 febbraio169o, 1 dicembre 1694. Per gli analoghi contratti sette-ottocenteschi cfr. oltrepp. 170-71, nota 12.
52
s'impegnano a seguire il primo alla data che verrà loro comunicatadal massaro, e in qualche caso, perché non siano tentati disfuggire agli obblighi contrattuali, ipotecano a favoredell'“anteniere” i beni in loro possesso, siano essi pure la“mezza vigna” di “olive e giardino con diverse frutta” possedutain territorio di Giovinazzo dai mietitori molfettesi Vincenzo eCorrado Pepe, “obbligata” all'“anteniere” Turtur nell'agosto 1796in vista del raccolto dell'anno seguente da realizzare in unamasseria di Gravina. Prima che le opere pattuite vengano prestatee il prezzo pagato, c'è ancora dell'altro lavoro per i notai: amaggio, qualche giorno prima della partenza per i campi damietere, si realizzano davanti a loro transazioni contrattualifrenetiche fra chi per impedimenti vari non può rispettare ilcontratto stipulato e non vuole incorrere in sanzioni e chi non hatrovato a tempo debito un ingaggio, magari perché troppo giovane otroppo vecchio, e viene ripescato all'ultimo minuto; chi si èobbligato con più “antenieri” e deve sceglierne uno, ma nelfrattempo ha potuto tenere per vari mesi più caparre, e chi non hacontratto obblighi e non ha ricevuto caparre, ma ora è inposizione di forza tale da pretendere un compenso più alto e, permaggior sicurezza, ipotecare in solidum i beni del sostituto edell'“anteniere”.
Questo livello insolito di formalizzazione di rapporti dilavoro e le tensioni che rivela confermano che si è qui a unosnodo di rilevanza tutta particolare per gli equilibri sociali diquest'area e per gli equilibri annonari del Regno, per i quali laPuglia è assolutamente centrale. In questo frangente. da un lato,l'azienda cerealicola affronta quasi la metà dei suoi costi diproduzione complessivi137, dall'altro il contadino, unendo spessoalla mietitura la trebbiatura e la “ventilatura”, magari conl'ausilio di un membro giovane del suo stesso nucleo familiare,giunge a ricavare in un mese o poco più l'equivalente di tre mesidi salario continuativo, e ancora di più se si tien conto chel'alloggio gratuito nella masseria e il vitto abbondante, chegiunge a valere quanto la quota in moneta del compenso delmietitore138, lo spesano del tutto e forse gli permettono direalizzare qualche piccolo traffico in proprio. Insomma, nelbilancio di un contadino olivicoltore tipico, sul lato delle137 Cfr. S. ZOTTA, Momenti e problemi di una crisi in uno «Stato » feudalenapoletano (1585-1615), in «Mélanges de l'Ecole Française de Rome. Moyen áge -Temps modernes», 1978, n. 2, P. 741.138 L. PALUMBO e G. ROSSIELLO, Salari di contadini: Altamura 183o-185o, in L'etàferdinandea 03or859) Bari 1 985, tabella p. 583.
53
entrate il ricavo della vendita dell'olio della sua microazienda,il salario dei lavori olivicoli in conto terzi e quello dellamietitura figurano come voci di importanza probabilmente simile.
Il significato per l'olivicoltore del reddito della mietiturarisalta meglio se si tiene conto che si tratta di una voceelastica, adattabile alle proprie esigenze e utilizzabile comeelemento residuale a compenso delle oscillazioni spesso violentedelle altre due. Se infatti, stando ai dati disponibili, icompensi unitari appaiono notevolmente livellati nelle varie zone,e cosi l'ammontare degli anticipi, fissi nel secondo Cinquecento aun ducato a mietitore, sembra operare un meccanismo dicompensazione del notevole dislivello fra i vantaggi comparati dichi miete alle porte di casa nell'area salubre della Murgia,rispetto a quelli di chi “cambia cielo” sperando di tornare sanodalle pianure malariche del Tavoliere, fondato sulladifferenziazione della durata delle operazioni di mietitura.Calcolando otto giornate di lavoro a versura139, la mietiturarichiede circa un quarto delle giornate lavorative avventizieassorbite dalla masseria, ma un numero di unità lavorativevariabile a seconda della rapidità con la quale si vuoleconcludere le operazioni: 100 versure possono essere mietute in ungiorno, 8 giorni o 80 giorni a secondo che si ingaggino 80o, 100 o10 mietitori. L'equilibrio fra l'esigenza di avere rapidamentegrano vendibile e la difficoltà di avere manodopera in questa fasedell'annata agricola viene trovato in punti differenti a secondadei casi: laddove le condizioni sono più favorevoli, e quindi piùabbondante è il lavoro disponibile, si assume un mietitore perogni 2,5-3 versure, cosicché la mietitura può essere completata inpoco più di 20 giorni; dove le condizioni sono meno favorevoli, eminore è la disponibilità di braccia, viene assunto un mietitoreper ogni 4-4,5 versure, e la mietitura dura poco meno di 35giorni. Parallelamente varia la retribuzione complessiva diciascun mietitore. Dunque, chi ha più bisogno di denaro “cambiacielo”, lavora più a lungo e rischia la malaria, ma riesce aguadagnare di più.
Anche a causa di tutto questo, la geografia di questo fenomenomigratorio non è compresa nei confini della nostra regioneeconomica; e purtuttavia le migrazioni stagionali presentano qui139 Cfr. DE CESARE, Delle condizioni cit., p. 83. Per dati ed indicazioni suquesti problemi cfr., oltre alla letteratura agronomica sette-Ottocentesca,SQUEO, Frumentocultura e allevamento Cit., nonché A. LEPRE, Feudi e masserie.Problemi della società meridionale nel Sei e Settecento, Napoli 1973, inparticolare l'appendice seconda.
54
un raggio relativamente breve. I mietitori delle zone oleariebaresi sono presenti in maniera sporadica nelle aree cerealicolepiù tradizionali, da Melfi a Lavello, su per Candela, Ascoli,Troia e Lucera, ai cui campi di grano inerpicati sulle primependici dell'Appennino per sfuggire alle greggi transumanti fannocapo gli itinerari dei “mietitori della montagna”, dell'AppenninoDauno, del Sannio, della Basilicata, dei Principati: provengonotutti di lì i lavoratori ingaggiati nei contratti registrati aMelfi fra il 1572 e il 1594, e quelli impegnati sulle terre delMonastero di San Bartolomeo di Lucera nel corso del Settecento140
descrivono una geografia del reclutamento molto simile, del restoin larga parte ricalcata - a conferma del carattere di permanenzesecolari di fenomeni di questa natura - su quella delle masserieregie di metà Quattrocento141. Tenendo conto non della distribuzionedei contratti per destinazione142“, ma della distribuzione perdestinazione delle unità lavorative coinvolte, le aree frequentatedai mietitori di Terra di Bari sembrano restringersi nel Cinque-Seicento in sostanza alle tre seguenti, elencate in ordine diimportanza: a) l'area cerealicola settentrionale della provinciacentrata su Andria e Canosa, che giunge a ridosso dell'areaolivicola con Ruvo e Corato, tocca il mare a Trani e Barletta esconfina brevemente in Capitanata scavalcando l'Ofanto indirezione di Cerignola e Casaltrinità; b) il Tavoliere di Foggia eManfredonia; c) l'area fra l'estrema Murgia centro-occidentale diGravina e Altamura e i primi rilievi della Basilicata di Matera,Montepeloso, Spinazzola e del Monteserico. Ma con ogniprobabilità, un documento come il contratto di “anteneria” tendeancora a sopravvalutare gli spostamenti lunghi a danno di quelliinterni alla provincia. La mietitura nelle aree cerealicole più aridosso di quelle olivicole, data l'ampia disponibilità di lavorolì presente, avrà richiesto un livello minore di formalizzazionedel rapporto di lavoro e quindi ha una minore visibilitàdocumentaria, e d'altro canto, spostando l'indagine dai notai deiluoghi di residenza dei mietitori reclutati a quelli dei luoghi di140 ARCHIVIO CURIA VESCOVILE, LUCERA, Libri della Temporale amministrazione delReal Monistero di San Bartolomeo di Lucera, 1728-1792;Giornali d'introito ed esito di questo real monistero di San Bartolomeo diLucera, 1758-1801.141 ASNA, Dipendenze della Sommaria, prima numerazione, b. 630, fs. i, b. 631, fs- i, che riportano i conti delle R. Masserie di Puglia diVulgano, Celone, Bardamento, Casanova e Florentino per gli anni 1451-1452 e1453-54.142 E il procedimento adoperato da MASSA in Salari agricoli in Terra di Baricit., pp. 4-5, che inficia in parte i risultati della sua vasta indagine.
55
destinazione interni alla provincia, emerge una rete dispostamenti di raggio breve e brevissimo che nel primo caso cisfugge: gli “antenieri” coinvolti nei 23 contratti rinvenuti neinotai roganti a Gravina nel Seicento, risiedono in dieci casi aGravina stessa, in quattro casi a Modugno, in tre casi a Palo, inun caso a Matera, Binetto, Capurso, Bitetto e Noia143.
Insomma, nonostante la differenza dei compensi, il contadinobarese sembra preferire la pendolarità infraprovinciale a quellaverso il Tavoliere. La mietitura in quest'ultimo rimane cosìaffidata in parte larghissima ai “mietitori della montagna” e aogni sorta di irregolari e marginali, e da episodio georgico tendea trasformarsi in festa crudele, nella quale i potenti possonopraticare il reciproco rapimento dei “garzoni”, i massari,costretti d'autorità ad assoldare lavoratori per le squadre chelottano contro le cavallette sotto la direzione degli ufficialidella Dogana, cercano poi di farli fuggire per impiegarli allamesse sui propri campi144 e i mietitori stessi, “fuggitivi delle piùlontane provincie del Regno o per cagione di debito o di delitto[...] uccidono i buoi, rubano la caparra e la sementa, appiccanoil fuoco alle mete ed esercitano [...] la infame arte digrassatori145“: fenomeni probabilmente amplificati daicontemporanei, ma che sono parte di un quadro di umanizzazioneinstabile e superficiale tipica di quell'area classica dicerealicoltura per il mercato, nella quale in grossi centri comeLucera o Ascoli Satriano i forestieri possono essere, nelle fasidi domanda intensa, quanto o più numerosi dei locali e una parteamplissima dei fuochi è costituita da un solo individuo146, e ivillaggi che si tenta di costruire per radicare la popolazionealla terra vengono subito “habites par des vagabonds que la misereou des délits ont obligés de quitter leurs demeures natales”147.
Da questo punto di vista il contrasto fra la strutturadell'insediamento in Capitanata e quello delle aree cerealicole
143 In un contratto non sono riuscito a identificare la residenzadell'«anteniere».144 F. MERCURIO, Uomini,. cavallette, Pecore e grano: una calamità di parte,in « Società e storia », 1985, n.30, p.788145 M. MANICONE, La fisica appula, vol. II, Napoli 1807, PP, 143-44- A. LA CAVA,La demografia di un comune pugliese nell'età moderna, in « Archivio storico perle province napoletane », 1939, PP. 25-66; ZOTTA, Momenti e problemi cit., p.757146 147 D. TUPPUTI, Reflexions succinctes sur l'état de l'agricolture et de quelquesautres parfies de l'administration dans le Royaume de Naples sous Ferdinand IV,Parigi 1807, P. 14-54
56
baresi è evidente. Certo anche qui le fasi di crescita tumultuosache investono alcuni centri - la Gravina nel primo Cinquecento,Andria nel secondo Cinquecento, Canosa e Minervino nel secondoSettecento - trovano una spiegazione anche nella loro capacità diattrarre forestieri, e di converso le fasi di crisi annonariaprotratta riempiono i centri granari “di huomini di fora” chetentano di catturare una frazione del cibo prodotto per lacommercializzazione a lunga distanza148; d'altro canto il sistemamicroazienda olivicola - masseria cerealicola non riesce sempre adassorbire l'intera offerta di lavoro degli olivicoltori quandoquesta monta a causa della crescita demografica e delladiminuzione della quota di reddito da lavoro autonomo149 cosicchénon mancano fra le masse degli immigrati definitivi del Tavolierei contadini della costa barese150. In generale, però, la mobilitàdella provincia, al suo interno o verso l'esterno, non è maitumultuosa, sconvolgente. Si prendano Gravina, Altamura e Coratonel Settecento, la prima in stasi demografica, le altre due increscita nettamente più rapida della media provinciale eprobabilmente anche di città della Puglia piana come Foggia eManfredonia. Come sottolineano gli studi di Giovanna Da Molin151 adifferenza che per queste ultime, lì le dinamiche demografiche nondipendono pesantemente dalla mobilità territoriale dellapopolazione, dato che le combinazioni matrimoniali fra residenti eforestieri sono relativamente poche, il raggio di provenienzadegli immigrati è relativamente corto e i fenomeni migratoriconservano un carattere stagionale più che definitivo.
Resistendo alle spinte disgregatrici indotte dall'alto livellodi commercializzazione da cui è investita, Terra di Bari conferma,anche nelle fasi calde del ciclo economico, quelle caratteristichedi stanzialità, di solidità del sistema dell'insediamento, didefinizione chiara delle appartenenze territoriali, sociali eprofessionali qui già più volte sottolineate.
Nello stesso senso lavora la rete dei rapporti costa-internofunzionante dal lato della circolazione del prodotto.
Che questo sia un ambiente di generale mercantilizzazione
148 Cfr. MASI, Altamura farnesiana cit., pp. 143-44.149 Cfr. oltre, pp. 97-104.150 G. DA MOLIN, Mobilità di contadini pugliesi fra fine '6oo e primo '8oo, in Lapopolazione italiana nel Settecento, Bologna 1980, PP. 435-75151 Cfr., oltre al saggio di cui alla nota precedente, sempre della stessaautrice, Aspetti di storia demografica e sociale della Puglia: le diocesi diGravina e di Troia nel Settecento, in Istituto di Scienze StoricoPolitiche,Facoltà di Magistero, Università di Bari, «Quaderni », 198o, I, pp. 1-8o.
57
anche dell'economia volta alla domanda provinciale non è certosorprendente, né individua una particolarità di Terra di Baririspetto ad altre aree produttrici di derrate per il grandecommercio: basti pensare alla domanda monetaria per una miriade dioggetti che una struttura come la masseria irradia attorno a sé152“,o alle esigenze di approvvigionamento dei pastori, capaci diprovocare tensioni annonar,e nei luoghi di transito obbligato153. Ilmercato non è frantumato come nel Mezzogiorno 'normale'; d'altrocanto esso non è unificato. Il circuito del vino, lo abbiamovisto, resta prigioniero di una molteplicità di unità di misura,di un personale mercantile scarsamente specializzato e di profilobasso, e i suoi movimenti, confusi, spesso ostacolati daimpedimenti amministrativi volti a privilegiare il prodottolocale, sono quasi sempre di raggio breve e brevissimo - nel casodi Bari non sembrano superiori i confini del suo agro154.L'artigianato, tranne qualche eccezione che dovremo sottolineare,non sembra mai assurgere alla dignità di settore commercialmenterilevante, e i suoi oggetti escono dalle piazze di produzioneessenzialmente in occasione della celebrazione dei mercatisettimanali, ritagliandosi poi uno spazio limitato in fiere che,non avendo un ruolo di centralizzazione del commercio in grande,come quella di Foggia per la lana, fungono da un lato da foires dechange, stanze di compensazione di transazioni mercantili di ognigenere, dall'altro da vetrine di merci manufatturate a Napoli edintorni, o provenienti dall'estero e transitanti per Napolidestinate al mercato locale, e di animali grossi da carne allevatisulle colline murgiane e lucane incettati dai “ferretti” dellacapitale155.
Un caso diverso è quello delle merci “estratte”. Non chemanchino qui problenù dal lato della circolazione interna. I
152 Cfr. LEPRE, Feudi e masserie cit., pp. 10- 11.153 Cfr. la protesta dell'affittatore della gabella della farina di Melfi, cheteme che le ventilate disposizioni annonarie inducano i forestieri ad evitare lacittà, « tanto più al presente che è la passata delle pecore in Puglia che limassari di masserie di dette pecore venghono a comprare quantitate di pane peraltri forestieri che stanno in dette lor masserie » (As Potenza, notaio Marco deAmatis, atto 7 settembre 1591)154 C. MASSA, Costo dei trasporti in Terra di Bari (1542-1722), estratto da «Giornale degli economisti e rivista di statistica», ottobre 1917,tab. I, PP. 7-8.155 Per l'importanza delle fiere di Altamura e Gravina per l'approvvigionamentodi carne della capitale cfr., ad esempio, F. DE ARRIETA, Ragguaglio bistoricodel contaggio occorso nella provincia di Bari negli anni 169o, 1691, 1692,Napoli 1694, P. 93.
58
flussi del commercio in grande raccolgono attorno a sé interessi,istituzioni, mentalità che prevaricano sugli scambi locali emanomettono il rapporto fra prodotto 'necessario' e sovrappiùvendibile. Non c'è nulla di così nuovo nel fatto che “la classedegli incettatori granisti” nel secondo Settecento, con grandescandalo di Francesco Longano, controlli “non già il superfluo,che si dovrebbe estrarre, ma quasiché tutta la raccolta”, tenendo“da sussistenza di milioni d'individui fra le sue mani, che ellapuò affamare, e fare perire d'inedia”156: in un centro mercantilecome la Bari del primo Seicento è possibile che manchi dallapiazza pressoché tutto, a causa, secondo un cronistacontemporaneo, oltre che degli “infiniti peccati nostri” e delle“false monete”, delle “tante diverse extrattioni ex Regno d'ognisorte di vitto quotidiano che insino alle cocozze d'India si sonoestratte”157. Situazioni di questo genere non chiamano in causa soloi “monopolisti”, ma esprimono comportamenti diffusi: i piccoliproduttori non distinguono sempre nel prodotto della loromicroazienda la parte da autoconsumare da quella da mettere invendita, e sui mercati locali dominati dagli incettatori delcommercio a lunga distanza si commercializzano piccole epiccolissime partite di derrate che poi dovranno essere ricomprateda quanti le hanno vendute per i propri bisogni alimentari o perla semina158 magari non prima di aver partecipato a un food riot piùo meno rituale ed aver ottenuto provvedimenti annonaricalmieratori dalle autorità amministrative.
Ma il mercato internazionale, che subordina e a volte umilia icircuiti interni di queste merci, ricrea al tempo stesso leragioni della loro esistenza; induce specializzazione produttivaper aree e quindi flussi mercantili infraprovinciali a loro modoregolari, dotati di una loro trasparenza statistica. I prezzi diolio e grano, le due merci protagoniste del commercio in grande,presentano indici di correlazione fra i mercati locali molto altiin assoluto e in relazione a quelli di altre merci, unavariabilità annua e mensile meno accentuata, una maggioreomogeneità e comunque una geografia stabile e leggibile, rispetto
156 F. LONGANO, Viaggi... per lo Regno di Napoli, vol. II, Capitanata, Napoli1790, P. 119157 Cfr. il brano delle Memorie di Scipione Cardassi riportato da MASSA, Bari nelsecolo XVII cit., P. 47.158 Cfr. la tesi di laurea, elaborata presso la facoltà di Lettere e Filosofiadell'Università di Bari, di G. ROSSIELLO, Aspetti della vita economica e socialedi Bitonto tra XVII e XVIII secolo (Rendiconti e bilanci della Congrega del S.S. Rosario), a.a. 1971-72.
59
a quella confusa e instabile del vino: le quotazioni del grano,afferma Paolo Macry 159, “salgono con progressione regolare daCanosa ad Andria a Barletta, o da Minervino a Corato a Bisceglie,o da Altamura a Grumo a Bari” distinguendo le aree di produzioneda quelle di consumo e dai porti di esportazione; e così le vocidell'olio di metà Settecento160 individuano nettamente come zona diprezzi minimi, quella specializzata interna di Terlizzi e Bitonto,e come zona di prezzi massimi la Murgia centro-settentrionale, conuna serie di posizioni intermedie di cui il costo dei trasporti ela funzione di centralizzazione dei porti d'imbarco nei confrontidell'entroterra riescono a fornire spiegazioni plausibili. Diconverso un centro come Acquaviva, sostanzialmente tagliata fuoridal commercio a lunga distanza, presenta prezzi caratterizzati daaltissimi indici di variabilità e relativamente alti, atestimonianza delle tensioni che si scaricano su un sovrappiùmercantilizzato di dimensioni relativamente ridotte, nel mentresalari nettamente inferiori a quelli costieri indicano una domandadi braccia fiacca e comunque collocata in maniera meno rigida esistematica all'incrodo fra calendario olivicolo e calendariocerealicolo. A risultati non dissimili si giunge collocando iprezzi, invece che sulla geografia della provincia, sulladiacronia. I coefficienti di instabilità annuale, se si prescindedagli shock occasionali, si alzano nelle fasi recessive e distagnazione del commercio a lunga distanza e si riducono nellefasi di slancio, e i coefficienti di correlazione fra i mercatilocali, pur sempre notevoli, sono più alti quando una buonacorrelazione fra porti d'imbarco e di destinazione segnalal'irrobustirsi delle linee di traffico.
Il dubbio legittimo che tutto questo sia l'effetto statisticonon di nessi fra le piazze provinciali, ma solo dei nessi fraciascuna di esse e lo stesso luogo di destinazione delle merci,come spesso accade nelle aree esportatrici di antico regime, vienefugato dall'evidenza documentaria dei massicci flussi interni. Qui159 P. MACRY, Mercato e società nel Regno di Napoli. Commercio del grano epolitica economica del '700, Napoli 1974, P. 140.160 Cfr. i prezzi per gli anni 1746, 1749 e 1757 in ASNA, f. Voci di vettovaglie,b. 123-24. Per le questioni affrontate in queste pagine, oltre alle opere diPalumbo e Rossiello citate alla nota 3 (pp. 61-62), cfr. anche L. PALUMBO e B.SALVEMINI, Aspetti dei mercato del grano in Tema di Bari nell'Ottocentoborbonico, in A. MASSAFRA (a cura di), Il Mezzogiorno preunitario. Economia,società e istituzioni, Bari1988, pp. 201-27, nelle cui tabelle 4 e 5 siorganizzano dati relativi ai coefficienti di instabilità e correlazione sullungo periodo. Si tratta comunque di aspetti che avrebbero bisogno di ulterioredocumentazione ed elaborazione.
60
il grosso nodo è l'approvvigionamento annonario dei grandi centrioleari, non solo di quelli che, come Molfetta, vivono“continuamente di grano che se li conduce da vaticali per non averterreno seminatorio”161 ma anche di quelli che terreno seminatorione hanno ma in misura insufficiente alle proprie esigenze, comeBari, Monopoli o Bitonto 162“. Intersecando i percorsi del grano edell'olio verso i porti all'imbarco per destinazioni lontane, fileinterminabili di carri pieni di cereali per il consumo provincialeripercorrono per secoli gli stessi itinerari, dalla Murgia centro-occidentale e dai margini orientali della Basilicata verso lacosta, con Barletta e la Capitanata che intervengono soprattutto atamponare situazioni diventate critiche; e insieme al granoscendono verso il mare, ma in misura ben minore, formaggi, lana,animali da lavoro e da carne, incrociando in senso oppostoessenzialmente il poco olio necessario all'alimentazione deicerealicoltori.
Dunque grano e olio sono protagonisti indiscussi del commercioinfraprovinciale così come di quello a lunga distanza, ma il loropeso relativo nel primo caso è molto diverso che nel secondo. Peravere un'idea grossolana dell'ordine di grandezza dei valorirelativi dei due flussi inversi di merce, proviamo a semplificarevigorosamente la realtà senza sconvolgerne i connotati. Sirappresenti il nostro sistema regionale come l'insieme di un'areaad olivicoltura specializzata e un'altra a cerealicolturaspecializzata di peso demografico uguale alla prima, nel quale icerealicoltori consumino per le proprie esigenze alimentari tantoolio quanto gli olivicoltori (da 6 a 9 kg a testa l'anno), equesti ultimi acquistino dai cerealicoltori solo la metà dei 5canonici tomoli di grano a testa l'anno, compensando il resto coni succedanei
161 Da una «conclusione decurionale» molfettese del 1627 citata da TULLIO,Molfetta Cit., P. 25, nota. Nella nota seguente l'autrice identifica,sulla basedi un «quinterno delli ordinati della grassa (1556-57)», i centri diapprovvigionamento di Molfetta in Corato, Gravina, Minervino, Spinazzola,Matera, Altamura, Casamassima, Rutigliano e Ascoli Satriano, i quali rimarrannosostanzialmente gli stessi per secoli: cfr. V. DE COSMO e L. PALUMBO, I prezzidel grano, dell'olio e del vino sul mercato di Molfetta nelle significatorie delseminario dal 1778 al 1815, in Università di Bari, «Annali dell'Istituto distatistica», a.a. 1968-69, in particolare pp. 38-46.162 Per Bari cfr. MASSA, Bari nel secolo XVII cit., appendice IV; per Monopoli P.DI BARI, Monopoli nella prima metà del'6oo. Condizioni economiche e sociali,Mola 1969, pp. 11-12; per Bitonto L. PALUMBO, Alcune premesse allo studio deiprezzi in Capitanata: 162o-165o, in « Studi storici meridionali », 1984, n. 2-3,pp. 183-84.
61
e il prodotto della semina sotto gli alberi, nel mentre loscambio in altri settori merceologici vi sia raffigurato come ungioco a somma zero. Sulla base di queste ipotesi, e tenuto contodelle ragioni medie di scambio fra grano e olio su baseplurisecolare, la sutura fra area cerealicola ed area olivicolarealizzata dal lato della circolazione vedrebbe un vistososquilibrio strutturale a favore dei cerealicoltori, i qualicederebbero grano di valore cinque volte circa più alto di quellodell'olio acquistato. Le risorse per compensare questo squilibriovengono trovate nella sutura fra le due aree realizzata dal latodella produzione, nel massiccio impiego di olivicoltori allamietitura, che non ha confronto col modesto impegno deicerealicoltori nella raccolta delle olive. I cerealicoltoriacquistano dagli olivicoltori molta forza-lavoro e poco lavorooggettivato in olio; gli olivicoltori acquistano daicerealicoltori poca forza-lavoro e molto lavoro oggettivato ingrano. In questo modo il cerchio tende a chiudersi ed il sistema afunzionare senza provocare tensioni interne irreparabili.
C'è naturalmente un altro e importantissimo polo in questosistema di scambi: i luoghi di destinazione del commercio a lungadistanza, che presentano un notevole disavanzo commerciale neiconfronti della nostra provincia - cedono ad essa, in cambio digrandi quantità di derrate, prodotti che costituiscono i saltuaricarichi di ritorno delle navi olearie e granarie e quelli immessitramite Napoli nel sistema delle fiere (manufatti, coloniali,legnami ecc.) - e lo compensano tramite la fornitura a caro prezzodi servizi finanziari e mercantili, i cui lauti proventiconfluiscono in parte nella capitale assieme alla rendita feudaleed alle imposte, in parte all'estero. Insomma, in forma cheoccorrerà studiare più avanti in questo scritto, anche Terra diBari è soggetta a una secolare sottrazione di risorse, che larende “assai giovevole”al Regno nel suo complesso e alle aree didestinazione delle sue derrate. Ma non è certo questo un datocaratterizzante. Ciò che occorreva invece sottolineare è che essasa essere “utile” anche a se stessa, che non è un desertomonocolturale ma una realtà profondamente diversificata, capacedi alimentare e utilizzare le sue diversità fino a configurarsicome una unità funzionale, un 'sistema' resistente e flessibile.
Ma certo non immobile, indifferente allo scorrere del tempo. Come gli aspetti sistematici fin qui tratteggiati sul piano
sincronico si modifichino attraversando le fasi evolutive einvolutive di un arco plurisecolare, è storia anch'essa
62
complicata, da raccontare partitamente.
III.
I RESPIRI E LE RIGIDITA'.
I. Domanda internazionale e offerta provinciale.
Nel tentativo di definire sul piano sincronico i caratteri delnostro sistema regionale abbiamo usato, a fini comparativi, una Capitanata grossolanamente ridotta ad area a forte mercantilizzazione dipendente e priva di ogni elemento di direzionalità interna, che ci permettesse di sottolineare, per differenza, la complessità e il carattere sistemico di alcuni aspetti della realtà di Terra di Bari in età moderna. Sul piano diacronico un modello di dipendenza estrema, utile per ordinare ilragionamento e misurare gli scarti da esso della nostra regione economica, può considerare popolazione e produzione, a differenza che nei modelli malthusiani, variabili dipendenti rispetto agli stimoli trasmessi per via del mercato e delle istituzioni da centri direzionali esterni al sistema. Uno schema di questa naturaapprossimativamente ritagliato su quanto già sappiamo di Terra di Bari può essere rappresentato, prescindendo dagli shock occasionali e guardando al medio periodo, in questo modo:
a) domanda interna e estera di grano a) domanda interna e estera di olio
b) prezzi del grano g) domanda interna di grano ed olio b) prezzi dell’olio
c) redditività della masseria cerealicola f) popolazione c) redditività del microfondo oleario
d) produzione ed “estrazione” di grano e) domanda di lavoro d) produzione ed “estrazione” di olio
Nello schema le frecce indicano il senso della causalità, le
63
lettere l'ordine della causalità, secondo una successione dieventi che, partendo dall'esterno, si ripercuotono separatamentenelle due aree fondamentali della provincia rappresentate nellaprima e terza colonna, e confluiscono poi in quella centrale, cheraffigura le cuciture del sistema regionale. Il segno (+ o -)davanti alle variabili a), le uniche considerate indipendenti,determina il segno delle altre, in un processo ascendente odiscendente che si autoalimenta attraverso il reagire delladomanda interna sulla redditività delle aziende. Insomma, perun'area di questo tipo, l'ipotesi di lavoro da cui partire è chepopolazione e risorse non si muovono nel tempo lungo tracciatisegnati da parametri naturali, ma dipendono dalle convenienze aprodurre per il mercato indotte da una variabile su cui laprovincia ha una scarsissima influenza, il livello della domandainternazionale. La dipendenza sarebbe compensata dall'integrazionedell'area nel circuito della grande storia.
Per verificare, smentire o complicare l'ipotesi di lavorooccorre indagare, facendosi largo nella ricchezza infinita didettaglio prodotta dall'incontro della grande storia con un'areacomplessa come la nostra, sui nessi che legano fra loro coppie divariabili presenti nel modello. I dati disponibili non sono certoquelli che si richiedono per soddisfare le nostre curiosità, maper Terra di Bari un punto di partenza di grande importanza ci èofferto dalle solide serie di prezzi raccolte ed elaborate daPalumbo e Rossiello, che consentono di coprire in maniera continuaed omogenea tre secoli e mezzo. Non che sia esercizio elementaretradurre queste cifre in termini rilevanti per il nostro sistemaprovinciale. I prezzi sono dati secondari, sintetici, stringonoassieme domanda e offerta con tutti gli accidenti e tutte le'scorie' istituzionali, sociali, politiche - che entrambe portanocon sé, rischiano di essere variabili anche esse dipendenti. In uncaso come il nostro, però, le cose stanno così solo in parte. Neiprezzi 'fatti' in piazze coinvolte nel commercio a lunga distanza,l'esito dell'annata agricola si confronta con una domanda il cuilivello viene determinato - e si pensi alle pagine di Braudel sulgrano163 - in una geografia vastissima, in un mescolarsi
163 BRAUDEL' Civiltà e imperi del Mediterraneo cit., pp. 602 sgg. L'influenzadel mercato sui prezzi è sottolineata non solo in riferimento a situazioni nellequali il commercio di esportazione ha grande importanza (cfr. W. KIJLA, Teoriaeconomica del sistema feudale, Torino 1970, PP, 93 sgg.), ma anche persituazioni 'normali” come quelle studiate da DUPAQUIER, LACHIM e MEUVRET inMercuriales du Fays de France et du Vexim Français (164o-1792), Paris 1968, inparticolare p. g. Ma cfr., su queste questioni, K. GLAMANN, La trasformazione
64
inestricabile di parametri obiettivi e manipolazioni monetarie,trame diplomatiche e militari, interventismi annonari e fiscali,speculazioni mercantili: se le vicende della produzione localepossono frastagliare le curve dei prezzi, la forma di questeultime è sostanzialmente determinata dalla domanda. Soprattuttopoi quando si tratta di derrate come il grano e l'olio “che sitrovano anche altrove” e sono quindi facilmente sostituibili, gliacquirenti, che già controllano “il credito, le forze marittime, ibastimenti, i porti164“, hanno un potere contrattualeincomparabilmente maggiore di quello del venditore. Insomma itrend dei prezzi rilevati nei mercati di Terra di Bari possonoessere assunti come indicatori dell'andamento della domandainternazionale quando giunge ad investire la provincia. Da essidunque, secondo il nostro schema, occorre partire.
Le merci da considerare con più attenzione sono, naturalmente,grano, olio e vino, quelle più rappresentative del mondodell'agricoltura provinciale oltre che le più documentate, nelmentre per la pastorizia occorre far ricorso ai prezzi della lanadella fiera di Foggia, la cui rappresentatività, in particolareper la Murgia gravitante sulle fiere di Gravina e Altamura, ètutta da verificare, dato che è possibile trovarvi tra i venditorisolo grossi produttori della zona settentrionale della provincia.Rimandando in particolare ai lavori di Palumbo e Rossiello e diMarino per un'analisi minuta e differenziata, e scontando lagrossolanità di un'elaborazione che ha il solo scopo di offrire unquadro d'insieme e comparativo di lungo periodo, raccolgo nellafigura I i numeri-indice delle medie decennali dei prezzi diqueste merci, facendo uguali a 100 i,valori del decennio 1671 -1680, che sembra essere quello di massima depressione della faseseicentesca, e saldando per il grano la serie di Altamura conquella di Bitonto, per l'olio quella di Molfetta e Bitonto:procedimento, quest'ultimo, non scorretto dato l'altissimo indicedi correlazione e lo scarso dislivello fra i valori assoluti quasisempre rinvenibile fra le serie di prezzi rilevati in differenticentri della provincia in questi due settori. Il grafico contieneanche le curve dei numeri-indice delle medie decennali dei salaridi giornatieri di masserie altamurane raccolti e tabulati sempre
del settore commerciale, cap. IV di E. E. RICH e C. H. WILSON (a cura di),Storia economica Cambridge, vol. V, Economia e società in Europa nell'etàmodema, Torino 1978.164 Da un manoscritto di F. Valignani, presidente della Sommaria dal 1724 al1733, citato in M. A. VISCEGLIA, sistema feudale e mercato internazionale. laperiferizzazione del paese, in «Prospettive Settanta», 1985, nn. 1-2, p. 85.
65
da Palumbo e Rossiello, nonché quelli dei nati rilevati neiregistri delle parrocchie della città di Bari, una delle pocheserie demografiche disponibili sul lungo periodo che siapienamente affidabile165.
Rimandando più in là una lettura complessiva di questi dati,limitiamoci per ora alle curve dei prezzi. Da questo puntod'osservazione le canoniche due fasi ascendenti e la fasediscendente sembrano essenzialmente contenute nei secoli-simbolo:nel Cinquecento e nel Settecento i prezzi salgono, nel Seicentoscendono o stagnano. Il Cinquecento sembra protendersi nelSeicento più per l'olio che per il vino e il grano.
165 Cfr. per il grano: i prezzi di Altamura dal 1526 al 1625 in L. PALUMBO e G.ROSSIELLO, Il mercato di Altamura tra Cinque e Seicento (1525-1625), in AA.vv.,Momenti dell'agricoltura meridionale dal Cinquecento all'Ottocento, Roma 1985,tab. pp. 25-26; i prezzi di Bitonto dal 1626 al 1675 in L. PALUMBO e G.ROSSIELLO, I Prezzi del grano a Bitonto nel secolo XVII, in POLI (a cura di),Ricerche su Terra di Bari cit., tab. pp. 15-16; i prezzi di Altamura dal 1676 al1700 in L. PALUMBO e G. ROSSIELLO, Mercati in Terra di Bari a fine Seicento(1675-1700), in «Archivio storico pugliese», 1984, tab. p.141; i prezzi diAltamura dal 1701 al 1750 in ID., Mercati in Terra di Bari nella prima metà delSettecento, in«Archivio storico pugliese», 1985, tab. p. 172; infine i prezzi diAltamura dal 1751 al 18oo tabulati da Palumbo e Rossiello ancora inediti,gentilmente fornitimi dagli autori. Per l'olio: i prezzi di Molfetta dal 1531al 1670 in L. PALUMBO, Il mercato dell'olio a Molfetta dal 153 o al 1740, in L.M. DE PALMA (a cura di), Uomini e vicende della Chiesa di Molfetta, Molfetta1985, tabb. pp. 164-67; i prezzi di Bitonto dal 1671 al 1700 in PALUMBO CROSSIELLO, Mercati in Terra di Bari a fine Seicento cit., tab. p. 151; i prezzidi Bitonto dal 170 1 al 1750 in ID., Mercati di Terra di Bari nella prima metàdel Settecento cit., tab. p. 179; i prezzi inediti di Bitonto dal 1751 al 18oomi sono stati forniti da Palumbo e Rossiello. Per il vino: i prezzi di Altamuradal 1526 al 1625 in ID., Il mercato di Al tamura fra Cinque e Seicento cit.,tabb. pp. 19-3o; quelli fra il 1675 e il 1700 in m., Mercati di Terra di Bari afine Seicento cit., tab. p. 147, quelli fra il 1701 e il 1750 in iD., Mercati diTerra di Bari nella prima metà del Settecento cit., tab. p. 187; quelli fra il1751 e il 18oo, inediti e sempre riferiti ad Altamura, mi sono stati fornitidagli stessi autori. Per i prezzi della lana alla fiera di Foggia: per ilperiodo 1623-39 M. C. NARDELLA, Attività creditizie e commerciali a Foggia nellaprima metà del XVII secolo, in A. MASSAFRA (a cura di), Produzione, mercato eclassi sociali nella Capitanata modema e contemporanea, Foggia 984, tab. p. 123;per il periodo 1641-1800 AIARINO, Pastoral Economics cit. Per i salari, tuttiriferiti a giornatieri altamurani: le medie decennali del periodo 1601-1700 inL. PALUMBO, Alcune premesse per lo studio dei prezzi in Capitanata. Il. 165o-17oo, in « Studi storici meridionali », 1985, tab. P. 309; per il periodo 1701-50, PALUMBO C ROSSIELLO, Mercati di Terra di Bari nella prima metà delSettecento cit., tab. p. 196; per il periodo 1751 i dati annuali mi sono statigentilmente forniti dagli stessi Palumbo e Rossiello. Per i nati Cfr. G.CHIASSINO e altri, Le nascite a Bari dall'inizio del XVI secolo all'unificazionedel Regno d'Italia, Quaderno n. 8 di «Studi di Demografia», Bari 1971.
66
Figura I.
Medie decennali dei prezzi del grano, dell'olio, del vino edella lana; dei salari; dei nati (numeri indice).
La curva del vino precipita rovinosamente dopo il massimo deiprimi dieci anni del secolo, riconquistato solo centosettanta annidopo; nello stesso decennio quella del grano tocca un massimoplurisecolare, mentre l'olio ha la sua cuspide principale duedecenni dopo, quando il grano ha una cuspide secondaria, e tornaancora ad impennarsi per raggiungere livelli tardo-cinquecenteschinegli anni '40. Anomalo è infine il comportamento della lana, ilcui prezzo, dopo essersi mantenuto nel Cinquecento - a quanto paredai dati sparsi disponibili - attorno a un trend stagnante,aumenta nel primo Seicento e tocca un massimo negli anni '50,seguendo poi un andamento speculare rispetto a quello del granofino alla fine del secolo.
Comunque, in una prospettiva di lungo periodo, il primodecennio del Seicento sembra chiudere definitivamente un secolo dicrescita trascinata, come altrove, dall'andamento travolgente delgrano166, che vede migliorare nettamente le sue ragioni di scambionon solo nei confronti della lana, ma anche del vino e dell'olio:a fronte di un aumento medio decennale fra il primo decenniodocumentato (1521-30) e quello di inversione generale del ciclo(1601-10) che per il grano è del18,5 per cento, i prezzi del vinoaumentano a un ritmo del 13,5 per cento, quelli dell'oliodell'11,1167. Fra il terzo decennio del Seicento e la grande crisiepidemica degli anni '50 le ragioni di scambio del grano tornano amigliorare nei confronti dell'olio; poi la tendenza si inverte e,tranne per il recupero relativo degli anni '70, nei decenni diimpennate e crisi congiunturali attraverso i quali viene166 Cfr., ad esempio, F. BRAUDEL e F. SPOONER, I prezzi in Europa dal 145o al175o, in E. E. RICH e C. H. WILSON, Storia economica Cambridge, vol. IV,L'espansione economica nel Cinque e Seicento, Torino 1975, In particolare P.458.167 La formula adoperata per il calcolo è ................., dove Pt è il prezzodell'ultimo periodo considerato, Po il prezzo del primo, t il numero dei periodie pm la media dei prezzi di tutti i periodi- I prezzi dell'olio non sonodocumentati per il decennio 1521-30; tenuto conto che per le altre due merci fraquesto primo decennio e quello immediatamente successivo c'è un incremento moltorilevante, il tasso di incremento dell'olio in relazione a quello di vino egrano andrebbe aumentato di qualche punto.
67
conquistato il Settecento, netto è il peggioramento delle ragionidi scambio del grano rispetto alle altre merci considerate.
La fase settecentesca, che comincia ad operare in pieno neglianni '30 e finisce negli anni confusi a cavallo fra Sette eOttocento, vede un riallinearsi delle curve su un trendascendente, in cui non è rinvenibile una merce-leader come erastato il grano nel Cinquecento: fra gli anni '20 e gli anni '90 ilprezzo dell'olio aumenta del 13,1 per cento a decennio, quello delgrano dell'i 1,9, quello del vino dell'11,7, e financo la lanapunta decisamente verso l'alto, anche se a un ritmo inferiore, l'8per cento, con periodi di accelerazione intensa che per l'olio sicollocano negli anni '40 e negli anni '60 e '70, per le altremerci soprattutto sullo scorcio del secolo. Ma sono cifre chevanno lette tenendo in debito conto quanto era avvenuto neidecenni fra Seicento e Settecento. Il grano riesce a non perdereterreno rispetto all'andamento generale dei prezzi della faseascendente settecentesca anche grazie al punto di partenza moltobasso degli anni '20: in realtà la caratteristica più importantedel movimento settecentesco dei prezzi provinciali è la caduta delprotagonismo dei cereali, nel quadro di trasformazioni del mercatointernazionale ed interno di cui sarà il caso parlare più avanti.
Una prima e approssimativa verifica della plasticità, neiconfronti della domanda esterna, del nostro sistema regionale è lacapacità di quest'ultimo di ricombinare i fattori produttivi inmodo da correlare ad essa l'andamento dell'offerta delle suederrate al netto dei consumi interni.
Come si sa, i dati del commercio a lunga distanza, quando sonodisponibili, sono infidi e sottostimati. Vediamo comunque diricavarne indicazioni sul problema che ci siamo posto, attribuendouna qualche sistematicità allo scostamento dai valori reali dellecifre pervenuteci.
Per il commercio cerealicolo i dati delle “estrazioni” daiporti non sempre permettono di distinguere le quantità esportateda quelle destinate a Napoli e da quelle redistribuite lungo lacosta; ma, come vedremo, queste ultime hanno un peso trascurabile,e i cereali imbarcati per Napoli o per l'estero si muovono in uncircuito dominato dagli stessi negozianti, dalle stesse navi,dagli stessi meccanismi finanziari e istituzionali, cosicché ladistinzione, dal punto di vista degli effetti sull'economiaprovinciale, è irrilevante e possiamo per il momento ignorarla.D'altro canto, il fatto che non sempre è possibile distinguerenelle cifre il grano dall'orzo e dagli altri cereali minori
68
costringe a dare dati globali, la cui confrontabilità conl'andamento del prezzo del grano è assicurata dall'altocoefficiente di correlazione quasi sempre riscontrabile fra iprezzi dei cereali.
Fra XV e XVI secolo grani ed orzi “estratti” dai porti dellaprovincia si collocano, con le solite cadute ed impennate, alivelli fra 300000 e 400000 tomoli168, che il Settecento farà faticaa reggere a lungo; nulla invece sappiamo delle reazioni delle“estrazioni” provinciali alla spasmodica domanda di granoproveniente in particolare da Napoli nella seconda metà delCinquecento. Nel Seicento le “estrazioni” indubbiamente cedono, mameno di quanto si possa pensare, e solo nei tardi anni '50 e '60la caduta si fa netta, fino a giungere a livelli minimi nei primidue decenni del Settecento (cfr. tab. 3). La ripresa è faticosa esi intensifica negli anni '40 e '50, quando le quantitàcommercializzate raggiungono punte massime a quanto pare non piùtoccate negli anni successivi alla crisi del 1756-63, ingombri diinterventismo annonario e chiusura di tratte, e caratterizzatidall'impennarsi della curva dei prezzi169.168 Dal I° settembre 1486 al 31 agosto 1487 il grano e l'orzo complessivamente «estratto » dai porti di Trani e Barletta ammonta a tomoli 262 940 (SALVATI, acura di, Copia quaterni cit.); un simile quaternus pubblicato in NICOLINI, Sultraffico navale barlettano cit., dà per il periodo 27 marzo 1303 - 24 aprile1304 Oltre 220000 tomoli imbarcati solo a Barletta; nel 1537 si può ipotizzareun”estrazione' di oltre 400000 tomoli sulla base delle indicazioni di S.SANTERAMO, Il R. Secreto e il R. Maestro Portulano di Puglia in Barktta, in«japigia», 1941, pp. 233-35; dal settembre 1539 all'agosto 1540 sono imbarcatiper Napoli dai porti di Barletta e Manfredonia 124 097 tomoli di grano ed orzo(CONIGLIO, Il Regno di Napoli al tempo di Carlo V Cit., P. 123). Appena 26537tomoli di cereali vengono invece imbarcati a Barletta dal io settembre 1533 al 9aprile 1534 (ASNA, f. Dipendenze della Sommaria, b. 78, f5. 25).169 Per gli anni 1639-68 cfr. i registri della tassa di «alboraggio» del porto diBarletta in ASNA, Rekvi, 202 (ma su questi anni cfr. E. PAPAGNA,Una fonte quantitativa: l'Officium Arboragii Terrae Baruti, in «I viaggi diErodoto», 1988, n. 5, PP. 86-97); ancora su un registro di alboraggio del portodi Barletta è fondato il dato per il 1720-2 1, in ASNA, Relevi, vol. 221; pergli anni 1699-1714, 1753-59 e 1781 cfr. le «declaratorie » del Regio Secreto eMaestro Portulano delle province di Bari e Capitanata sull'introito dello iussalmarum, in ASBA, Carte Esperti, h. i (sull'ammontare dello ius salmarum cfr.ivi, le lstruttioni che si danno per la Regia Camera della Sommaria al Mag., D.Giorgio Cangiano, Regio Mastro Portulano delle Province di Bari e Capitanata[...] , 17 ottobre 1674); per gli anni 1716-34 vedi i proventi dello jus salmarum della prima colonna della tab. a p. 187 di A. Di Vittorio,Esportazioni pugliesi nella prima metà del XVIII secolo: le saccarie, in«Quaderni storici », 1970, n. 13; i dati per il 1741, 1787 e 1793 in M. A.VISCEGLIA, Il Commercio dei porti pugliesi del Settecento. Ipotesi di ricerca,in AA. VV., Economia e classi sociali cit., pp. 193 -94. C'è da tener presente
69
Inutile insistere sull'incertezza degli elementi di giudizioricavabili da questi dati, tanto più che essi non tengono contodel variare delle quantità inviate dalla Puglia a Napoli viaterra, né di quelle che soprattutto da Gravina, Santeramo edAltamura scendono verso Taranto dirette alla capitale170. Le ipotesiche è possibile inferirne trovano comunque sostegno nei dati delcommercio oleario riguardanti quasi sempre le quantità esportate,dato che l'annona napoletana, per ragioni geografiche e diorganizzazione mercantile, si rifornisce in larga parte dai porticalabresi e ionici.
Sull'esportazione di olio nel Cinquecento e nel Seicentoabbiamo solo dati sparsi e indizi di incerta interpretazione. Idati riportati da Mantelli sugli estagli pagati dagli arrendatoridel ducato per salma di olio esportato, suggeriscono per ilsecondo Cinquecento quantità nell'ordine delle 70000 salme edoltre uscite dai porti del Regno, fra i quali giganteggiano quellipugliesi: nel biennio fra l'11 gennaio 1554 e l'11 gennaio 1556,
Tabella 3.Cereali “estratti” dai porti di Terra di Bari.
Tomola Tomola
1639 238697 1709 104201640 263868 1710 85001641 359 810 1711 203001642 240509 1712
98321643 289327 1713 78197
che dagli anni '3o del Cinquecento fino agli anni '3o del Settecento il porto diTrani rimane pressoché inattivo (cfr. i cenni contenuti nella voce « Trani » delDizionario geografico ragionato del Regno di Napoli di L. Giustiniani, vol. IX,Napoli 1805, pp. 227-36, confermati dalla presenza estremamente infrequentedella città nella documentazione commerciale di quei due secoli),cosicché, anche dato il ruolo irrilevante dei porti oleari nel commerciocerealicolo, i dati seicenteschi riguardanti il solo porto di Barletta sonoconfrontabili con quelli settecenteschi riguardanti tutti i porti provinciali.170 Cfr. sopra, p. 21, le indicazioni della nota 15. Sull'importanza del porto diTaranto per l'approvvigionamento di Napoli nel Settecento vedi L. DE ROSA, Navi,merci, nazionalità, itinerari in un porto dell'età preindustriale. Il porto diNapoli nel i76o, in Saggi e ricerche sul Settecento, Napoli1968, in particolaretab. XXV; MACRY, Mercato e società cit., p. 167.
70
1644 165430 1714 123155
1645 260784 ...1646 337744 1716 1631981647 182 807 1717
567771648 78258 ...1649 138687 1720 469801650 262501 1721
12214 b1651 249565 ...1652 339619 1723 1021991653 321 725 1724 1058141654 234546 1725 740581655 246849 1726 1122321656 102574 ...1657 110973 1729 1490621658 52 122 1730
1068821659 105564 ...1660 47328 1732
1758371661 41505 ...1662 136071 1734
60ooo1663 98119 ...1664 190523 1741
279991c1665 98428 ...1666 125902 1753 8374751667 308123 1754 4589011668 134980a 1755
110405... 1756
1406001699 137963 1757 4761241700 116 194 1758 4666551701 175249 1759 2173621702 266821703 45402 1781
852101704 91 605 ...
71
1705 122272 1787 251350c
1706 69865 ...1707 23542 1793
397545
Il dato è parziale.Dal 22 luglio 1720 al 21 luglio 1721Solo dal porto di Trani
per il quale abbiamo dati precisi, Terra di Bari esporta 68590salme, Terra d'Otranto 84590171, realizzando medie annue che, comevedremo (cfr. tab. 4), in particolare per la nostra provincia,sono di gran lunga più alte di quelle del Settecento. Una partemolto rilevante di questo olio ha come destinazione Venezia, e idati veneziani, pur sempre sparsi ed incerti ma collocati su unperiodo lungo, suggeriscono per il Cinquecento livelli diesportazione molto rilevanti ma notevolmente rigidi, con cadute incoincidenza di misure fiscali che danno spazio a Ferrara, eriprese quando la politica commerciale della Serenissima si fa piùaccorta. Nel Seicento i dati flettono, da un lato per ildivaricarsi delle rotte dell'olio pugliese - quello di Terra diBari continua a navigare alla volta dell'Adriatico settentrionale,quello di Terra d'Otranto si dirige ormai in prevalenza verso ilNord attraverso l'Atlantico - dall'altro per la crisi di Venezia,solo in parte compensata dal crescere di Ferrara; ma, lo vedremonel prossimo capitolo, numerosi indizi alludono al persistere neiporti baresi di pezzi di società tenacemente aggrappati aitraffici oleari fin nei decenni più difficili, pronti adapprofittare poi della congiuntura positiva della domandainternazionale di olio nel primo Settecento. Nel secondoSettecento il declino ormai catastrofico di Venezia come porto didestinazione dell'olio meridionale incrocia l'ascesa del porto diTrieste, che si fa prepotente soprattutto a partire dal 1750circa: i diritti di ancoraggio, in media 2066 fiorini l'anno nelperiodo 1750-55, salgono a 3176 fiorini nel quadriennio 1763-66, a5000 circa fra il 1773 e il 1776, a 10000 circa alla fine deglianni '80. Ma non sembra che l'economia della nostra provincia ne171 R. MANTELLI, Burocrazia e finanze pubbliche nel Regno di Napoli, Napoli 1981,Pp. 241-43Cfr. Oesterreichische Nationalbibliothek, Vienna, Eclaircissementcit.; Hofkammer Archiv, Vìenna, Kommem-Litorale, R. N. 574, fs. 28, 29, 44.
72
approfitti molto. Se nel 1765 l'olio meridionale importato aTrieste, cioè ormai essenzialmente l'olio proveniente dai portidella costa barese, corrisponde ad oltre il 90 per cento dell'olioglobalmente importato e al 2 8, 1 per cento del valore totale delcommercio di importazione dello scalo austriaco, il dato del 1783corrisponde al 57 per cento dell'olio importato e al 6,3 per centodel valore delle importazioni totali, e nel 1789 il valoredell'olio meridionale sul totale delle importazioni si riduce al4,8 per cento”. Né la crisi delle rotte olearie tirreniche perragioni belliche, che porta nel 1794 al raddoppio delle quantitàdi olio meridionale destinato ai porti dell'Alto Adriatico (53 966salme contro le 25000 circa del periodo 1788-92)172 sembrabeneficiare in particolare Terra di Bari, la quale, nonostante ivantaggi derivanti dalla sua collocazione geografica, lascia cheTerra d'Otranto riconverta rapidamente la gerarchia dei propriporti a favore di quelli
Tabella 4.
Olio meridionale esportato a Venezia, Ferrara, Trieste eMarsiglia (medie annue).
Fonti: per la prima colonna i dati cinque-seicenteschi,inclusi quelli del primo decennio del Settecento, sono ricavati daI. MATTOZZI, Crisi, stagnazione e mutamento nello stato venezianosei-settecentesco: il caso del commercio e della produzioneolearia, in “Studi veneziani”, 1980, pp. 199-276; quellisettecenteschi da s. CIRIACONO, Olio ed ebrei nella Repubblicaveneta del Settecento, Venezia 1975, tab. p. 172, tranne i datirelativi al 1735 e agli anni '90, per i quali cfr. VISCEGLIA, IlCommercio Cit., Pp. 204 e 2 o6. Per i dati seicenteschi dellaseconda colonna cfr. ancora MATTOZZI, Crisi cit., e per quellisettecenteschi R. ROMANO, Le Commerce du Royaume de Napks avec laFrance et les pays de l'Adriatique au XVIII siècle, Paris 195 1,PP - 78 e 79. Per la terza colonna il dato per il periodo 1750-55cfr. ibid., PP. 74 e 75; quello dei 1765 in W. KALTENSTADLFR, Derosterreichische Seebandel úber Triest im A. Jahrbundert, in“Virteljahrschrift fúr Sozial- und Wirtschafts-geschichte”, 1969,tab. x, p. go; quelli del 1778 e 1782 in VISCEGLIA, Il CommercioCit., P. 205; quello del periodo 1770-75 in Hofkaminer Archiv,
172 P. CHORLEY, Oil Silk and Enlightemnent. Economie Problems in XVIIIth CenturyNaples, Napoli 1965, pp. 36-37.
73
Vienna, Kommerz-Litorale, Rote Nummer 582, Memoires sur lecommerce auffichien par la route du Litorale; quello dei 1783,ibid., Importazione per mare nel portofranco di Trieste nell'annomilitare 1783, quello del 1789 in osterreichischeNationalbibliothek, Vienna, N. S. 1670, ff. 2-19,Eclaircissementsurla grande importance du commerce de Triestepourla Afonarrbie Auffichienne avec des cartes et tabelles. La quartacolonna è stata elaborata sui registri delle Dépositions de santéin Archives Départementales des Bouches-du-Rhóne, Marsiglia, serie200 E i. Tutte le quantità, espresse in varie unità di misura,sono state tradotte in salme napoletane.
Venezia Ferrara TriesteMarsiglia(a)
anni salme anni salme anni salmeanni salme
primo '500 52000 1669 16-2000 1750-1755 20000 1710-1719 100
1580-I586 41828 1686 30000 1765 15460 1723-1730 821592-1596 51000 1694 32000 1770-1775 13600 1731-1740 5401610-20 65000 1734-35 9217 b 1778 8972
1741-1750 2521630-1640 44000 1775-60 15-18000(c) 1782 14612 1751-1760
12921663-1670 30534 1783 12000 1765-1770
14591671-1680 27907 1789 12500 1771-1780
45301685-1690 21 487 1781-1792
15381691-1700 25392 1793-1815
I1001701-1709 191681714-1717 113751735 7396(a)1745-1746 12 1241760/61-1770/71 13981771/72-1780/81 27831881/82-1790/91 9151789-180o 818
(a) Solo dai porti di Terra di Bari.(b) Solo su navi provenienti da Terra di Bari e battenti bandiera
napoletana.(c) Solo su navi battenti bandiera napoletana.
adriatici e torni a incontrare una porzione molto elevata
74
della domanda globale.I dati settecenteschi ricavati dagli archivi meridionali
confermano un grado di rigidità dell'offerta netta della provinciapiù alto di quello di altre aree meridionali produttrici di olioper l'esportazione (cfr. tab. 5). Certo, soprattutto se misuratoin rapporto alle accresciute dimensioni dell'economia rispetto aquelle cinquecentesche, il commercio oleario settecentescodell'intero Mezzogiorno non sembra in grado di riguadagnare leposizioni di due secoli prima sotto il profilo delle quantitàesportate, anche se, in termini di valori misurati in unità digrano, questo decadimento relativo potrebbe essere reso illusoriodalle vicende delle ragioni di scambio fra olio e grano. Ciò cheappare invece reale, in qualunque modo si vogliano valutare i datidisponibili, è il ridimensionamento del ruolo di Terra di Bari nelmercato oleario internazionale. Nel ventennio 1715-34 il Regnoesportava mediamente 40 - 60000 salme l'anno, una metà circa daiporti di Terra d'Otranto, all'incirca un altro 40 per cento daiporti baresi.
Negli anni 1781-94 la situazione si presenta radicalmentemodificata: la media annua delle esportazioni di Terra di Bari,calcolata sugli anni per i quali abbiamo dati, è scesa da pocomeno di 20000 salme a poco più di 140oo, quella di Terra d'Otrantoè salita da 25 000 salme circa a 36750, nel mentre la Calabriaultra, che aveva nel primo Settecento un ruolo marginale nelcommercio oleario, con le sue 27000 salme circa sulle 85700 dellamedia annua del Regno rappresenta ben il 32 per cento delleesportazioni del settore, collocandosi dopo il 43 per cento diTerra d'Otranto e ben più avanti del 16 per cento di Terra diBari.
Si tratta, lo ripeto, di cifre da prendere con largo beneficiod'inventario. Esse però, lette sullo sfondo delle curve deiprezzi, segnalano in maniera inequivocabile un elemento diimportanza centrale: la nostra regione economica, pur ampiamentemercantilizzata, non si adegua pedissequamente al mercato, come inun gioco senza storia di 'fattori produttivi' gravitanti versol'equilibrio. La domanda internazionale spinge verso l'alto overso il basso la quantità di risorse mobilitate perl'esportazione entro limiti ristretti e presto raggiunti, ben piùrigidi che in altre situazioni perché segnati, in ultima istanza,dalle coerenze stesse, fisiche ed economiche, del sistema. Così levariabili fondamentali 'endogene', popolazione e produzione,acquistano margini di autonomia dalla domanda e postulano nessi
75
reciproci fra loro, si muovono nel tempo secondo logiche chevanno studiate di per sé.Che lo spettro di Malthus aleggi anche su questa terra di trafficie “bracciali”?
Tabella 5.
Olio esportato (in salme) da Terra di Bari, Terra d'Otranto eRegno.
Fonte: i dati delle prime due colonne relativi al periodo1717-34, tranne quelli dei 1721 per Terra di Bari e del 1732 per Terradi Bari e Terra d'Otranto, sono tratti da DI VITTORIO,Esportazioni pugliesi cit., tab. p. 186; per quello del 1721 perTerra di Bari Cfr. ASNA, f. Dipendenze della Sommaria, lanumerazione, b. 348, f s. 3; per quelli del 1732 ASNA, f.Percettori e tesorieri provinciali, f s. 5645. I dati dal 1715 al1734 relativi al Regno sono tratti da A. DI VITTORIO, GliAustriaci e il Regno di Napoli. 1707-1734. Le finanze pubbliche,Napoli 1969, tab. p. 230; quelli del periodo 1760-94 da CHORLEY,Oil Silk and Enlightenment cit., p. 219, e sempre ibid., p. 27, ildato relativo a Terra d'Otranto per il 177 1 . Per i dati dal 1781al 1790 per Terra di Bari e Terra d'Otranto cfr. Bp Bari, b. 137,CC. 223 e 226, Dimostrazione delle salme d'olio estratte per extraRegno da gennaio 1781 a dicembre 1790; per quelli dal 1791 al 1794A. LEPRE, Contadini, borghesi ed operai nel tramonto delfeudalesimo napoletano, Milano 1963, pp. 264-65, ripresi poi daCHORLEY, 0il Silk and Enlightenment cit., p. 23 e parzialmente daL. DE ROSA, La crisi economica del Regno di Napoli (e la Terra diBari, 1794-1798), in Terra di Bari all'aurora del Risorgimentocit., P. 75. La fonte napoletana utilizzata da Lepre e Chorleycomincia a dare i dati a partire dal 1785; questi coincidonoperfettamente con i dati BP Bari, tranne il dato del 1789, che èerrato nel prospetto napoletano (33380 salme e 314), come dimostrala cifra globale delle esportazioni olearie del Regno data dalministero delle Finanze per quell'anno e riportata da CHORLEY, OilSilk and Enlightenment cit., p. 21.
Terra Terra Regno Terra Terra Regnodi Bari d'Otranto di Bari d'Otranto
1715 - - 42000 1767 - - 105686
76
1716 - - - 1768 - - 872921717 18509 13 244 39236 1769 - -
541041718 - - 35779 1770 - - 882991719 - - 44876 1771 - 61621 1289961720 - - 20 918 1772 - -
18501721 15548 21 874 - 1773 - -
624531722 - - 27243 1774 - - 1079201723 - - 46292 1775 - - 494381724 15 199* 24 926* 39654 1776 - -
1259501725 - - 41274 1777 - - 459711726 15880 31 796 49748 1778 - -
657721727 - - - 1779 - - 6441l1728 - - 41 372 1780 - -
913511729 16086 15339 - 1781 15953 14692 641111730 22874 31 792 - 1782 14612 36730
1103891731 21 831 30317 61 951 1783 14159 28 131
553531732 25 135 41 614 - 1784 6488 32667
794451733 21 217 27904 54939 1785 3414 23 625
37 8111734 13 912* 10 413* 28467 1786 9996 48023
111588... 1787 10201 22848 516581760 - - 53994 1788 17990 28658 969901761 - - 48493 1789 23381 43796 1068361762 - - 59304 1790 16326 25512 996081763 - - 48879 1791 14213 69178 125 2911764 - - 29209 1792 20811 61537 1147691765 - - 69623 1793 6216 22 127
379401766 - - 47897 1794 23754 44424
102634
*Dati parziali.
2. Popolazione e produzione.
A guardare, per quanto è possibile sulla base degli elementidi fatto disponibili, l'andamento nel tempo delle variabili
77
malthusiane classiche, se si prescinde dalla fase di crescitaimpressionante che coincide con il processo di strutturazione delnostro sistema regionale e si esaurisce in sostanza verso la metàdel Cinquecento, la relativa rigidità della società di Terra diBari rispetto agli impulsi della domanda esterna messa in evidenzadalla vicenda delle “estrazioni” sembra ricevere confermesignificative. Non che popolazione e dissodamenti non rispondanoin generale positivamente ai prezzi, a conferma delle differenzeprofonde fra una situazione come quella qui studiata e quellecontadine 'normali'; il punto è che l'elasticità della risposta èin primo luogo relativamente modesta sul medio periodo perentrambe le variabili, in secondo luogo più alta per lapopolazione che per i dissodamenti, e trasmette perciò al sistemaelementi di tensione che si cumulano e determinano condizioni didifficoltà e crisi prima dell'inversione del trend della domanda.
Assegnando nulla più che valore comparativo e di primaapprossimazione al confronto fra le numerazioni dei fuochi, e fraqueste e i dati demografici tardo-settecenteschi, è possibileindividuare i tratti generali della dinamica della popolazionedella provincia sullo sfondo di quella del Mezzogiornocontinentale173. Le cifre relative al Regno di Napoli, esclusa la
173 I dati della numerazione dei fuochi del 1443 sono tratti da G. DAMOLIN, Lapopolazione del Regno di Napoli a metà Quattrocento, Bari 1979, e F. COZZETTO,Mezzogiorno e demografia nel XV secolo, Soveria Mannelli 1986, corretti edintegrati per quel che riguarda Gioia, Canosa e Carbonara sulla base delRegistro d'introito dei dritto di mezzo ducato a tomolo di sale compilato dalpercettore di Terra di Bari nel 1459, in ASNA, f. Percettori provinciali, fs.5382, nel quale sembra che ogni rotolo di sale corrisponda a due fuochi. Perlanumerazione del 1505 cfr. ivi, fs. 5385, registro delle esazioni fiscalicompilato nel 1507. Per le numerazioni dal 1545 al 1669 GIUSTINIANI, Dizionariocit. Per la numerazione dei 1732 cfr. M. R. BARBAGALLO DE DIVITIIS, Una fonteper la storia della popolazione del Regno di Napoli: la numerazione dei fuochidel 1732, Roma 1977 (sono stati interpolati i dati relativi ai cinque centri noncensiti). I dati globali relativi al 1767 e quelli analitici per il 1796 sonotratti da P. VILLANI, Documenti e orientamenti per la storia demografica delRegno di Napoli nel Settecento, in «Annuario dell'Istituto Storico italiano perl'età moderna e contemporanea», 1963-64, PP. 45-51 e 119-20. Tutti gli altridati analitici relativi ad anni diversi da quelli delle numerazioni dei fuochisono tratti dalle Relationes ad limina, per le quali cfr., per centro ed anno,ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, Archivio della Congregazione del Concilio. Alcuni diquesti dati sono riportati e discussi in M. AYMARD, Stati d'animo e storiademografica, in Atti del congresso internazionale di studi sull'età delViceregno, Bari 1977, pp. 217-3 8. Per il confronto con i dati globali del Regnosi è tenuto conto, oltre che di P. Villani, di LEPRE, Storia del Mezzogiornod'Italia cit. Il moltiplicatore adottato per tradurre i fuochi in abitanti è 4,5
78
capitale e i suoi casali, individuano due fasi di dimensioneparagonabile in cui la popolazione cresce a un passo grosso modosimile, separate da un periodo di crisi più breve e che si tienecomunque lontana dall'andamento catastrofico tre-quattrocentesco:fra il 1443 e il 1595 l'incremento è del 131 per cento contro il147 del periodo 1669-1794, con un decremento del 25 per cento nelprimo settantennio del Seicento. In Terra di Bari i trend hannopunti di inversione non dissimili ma angolature molto diverse. Lafase ascendente quattro-cinquecentesca realizza un incrementopressoché triplo rispetto a quello del Regno (+ 373 per cento),determinato dal recupero, dopo la catastrofe tre-quattrocentesca,qui particolarmente drammatica, del livello demografico al qualela provincia era stata condotta dall'espansione medievale174; unrecupero che comincia ad esaurirsi già verso la metà delCinquecento, quando il tasso d'incremento dei fuochi mutadrasticamente passo, scendendo da un 11-12 per cento a decenniofra la numerazione del 1443 e quella del 1545 a un 6-7 per centrofra il 1545 e il 1595, rispetto a una caduta del tassod'incremento del Mezzogiorno continentale sensibile ma menoaccentuata (dal 6-7 al 4-5 per cento). Al contrario nel Sei-Settecento l'incremento provinciale è della metà (+ 73 per cento)rispetto a quello del Regno, a causa di un trascinamento dellafase recessiva seicentesca, nella forma di una sostanzialestazionarietà del livello della popolazione, fin dentro ilSettecento, e di una partecipazione relativamente debole al boomfra il quarto e il sesto decennio del secolo. D'altro canto, lacrisi seicentesca provoca un calo demografico contenuto (-19 percento) e lascia l'impressione di non aver liberato risorse asufficienza, dopo lo straordinario incremento cinquecentesco, perconsentire a Terra di Bari di tenere il passo del Regno nel secoloseguente. L'immagine che si ricava da questi dati è dunque quelladi un'area che, riconquistata nel corso del Cinquecento unacondizione di intensa anche se ineguale umanizzazione, ha spaziristretti per incrementi ulteriori nel quadro delle compatibilitàe coerenze descritte nel capitolo precedente.
Anche sull'altro versante del rapporto qui studiato, quellodella dinamica delle superfici a coltura, il Cinquecento sembrasegnare il punto di arrivo di un processo di risistemazione delpaesaggio agrario che parte dalla grande crisi tre-174 Sulla base delle valutazioni di A. FILANGIERI, Territorio e popolazionenell'Italia Meridionale, Milano 198o, pp. 125 e sgg. e 281, la popolazione diTerra di Bari nel 132o doveva essere grosso modo simile a quella di fineCinquecento.
79
quattrocentesca. Un groviglio di vincoli economici, sociali,naturali, che occorrerà dipanare man mano, trattiene il giocodelle variabili fondamentali all'interno di quadri territorialiche, definitisi fra l'autunno del Medioevo e l'alba dell'etàmoderna, hanno margini di movimento più ristretti che altrove, ecomunque inferiori rispetto a quelli pur relativamente modestidella popolazione. A guardare i pochi dati catastali che èpossibile mettere a confronto sul lungo periodo175, l'elemento dimovimento del paesaggio agrario appare il solo vigneto: il suoinserimento in un circuito mercantile di raggio corto e per ciò175 La distribuzione delle colture in rapporto alle superfici censite nei catastia Molfetta, Bisceglie e Palo ha questo andamento nel tempo:
Molfetta 1561 1754 1812oliveto e mandorleto 71,88 71,82 64,34vigneto 11,56 5,38 18,8seminativo 11,69 15,21 15,27altro 4,87 7,59 1,58
_____ _____ _____100 100 100
secondoBisceglie Cinquecento 1812
oliveto e mandorleto 53,4 56,01*vigneto 20,77 9,02seminativo 7,89 16,84altro 17,94 18,13
_____ _____100 100
1633-34 1750 1814Palooliveto e mandorleto 30,62b 28,29b 29,78vigneto 10,09 19,21 15,3seminativo 58,79c 49,95c 54,22caltro 0,5 2,55 0,7
_____ _____ _____100 100 100
a) Compreso il « seminativo olivetato ». b) Compreso il « seminativo arborato ». c) Comprese le « terre ».
Queste cifre sono elaborate sulla base di Pom, Distribuzione della proprietàfondiaria a Molfetta nel 1561 cit, tab p: 234; TULLIO, Molfetta cit, tab. p. 27per il catasto onciario di Molfetta; VITARELLI, L'economia cit., tab: p. 57 perPalo nel 1633-34; RICCHIONI, Saggio sull'estensione cit., tab. p. 16 per
80
stesso più elastico e manovrabile dai ceti dominanti locali, e itempi brevi intercorrenti fra la messa a dimora delle piante e lafase produttiva piena lo rendono strumento efficace per tentarel'assalto all'incolto e al seminativo nudo - non a caso esso èl'oggetto principale di ogni forma di contratto miglioratario -,per poi ritirarsi senza danni irreparabili quando le convenienzemutano. Ma - lo abbiamo visto - la vigna è elemento importante manon certo protagonista di un'agricoltura pesantemente dipendenteda colture di dinamica limitata.
Per la fase cinquecentesca i dati catastali non ci sono dialcun aiuto, ma, come vedremo, gli indizi disponibili suggerisconoper la nostra provincia scansioni temporali nella vicenda delrapporto fra popolazione e risorse che in una qualche misuraanticipano quelle dei propri mercati di sbocco, probabilmenteanche per il particolare vigore della ripresa demografica locale.Come si sa, nel determinare l'andamento ascendente dei prezzieuropei, all'incidenza dell'oro americano, alla crescitademografica, all'emergere di grandi città avide di sovrappiù,all'incertezza degli approvvigionamenti che percorrono le rotted'Oriente e alla presenza sporadica nel Mediterraneo fino alloscorcio del secolo di quelli delle rotte d'Occidente, si aggiungel'affanno generalizzato della produzione agricola, cioè, inassenza di mutamenti significativi della produttività, il passolento, inceppato, intermittente dell'espansione delle superficicoltivate che va bloccandosi attorno ai difficili anni '80. Nellanostra provincia, come vedremo, gli anni '80 sembrano acuiredifficoltà produttive evidenti già negli anni '60, sottolineatedal trascinarsi, sia pure a tassi ben più modesti che nel periodoprecedente, della crescita demografica fin dentro il secolosuccessivo. Più variegata si presenta la situazione europeanell'altra grande fase di spinta della domanda, quellasettecentesca, nella quale in alcune aree la produzione sembratenere con successo il passo della popolazione, in altre, piùlimitate, addirittura sopravanzarla. Ma, ancora nel nostroSettecento provinciale, in termini comparativi demograficamentemodesto, sembra riproporsi una condizione cinquecentesca didivaricazione a forbice, sotto l'impulso della crescita dei
l'onciario di Palo; ASBA, Registro riassuntivo dei catasti provvisori, peri datidel 1812-14. I dati del catasto cinquecentesco di Bisceglie sono contenuti in unlavoro inedito di G. Poli. Nel valutare questi dati occorre usare tutta lacautela imposta dai diversi criteri di rilevazione e classificazione delle terrecensite e dall'inevitabile margine di arbitrio che comporta l'accorpamento, afini di leggibilità, di denominazioni colturali incerte ed oscillanti.
81
prezzi, di popolazione e superfici dissodate.Si sommino, allo scopo di ridurre gli errori e di costruire un
campione significativo della realtà provinciale, i dati di novecentri variamente collocati nel territorio provinciale - Molfettae Bitonto nel cuore dell'area olivicola, Trani sulla costacerealicola, Minervino e Spinazzola nella Murgia nord-occidentale,Palo e Binetto ai margini della conca barese, Sammichele eCasamassima nella Murgia di Sud-Est: fra metà Settecento e primianni '10 dell'Ottocento, a fronte di prezzi che raddoppiano per letre derrate maggiori e di un incremento demografico che nei centriin questione si aggira sul 70 per cento, l'incremento dellesuperfici coltivate, anche a considerare del tutto incolte leterre non censite nell'ondario e ad attribuire quindi tutta adissodamenti la differenza fra la dimensione degli agri risultantenei catasti del periodo francese e quella rilevata a metàSettecento, non va al di là di un 30 per cento circa e lasciasostanzialmente immutata la proporzione fra le colture176.
Costretta a difendere, quando cresce la domanda del commercioin grande, gli spazi delle “estrazioni” attaccati dalla diversaelasticità di popolazione e dissodamenti rispetto ai prezzi, construmenti di limitata efficacia in condizioni di antico regime -in primo luogo la crescita della produttività e la compressionedel consumo pro capite - Terra di Bari finisce per assumere nelquadro dell'economia internazionale una collocazione particolare:già dal secondo Cinquecento troppo popolata e strutturata perlogiche interne elaborate nel confronto con un paesaggio ostile edavaro, essa produce attivamente sovrappiù destinati al grandecommercio, senza però fungere, come altre aree specializzate, dadeposito di riserve strategiche al servizio dei mercati di sbocco,mobilitabili all'occorrenza da parte di questi ultimi. Ed ancorauna volta si prenda a riferimento la Capitanata, “scatola vuota”spopolata e plasmabile dall'esterno, utilizzata, a fini fiscali edi sostegno degli equilibri economici e sociali della montagnaabruzzese, in larga parte per la pastorizia, ma capace, nelle fasiacute, di rispondere efficacemente alla domanda di granonapoletana ed estera mobilitando terra fresca attraversolacerazioni lecite o illecite del vincolismo pastorale. Qui, benpiù che in Terra di Bari, schemi di spiegazione delle dinamiche di176 Il confronto è fra i dati dei catasti onciari di ciascun centro - per i qualirinvio agli studi già citati, oltre che, per Casamassima, a G. POLI, Appunti perun'interpretazione del paesaggio agrario pugliese attraverso i catasti onciari,in Il Mezzogiorno settecentesco attraverso i Catasti onciari cit., vol. II, P.307 - e il Registro riassuntivo dei catasti provvisori in ASBA.
82
lungo periodo fondate sull'incidenza esclusiva di variabilieconomiche e amministrative esterne e indipendenti troverebberoelementi di verifica.
A parte il suo fragile sostegno documentario, un ragionamentocondotto a questo livello di aggregazione può far risaltareaspetti della realtà che altrimenti ci sfuggirebbero, ma rischiadi perderne di vista troppi altri e di non cogliere i nessispecifici fra le variabili fondamentali di un territorio cosìfortemente differenziato.
Il punto da cui ripartire per analizzare questi nessi èl'articolazione della provincia per zone agricole delineata nelcapitolo secondo, che può essere formalizzata - e irrigidita -come nella figura 2. Scomponendo i dati demografici per zone, èpossibile disegnare un fascio di curve di forma sostanzialmentesimile, ma con pendenze e punti d'inversione diversi, cheindividuano tre aree subregionali: quella sud-orientale interna(zone 7 e 8), quella cerealicola mercantile (zone 4, 5 e 6),quella olivicola (zone i, 2 e 3). Pur fortemente differenziata alsuo interno, ciascuna area presenta aspetti di omogeneità sulpiano che qui interessa, quello del rapporto popolazione-produzione (cfr. tab. 6).
L'area sud-orientale interna, come del resto ci siaspetterebbe, appare meno sensibile delle altre a quanto succedesul mercato delle derrate commercializzate a lunga distanza, dalquale appare relativamente schermata dal peso della suapolicoltura, della sua produzione artigianale mossa nei circuitibrevi dei mercati settimanali, dell'autoconsumo. Di conseguenza lasua demografia sembra svolgersi in presa più diretta con ifenomeni meteorologici, con le vicende fisiche della produzione,in un contesto in cui il rapporto fra uomini e risorse ambientaliè meno teso che nelle zone mercantili della provincia. Lapopolazione segue qui un sentiero anticiclico rispetto allademografia provinciale, con impennate e cadute relativamentemodeste, realizzate attraverso un sistema di compensazioni fracentri contigui: nel Settecento, mentre Turi, Noci, Gioia,Casamassima, Fasano e Cisternino crescono impetuosamente, centridi passato illustre come Acquaviva, Rutigliano o Conversanoavanzano stentatamente senza riuscire a tornare ai livelli massimicinquecenteschi.
Non sembra questo il terreno di coltura adatto per centri dipeso demografico paragonabile alle grandi città contadine emercantili della provincia, e se volta a volta, nel corso dell'età
83
moderna, Rutigliano e Conversano, Acquaviva e Putignano siagganciano al gruppo dei centri più popolosi di Terra di Bari,esse non
Figura 2. Zonizzazione di Terra di Bari.
I . Bari e la conca.
Bari, Binetto, Bitetto, Bitritto, Canneto, Capurso, Carbonara,Ceglie, Cellammare, Grumo, Loseto, Modugno, Montrone, Palo,Sannicandro, Toritto,
Triggiano, Valenzano.
2. Olivicola specializzata.
Bisceglie, Bitonto, Giovinazzo, Molfetta, Terlizzi.
3. Olivicola meridionale.
Mola, Monopoli, Polignano.
4. Cerealicola centrale.
Altamura, Gravina, Santeramo.
5. Cerealicola costiera.
Barletta, Trani.
6. Cerealicola settentrionale.
Andria, Canosa, Corato, Minervino, Ruvo, Trinitapoli.
7. Murgiana meridionale.
Acquaviva, Alberobello, Casamassima, Cassano, Gioia, Noci, SanMichele, Turi.
8. Premurgiana meridionale.
Castellana, Cisternino, Conversano, Fasano, Locorotondo, Noja,Putignano, Rutigliano.
84
riescono a mantenere a lungo le posizioni conquistate e perdonodefinitivamente contatto fra Settecento e Ottocento. Ma tuttoquesto non rende meno efficace la demografia dell'area, che frametà Quattrocento e fine Settecento, tranne che per i decenni acavallo fra XVII e XVIII secolo a causa anche delle conseguenzedella peste del 1690-92, va rosicchiando ininterrottamenteposizioni e spinge la sua popolazione dal 19,5 di metàQuattrocento al 26,4 per cento di fine Settecento rispetto altotale provinciale.
Ben più importante per gli equilibri complessivi dellaprovincia e per la sua collocazione nel contesto meridionale einternazionale è quanto avviene nel resto del suo territorio.Nella vasta area della cerealicoltura specializzata la demografiasegue un percorso fortemente pro-ciclico, con forti impennate ecadute rovinose in significativo contrasto con le pendenze dolci ele inerzie dei dati globali della demografia del sud-est. Qui lafase fra metà Quattrocento e metà Cinquecento appare segnata dadue fenomeni demografici di grande rilievo: da un lato, lo vedremomeglio in seguito, il rientro di Trani e Barletta, nella zona 5,dalla condizione di città mercantili conquistata nel corso delMedio Evo, a quella di centri integrati nel paesaggio agrariodella Murgia cerealicola centro-settentrionale, della quale, dopoil disastroso calo relativo verificatosi fra la numerazione del1443 e quella del 1545, vanno man mano assumendo il passo;dall'altro lo slancio travolgente della Murgia di Gravina,Altamura e Santeramo (zona 4), che, nello stesso periodo, vedemoltiplicarsi i suoi fuochi per un fattore 6.
Tabella 6. Numeri-indice della popolazione, per zone agricole.
1443 1505 1545 1595 1648 ~669 1732 1765 17961. Bari e la conca 21 45 105 135 126 100 102 -
1842. Olivicolaspecializzata 26 46 83 108 108 100 98 -
1763. Olivicolameridionale 17 39 76 110 110 100 67 -
1774. Cerealicola
85
centrale 17 39 101 118 1118 100 86 - 1425. Cerealicolacostiera 88 93 120 154 160 100 117 - 2646. Cerealicolasettentrionale 34 50 87 162 160 100 97 -
2157. Murgianameridionale 21 44 70 114 115 100 94 -
1858. Premurgianameridionale 18 35 73 110 117 100 90 -
1689. Terra di Bari 26 46 88 124 124 100 96 134
173Regno 58 64 107 134 127 100 111 197
247
La vicenda quattro-cinquecentesca della Murgia centro-occidentale è simile a quella della contigua area cerealicola diTerra d'Otranto gravitante su Taranto, ma speculare rispetto a quella della Murgiasettentrionale (zona 6), la cui demografia ha grosso modo il passodella demografia di Capitanata. Nel secondo Quattrocento, comerisentendo dell'avvitamento in termini relativi della popolazionedella provincia contigua causata dalla formalizzazione dei vincolidoganali - fra il 1443 e il 1505 la Capitanata precipita da unlivello all'incirca pari a quello di Terra di Bari a meno dellametà - la zona cerealicola settentrionale presenta l'incrementopiù basso di ogni altra zona di Terra di Bari esclusa quella diTrani e Barletta, ed è ancora nettamente al di sotto della mediaprovinciale nella prima metà del Cinquecento, quando la Murgiacentro-occidentale è di gran lunga l'area più dinamica; ma nellaseconda metà del Cinquecento, mentre quest'ultima precipita dalprimo all'ultimo posto nella classifica scandita dal tasso diincremento demografico, la prima si colloca nella posizione ditesta realizzando una crescita percentuale cinque volte più altadi quella dell'altra area cerealicola mercantile e collocandosiancora una volta in sintonia con la Capitanata, che sembra nel
86
frattempo aver imparato a convivere con la Dogana.In queste aree cerealicole, sul versante della produzione del
grano mercantilizzato le cose sembrano correre in modo del tuttoconsonante con la demografia. Come abbiamo visto, i vincolidoganali, presenti in Terra di Bari soprattutto nelle areeconfinanti con la Capitanata, sembrano nel secondo Quattrocento enel primo Cinquecento spingere verso Sud, verso Gravina e Taranto,il cuore della cerealicoltura mercantilizzata pugliese eindirizzano verso lo Ionio molte delle navi granarie destinate aNapoli. Ma qui la capacità di espansione della produzione siesaurisce presto, dato che all'inizio del Seicento, secondo datiframmentari sui terraggi pagati al feudatario di Gravinaconfermati da quanto si sa per Santeramo, le semine non sonoandate oltre il livello di metà Cinquecento; e, con essa, lacapacità di crescita demografica che, dopo aver portato Gravinanelle numerazioni del 153 2, del 1545 e del 1561 di gran lunga alprimo posto per popolazione fra i centri della provincia,rispettivamente con 2245, 2761, 2864 fuochi, blocca il grandecentro murgiano nel 1595 al livello di 2734 fuochi177. Nel secondoCinquecento, invece, continua e si accentua in termini relativi lacrescita demografica della Murgia settentrionale, nel mentrel'atteggiamento più permissivo nei confronti del vincolismopastorale imposto alle autorità dalle crescenti difficoltàannonarie e la maggiore fertilità delle terre sottratte al pascoloripropongono, nella produzione di grano per le grandi rotte, lacentralità del Tavoliere e della parte settentrionale di Terra di
177 Traducendo in numeri-indice i dati sui terraggi gravinesi di un lavoro diprossima pubblicazione di A. Massafra, la tendenza di lungo periodo apparechiaramente individuata:
Grano Orzo Avena Fave
1545-1550 (medie annue) 100 - - -1553-1554 103 - - -16oo-16o1 100 100 100 1001601-1602 104 89 97 1041602-1603 100 89 106 351603-1604 101 99 109 1691604-1605 92 85 96 2041605-16o6 85 106 76 15716o6-1607 65 69 64 1121640-164 164 87 63 16o1675-1685 (medie annue) 46 47 27 1441704-1705 48 62 43 -
Per quel che riguarda Santeramo, cfr. la già citata tesi di laurea di Aquilino.87
Bari, dove si segnalano diffusi dissodamenti178.Ma agli inizi degli anni '20 del Seicento la situazione volge
ovunque al peggio: anche i massari delle terre della Doganaconvertite alla cerealicoltura, afferma un corrispondente toscanoda Napoli nel 1621, “sono falliti”, e quindi si sono ritiratiprima di andare in rovina non vogliono tornare a “questo mestierocome troppo risicoso et suggetto a infiniti pericoli di cielo erdi principe. Si che per questo e altro restano oggi inculti etsodi più di due terzi dei terreni della Puglia”179. Nell'area digravitazione di Barletta la relativa tenuta dei prezzi de grano eil resistere su livelli discreti delle “estrazioni” via maredevono aver attutito, nella prima metà del secolo, l'impatto sullademografia delle difficoltà produttive che è invece a Gravinadiretto e irrimediabile. Mentre a Gioia, Palo, Rutigliano e Mola,i cui grani circolano in spazi brevi, la produzione si espande otiene fin dentro il Seicento e solo i decenni centrali del secoloindividuano una fase di svolta negativa180, a Gravina i dati
178 Cfr. PALUMBO, Appunti cit., pp. 224, nota.179 CONIGLIO, Il Viceregno di Napoli cit., PP. 43-44, NOTA.180 Cfr. i seguenti numeri-indice dei terraggi corrisposti in queste città, daconfrontare con le cifre riguardanti Gravina della nota 5:
Gioia Palo Rutigliano + Mola__________ ________________________ ________________
grano fave grano orzo avena grano
1607-16o8 100 100 1629 120 - - 16o8 I0016o8-1609 163 370 1667 100 100 100 1609 I001609-1610 138 285 1671 121 132 113 1613 1001635-1636 279 320 1672 118 - - 1616 1101636-1637 338 46o 1673 - 117 97 1618 1121637-1638 98 110 1674 138 - - 1620 1181649-1652 ~100 ~120 1676 129 154 108 1622 118
1681 108 107 66 1625 1191683 - 28 28 1626 1191690 - 106 64 1627 1191693 42 66 34 1628 120
1629 1161630 1161696 77
Fonti: per Gioia BN B ari, f. D'Addosio, I - 13 4; per Palo ASBA, f. Atti delcomune di Palo, serie antica, b - i, fs - 6, 8- 15, 17, 18; b. 2, fS. 20-2 2;
88
demografici delle relationes ad fimina(20ooo anime nel 1615, 16000nel 1622, 120oo nel 1631, 5145 nel 1647) registrano fedelmente ladrastica riduzione delle semine successive alla crisi del 1606-607, che, dapprima timidamente contrastata dalla maggiore tenutadei cereali meno commercializzati, si aggrava ulteriormente neglianni '70 e '80 segnalando una crisi ormai generale e irreversibiledella società del grande centro murgiano: i timidi segnali diripresa, produttivi e demografici, degli anni a cavallo fraSeicento e Settecento non preannunciano sviluppi consistenti, masolo l'inizio di un recupero che non giungerà mai a compimento.
Ritardato ed in un rapporto con le vicende economiche mediatoda quelle epidemiche, il crollo seicentesco della zona cerealicolasettentrionale non sarà meno spettacolare. La catastrofe epidemicadegli anni '50181, si abbatte sui centri della provincia conbizzarra selettività, vagando a zigzag negli spazi ristretti dellaconca barese o colpendo duramente, fra i centri maggiori, Terlizzie Gravina ma non le contigue Bitonto ed Altamura che si vedonocosì collocate, alla numerazione del 1669, ai primi due postinella graduatoria dei centri più popolosi della provincia. Manella fascia cerealicola settentrionale, dal mare allaBasilicata, l'epidemia non sembra discriminare: se fra lanumerazione del 1648 e quella del 1669 Trani e Canosa contengonoil declino rispettivamente al 22 e al 24 per cento dei fuochicensiti, Barletta perde il 43, Andria il 51, Minervino addiritturail 59 per cento. Né la ripresa è proporzionale alle dimensionidella catastrofe: nuovamente colpita dall'epidemia, Minervino vedeancora dimezzati i suoi abitanti fra il i 680 e il 1683; ma èl'intera zona che sembra perdere l'aggancio con la Capitanata, chesi va vigorosamente riprendendo già nel secondo Seicento182“.
La crescita torna a farsi intensa fra gli anni '30 e gli anni'60 del Settecento, per poi attenuarsi sullo scorcio del secolo:fra il quarto e il settimo decennio Canosa e Minervino raddoppianola propria popolazione e Andria aumenta del 50 per cento, per poicollocarsi su un trend quasi piatto che non le permette, a fine
per Rutigliano e Mola Archivio della basilica di San Nicola, Bari, Procura 2/10-13 e 3/14-15, Gestione ex feudi, I.La maggiore fragilità della produzione cerealicola per il mercato èsottolineata da R. VILLARI, La rivolta antispagnola a Napoli. Le origini (1585-1647), Bari 1967, pp. 6o-65.181 Sulla quale cfr. ora G. DA MOLIN, 1.9 Mortalità in Puglia dal XVII al XIXsecolo, Bari 1984, in particolare cap. VII.182 Cfr., fra l'altro, A. DI VITTORIO, Tavoliere pugliese e transumanza:distretti rurali e città minori tra XV71 e XIX secolo, in «Rivista di storiadell'agricoltura», 1974, n. 3.
89
secolo, di superare i livelli del primo Seicento. Bastano comunquequei pochi decenni di sviluppo incisivo per ricollocare la fasciacerealicola settentrionale di gran lunga alla testa delle zoneprovinciali per tasso di crescita della fase sei-settecentesca, ese nella Murgia centrale la crisi di Gravina trascina verso ilbasso i dati complessivi, Altamura e Santeramo presentano unadinamica non meno vivace dei centri cerealicoli settentrionali.Ed ancora una volta il rapporto con le vicende della produzioneper il mercato sembra essere immediato, dal momento che, dopoalcuni decenni di crescita vivace, la dinamica dei dissodamentidelle aree di cerealicoltura specializzata, come nel Cinquecento,sembra rallentare e bloccarsi precocemente insieme allapopolazione già all'inizio degli anni '80183.
Infine, l'area olivicola, dove l'andamento delle grandezze quistudiate torna a farsi meno leggibile, e i dati generali esprimonomedie fra situazioni locali a volte divaricate. Anche qui la fasedi più intensa dinamica demografica dell'intero periodoconsiderato è quella che va fra metà Quattrocento e metàCinquecento con tassi di sviluppo che sembrano decrescere man manoche si passa da zone con forte presenza di colture promiscue azone più specializzate. La zona di Molfetta e Bitonto (zona 2),dopo una crescita quattro-cinquecentesca relativamente modesta,risente della crisi seicentesca in maniera attenuata e torna acrescere nel Settecento a un tasso inferiore rispetto alla concabarese (zona 1), più duramente colpita dall'epidemia. del 1656, edella costa meridionale (zona 3) dove ha imperversato la peste del1690-92.
Nel Settecento la situazione si fa confusa. Se Biscegliesembra crescere a un passo costante, le cifre complessive di Bari,confermate da quelle dei registri dei battesimi, ne bloccano lacrescita a metà secolo, e la popolazione di Mola, che nei primicinquant'anni era aumentata a un tasso medio decennale del 13,4per cento, vede ridurre il suo passo a un modesto 6,6 per cento;al contrario a Monopoli la ripresa si fa travolgente proprio negliultimi decenni del secolo, e così a Molfetta le nascite, che neiprimi settanta anni del Settecento aumentano a un tasso mediodecennale del 5,5 per cento, balzano negli ultimi trent'anni delsecolo a un tasso del 15 per cento. La zona dell'olivicoltura183 Cfr. l'indagine governativa del 1781-84 utilizzata da MACRY, Mercato esocietà cit., PP. 461 sgg. I terraggi percepiti dalla mensa arcivescovile diGravina, anche se riguardano una situazione ormai marginale, individuanosignificativamente una cronologia simile: Masella, Mercato fondiario cit., pp.271-72, nota.
90
specializzata interna, infine, realizza una crescita importante,nell'ambito di uno scambio, in parte già realizzatosi nelCinquecento, che vede Bitonto bloccarsi fra i 12000 e i 15000abitanti, ai livelli alti difesi nel corso della crisiseicentesca, e la contigua Terlizzi, che invece dalla crisi èuscita devastata, rastrellare ogni incremento di popolazione finoa giungere a fine Settecento, dopo aver più che raddoppiato leproprie dimensioni nel corso del secolo, a minacciare lapreminenza dell'illustre vicina184.
Una volta aggregati, anche qui i dati compongono comportamentiche hanno una propria coerenza sul lungo periodo. La demografiadelle zone olivicole appare seguire un sentiero intermedio fraquello della provincia di sud-est e quello dell'area cerealicolaspecializzata: essa è più nervosa e reattiva che nelle zone aimargini dei grandi itinerari mercantili, ma, nei confronti dellaMurgia centro-settentrionale, le pendenze delle sue curve sonomeno ripide in salita e in discesa, le fasi d'inversione ritardatee arrotondate. Anche qui per rispondere alla questione al centrodi queste pagine occorre aggrapparsi ad indizi; questisuggeriscono comunque, concordemente, da un lato un rapporto menostretto fra vicende demografiche e vicende produttive delladerrata principale, l'olio, di quello esistente fra demografia eproduzione granaria della Murgia mercantile; dall'altro, una piùpronta capacità di risposta alla domanda monetaria da parte delgrano rispetto a quella dell'olio, ma anche una sua maggiorefragilità al mutare della congiuntura. Nelle zone murgiane centro-settentrionali una produzione mercantile più variabile si scaricacon più immediatezza sui livelli della popolazione, inarcando lecurve demografiche al di sopra e al di sotto di quelle areeolivicole, dove una produzione più stabile ha un rapporto piùmediato con la popolazione.
Anche a guardarne i comportamenti nel tempo, il nostro sistemaregionale restituisce un'immagine complessa, che non invita aconclusioni perentorie. Prima di azzardare qualche risposta allequestioni sul tappeto, occorrerà saperne di più su cause e formedelle dinamiche interne alle articolazioni territoriali, inparticolare di quelle più esposte al mercato e per ciò stesso più
184 Oltre alla bibliografia e alle fonti citate sopra, P. 71, nota i, cfr.GUASSINO, Le nascite a Bari cit.; G. DA MOLIN, Lo sviluppo demografico di Moladi Bari nel Settecento, in« Archivio storico pugliese», 1974, pp. 539-582; -0,MOlfet44 Cit., Pp. 94 Sgg.; A. F. CARDAMONE, La dinamica demografica di Terlizzinel XVIII secolo, in La popolazione italiana nel Settecento, Bologna 198o, PP.335-51
91
'anornale', ed esplorare le possibili interferenze e integrazionifra di esse.
3. L'imprenditore senza innovazione.
Nel mondo murgiano, a differenza, come vedremo, che nellaprovincia olivicola, i nessi che legano produzione e popolazionesembrano assumere, più che la forma consueta dell'interdipendenza,quella di una causalità che discende dalla prima alla seconda. Ilvariare della produzione può essere seguito indipendentemente dalvariare della popolazione, mentre l'andamento di quest'ultimasembra comprensibile solo tenendo ben presente l'andamento dellaprima.
Il comportamento particolarmente mutevole della produzionecerealicola destinata al mercato lontano non può non avere unrapporto stretto con i caratteri fisici di questa coltura: da unlato con la relativa rapidità dei processi di conversione delterreno saldo in seminatorio economicamente produttivo rispetto aitempi lunghi intercorrenti - per fare l'esempio più rilevante nelnostro caso - fra l'impianto dell'oliveto e il suo ingresso nellafase produttiva piena; dall'altro lato con la relativa esiguitàdel lavoro morto incorporato nella terra a grano rispetto allavoro vivo, cosicché la rinuncia alla coltura è relativamentefacile e poco costosa. Ma non è cercando in questa sola direzioneche è possibile trovare spiegazioni esaustive.
La documentazione disponibile indica, per un'agricoltura che,come quella murgiana, non soddisfa bisogni primari ma è mossa daun calcolo economico, un dispiegarsi dei processi di contrazioneed espansione in riferimento a una trama molto più fitta dicondizioni e cause, al centro della quale si situano i soggetti ele procedure della decisione produttiva fondamentale, quellarelativa alla riapertura del ciclo agrario della “massariagrossa”.
Sotto questo profilo l'opposizione fra il mondo della“massaria grossa” e la policoltura contadina autoconsumatrice oproduttrice per mercati vicini è assoluta. Nella seconda la decisione sulla riapertura del cicloproduttivo è 'democraticamente' esercitata da una miriade dicontadini in possesso perenne o temporaneo dei mezzi diproduzione, ma resa in un certo senso fittizia dal fatto che, senon producessero, essi non avrebbero di che vivere; così l'alternavicenda dell'agricoltura non risponde a valutazioni economiche ma
92
al reciproco condizionarsi di risorse umane e naturali. Nellacerealicoltura specializzata murgiana, al contrario, la decisionesull'entrata in funzione della
masseria, cioè su una porzione rilevantissima della produzionesociale, è nelle mani di una oligarchia ristretta di lavoratoriagricoli, i massari, in possesso di risorse sufficienti incapitali e terre, animali e attrezzi, per poterla esercitare senzala costrizione del bisogno immediato, sulla base delle prospettivedi redditività dell'investimento elaborate nel confronto con unmercato vasto e ampiamente monetizzato.
Il massaro è certo una figura enigmatica, di difficilecollocazione nelle partizioni sociali canoniche. La stessalocuzione è semanticamente incerta, e la si può trovare attribuitaa semplici contadini o ad esponenti dei gruppi dominanti cheentrano in rapporto con la masseria di proprietà altrui nel quadrodi complesse strategie economiche - la si prende in fitto persubaffittarla, si costituiscono società di capitali coiconduttori, si tenta di mantenere per periodi lunghi la titolaritàdella locazione per poter affermare diritti sui beni locati... Ingenere, comunque, dietro le complicazioni pattizie, èindividuabile un conduttore diretto che acquisisce l'usotemporaneo di terra e immobili dietro corresponsione di un canonein larga parte monetario: per certi versi, una sorta diimprenditore capitalistico ante litteram.
A guardar meglio, però, non c'è alcun futuro che il massaroriesca a precorrere. In primo luogo gli studi disponibili sullacerealicoltura specializzata meridionale sottolineano una sorta disquilibrio permanente fra la notevole massa di capitali occorrenteal funzionamento della masseria e la pur sempre limitatadisponibilità di risorse del massaro, il quale, quando gli riescedi arricchirsi per davvero, cerca di lacerare il rapporto collavoro agricolo che lo tiene confinato nel livello basso dellospettro sociale, e di ascendere alla condizione “civile”; diconseguenza egli deve consegnare un pezzo rilevante della propriaautonomia imprenditoriale ai finanziatori, siano essi iproprietari della terra o i protagonisti della circolazione deiprodotti. D'altronde egli viene inchiodato contrattualmente alrispetto di pratiche agronomiche, proporzioni fra le colture,rapporti di lavoro, di un complesso di saggezze georgicheelaborate nei secoli in relazione ai caratteri della società e delpaesaggio agrario. Lungi dal poter combinare e ricombinare i'fattori produttivi', dal rispondere alle sfide proposte dalla
93
congiuntura tramite il mutamento nell'organizzazione e nelletecniche, il massaro è in un certo senso la vestale dellepermanenze, il garante dei vincoli entro i quali l'interagiredegli uomini con un ambiente infelice è risultato in una qualchemisura proficuo. Di conseguenza egli vive stretto in unacontraddizione insolubile: da un lato l'esito della produzione èreso tanto più variabile in quanto al succedersi delle annateagrarie buone e cattive si intrecciano le bizzarrie del mercatomonetario nel quale la masseria è immersa; dall'altro il massaro èpressoché del tutto disarmato, privo di margini di manovraconsistenti: la scadenza breve del contratto di locazione dimasserie riflette non solo l'interesse del proprietario adadeguare alla congiuntura il canone, ma anche l'esigenza delmassaro di usare, senza essere penalizzato, il “rifiuto dellecolture” come un normale strumento di vita economica. Certo, nonrinnovare il contratto alla scadenza in una congiuntura avversa,per il massaro può significare dover liquidare a prezzirovinosamente bassi capitali da lui immobilizzati in attrezzaturee derrate, e viceversa, la decisione di intraprendere laproduzione nelle fasi positive sottoscrivendo un contratto dilocazione, può essere ritardata dalla ricerca delle risorsefinanziarie che garantiscano il locatore e permettano ilfunzionamento della masseria. Si tratta, comunque, di fattori diinerzia di importanza limitata. In generale il mutare delleconvenienze determina senza mediazioni le decisioni del massaro,che si limita a registrare passivamente alti e bassi dellacongiuntura e a ritrasmetterli nella produzione, alimentando, aseconda dei casi, crescita e crisi. E' dunque, in ultima istanza,nell'andamento delle convenienze con le quali egli si misura cheva cercata la ragione delle impennate e delle cadute dellacerealicoltura murgiana.
Secondo il nostro schema iniziale, il livello della domandanapoletana e internazionale di grano è fattore certo determinanteanche se, come vedremo, non unico; ma qui le complicazioni sipresentano immediate, dato che il prezzo del grano è, più che ognialtro prezzo, misura grossolana e approssimativa delle convenienzea produrre.
Il mercato cerealicolo di antico regime, ingombro di politica,di istituzioni, vincolato da lacci e laccioli più di tutti glialtri, presenta comportamenti spesso paradossali. Nelle fasi incui la domanda è debole, i prezzi bassi, le tensioni sul mercatocontenute e, di conseguenza, l'interventismo amministrativo
94
limitato, spesso la fluidità della circolazione è maggiore, piùalta la facilità di realizzazione per i produttori e minori icosti finanziari; al contrario, al crescere della domanda e deiprezzi, l'interventismo statale si fa pesante, l'incertezza dellarealizzazione diventa acuta, la taglia pagata per leintermediazioni finanziarie pesa sui conti aziendali propriomentre l'estendersi delle colture a terreni meno produttivi e iringrani provocano l'insorgere della “stanchezza della terra”. E'il nodo delle politiche annonarie che, a partire dal secondoCinquecento, si fanno ovunque soffocanti e hanno un impattoviolento soprattutto in aree di cerealicoltura specializzata comela nostra, nelle quali si rivela in tutta la sua contraddittorietàil tentativo di massimizzare la disponibilità di un prodotto inlarga parte monetizzato, a prescindere dalla redditività monetariadelle aziende produttrici: una forma di intervento capace difunzionare quando i problemi sono di dimensione contenuta, cioèquando essa è relativamente inutile, controproducente quando lacrisi monta. Nel quadro vivacissimo presentato da Silvio Zottadella crisi dei decenni fra Cinque e Seicento vista da un'areacontigua a quella della Murgia interna, il “far con la forza ognicosa”185 dei governanti provoca una frantumazione del mercato,determina incertezza, appesantisce la speculazione ai danni dellaproduzione, spinge in ultima istanza i massari verso un precoce“rifiuto delle colture” anche di fronte a una domanda spasmodica.L'allentarsi del vincolismo pastorale, i dissodamenti leciti eilleciti delle terre della Dogana che accompagnano in Puglial'appesantimento dell'interventismo annonario, come per attutirnegli effetti perversi richiamando alla produzione terre fresche dipiù alta produttività, rimandano il precipitare della situazionenel mentre - come abbiamo visto - ridisegnano la gerarchia dellearee cerealicole provinciali a favore di quelle settentrionali; mai nodi, con questo, non sono sciolti e non tardano a venire alpettine. Insomma, i prezzi bassi dei punti di svolta inferiori delciclo possono non essere un disincentivo ad avviare la produzione;i prezzi alti delle fasi a ridosso dei punti di svolta superiorispesso non riescono a impedire l'abbandono della produzione. Ilmassaro misura le sue convenienze in base ad aspettative, equando il futuro si presenta confuso e incerto, il mercatoilleggibile, l'induzione all'investimento è drasticamenteindebolita.
185 Da una relazione di uno degli amministratori dello «stato » feudale di Melfidel 1589 (ZOTTA, Momenti e problemi cit., P. 788).
95
Ma naturalmente pesa su queste scelte, e le modifica nel tempoanche a fronte di congiunture simili della domanda, il latodell'offerta, la disponibilità e il costo dei 'fattoriproduttivi', il cui spazio di mercato, attentamente sorvegliatonelle società di antico regime al fine di ottenere prezzi giusti',si presenta in un'area come la nostra particolarmente dilatato,tende a forzare limiti e divieti consuetudinari, canonici,amministrativi, rispondendo agli impulsi delle grandezzeeconomiche in gioco.
In primo luogo il mercato dei capitali, sul piano dellevicende e delle figure sociali strettamente connesso ai nodi delmercato del grano e alle forme complesse che la domanda vi assume,ha un'importanza assolutamente decisiva per la produzionecerealicola. In generale in esso si incrociano, da un lato, ladomanda di mezzi finanziari generata di continuo dal lo squilibriofra la consistenza patrimoniale del massaro e le dimensioni delcapitale circolante richiesto dal funzionamento normale dellamasseria e dalla variabilità della produzione e delle condizionidi realizzazione di mercato; dall'altro la carenza di mezzi dipagamento in loco determinata dalla collocazione della provincianegli equilibri complessivi del Regno, dal drenaggio di risorsefinanziarie verso l'estero e in particolare verso Napoli, a causadel concentrarvisi dell'apparato direzionale del commercio ingrande, di quello fiscale, della spesa opulenta dei baroni. Laquestione sempre risorgente e riproposta con forza daicontemporanei186 sarà quella della chiusura di questo circolo: dicome far sì che i capitali esteri e napoletani tornino adisposizione dei produttori provinciali a condizioni tali cherisulti loro conveniente reinvestirli; di come riequilibrare itassi d'interesse provinciali con quelli più bassi prevalenti aNapoli187.
Per quanto riguarda in particolare il circuito dei cereali, ilfinanziamento della produzione pugliese sembra attraversare unlungo e difficile apprendistato connesso alle vicende dell'annonanapoletana e segnato da sconfitte che hanno - in un certo senso -una funzione pedagogica. La più significativa è quella che provocal'arresto e poi l'arretramento produttivo dei decenni a cavallofra Cinquecento e Seicento: in una situazione generale di fuga di
186 Cfr. GALANTI, Della descrizione geografica cit., VOI. II, Pp. 211 -12; perPalmieri e Spiriti cfr. Chorley, Oil cit ., P - 44.187 Cfr. CONIGLIO, Il Viceregno di Napoli cit., pp. 69-70; A. PLACANICA, Monetaprestiti usure nel Mezzogiorno moderno, Napoli 1982
96
capitali dal Regno, svalutazione e diradamento della moneta188, e difronte all'infittirsi di un interventismo annonario che cerca dicompensare i suoi effetti perversi anche con moratorie sui debitidi chi semina, si interrompe il flusso massiccio di capitali diprivati napoletani prestati “alla voce” ai massari che avevanosostenuto l'espansione cinquecentesca, “parte perché [essi] nonvogliono sottomettere li [... 1 denari a moratorie, et parteperché non vogliono grani sugietti a tante pramatiche”189.
Non essendo feudatari e mercanti locali interessati arischiare per “sovvenire a li massari190“, la selezione fra costorosi fa durissima, provocando un mutamento significativo nellasocietà cerealicola che trova spazi nella persistenza di unadomanda che non può vanificarsi fino a quando non verrà saziata lafame di Napoli e quella della popolazione locale. Dopo la cadutadel secondo decennio del secolo, il grano vede migliorare le sueragioni di scambio nei confronti dell'olio, che nella crisi delmercato internazionale non può trovare compensazioni in unadomanda regionale, come si è visto, strutturalmente debole, e le“estrazioni” da Barletta, dirette ormai in larga parte versoNapoli, reggono su livelli notevoli, entrando in tensione con leesigenze annonarie locali: le opportunità non sono del tuttovenute meno, e se la figura del massaro non sembra in grado dicoglierle, tende a farsi largo il feudatario che cerca di estrarrereddito da masserie che non riesce più a fittare gestendole ineconomia, e che aggiunge al grano da lui prodotto quelloconferitogli in forma di decime e terraggi dai contadini degliormai preziosi appezzamenti di piccola agricoltura voltasoprattutto all'autoconsumo. In una fase in cui la domanda non puòessere aspettata, ma va attivamente cercata, in cui occorretrafficare e manovrare per una “tratta” o un “partito”, e unavolta trovato un acquirente non si può far conto su prezzi altineanche se il raccolto è riuscito scarso; “in questi tempi fuor disperanza di guadagni stravaganti”191, solo i baroni possono tentaredi ritagliarsi un margine fra costi e ricavi contendendo ai grandi188 Cfr. L. DE ROSA, I cambi esteri del Regno di Napoli dal 1591 al 1707, Napoli1955, in particolare per il periodo dal 1591 alla rivalutazione del1622, PP. 33-40. Ma cfr. ora, su queste questioni in generale, ID., Il Mezzogiorno spagnolotra crescita e decadenza, Milano1987.189 Dalla stessa relazione del 1589 già citata (ZOTTA, Momenti e problemi cit.,p. 787).190 E' la proposta che fa il tabulario De Marino (Apprezzo cit., p. 64) alfeudatario di Gravina per aumentare il ricavato del terraggio.191 Da una relazione del 1646 sui feudi lucani dei Doria (ZOTTA, Le vicendeagrarie cit., p. 264).
97
mercanti napoletani il controllo dell'intermediazione e dellacommercializzazione.
Ma è una strada senza uscita. Con la crisi degli anni '50 glispiragli si chiudono, le “estrazioni” cadono, le ragioni discambio del grano peggiorano, i baroni trovano nella pastoriziainvestimenti più remunerativi che nella cerealicoltura192.Nettamente ridimensionato il ruolo della domanda napoletana einternazionale, il trend dei prezzi tende a neutralizzarsi e lavariabilità dei prezzi annuali - nelle fasi ascendenti forte versol'alto e debole verso il basso, nelle fasi discendenti viceversa - si fa violentain entrambe le direzioni legandosi all'andamento delle annateagricole. In questo contesto, più che mai, la capacità diautofinanziamento si presenta come un elemento indispensabile pergestire con una qualche possibilità di successo la masseria. Eopinione diffusa - si afferma in una relazione sulle masseriedella casa gesuitica di Castellammare dislocate nella Puglia piana- che questa sia la natura delle terre seminatorie di Puglia,rovinare i poveri et arricchire i ricchi; perché li grani, se leraccolte sono buone, non hanno prezzo, e così con la quantità noneguagliano le spese; e se le raccolte sono scarse la scarsezza degrani, benché abbiano maggiore prezzo, neanche eguaglia la spesafattasi. Onde non può non perdersi e rovinarsi chi semina inPuglia, se non può conservare la raccolta abbondante per queltempo che la scarsezza aggiunge prezzo alli grani e perciò civuole una ricchezza tale, che non sia la persona costretta avendere per coltivare193.
Ma questa condizione è di pochissimi, massari e non, e delresto, se generalizzata, implicherebbe un impossibilerovesciamento della secolare subordinazione della Puglia a Napoli.
Con questa subordinazione la cerealicoltura della nuovaespansione settecentesca, riconsegnata a massari incapaci diautofinanziarsi, sembra imparare in un certo senso a convivere. Inun quadro certo meno difficile e confuso sotto il profilomonetario rispetto a quello fra Cinque e Seicento, l'irrigidimentodei vincoli annonari successivo alla crisi del1756-64 non soffocasubito la crescita produttiva forse anche perché prestatori dicapitali, esportatori ed apparati amministrativi, così comeemergono dall'analisi di Macry194, non agiscono più in ordine sparsoma si legano in un groviglio di connivenze che, se scarica sulla192 Ibid., pp. 268 sgg.193 LEPRE, Feudi e masserie cit., pp. 101-2.194 Mercato e società cit. ,
98
produzione costi finanziari altissimi, tende a garantire ad essauna prospettiva di profitti limitati ma certi - che è poi lacondizione perché i grossi profitti intermediari e speculativicontinuino ad essere estratti. Le difficoltà produttive degli anni'80, a cui si è accennato, sono certo indizio della debolezzapersistente della cerealicoltura mercantilizzata, ma sono di granlunga meno gravi di quelle della fase finale di ascesa dei prezzifra Cinque e Seicento, e la successiva messa a disposizione per lasemina di terre fiscali di pertinenza della Dogana di Foggia - le“poste frattose” censite dal 1789 - contribuisce a rilanciare losviluppo in forme che sottolineano le novità intervenute. “Pochimercadanti - dice in proposito un testimone attento come NataleCimaglia in un testo pubblicato nel 1790 - prendono, e commercianotutte le somme che avvanzano in mano de' nobili, e doviziosiuomini che sono in Napoli”, e da essi “si diffonde per questecontrade un fiume d'oro, perché ciascun pugliese intraprenda sìsmodate seminagioni”195: è in effetti “dalla facilità d'ottenersitali aiuti proporzionati al quantitativo della semina” che“proviene il furore d'estendersi i campi il più che si possa”196.
Alto è però il prezzo da pagare in termini di squilibriindotti da questi processi espansivi nella società cerealicola.Avendo i mercanti “costituiti de' pugliesi cotanti loro gastaldi,e fattori”197 ed avendoli esclusi pressoché completamente dalmomento della circolazione, nel quale essi avevano mantenuto unapresenza risicata ma importante per gli equilibri aziendali,ancora più grande diventa “la facilità di menar alla decozioneogni massaio”198. La risposta possibile di quest'ultimo è allora laricerca affannosa di sovraprofitti da estrarre nel momento dellaproduzione, tramite un'aggressione alle permanenze e coerenzedell'agricoltura secolare del grano che non genera innovazione,ma, al contrario, si esplica in un ridimensionamento degliinvestimenti: “l'industria e la difficoltà della riuscita aguzzanoin molti l'ingegno, in modo che sanno garentirsi in parte dallarovina degli infelici eventi della messe, colla parsimonia de'fondi e delle spese”199. Ed ecco che, nella ricerca micragnosa delrisparmio, il pane per i lavoratori della masseria viene fatto,invece che col frumento, con “scopature dell'aja”200 ed ecco il
195 CIMAGLIA, Della natura e sorte cit., p. 63.196 Ibid., p. 64.197 Ibid., p. 63.198 Ibid., p. 53.199 Ibid.200 Ibid., p- 45I
99
lesinare sulle arature, sulla qualità del seme, sul rinnovo degliattrezzi, nella presunzione “che il buon evento riesca spessouguale, così in coloro che miseramente abbian appena grattuggiatala terra, che in coloro ch'abbian profuso in eseguire esattamenteil canone agreste pugliese”201.
Espansione produttiva e imbarbarimento agronomico siintrecciano annunciando tempi nuovi. L'eutanasia del massaro comefigura centrale dell'agricoltura pugliese e delle permanenze a cuiegli sovrintende è ormai avviata, con esiti che andranno emergendonel corso dell'Ottocento con particolare evidenza in Terra diBari.
Per l'intanto, però, non pare che la nostra provincia abbiapartecipato alla crescita tardo-settecentesca delle superficicoltivate, riproponendo comportamenti in parte già riscontrabilinel secondo Cinquecento. Cicli della domanda, interventismoannonario, politica monetaria, flussi creditizi tendono auniformare le convenienze del massaro murgiano, foggiano ocrotonese, inducendo ovunque un andamento della produzionecerealicola specializzata fatta di impennate e cadute. D'altrocanto, qui la produzione granaria sembra derivare caratteri difragilità più accentuati che altrove dai particolari quadriambientali e dalle coerenze economico-sociali della provincia, lequali finiscono per incidere sulla disponibilità e sul prezzodelle altre due voci di costo fondamentali del massaro, il lavoroe la terra.
Area di poca terra proficuamente arabile rispetto ai moltiuomini disponibili in loco o a portata di mano all'interno delsistema regionale, la Murgia barese dovrebbe essere caratterizzatada bassi salari e rendite elevate, al contrario della vicinaCapitanata di molta terra e uomini radi, rendite basse e salaritenuti alti dalla necessità di compensare la carenza di manodoperalocale con quella forestiera. Non abbiamo serie di salari e dicanoni e prezzi della terra da confrontare con quelli disponibiliper Terra di Bari, che ci permettano di avvalorare letestimonianze dei contemporanei.
Certo, per quanto riguarda il mercato del lavoro, è inCapitanata che si concentrano le tensioni più clamorose - forme disciopero invano represse dalle autorità, semine fuori tempo permancanza di “garzoni”, minacce di rapimento di mietitori perimpiegarli altrove, lievitazioni di salario che richiamanointerventi dall'alto allo scopo di fissarlo al livello “giusto” e
201 Ibid-, p- 53100
“solito”202. Eppure non pare, come si è visto, che i salari unitarialla mietitura siano li più alti che in Terra di Bari. Imeccanismi di compensazione degli svantaggi di chi miete nelTavoliere, che determinano un allungamento del periodo dellaraccolta, possono provocare un qualche ritardo dell'immissione delprodotto sul mercato che può trovare compenso nella maggiorefacilità di trasporto nella Puglia piana rispetto alla Murgia,nella vicinanza di una grande piazza di mercato come Foggia, nellapiù facile raggiungibilità di Napoli via terra. D'altro canto lemasse di avventizi che scendono dalla montagna in Capitanata eriempiono stagionalmente le piazze dei borghi contadini attrattidalla prospettiva di un buon guadagno, ma non sempre con uncontratto di lavoro in tasca e spesso disposti a vendere leproprie braccia per un tozzo di pane, sono certo il segno di unmalessere sociale complessivo che può giungere a pesare sui costiaziendali a causa della loro scarsa specializzazione eaffidabilità; e però, al contempo, essi possono costituire unfattore di flessibilità di grande importanza quando la congiunturapositiva spinge verso l'espansione delle colture. Al contrario inTerra di Bari la condizione di maggiore umanizzazione estanzialità della compagine sociale è conquistata attraverso lacomplementarietà delle colture e delle occasioni lavorative che sirovescia in una sorta di rigidità anche sul piano del mercato dellavoro. L'offerta di braccia, in larga parte provenientedall'interno della provincia stessa, si situa all'incrocio fracalendario cerealicolo, olivicolo e viticolo, e all'interno di unadistribuzione geografica della disponibilità della forza-lavoroche non può essere sconvolta; così, quando l'espansione produttivacomincia a premere su queste coerenze, anche qui la caparra deibracciali può giungere a “un prezzo alteratissimo” e può capitareche molti di essi vengano condannati per non essersi presentati allavoro dopo averla riscossa203.
Incapace di ridurre in maniera sostanziale il costo del lavoroper il massaro, l'umanizzazione incisiva e stabile preme suicanali seminatori stretti fra i dossi rocciosi, ne alza laproduttività ma anche il prezzo, avvicina la fase dei rendimentidecrescenti, situa il rapporto fra uomo e ambiente in unacondizione di tensione perenne al tempo stesso nascosta e202 Cfr., per episodi di questa natura, A. LEPRE, Le campagne pugliesi nell'etàmoderna, in C. D. FONSFCA (a cura di), Civiltà e culture di Puglia, vol. III, LaPuglia tra medioevo ed età moderna. Città e campagna, Milano 1981, PP. 327-28.203 G. MASI, Strutture e società nella Puglia barese del secondo Settecento,Matera 1966, P. 75.
101
sottolineata dall'infinita monotonia del paesaggio. Gli altirendimenti che i massari riescono ad estrarne nelle fasiascendenti iniziali del ciclo determinano un “accorrere allecolture” che esaurisce le superfici coltivabili proficuamente, ele difficoltà mercantili, annonarie, creditizie sorprendonomassari in preda alla tentazione di infrangere il “canone agrestepugliese” ringranando indefinitamente nei canali, altriall'assalto del bosco residuo, altri ancora che vanno risalendo ipendii quasi privi di humus contendendoli alle pecore.
Non è difficile pensare che non potranno a lungo rimanerviaggrappati.
4 - La crisi cerealicola.
Una volta che le colture cominciano a ridiscendere nei canali,ad abbandonare quelli più lontani dalle città, meno profondi, menoumidi, la crisi produttiva si rovescia in crisi demografica, creale condizioni perché un'eventuale crisi epidemica diventidevastante, mette in movimento processi che appaiono piùcomprensibili uscendo da un'analisi delle variabili ordinata percatene causali e centrando lo sguardo sul loro interagire,osservando come l'andamento, i flussi, la struttura dellapopolazione influiscano a loro volta sull'ambiente in cui maturanole scelte produttive.
A causa delle ineguaglianze del calendario agricolo le“massarie grosse”, entrando in produzione, irradiano una domandadi unità lavorative in proporzione ben più alta della domanda digiornate lavorative, la quale tende ad essere soddisfatta tramitel'intreccio fra la crescita della distanza fra natalità emortalità locale, stimolata dalla maggiore disponibilità dirisorse, e un maggior afflusso di migranti stagionali e dimigranti che tendono a diventare definitivi integrando il salariosul latifondo con il lavoro autonomo sui fondi seminativi e vitatidei “distretti” delle città del grano: ne consegue l'impennarsidella demografia tipica delle fasi iniziali di crescita di questearee. Una volta entrate in crisi le masserie, lo stesso meccanismoagisce all'incontrario e la Murgia perde rapidamente abitanti. Lasocietà del grano appare allora un insieme scombinato, incapace,come avviene altrove, di galleggiare sulla crisi mercantile, diconvivere con essa, di cogliere l'occasione che essa offre perridurre la sua dipendenza, per ridimensionare incisivamente lamonetizzazione della produzione e dello scambio, per costruire un
102
rapporto meno aggressivo con l'ambiente.Non che siano qui del tutto assenti forme di risposta e
adattamento alla crisi degli scambi di raggio lungo del tipo diquelli individuati da Gérard Delille per la Valle Caudina204. Siconsideri l'andamento dei salari e del valore di mercato dellaterra nel Seicento. Per quanto riguarda i primi205 sembra prevaleresul lungo periodo, in Terra di Bari come altrove, una notevolerigidità dei salari nominali che si traduce in una caduta deisalari reali quando i prezzi si inerpicano, in una lororivalutazione quando i prezzi, come nel Seicento, cadono. Laflessibilità dei salari nel periodo breve in risposta allacongiuntura mercantile e la capacità dei bracciali di utilizzarele occasioni in cui i rapporti di forza sono spostati in lorofavore per accrescerli - in particolare alla mietitura, le cuiretribuzioni, anche perché in buona parte in natura, sembranomolto meglio difese dall'inflazione - rendono poco credibiliinterpretazioni del fenomeno in termini di vischiosità, di'illusione monetaria' coniugata al prestigio del prezzoconsuetudinario che premierebbe i ceti volta a volta schierati insua difesa, e ci riporta all'andamento delle grandi variabili ealle loro interconnessioni. Se crisi della masseria e crisidemografica sono fenomeni connessi, la curva discendente dellapopolazione non coincide con la curva discendente dell'offerta dibraccia dal momento che la pendenza di quest'ultima è resa piùaccentuata dal tentativo dei contadini di rispondere allacongiuntura costruendo sui loro minifondi un'agricoltura inrapporto più immediato con i propri bisogni, meno specializzata emonetizzata: una percentuale minore del diminuito numero dilavoratori agricoli offre braccia su un mercato che, come abbiamovisto, almeno fino alla catastrofe epidemica di metà secolo,continua in qualche modo a funzionare e, in particolare neimomenti acuti del calendario agricolo, finisce per chiederne,dipiù di quelle disponibili, spingendo in su il salario medio intermini reali nel mentre, a causa della despecializzazione, isalari pagati per le prestazioni più qualificate scendonoridimensionando decisamente il ventaglio delle retribuzioni. Alcontempo il mutato equilibrio nel bilancio familiare contadino frail reddito del lavoro in proprio e quello del lavoro in contoterzi - quest'ultimo in diminuzione complessiva anche se crescente204 G. DELILLE, Croissance d'une société rurale. Montesarchio et la Valle Caudineaux XVII et XVIII siècles, Napoli 1973.205 Cfr. in proposito, oltre alla bibliografia citata alle pp. 61-62, nota 3, leconsiderazioni generali svolte in PALUMBO, Appunti cit., pp. 243 sgg.
103
in valore unitario fino agli anni '50, e poi duramente colpitodall'andamento discendente dei salari dopo la crisi epidemica e laconseguente disorganizzazione del circuito del grano destinato amercati lontani - annulla l'effetto della minore pressione dellapopolazione sulla terra disponibile e provoca una domandamassiccia di minifondi, il cui andamento di mercato diventa,significativamente, opposto a quello delle masserie: a Gravina,nella prima metà del secolo, i fitti delle masserie precipitanofino quasi a un terzo del valore iniziale, mentre il valoreunitario dei piccoli appezzamenti a vigneto oscilla senza caduteconsistenti e quello del seminatorio aumenta nettamente fino agiungere, negli anni '70, al doppio del valore del primo decenniodel secolo in termini nominali206.
Ma questi non sono segnali di un ricomporsi della società informe nuove, secondo nuove coerenze dettate dalla nuovasituazione; semmai di un processo di complessivadisorganizzazione. Il nodo attorno a cui si affaticherannoriformatori e agronomi sette-ottocenteschi, quello della rigiditàeconomico-sociale e agronomica dell'ambiente della cerealicolturaspecializzata pugliese, appare insolubile. Un paesaggio agrario avocazioni così forti e antiche e, al tempo stesso, cosìdolorosamente segnato da una umanizzazione aggressiva, una societàrurale così articolata e saldamente strutturata attorno alladomanda esterna di una sola derrata, non ha modo e tempo perriconvertirsi quando vien meno la convenienza a produrre ingrande. La distruzione di risorse che accompagna la crisi dellamasseria non consente alla compagine sociale investimentisufficienti a ingigantire il “ristretto” e trasformareun'agricoltura di latifondo in una policoltura contadina; iminifondi seminati e vitati continuano a rimanere troppo piccoliper tendere a un'autonomia aziendale e spargere per i campil'insediamento accorpatosi nei grandi borghi; il cresceredell'importanza relativa dei minifondi stessi non è in sintonia, aguardare i pochi dati disponibili207, con una modificazione206 Cfr. MASELLA, Appunti cit., p. 140; ID., Mercato fondiario Cit., P. 279.207Mancano studi sulla modificazione dei quozienti sul lungo periodo. Qualcheindicazione su centri murgiani in DA MOLIN, La mortalità cit., in particolarePP. 47 sgg. Elementi più consistenti si hanno per altre aree della provincia,dove pure il fenomeno della rigidità dei tassi di natalità e nuzialità sul lungoperiodo sembra riproporsi: cfr., oltre alla bibliografia citata a p. 82, nota12, G. CHIASSINO e altri, I matrimoni a Bari dalla metà del XVI secoloall'Unificazione del Regno d'Italia, quaderno n.15 di « Studi di Demografia »,della cattedra di Demografia dell'Università di Bari,1978; S. DISTASO, L4ripresa demografica del '700: l'esperienza di Putignano (Bari), in La
104
significativa dei meccanismi demografici elementari e dellestrutture familiari, in particolare col ritardo dell'età almatrimonio fino all'acquisizione del possesso fondiario; ilrapporto con la terra rimane scarsamente simbolico, essenzialmentestrumentale, mercantile, fondato su una gamma ristretta di usi eprodotti gestiti da lavoro in larga parte maschile.
Neanche gli altri settori sembrano funzionare in sensoanticiclico, cogliendo occasioni offerte dalla crisi. Non ci sonoqui segnali significativi del diffondersi, come in altre areemeridionali, della manifattura rurale208, né del rafforzarsi delcommercio a distanza breve, che risulta invece colpitodall'indebolirsi della divisione del lavoro fra aree subregionaliparallelo all'incepparsi della produzione specializzata perl'esportazione.
La stessa pastorizia, durissimamente segnata dalla strage dipecore dell'inverno 1611-12209, finisce per rendere ancora più gravela recessione determinata dal crollo della cerealicoltura. Solo lacarenza generalizzata di manodopera determinata dall'epidemia del1656, incontrandosi con un deciso miglioramento dei rapporti discambio della lana rispetto al grano, sembra provocare, come si èvisto, una riconversione consistente di capitali ecclesiastici efeudali dalla masseria di grano alla masseria di pecore, che varioccupando i canali seminatoriali abbandonati dai contadini, siincunea verso il mare, cerca di rispondere all'andamentorelativamente favorevole del prezzo della lana introducendoaccanto alle pecore comuni quelle “gentili”. Ma, in un ambienteostile nel quale occorre quasi un ettaro per nutrire una pecora ele epizoozie continuano ad incombere210, in assenza di iniziative'protoindustriali' consistenti che trasformino in loco il prodottogrezzo e vi aggiungano valore assorbendo lavoro in più rispetto aquel poco che l'allevamento richiede, la capacità del settore disvolgere una funzione di compensazione della crisi agraria appare
popolazione italiana nel Settecento cit., PP. 301-12; A. F. CARDAMONE, Il CicloStagionale dei matrimoni, delle nascite e dei decessi a Bitonto dal 1661 al1800, in E. SORI (a cura di), Demografia storica, Bologna 1975, pp. 227-36. 208 Cfr., ad esempio, M. AYMARD, Commerce et consommation des draps en Sicilieet en Izalie méridionale (XVe-XVIIIe siècles), in M. SPALLANZANI (a cura di),Produzione, commercio e consumo dei panni di lana (nei secoli XII-XVIII),Firenze 1976, pp. 127-39- Il caso speculare sarebbe naturalmente la Lombardia diDomenico Sella.209 Su queste questioni cfr. ancora MARINO, Pastoral Economics cit.210 Cfr., per quella del 1687, MASI, Altamura farnesiana cit., pp. 214-15 e D.NARDONE, Notizie storiche sulla città di Gravina dalle sue origini all'unitàitaliana, Bari 1941', pp. 241-44
105
limitata.A parte l'incidenza relativamente minore della pastorizia
sugli equilibri economici e sociali, il sentiero anticiclicoseguito nel secondo Seicento non sembra rispondere a una funzionedi questo comparto legata alle sue caratteristiche strutturali;anzi, sul lungo periodo, esso ha un andamento quanto meno noncontraddittorio nei confronti dei grandi cicli dell'economiadeterminati dalle vicende della produzione agricola.1a pastoriziainquadrata nella Dogana di Foggia, che riguarda solo una partedella Murgia ed è gestita soprattutto da pastori della montagna,ma può fornirci elementi significativi sotto il profilo che quiinteressa, non sembra incontrare, nel corso del boom cerealicolocinquecentesco, difficoltà produttive e può espandersitumultuosamente saturando le terre fiscali e soddisfacendo ladomanda di lana senza provocare tensioni sui prezzi, fino aquando, seguendo da vicino la crisi cerealicola, l'epizoozia del1611 - 12 a cui si è accennato non apre una fase di bassi livelliproduttivi ed utilizzazione scarsa delle risorse. Ancora nelSettecento, dove si diffonde la “furia di coltivare” sembraaffermarsi assieme una “furia di pascolare”: poste. locazioni ederbaggi liberi tornano a riempirsi di pecore abruzzesi e localifino al limite della capacità fisica del suolo, e se nella Pugliapiana lo sviluppo parallelo di pastorizia e cerealicoltura checoncorrono per la disponibilità degli stessi terreni finisce perprovocare tensioni e polemiche fra pastori e agricoltori,nell'ambiente murgiano, che distingue nettamente le terreseminatorie dei canali da quelle non seminabili dei dossi, i duesettori possono crescere senza interferenze e sviluppare, loabbiamo visto, sinergie elementari con lo scambio di letame daconcime e paglia. D'altro canto a Gravina, di fronte aun'agricoltura che non riesce a risalire la china dopo la crisidi primo Seicento e porta ancora nell'onciario segni evidenti dimarginalizzazione e difficoltà, la pastorizia non porta sollievo:le pecore, che nel primo Seicento erano 35000 circa, esclusequelle degli enti ecclesiastici, si sono ridotte nel 1739 a circa30000, incluse le proprietà ecclesiastiche, e dopo la moria del1745 si riducono alle 20685 registrate nel catasto carolino211.Allevamento ovino e agricoltura del grano seguono ritmi econgiunture proprie, ma sul lungo periodo crescono e cadonoassieme.
211 DE MARINO, Apprezzo cit., P. 33; As Foggia, f. Dogana, b. 20, fs. 3969;SQUEO, Società civile cit.
106
Così la crisi non riesce a trovare compensazioni e finisce peressere elementare, semplicemente distruttiva anche sotto ilprofilo demografico. Avida di uomini allorché la “massaria grossa”entra in piena attività, la Murgia cerealicola, quando laproduzione in grande arretra, offre scarsi margini a cui lapopolazione possa aggrapparsi. Ai primi annunci di difficoltà, nelmentre il “rifiuto delle colture” da parte dei massari riduce ilprodotto complessivo disponibile, e gli interessi, le istituzioni,le strutture mercantili che si raccolgono attorno al commercio alunga distanza ne incanalano verso i porti di “estrazione” unaparte notevole sottraendola al consumo locale, la popolazione,spinta dalla precarietà della situazione annonaria, sembra entrarein una fase di mobilità acuta e confusa, e può capitare che uncentro come Altamura si riempia di “huomini di fuori” che tentanodi conquistare un frammento della pur sempre notevole quantità digrano circolante collocandosi fisicamente più vicini ai luoghi diproduzione212. Ma le cose spingono in una direzione opposta. Lariduzione delle occasioni di lavoro blocca il fenomeno diconversione dell'emigrazione stagionale verso le terre del granoin emigrazione stabile, e rimpatriano quei forestieri che non vihanno ancora messo radici, sviluppato un senso di appartenenza,legami ed alleanze sociali. D'altro canto questi fenomeni, pursignificativi, sono di gran lunga meno rilevanti che inCapitanata, e la popolazione rimasta è sovradimensionata rispettoal nuovo livello di risorse disponibili, cosicché la distanza franatalità e mortalità deve ridursi e si creano occasioni e spaziperché le epidemie infieriscano.
Non riuscendo la società a ricombinarsi in forme nuove, nonresta che attendere che la crisi faccia il suo corso e siripresentino le occasioni e il clima propizio per il recuperodelle vecchie.
5. Forme della crisi e limiti della crescita nell'area olivicola.
Una quota di contadini olivicoli emigrati nelle città delgrano, quando la domanda di lavoro del latifondo comincia a farsifiacca e incerta, torna sulla costa contribuendo a prolungare lacrescita demografica dei grandi centri oleari per qualche decenniodopo il blocco e la crisi dei centri cerealicoli.
Nel determinare queste migrazioni di ritorno, accanto al
212 Masi, Altamura farnesiana cit., pp. 143-44.107
fattore di spinta' del venir meno della domanda di lavorosalariato sulla Murgia, agiscono anche fattori di 'tiro'. Chitorna sulla costa vi trova giunti in piena produzione gli olivipiantati vent'anni prima, quando la domanda vigorosa del mercatointernazionale prospettava un futuro roseo; un prodotto il cuiprezzo non punta più senza incertezze verso l'alto, come nelCinquecento pieno, ma che migliora le proprie ragioni di scambiocol grano dopo una prolungata fase di peggioramento; un ambienteagronomico più elastico di quello del grano, forzabilenell'immediato in varie direzioni, in particolare con l'uso delsuolo sotto gli alberi per colture schermate dall'impatto delmercato perché autoconsumate o destinate a un circuito breve.D'altronde, essendo qui la decisione sulla riapertura del cicloproduttivo, al contrario che nella Murgia cerealicola, nelle manidi una maggioranza di produttori e esercitata sotto l'impulso,nella gran parte dei casi, del bisogno immediato - il piccolocontadino gestisce la sua microazienda per integrare il salario,non perché abbia speranza di accumulare - i margini di elasticitàdel paesaggio tendono ad essere sfruttati fino in fondo. Ed anchedove una più antica ed intensa specializzazione non permetteforzature ulteriori, una certa maggiore elasticità dell'economianel suo complesso permette in qualche modo di rinvenire ai marginidell'agricoltura - nei piccoli traffici, nel mare, nei servizi -risorse per braccia e bocche aggiuntive: a Molfetta, nonostantegià dal 1558 siano “mancate generalmente le entrate delle olivenel territorio” e la crisi si approfondisca fra il 1585 e il1592213, le nascite continuano a crescere raggiungendo una cuspidenegli anni '30 del Seicento, e a Bari solo negli anni '40 il trenddelle nascite si inverte214.
Ma, come vedremo, anche l'articolazione sociale dei centricostieri ha margini contenuti e la loro economia rimane sempresaldamente ancorata all'agricoltura specializzata. D'altronde, learee che producono per il mercato nell'ambito del nostro sistemaregionale presentano un grado notevole di interdipendenza, e diconseguenza la libertà reciproca dei comportamenti economici edemografici di ciascuna di esse, ha limiti precisi.
A guardar meglio, i decenni nei quali i trend produttivi edemografici olivicoli continuano a tendere verso l'alto dopol'inversione di quelli cerealicoli appaiono un'appendice dellafase di crescita, carica di tensioni e contraddizioni che
213 TULLIO, Molfetta Cit., P. 57, nota.214 Ibid., tab. pp. 96-97; CHIASSINO, Le nascite a Bari cit.
108
preparano la caduta. La precoce crisi della cerealicoltura provocauna diminuzione della massa salariale trasferita dalla Murgia allacosta, in particolare alla mietitura, da distribuire fra un numeroancora crescente di famiglie contadine, e ne mette in discussionegli equilibri economici, inducendole a tentare di ingrandire, acompensazione, le altre due voci di reddito, quelle estratte daicampi olivetati. Ma gli effetti sono perversi. La crescitadell'offerta di braccia in conto terzi si a più che proporzionalealla crescita demografica e spinge verso il basso il salariounitario olivicolo in termini reali, mentre la domanda diminifondi si fa spasmodica, canoni e prezzi della terra, risorsasulla costa ancora più scarsa che nell'interno, crescono a unpasso più rapido dei prezzi della derrata commercializzata, e diconseguenza si riduce ulteriormente la dimensione dell'aziendagestibile dalla famiglia contadina e dei redditi da essaricavabili215.
Anche l'altra fondamentale voce di costo del contadino, ilcapitale, si appesantisce nonostante i vincoli canonici che,impedendone il libero movimento e financo il riconoscimento cometale del tasso di interesse, tentano in una qualche maniera dischermare le transazioni finanziarie dagli influssi di un mercatopesantemente squilibrato a favore dei possessori di contante. Nonche sia da sottovalutare - e studi recenti sottolineano con forzaquesto punto216 - l'efficacia dell'intervento istituzionale inquesto ambito. A parte le attività assistenziali e caritativedirettamente gestite dalla Chiesa o da istituti come monti dipegni, di maritaggio e simili, che in un'economia di piccoleaziende sono difficilmente separabili dalle attività propriamentecreditizie nel determinare gli esiti della produzione, ilcontratto “alla voce”, importantissimo nella fase di primacentralizzazione del sovrappiù dei minifondi, affidando la
215 Qualche indicazione su queste questioni è ricavabile dai vecchi lavori diMASSA (del quale cfr. in particolare Salari agricoli cit.; La vita privata inBari nel secolo XVI, in « Atti dell'Accademia Pontaniana », a. XXXVII, memorian. 4, Napoli 1907, in particolare i dati a p. 11, che vanno confrontati conquelli forniti dallo stesso in Bari nel secolo XVII cit., tab. pp. 96-97).216 Cfr., in particolare, PALUMBO, Vicende agrarie ed organizzazioneecclesiastica cit.; ID., Le relazioni per le visite «ad limina» dei vescovimolfettesi dalla fine del Cinquecento agli inizi dell'Ottocento, in « Archiviostorico pugliese », 1976, pp. 137-61; ID., Aspetti dell'attività creditizia inTerra di Bari nei secoli XVII e XVIII, in «Revue internationale d'histoire de labanque», 1975, PP. 42-58. Su queste questioni cfr. anche MASSA, La vita privataa Bari cit., in particolare pp. 5-6; nonché G. DE GENNARO, Studi di storiacreditizia pugliese dal Medioevo all'età moderna, Milano 1972.
109
fissazione del prezzo di solito all'università sottrae iproduttori al temuto confronto diretto coi creditori tipico delcontratto “a prezzo fissato”, che misura spietatamente i rapportidi forza sul mercato; e anche nel campo del credito a lungotermine, che però riguarda in questa fase una piccola minoranzadei produttori diretti e una porzione invece considerevole deiceti intermedi ed alti, indubbia è l'influenza calmieratrice dei“censi bollari”, sia per la grande quantità di risorse messe incampo dalla Chiesa in questa forma, sia perché forme creditiziediverse e meno favorevoli al prenditore rischiano di ricaderenella casistica ampia dell'usura. Ma, come si sa bene, quando ilcontante scarseggia mille sono le forme nelle quali si celanopatti usurai sfuggendo alla rete protettiva istituzionale - dallastipula di società ai patti agrari, assicurativi e via dicendo - egli stessi contratti sottoscritti alla luce del sole finiscono perrisentire dei disordini monetari e della crisi, di mercato ecreditizia insieme, di cui è vittima la cerealicoltura fra Cinquee Seicento: man mano che ci si avvicina a quei decenni crucialil'interesse pagato sui “censi bollari” preme sul limite canonicodel io per cento e le autorità ecclesiastiche devono darsi da fareper impedire che venga travolto, e i contratti “alla voce”, comesempre avviene quando l'incertezza monetaria e commercialeamplifica l'instabilità stagionale dei prezzi, tendono a diventareiugulatori.
Di fronte al costo crescente del capitale e della terra, ealla riduzione del salario in termini reali, che, lungi dalportare sollievo a un'agricoltura consumatrice soprattutto dilavoro autonomo, contribuisce a sbilanciare i conti delle famigliedei produttori, questi ultimi, costretti a riaprire comunque ilciclo produttivo per procurarsi da vivere, sollecitanoeccessivamente i minifondi, li aggrediscono con pratiche di rapinaquando di proprietà ecclesiastica, quando di loro proprietà liinfoltiscono eccessivamente di alberi intensificando al contempola semina sotto di essi, fino a provocare, in concorrenza coimutamenti climatici, la “stanchezza della terra”, il rifittirsidelle annate “penuriose” che fa scivolare il prodotto dallacadenza biennale a quella triennale. Così l'inversione del trenddella domanda internazionale di olio, che finalmente concludel'andamento alternante dei primi decenni del Seicento, trova lasocietà costiera assediata da difficoltà gravi e faprecipitare lacrisi insieme produttiva e demografica.
Nella crisi l'oliveto tende, più che ad arretrare, a
110
imbarbarirsi217. Il rapporto fra l'importanza delle colture del“suolo” e quelle del “soprasuolo” si sposta a favore delle prime,il ruolo degli alberi si indebolisce rispetto a quello dei cerealiche vi crescono sotto, ed essi si vanno diradando per le cure menoassidue, le mancate sostituzioni, una potatura che punta allalegna da ardere più che al rinvigorimento della pianta. Ilmicrofondo olivetato, Strutturato in funzione del mercatointernazionale, tende a diventare un innaturale, scomodo,deprezzato strumento di economia di sussistenza che non regge piùil confronto coi microfondi originariamente destinati allaproduzione per l'autoconsumo e i mercati locali, anche perché lacaduta del prezzo dell'olio, non frenata da un mercato internoconsistente come quello cerealicolo, fa precipitare le ragioni discambio olio-grano fino a quando la crisi epidemica di metà secoloprovoca un vuoto di domanda di grano e la domanda internazionaleolearia comincia timidamente a riprendersi. Dopo aver raggiuntovalori altissimi, a Bari l'oliveto va precipitando fino a toccare,negli anni '90, un sesto del valore locativo del primo Seicento; aPolignano nel corso del secolo esso perde i due terzi del suovalore fondiario, e se a Molfetta scende solo del 40-50 per centoa causa della difficoltà degli enti ecclesiastici di trovareinvestimenti alternativi e in mancanza di spazi consistenti dadestinare a colture diverse nell'agro, i canoni di fitto siriducono nello stesso torno di tempo a meno di un terzo. Nelcontempo valori e canoni di mini-fondi vitati e seminatoriali diBari non scendono al di là della metà del livello del primoSeicento218.
Neanche in questo caso le trasformazioni su descritteannunziano una conversione verso un'agricoltura contadina'normale', centrata sull'autoconsumo e lo scambio breve e sustrutture antropologiche e insediative adeguate. Il Seicentobarese restituitoci dalle cronache contemporanee vive in un climacupo e disperato, segnato dalla fatica del vivere quotidiano.dalla fame di massa, dall'inseguimento affannoso da parte degliamministratori delle esigenze elementari non soddisfatte,dall'imbarbarimento della produzione e dello scambio, di cuifiniscono per essere emblematiche le formule ossessivamenteripetitive e sinistre che si insinuano negli atti notarili - “inhis temporibus penuriosis, egestosibus, sterilibus, caristosis,tani calamitosis et extremis, ob penuriam presentium temporum, ob217 Cfr. PALUMBO, L'olivicoltura a Molfetta nel secolo XVII cit.218 Cfr. MASSA, Bari nel secolo XVII cit., tab. pp. 96 e 97; MASELLA, mercatofondiario Cit., P. 287; PALUMBO, L'olivicoltura a Molfetta cit., tab. P, 43
111
inopiam temporum et pecuniarum, stante anni sterilitate...”219. Inquesto contesto la relativa inerzia dei quozienti demografici edell'antropologia che li presuppone e li spiega è, in una qualchemisura, piuttosto che il segno di una certa capacità digalleggiare sulla crisi, espressione della difficoltà grave diadattamento di questo mondo alle condizioni nuove, e ilconseguente effetto di freno, in assenza di episodi epidemicigeneralizzati e catastrofici come quello del 1656 della Murgiasettentrionale, sulla caduta della popolazione accentua lascarsezza delle risorse e ammassa dentro le mura delle cittàolivicole settori di società senza radici, che non emigra perchénon saprebbe dove andare data la crisi contestuale dellacerealicoltura. E però, quando già nell'ultimo Seicento lacerealicoltura di Capitanata si riprende, là si recano a“colonie”220 i contadini che si lasciano dietro le spalle glioliveti devastati di Molfetta e Bisceglie.
La ripresa settecentesca rimette in sintonia strutturedemografiche e situazione economica, cosicché crescita dellaproduzione e crescita della popolazione tornano ad alimentarsi avicenda, si ripristinano le cuciture del sistema regionale, lecurve riprendono la forma che ci è familiare, in generale diangolo maggiore quelle demografiche delle città del grano ancheper il limitato ma incisivo contributo migratorio da parte dellecittà dell'olio; il tutto entro i limiti segnalati dalle cifreglobali già riferite, che indicano una crescita fortementeselettiva in entrambe le aree mercantilizzate e un rallentamentoanticipato, così come nel Cinquecento, in quella cerealicola.
Rispetto alla prima età moderna, naturalmente, le differenzesono notevoli anche in un disegno per grandi linee come quello quiproposto. Se il Cinquecento era stato il secolo del grano e dellesue città, il Settecento è il secolo dell'olio, che vedemigliorare le sue ragioni di scambio con le altre merciprincipali. La situazione del mercato dei capitali sembraconfermarlo. Così come viene alla luce nei catasti onciari e negliatti notarili settecenteschi, esso ha un volto profondamentediverso rispetto a quello della prima età moderna, in un quadro alquale non può certo essere estranea la maggiore scorrevolezzadella circolazione dei capitali fra Napoli e la Puglia219 Cfr. gli atti notarili in appendice a MASSA, Bari nel secolo XVII, inparticolare PP. 36-42.220 P. SARNELLI, Memorie de' vescovi di Bisceglia---, Napoli 1693, P. 111. Per lemigrazioni da Molfetta nello stesso torno di tempo cfr. TULLIO, Molfetta cit.,pp. 63-64.
112
cerealicola, ma che è segnato in particolare - lo si vedrà piùavanti - dal farsi largo, all'interno della 'dipendenza di etàmoderna' della provincia, di una capacità di trattenere in locouna porzione importante dell'intermediazione mercantile olearia,dall'emergere nei centri costieri di figure di banchieriprovinciali di raggio ben più ampio della solita democrazia diprestatori di paesi agenti negli interstizi non occupati dalleistituzioni ecclesiastiche. Se nel catasto cinquecentesco diMolfetta e in quelli di Bari e Monopoli di primo Seicento ilpossesso contadino è sostanzialmente libero da censi di naturabollare221, nel Settecento i censi bollari riguardano una porzionemolto varia a seconda dei centri, ma in generale molto consistentedella proprietà contadina, configurando una condizione di fervore,di mobilità, di scommessa sul futuro nel mondo deimicroproduttori. Il debito ipotecario è certo un onere, ma altempo stesso una conquista di questi ceti, moltiplica per essi lepossibilità di accesso alla terra222 permette di configurarestrategie più flessibili del solito alternarsi di cessioni delpossesso nelle congiunture personali o generali avverse e acquistoin quelle favorevoli; tanto più che, qui come altrove, l'interessea metà Settecento si presenta più basso di un secolo prima anchese le condizioni non sono più defiazionistiche mainflazionistiche, e va abbassandosi ulteriormente nella secondametà del secolo fino al punto che la riduzione d'imperio del tassomassimo prima al 5 poi al 4 per cento non provoca fuga di capitalie tesoreggiamento massiccio: nel giro di qualche decennio letransazioni si sistemano attorno a questo nuovo piede, e se ilvecchio contratto di censo, senza scadenza e redimibile a volontàdel creditore, si va rarefacendo, i capitali continuano ad esseremessi a disposizione dei produttori tramite contratti di normalemutuo ipotecario223. Le conseguenze positive per l'agricolturaprovinciale di tutto ciò sono sottolineate da Galanti: anche
221 G. POLI, Sui 'censi' gravanti sulla proprietà fondiaria nel sec. XVI: il casodi Molfetta, in AA.VV., Molfetta nei secoli, studi storici, Molfetta 1976, pp.27-43; P. DI BARI, Monopoli nella prima metà del '600. Condizioni economiche esociali, Mola 1969.222 Sui 1015 contratti di censo del periodo 1740-90 stipulati a Conversano,rinvenuti da VENERUCCI (Le campagne di Conversano cit.), la motivazionedell'acquisto del microfondo è esplicita nel 26 per cento dei casi, quellodell'acquisto della casa in un altro 11 per cento, e il 47 per cento nel qualela richiesta di censo ha lo scopo di «affrancarsi da un altro debito » puònascondere molti altri contratti riconducibili alla volontà di accesso allaproprietà.223 PALUMBO , Aspetti di attività creditizia cit., PP. 50 sgg.
113
grazie alla maggiore disponibilità e al minor costo del credito,“i poveri contadini si sono trovati alleviati, e gli ecclesiasticiche posseggono molti fondi hanno impiegato il loro denaro amigliorarli. Così sono divenuti molto più ricchi che non fosseroquando davano il loro denaro a censo coll'otto e dieci percento”224.
Ma la medaglia ha un'altra faccia: nel tardo Settecentoottimismo e pessimismo, speranza e disperazione si intreccianonelle testimonianze di osservatori e attori della scena sociale.Gli elementi di novità non riescono a disgregare le logiche chegovernano da secoli il nostro sistema regionale, cosicché itradizionali meccanismi di limitazione della crescita tornanopuntualmente a funzionare. Mentre le difficoltà dellacerealicoltura provinciale limitano i redditi della mietitura ocostringono i contadini ad allungare il raggio delle migrazionistagionali per raggiungere la Puglia piana. il procedere, sotto lostimolo dei prezzi crescenti, della mercantilizzazione e dellaspecializzazione e il ridursi dell'importanza dell'autoconsumotornano a spingere sul mercato delle braccia unità lavorative a unritmo più che proporzionale a quello dell'incremento demografico,provocando, insieme alla riapertura del ventaglio delleretribuzioni, una riduzione del salario reale medio espressa dallaforbice fra la curva del salario nominale, che non riesce adabbandonare un andamento sostanzialmente parallelo all'asse delleascisse, e quelle dei prezzi. Al contempo la domanda sempre piùintensa di minifondi olivetati, confrontandosi con un'offertastrutturalmente scarsa a causa della ristrettezza degli agri edella scarsa capacità di adattamento delle dimensioni dell'olivetoalla congiuntura, determina una crescita della rendita di granlunga superiore a quella dei prezzi dell'olio: dopo un aumentograduale nei primi sessanta anni del secolo, i valori unitaridegli oliveti di Polignano s'impennano violentemente, finendonell'ultimo decennio a un livello nove volte più alto che nelprimo, e un andamento non dissimile presentano gli oliveti diMolfetta e Conversano, mentre i minifondi seminatoriali destinatiin prevalenza all'autoconsumo, che nella fase seicentesca dicaduta della domanda interna e della specializzazione eranocresciuti di valore relativamente ai fondi olivetati, hanno unandamento molto meno dinamico e il loro valore cresce meno deiprezzi del grano225.
224 Ibid., p. 56.225 MASELLA, Mercato fondiario Cit., P. 287; A. MASSAFRA, Mercato
114
Diminuzione in termini reali del salario e aumentospropositato della rendita mettono ancora una volta in discussionegli equilibri economici della famiglia contadina, limitano lacapacità di espansione di questa forma di produzione sulterritorio e la crescita del prodotto disponibile per il mercato,tendono ad attaccare gli ammortizzatori costruitisi nei secoli frail mercato e i microproduttori. In un caso estremo come quello diMolfetta, il cui agro offre riserve risicate di terra richiamabilialla produzione sotto l'impulso della domanda, i fenomeniappaiono amplificati ma si collocano lungo la direzione di fondodelle trasformazioni della provincia. Dato che la terra olivetatanon si confronta con individui, ma con la domanda monetaria daessi espressa, la riduzione delle dimensioni dell'azienda agricolanella crescita demografica non è proporzionale in tutte le classidi ampiezza, ma è distorta dal modificarsi della distribuzione deiredditi impiegabili nel suo acquisto. Così nella fase espansivadel secondo Settecento - come, con ogni probabilità, in quellacinquecentesca - aumenta nettamente la percentuale di famigliesenza proprietà, e, fra le famiglie che la conservano, cresconoquelle situate ai poli estremi, titolari di frazioni sempre piùpiccole o di latifondi, mentre crolla la percentuale di quelleproprietarie di estensioni intermedie, fra le 6 e le 50 vigne inparticolare (cfr. tab. 7).
Parlare di proletarizzazione è probabilmente improprio, datoche la gestione diretta da parte di titolari di medie e grosseestensioni rimane in frequente e i contadini nullatenentiricostruiscono, ricorrendo al fitto, la molteplicità delle fontidi reddito indispensabile per non soccombere ai mille accidenti diquesta forma di produzione per il mercato; essi devono comunqueaffrontare il mercato in condizioni di inferiorità crescente,vedono allungarsi i periodi del loro ciclo vitale in cui nonpossono far conto sul reddito della microazienda devono cercarecompensazioni saltuarie in ogni sorta di piccoli traffici: nellaraccolta di alghe e legna, nel contrabbando, e inducono i lorofigli a cercare spazi in settori marginali, ma che vanno assumendoanche sotto gli stimoli provenienti dai limiti di sviluppodell'agricoltura specializzata e dalla disponibilità di braccia,un ruolo e una consistenza maggiori - la marineria da commercio eda pesca in primo luogo.
e valori fondiari nella seconda metà del XVIII secolo, in AA.VV., Economia eclassi sociali cit., pp. 87-112; L. PALUMBO, Una piccola azienda agricola inTerra di Bari dal 1789 al 1864, in «Archivio storico pugliese», 1968, tab. P.227.
115
Ma, naturalmente, non dovunque questi spazi sono disponibili,e allora lo stesso incremento demografico finisce per risentirne.Il clima di disperazione diffuso nelle classi subalterne, latensione sociale acutissima che pervade l'ultimo Settecentoprovinciale226, segnalano che il sistema regionale barese è statoricondotto, dalla dialettica fra spinte alla crescita e suecoerenze interne fisiche e sociali, a un limite di rottura. Lecose non possono andare avanti così a lungo: una nuova fase diarretramento o la fuoriuscita dalle costrizioni del vecchiomodello regionale sono le alternative sul tappeto.
Tabella 7.
Distribuzione della proprietà fondiaria a Molfetta per classidi ampiezza.
Fonti: elaborazioni su POLI, Distribuzione della proprietàfondiaria cit., tab. p.233; TULLIO, Molfetta cit., tab. p. 22; G.CORMIO, I catasti murattiani e borbonici di Molfetta (1808-1824),tesi di laurea discussa presso la facoltà di Economia e commerciodell'Università di Bari, a.a. 1965-66. La vigna a Molfettacorrisponde a 0,49 ettari.
1561 1754 1813______________________ _________________ ____________________fuochi superf. superf. fuochi superf. superf.famiglie superf superf.
per fuoco per fuoco per famiglie in vigne in vigne in vigne
nessuna proprietà 17 - - 35 - - 50 - -0 - 5 vigne 48,43 13,54 2,50 50 22,58 2,18 39,4 19,8 1,666-10 12,52 11,10 7,96 7,52 14,02 9 5,25 11,7 7,211-50 19,49 47,92 22,o6 6,18 23,78 18,56 4,45 28,3 20,5751-100 1,99 14,81 66,65 0,66 10,47 76,06 0,4 7,3
60,7oltre 100 0,55 12,63 204,71 0,61 29,15 226,05 0,5
32,9 210
226 Cfr. CORMIO, Le classi subalterne cit.116
6. Tempi circolati o tempi lineari?
I dati a disposizione, come sarà parso evidente, sono troppoframmentari perché se ne possa trarre un'immagine organica delledinamiche di età moderna di questa realtà provinciale. Alcunielementi utili per misurare l'efficacia euristica dello schema'estremo' adottato all'inizio del capitolo possono comunqueconsiderarsi acquisiti. Incontrando le coerenze e le articolazionidella nostra regione economica, la domanda internazionale enapoletana riesce a determinare l'andamento delle variabilifondamentali entro limiti e forme proprie di ciascuna areasubregionale e, al tempo stesso, interconnesse nell'ambito delsistema regionale nel suo complesso.
Al crescere della domanda la società provinciale non cresce intutte le sue componenti, ma si modifica, accumula elementi dicrisi che emergono anche prima dell'inversione del trend delladomanda stessa. D'altro canto, è attorno al mercato che la regionesi struttura, si cuce, diventa riconoscibile in quanto tale.
A riassumere le indicazioni e le ipotesi avanzate nelle pagineprecedenti individuando - secondo una terminologia impropria maormai classica - fasi di crescita (A, e A,) e fasi di declino (B,e 13), gli intrecci e, al tempo stesso, le tensioni fra logichedella dipendenza e logiche sistemiche regionali risaltano conparticolare evidenza.
Fase A,.
La domanda internazionale e napoletana di grano e olio segueun trend ascendente lungo il quale i fallimenti dei raccolti sonosegnati da impennate improvvise dei prezzi e i raccoltiabbondanti da flessioni contenute o nulle. La cerealicolturaspecializzata murgiana si espande vigorosamente a causa deldisporsi favorevole delle convenienze del massaro - i prezzicrescono, l'interventismo annonario è ancora 'leggero' e nonprovoca incertezze, l'intermediazione è relativamente pocopesante, la terra buona è disponibile a prezzi ragionevoli e laproduzione può allargarsi in condizioni di rendimenti costanti. Ladomanda di unità lavorative, che cresce in maniera più cheproporzionale alla produzione a causa delle ineguaglianze delcalendario agricolo, viene soddisfatta tramite una natalità che, a
117
differenza che nelle situazioni canoniche, appare correlatapositivamente ai prezzi, migrazioni stagionali e migrazionidefinitive stimolate anche dalla diffusione del vigneto infunzione di sostegno dei redditi del latifondo. Una parteconsistente delle migrazioni stagionali e definitive verso lecittà del grano proviene dalle città dell'olio, la cui colturafondamentale avanza ai margini molto più lentamente del grano, erisponde alla domanda soprattutto accrescendo il livello dispecializzazione dei campi olivetati. Col ridursi degli elementipolicolturali presenti nell'oliveto, si accrescono le distanze fravuoti e pieni del calendario olivicolo, si accresce l'offerta dibraccia, soprattutto nella tarda primavera e d'estate, e ladomanda di cereali che le semine sotto gli olivi e ai marginidell'oliveto non possono soddisfare. La complementarietà fra ledue aree mercantilizzate della provincia si fa evidente, ilsistema regionale si organizza e si ricuce.
Fase A,.
Il vincolismo annonario e l'appesantirsi dei margini daconsegnare alla speculazione riducono l'effetto positivo dellacrescita dei prezzi sulle aspettative del massaro, nel mentre laterra nei canali seminatori va esaurendosi e la rendita cresce piùdei prezzi. Di conseguenza l'espansione cerealicola tende abloccarsi, e con essa si blocca la crescita delle migrazionistagionali e definitive. La crescita demografica delle cittàdell'olio supera quella delle città del grano provocando unaccumulo di tensioni interne: un accresciuto numero diolivicoltori deve compensare la diminuzione relativa del redditoestratto dalla mietitura e offre braccia all'olivicoltura inproprio e a quella in conto terzi, spingendo in basso il salarioreale e in alto il valore della terra. L'equilibrio economicodella famiglia contadina e, insieme, l'efficienza della cellulaproduttiva fondamentale dell'olivicoltura che da essa dipende,vengono messe in discussione. Il reddito pro capite tende aridursi e la sua distribuzione a diventare più iniqua.
Fase B,.
La domanda napoletana e internazionale di grano e quelladell'olio si collocano su trend discendenti, rappresentati dacurve dei prezzi su cui le annate “penuriose” provocano lievi
118
increspature, quelle abbondanti cadute brusche; parallelamentecadono i valori delle strutture produttive per il mercato -masserie e minifondi olivetati - e crescono relativamente i valoridella terra destinata all'autoconsumo. I trend dei prezzi delledue derrate fondamentali hanno però pendenze diverse: mentre ilprezzo dell'olio, che ha un mercato interno strutturalmentelimitato, precipita seguendo la contrazione della domandainternazionale, la domanda di grano, fino a quando l'andamentodella demografia non si fa catastrofico, continua ad esserealimentata da Napoli e dalle stesse città olearie; di conseguenzale sue ragioni di scambio migliorano, la caduta del commerciocerealicolo è contenuta, sopravvivono convenienze alla produzionecerto non più a misura delle deboli spalle dei massari, macoglibili dalla grande proprietà feudale ed ecclesiastica, privatadella possibilità di investimenti alternativi dalla contestualecrisi della pastorizia. Tutto questo, d'altro canto, non attenuale difficoltà della società delle aree della provincia piùmercantilizzate, che finiscono per costituire terreno fertile perle crisi epidemiche. Quando queste si fanno particolarmenteincisive, i circuiti produttivi e mercantili cerealicoli sidisorganizzano del tutto, la crisi si generalizza.
Fase B,.
Mentre il prezzo dell'olio torna a trasmettere stimoli ancoradeboli e incerti della domanda internazionale, il prezzo del granosi conosca su un trend stagnante come quello della popolazioneprovinciale, che costituisce ormai la sua principale fonte didomanda, ed entra in sintonia sul breve periodo coi raccolti,presentando una variabilità non più dimidiata - forte verso l'altoe debole verso il basso quando il trend è ascendente, viceversaquando è discendente - ma forte in entrambe le direzioni anche perla ridotta quantità di sovrappiù che passa dal mercato, cosicchésolo chi ha i capitali per rimandare la vendita fino al prossimorialzo dei prezzi può correre il rischio della produzione ingrande. Agli stessi prezzi dei cereali torna sul breve periodo acorrelarsi la natalità, non più in positivo, ma in negativo,secondo il modello canonico elaborato per le situazioni 'normali'.La riduzione a livelli non significativi degli indici dicorrelazione fra prezzi locali e prezzi internazionali, risultatoeloquente del ruolo ormai marginale del commercio in grande, siripercuote in un abbassamento degli stessi indici di correlazione
119
dei prezzi provinciali, a dispetto della solidarietà fra i mercatilocali determinata dalle comuni vicende meteorologiche. I vincolifunzionali del sistema regionale si allentano, si indeboliscono lesue cuciture, la costa acquista meno grano dall'interno e da menomietitori, nel mentre le lunghe file di pecore e pastori cheritmicamente scendono dall'Appennino e vi risalgono tendono aproporre una lettura del territorio per insiemi che non coincidonopiù grosso modo con la provincia amministrativa, non più fondatisulla dialettica costa olivicola - Murgia cerealicola, ma sulrapporto di scambi reciproci fra montagna appenninica e rilievimurgiani. In generale gli oliveti imbarbariti, le fosse per granivuote, i porti interrati, le pecore che pascolano fra i “commodi”in rovina delle masserie, le locande una volta affollate divaticali ed ora deserte segnalano una utilizzazione superficiale einefficace dell'ambiente. Al tempo stesso la tensione frapopolazione e risorse si allenta, le terre rimaste incolte vannoriacquistando fertilità, i 'fattori produttivi' tornano ad esseredisponibili a buon mercato, si ricreano potenzialità che laripresa della domanda internazionale traduce in atto. L'inversioneverso l'alto del trend dei prezzi, incontrando questa situazionelocale, ricostruisce le convenienze per un rilancio produttivo,che a sua volta riavvia la specializzazione e la reciprocafunzionalità delle aree subregionali, riporta in vita la regioneeconomica, restituisce la provincia alla fase A,.
Insomma la crisi, osservata dalle campagne, non riesce qui adessere un laboratorio in cui si sperimenta il futuro. Quando vienemeno il commercio a lunga distanza, attorno al quale era andataorganizzando le sue coerenze interne, la regione economica si vascombinando e, al tempo stesso, va ricostruendo le premesse delsuo riemergere, che si fa evidente quando i prezzi riprendono asalire. Allora le sue potenzialità appaiono dispiegarsi, lerisorse aumentano, le città si riempiono di uomini, ma al contempovanno accumulandosi fattori di squilibrio che l'inversione deltrend dei prezzi fa esplodere. Ogni fase sembra destinata arovesciarsi nella successiva, in una sorta di 'respiro' connessoai tempi e alle vicende dei 'centri' da cui la provincia dipende,ma preparato dall'accumularsi delle contraddizioni e delletensioni interne al sistema.
Il tempo di questa società si avvolge dunque su se stesso comein una sorta di 'eterno ritorno'?
Le cose stanno così solo in parte, e del resto già da quantosiamo andati dicendo è possibile individuare il farsi largo di un
120
tempo lineare della provincia, di aspetti senza futuro e novitàconsistenti, di energie che si accumulano e spingono verso larottura delle coerenze del nostro sistema regionale. Ma tempi emodi di questi processi ci rimarranno sfuggenti fino a quando nonli si potrà rileggere alla luce di un'analisi articolata di quella'dipendenza di età moderna' lasciata finora sullo sfondo come unasorta di quadro di riferimento immobile del nostro ragionamento, edei luoghi della provincia in cui essa si struttura, si modifica,prende corpo in ceti, istituzioni, mentalità.
Il dossier delle città, chiuso in corrispondenza della crisidei centri mercantili tardo-medievali, va ormai riaperto.
IV.
LUOGHI E FORME DELLA SUBORDINAZIONE. LE 'CITTA' PORTUALI.
I. L'eccezionalità dell'insediamento.
Il modello insediativo della provincia, già fuori del comunenel quadro di quello meridionale per quanto è possibile spingereall'indietro lo sguardo, si presenta alle soglie dell'età moderna,dopo gli sconvolgimenti del Tre e Quattrocento, del tuttoeccezionale già a far conto delle cifre demografiche.
Terra di Bari è di gran lunga la provincia meridionale delRegno con il minor numero di insediamenti di livello gerarchicoinferiore - castelli, casali e terre - per ogni “città”227, con lamaggiore dimensione demografica per centro, con il più alto tassodi concentrazione della popolazione: a metà Quattrocento quattrocentri sui cinquanta della provincia - Barletta, Trani, Bitonto eAndria - contengono il 33 per cento dei fuochi complessivi e il 56per cento è contenuto nei dieci centri maggiori228. Assumendo atermine di confronto, come ha fatto Giovanna Da Molin, le altredue province pugliesi, quella 'normale' di Terra d'Otranto el'altra, di caratteristiche più vicine alla nostra, di Capitanata,si ha che mentre nella prima la gran parte dei centri abitati il73 per cento) si situa nella classe di ampiezza minima (1-50fuochi) e in essi risiede una parte consistente della popolazione227 LEPRE, Storia del Mezzogiorno d'Italia cit., I, pp. 20-21.228 Quando non altrimenti specificato, le fonti su cui sono stati elaborati idati sulla dimensione demografica e l'andamento della popolazione delle cittàsono quelle di p. 71, nota I
121
(il 24 per cento), nelle altre due i valori scendono, per Terra diBari rispettivamente al 25 e al 2,7 per cento, e per la Capitanataal 19 ed al 2,7 per cento. Sul lato opposto dello spettro delledimensioni, i centri con più di 200 fuochi rappresentano in Terrad'Otranto l'8,5 per cento e vi risiede il 52 per cento dellapopolazione, mentre in Capitanata i valori sono rispettivamente il24,6 e il 62 per cento, e in Terra di Bari il 34 e il 74,5 percento.
Gli indici di concentrazione sembrano ridursi nel corso deisecoli, in particolare nei periodi di crescita demografica (cfr.tab. 8). Che si esprima anche per questa via quel processo diruralizzazione della provincia iniziato con la crisidell"urbanità' medievale? Vedremo più avanti quanto poco questaconcettualizzazione sia adeguata alla realtà che vuole esprimere.Ciò che già da ora va sottolineato è che l'evoluzione dei grandicentri baresi va seguita, oltre che in termini relativi, intermini assoluti: una crescita dei centri maggiori che avessetenuto il passo della crescita demografica della provincia liavrebbe presto portati a dimensioni tali da implicare lastrutturazione di funzioni propriamente urbane non inseribili nelquadro di compatibilità già descritto. E, del resto, già lacrescita demografica dei grandi centri che ebbe effettivamenteluogo e le modificazioni funzionali in qualche misura connesse adessa, avrebbero indotto, come vedremo, tensioni acute e fecondesenza riscontro in altre aree del Mezzogiorno continentale.
Lungi dal ridursi, in termini comparativi, l'eccezionalitàdella rete degli insediamenti della provincia sembra crescere neltempo. Se nella prima metà del Cinquecento l'affollarsi di centricon più di mille fuochi in Terra di Bari è fenomeno già vistoso,la cartina dei centri con più di diecimila abitanti del primoOttocento diventa confusa in corrispondenza dell'area dellaprovincia e lascia amplissimi spazi bianchi altrove (cfr. figg. 3e 4)229. E così la tabella 9, che situa la popolazione in relazionealle classi di ampiezza dei centri, vede fra 1443 e 1796 unacaduta lineare e progressiva, tranne che in coincidenza dellacrisi seicentesca, degli abitanti dei centri inferiori alletremila anime, e un addensamento della popolazione altrettantoprogressivo e lineare nei centri con più di cinquemila anime, chenon troviamo nel resto del Mezzogiorno continentale. A fineSettecento, mentre in Terra di Bari superava i cinquemila abitanti229 La cartina relativa al 1532 è elaborata sulla base di GIUSTINIANI, Dizionariocit.; quella per il 1818 è ripresa da G. ALIBERTI, Ambiente e societànell'Ottocento meridionale, Roma 1974.
122
il 45 per cento degli insediamenti, e vi risiedeva il 75,4 percento della popolazione, nel Regno, esclusa Napoli, solo l'8,4 percento dei centri aveva più di cinquemila abitanti e in questirisiedeva il 28,5 per cento degli abitanti stessi.
Tabella 8.
Indici di concentrazione.
Dimensione Dimensione % abitantimedia Numeri- media Numeri- primicentri indice dei primi indice 10
centri(abitanti) 10 centri sul totale
1443 934 100 2623 100 56,21505 1613 175 4188 160 50,91545 3167 339 7743 295 48,91595 4358 467 10846 413 48,81648 4269 457 10945 417 49,31669 3454 370 8587 327 47,81732 3537 379 7980 304 48,01796 6093 652 13760 524 41,8
Un altro elemento, accanto a quello della concentrazione, vasottolineato a riguardo del modello insediativo provinciale: lasua stabilità. Non vi sono qui centri che scompaiano sotto i colpidelle crisi demografiche, né città nuove - a parte il caso deltutto isolato di Sammichele, fondata all'inizio del Seicentodall'attivissimo feudatario di Mola, H Vaaz, come colonia di serbiin fuga davanti ai turchi, e poi, dopo il fallimento di questodisegno, abitata da contadini di centri vicini230. D'altro canto lapromozione dell'insediamento sparso nella selva di Alberobello daparte del conte di Conversano, nello stesso Seicento, non riusciràad aver successo al di là di un'area di estensione e pesoeconomico del tutto marginale231. Il nesso medievale traintensificazione agricola e fondazione di casali è scioltodefinitivamente. La campagna di Monopoli, nel secondo Settecento,è punteggiata di “fabbricati e grati casini” per il “dolce
230 Cfr. M. D'ADDABBO, S. Michele e una colonia serba, in «Iapigia», 1936, fS.III, Pp. 289-301.231 Qualche indicazione in proposito in G. MASI, Aspetti della crisi edilizia inPuglia nel XVI secolo, in «Annali della facoltà di Economia e commerciodell'università di Bari», 1948, p. 17, nota; ID., Strutture e società cit., pp.96-97.
123
diporto” autunnale232, e nell'Ottocento insediamenti come Palombaio,Torrequadra e Mariotto “non sono che luoghi dove si ritorna nellebelle stagioni dell'anno per diportare”233; subito dopo ci sirifugia nei grossi centri secolari.
Tabella 9.
Distribuzione dei centri di Terra di Bari per classi diampiezza (per ciascun anno sono indicati la percentuale degliabitanti sul totale provinciale e il numero dei centri).
Abitanti 1443 1505 1545 1595 1648 1669 1796
1 -500% 7,6 4,7 0,8 0,6 0,5 0,9 0,1centri 20 14 4 4 5 6 1
501-1500% 39,1 23,3 11,2 4,5 4,0 6,7 1,2centri 21 19 16 9 9 12 5
1501-3000% 31,8 21,1 16,3 12,3 9,2 14,8 8,2centri 7 8 11 12 10 12 12
3001-5000% 10,3 37,3 19,7 19,3 22,2 13,8 15,2centri 1 8 8 11 13 7 12
5001-10000% 11,1 13,6 37,6 24,4 24,9 44,8 33,6centri 1 2 9 8 8 12 15
10001-20000% - - 14,5 38,8 39,1 18,9 41,8centri - - 2 7 7 3 9
232 A. NARDELLI, La Minopoli o sia Monopoli manifestata, Monopoli 1888 (ristampaed. Orsino, Napoli 1773), P. II233 ASNA, f. Interni, Il, b. 4o69, Atti del Consiglio provinciale di Terra diBari, maggio 1839.
124
Figura 3.Centri con più di 1000 fuochi nel Mezzogiorno continentale
(1532).
Figura 4.Centri con più di 10000 abitanti nel Mezzogiorno continentale
(1818).
Per di più, il gruppo di questi ultimi centri presenta una suagerarchia relativamente rigida. Fra metà Quattrocento e metàOttocento, osservando la situazione ad intervalli grosso modoregolari (1447, 505, 1545, 1595, 1648, 1669, 1732, 1796, 1815,1861), mentre nelle posizioni di coda staziona un gruppo di centridella conca barese, quindici centri si avvicendano ai dieci postidi testa. Tra questi ultimi cinque sono sempre presenti (Bari,Barletta, Bitonto, Andria e Monopoli), Altamura è assente solo almomento dell'Unità, Bisceglie è presente otto volte su dieci,Corato e Gravina sette su dieci, con un andamento opposto neltempo - progrediente per la prima e regrediente per la seconda;Trani sei volte, con una eclissi che dura dal secondo Cinquecentoal secondo Settecento, Molfetta cinque volte, con una parabolasimile a quella di Trani ma meno pronunciata, dal momento cheanche nelle fasi in cui non compare tra i primi dieci centririmane nelle posizioni immediatamente a ridosso a quelle di testa.
Dimensioni demografiche e tempi lunghi sembrerebberocongiurare a fare di questo pugno di grandi insediamenti i nodi diun reticolo urbano regolato da un sistema di assi e gerarchiedirezionali estratto dalla modellistica geografica.
2. I borghi rurali e gli annunci del futuro.
Eppure, come abbiamo visto, il filo di una possibile letturadel reticolo insediativo provinciale come sistema sembra smarrirsiproprio agli albori dell'età moderna, e non è rintracciabile
125
ancora per secoli, nei quali il modello esplicativo dell'agrotown234
si presenta come uno strumento efficace per penetrare paradossi ecaratteri dei borghi baresi. Purché, però, lo si utilizzi senzaoscurare le articolazioni e la complessità della realtà che sivuole comprendere.
Un primo passo da compiere è quello di evitare di considerareesaustive le spiegazioni 'speciali' dell'accorpamento abitativo,siano esse la minaccia dei corsari sugli abitanti sparsi nei campiin un ambiente fisico che rende impossibile l'arroccamento, o levessazioni fiscali dei potenti sui casali, che avrebbero poicreato tradizioni, mentalità, consuetudine al vivere associatocostose sul piano dell'economia, disfunzionali rispetto aun'agricoltura ideale: l'agrotown, insomma, come realtà laceratafra le ragioni della cultura e quelle della produzione.
L'esercizio consueto dell'elencare i ricaschi sociali negatividi questa forma di insediamento - i tempi lunghi per raggiungere iposti di lavoro, l'inefficienza delle case rese minuscole dallacarenza di spazi dentro le mura quale mezzo di produzione di benisecondari, l'ozio forzato e moralmente pericoloso delle donne -prodotto a sostegno di innumerevoli e ripetitive proposte dinormalizzazione della società provinciale a partire dal Settecentoriformatore, fa spesso riferimento a forme di ruralità estraneealla provincia, a contadini con legami stabili con la terra cheestraggono sovrappiù tanto più consistenti quanto più intenso è illoro rapporto con il campo coltivato, che assegnano al suopossesso un valore simbolico e accedono al matrimonio quando loconseguono; produttori autonomi che usano la piazza per scambiare,in occasione dei mercati periodici, ciò che hanno prodotto in piùcon quanto hanno prodotto in meno rispetto al 'bisogno', per poicorrere a reinsediarsi nei luoghi di produzione al tempo stessodi valori economici e simbolici. Il punto è che ad ammucchiarsinelle città pugliesi non è il normale “sudiciume campestre”, ma,lo sappiamo già, i protagonisti di un'agricoltura fortementemercantilizzata, che hanno con la terra un legame superficiale, sisposano prima di ottenerne il possesso e raramente possiederannonel corso della loro esistenza un appezzamento sufficiente aconfigurare una qualche autonomia aziendale.
Rispetto a costoro e alle forme di produzione a cui dannovita, cultura ed economia tornano ad essere leggibili assiemenella forma degli insediamenti, e l'agrotown si rivela a suo modo
234 Per una discussione del problema e della letteratura in proposito rimando,per tutti, a G. GALASSO, L'altra Europa, Milano 1982, pp. 13-63.
126
funzionale già dal livello più elementare: dispersi i frammenti dipossesso e le occasioni di lavoro in conto terzi in ognidirezione, il borgo rurale diventa il centro di irradiazione deipercorsi dei contadini verso e dai campi e quindi,paradossalmente, il punto mediamente meno distante da essi; e delresto, ricondotti trappeti e mulini, fosse granarie e cisterneolearie in larga parte entro le mura cittadine, la città stessa sipresenta come una gigantesca struttura di servizio alla produzioneche, con la sola eccezione di jazzi e masserie, richiama al suointerno tutto il lavoro agricolo non direttamente erogato suicampi.
Non che l'immagine tradizionale vada del tutto ribaltata. Aparte le fasi stagionali di trasformazione dei prodotti agricoli,la città è consegnata di giorno alle donne, che, impegnate solosaltuariamente nel lavoro dei campi, popolano “oziose” le cortiarabe e i gomitoli di strade e, strette tra una casa di dimensioniminime e la pubblica via, si vedono precluse, insiemeall'allevamento di animali da cortile, alla produzione di ortaggi,alla gestione di un forno, anche molte forme di manifatturadomestica. Ma neanche l'ozio delle donne è computabile tutto dallato dei costi. In un'agricoltura spinta a questo livello dispecializzazione, la disponibilità di manodopera come quellafemminile, mobilitabile immediatamente e a costi molto bassi inalcune fasi del calendario agricolo - in particolare laspigolatura, la vendemmia, la raccolta delle olive - è un fattoreimportante degli equilibri complessivi, e d'altronde la relativascarsezza del loro impegno sul piano del lavoro extragricolo èparte di un quadro di generale debolezza del settore secondarioinsita nei caratteri di fondo dell'area.
Qui gli stimoli allo sviluppo e di forme di poliattivitàprotoindustriali - spesso incisive nell'agricoltura contadinapolicolturale perché vi fungono da compensatrici dei vuoti didomanda di lavoro agricolo, piccoli e dispersi lungo il calendario- risultano deboli proprio perché, con paradosso solo apparente,le discontinuità del calendario agricolo prodotte dallaspecializzazione e dalla mercantilizzazione sono clamorose econcentrate, coinvolgono al contempo la gran parte della forza-lavoro disponibile e richiederebbero per essere compensate unosviluppo manifatturiero di proporzioni gigantesche, impensabilenelle condizioni date; d'altro canto le navi granarie ed olearietornano cariche anche di manufatti di buona qualità e prezzorelativamente basso che si diffondono per mercati, fiere e
127
fondachi sottraendo spazi all'artigianato di autoconsumo e aquello mercantile locale. Così è nel quadro dell'agricolturastessa e delle sue articolazioni territoriali che si sviluppanoforme di poliattività in grado di incidere sul mercato del lavoro,tramite il reciproco sostegno della microazienda contadina edell'azienda maggiore o del vigneto e del latifondo granario.
L'insediamento, che nel quadro dell'agricoltura contadina'normale' è il luogo della produzione di beni e serviziextragricoli scambiati con derrate, si conferma come sempliceprolungamento del mondo dei campi.
Il che non conferma affatto immagini di immobilismo,arretratezza, debolezza dei nessi e degli scambi economici. Inparticolare nella nostra regione economica, che si subordina almercato internazionale senza smarrire ogni principio ordinatoresul proprio territorio, l'agrotown presenta, come si è già detto,una stanzialità relativamente alta e, al tempo stesso, riesce atrattenere al proprio interno istituti, ceti, funzioni diorganizzazione non irrilevanti nell'agricoltura. La debolezzastrutturale dell'economia del vicolo, delle mille forme diproduzione autonoma e dello scambio non monetario, si rovescia nelrigoglio dell'economia della piazza, dove si rannoda la vitaquotidiana dell'intera compagine sociale: lì la famigliacontadina, condannata a un livello basso di autoconsumo, viacquista non solo i manufatti, ma spesso lo stesso cibo,smerciandovi le derrate prodotte con il lavoro in proprio; lìgiungono i terminali del commercio a lunga distanza e si organizzaquello a distanza intermedia che ricuce la provincia olearia aquella granaria, vi si contrattano prestazioni lavorative perluoghi vicini e lontani, vi si realizza la compravendita frequentedei microfondi connaturata al rapporto strumentale con laproprietà, si stipulano contratti di fitto a breve e brevissimotermine; il tutto per il tramite di sensali, notai, giudici acontratto, agrimensori, antenieri, professionisti di ogni tipo diintermediazione. Il profilo sociale del contadino è così definitoda un lavoro agricolo che non è rapporto fra uomo e natura, maprevalentemente fra uomini, e ha bisogno, per organizzarsi, di unambiente urbano di fondachi e “hostarie”, scambi monetari eformalizzazione giuridica.
Nulla di più lontano dalla realtà, dunque, dell'immaginecorriva dei grandi borghi baresi come immensi dormitori dicontadini. Il volto particolare di queste città e il sapore dellaloro vita associata si costruiscono nell'intreccio tra il vuoto
128
dei vicoli e il pieno delle piazze, tra un massimo di ruralità eun massimo di artificiosità delle funzioni produttive e diapertura agli impulsi della vita economica europea.
Ma - ed ecco il secondo punto che vorrei sottolineare conforza - se la condizione di agrotown implica un residuo didirezionalità, una qualche complessità del tessuto sociale, unadotazione di strutture e ceti a sostegno della circolazione deiprodotti, essa non è connaturata ad ogni insediamento, vaconquistata, conservata, può essere perduta, implica elementideboli ma pur sempre visibili di articolazione e gerarchizzazione,costruisce polarità di raggio breve ma in qualche caso incisive.
Guardiamo più da vicino la società che nei singoli centri siaggiunge alla massa, sempre nettamente prevalente, dei lavoratoriagricoli. All'inizio del Seicento Gravina ha già perso il primatonella provincia per numero di abitanti, conquistato nel corso delsecolo precedente, ma porta ancora i segni di una prosperità, nonpiù ritrovata in seguito, che le permette di nutrire una fettaarticolata di società non agricola. Fra i suoi 15-20000 abitantitroviamo 20 dottori utroque iure e “multi che si esercitano allaprocura”, 6 notai, 4 giudici a contratto e 2 compassatori; 4medici, speziali di medicina e 3 chirurghi, un pittore e 3scultori, gli insegnanti delle 6 “scuole per leggere e grammatica”e delle “scuole per scrivere ed abaco”, una folta schiera dimilitari ed ecclesiastici; e, fra le botteghe dei calzolai esarti, falegnami e ferrari di “opere grosse” o “nariute”,conciapelle e beccai, spiccano 4 fondaci di “drappi de seta, panniet altre cose”, 6 mercerie, 4 “hostarie dove allogiano passagiericon ogni comodità” ed 8 “taverne dove se dona da mangiare et dabere” anch'esse “molto comode”, mentre al centro della piazza 20“pianche” espongono in vendita “ocelli, fugliami, pesci, et altrecose commestibili”, e tutt'intorno alla stessa piazza e sparse perla Città 22 “botteghe lorde” “vendeno ogni sorte de cose salate”235.Acquaviva nello stesso torno di tempo ha meno della metà degliabitanti di Gravina, ma una piazza altrettanto vivace, unconsistente gruppo di professionisti e mercanti qualificati - 6dottori in legge, 4 medici, 2 chirurghi, 5 notai, 4 speziali dimedicina, 2 speziali manuali, 3 mercanti di panni e sete, moltimerciai - e, soprattutto, una presenza manufatturiera nel settoredella lavorazione delle pelli che non ha uguali in Terra di Barie che trova spazio nella marginalità di questo centro rispetto aigrandi flussi mercantili e all'agricoltura specializzata che li
235 DE MARINO, Apprezzo cit., PP. 31-33,129
sostiene: infiniti scarpari vendono i loro prodotti per tutta laprovincia e una “bellissima e ricca conciaria” manda i suoiprodotti addirittura fuori236.
La situazione sembra cambiare per i centri minori: al di sottodi una soglia variabile, a seconda delle situazioni, fra i 2000 ei 500 abitanti la riduzione dell'articolazione e delle dimensionidella società non agricola sembra ben più che proporzionale allariduzione delle dimensioni demografiche dei centri. All'inizio deiSeicento, Gioia ha 526 fuochi e un'articolazione professionaletanto scarsa da far pensare a una sua dipendenza per i serviziprofessionali e commerciali qualificati dalla vicina Acquaviva; ela crisi demografica di metà Seicento sembra provocare unulteriore ritrarsi della città nel mondo rurale: nel 1653 essa haperso circa un quarto dei suoi fuochi, ma gli 8 professionisti e i35 artigiani e commercianti al minuto registrati nell'apprezzo del1640 sono diventati rispettivamente 4 e 10237. Ed a risultati dellastessa natura si giunge ponendo a confronto, nel 1668, Spinazzola,che ha attraversato senza danni sostanziali i terribili anni '50 evanta una piazza in cui fanno bella mostra di sé una “poteca dizagarelle et altre galanterie” e un “copetaro che fa copete alfronte di quelle di Bari”, e la vicina Minervino che, devastatadall'epidemia, ha meno della metà degli abitanti della prima e unapiazza di gran lunga più sguarnita238. Nello stesso torno di temposulla costa Polignano ha 1000 abitanti in più rispetto aMinervino, ma un'articolazione sociale non meno povera239, cheappare quasi del tutto annullarsi nel corso degli ultimi decennidel secolo: nel 1713 la sua popolazione si è ridotta a 1720abitanti, tutti massari e contadini tranne “io persone civili, frai quali v'è un dottore di legge ed un dottore fisico” e 18artigiani240.
Sulla costa i catasti cinque-seicenteschi consentono unamisurazione meno impressionistica della diversa consistenza dellasocietà extragricola nei singoli centri, che conferma lacorrelazione positiva tra dimensioni demografiche e dimensionerelativa dei ceti artigiani, commercianti e professionali.
Bari in particolare, che pure rimane inchiodata, dal suo 50per cento di lavoratori della terra sul totale dei capifuocostretti tra le sue mura, alla tipologia dell'agrotown, si stacca236 LUCARELLI, Acquaviva delle Fonti all'inizio del secolo XVII cit., PP. 20-22.237 BN Bari, f. D'Addosio, 1-134238 Ibid., 11-32.239 ASNA, f. Relevi, vol. 192240 ASNA, f. Notai del Seicento, notaio G. Tomasuolo, prot. 1150/19.
130
nettamente dalle altre per la vivacità, la ricchezza, laraffinatezza delle iniziative artigianali e mercantili gestite dapersonale in larghissima parte di origine forestiera. D'altrocanto solo qui il mare sembra segnare con qualche consistenza ilvolto sociale della città, anche se con una presenza di pescatoripiù che di marinai da commercio; altrove la sua scarsa incidenzaconferma l'impossibilità di tracciare linee di demarcazione checorrano lungo il discrimine della collocazione costiera. ABisceglie e Molfetta, centri marittimi, il predominio dellacampagna è solo marginalmente meno pesante che a Palo (cfr. tab.10), e le differenze possono essere fatte risalire alla regoladella ruralità che cresce con il decrescere della popolazione.
Quale rigidità questa regola abbia lungo lo spettro delledimensioni demografiche, e quali siano le ragioni che lasostengono non è dato di sapere sulla base della documentazione,quantitativa e non, disponibile per la prima età moderna. Elementipiù numerosi è possibile cercare nel più ricco campione tratto daicatasti onciari, che inducono anche ad azzardare qualche ipotesisulla direzione e la consistenza dei mutamenti intervenuti.
La tabella 11 conferma, al gradino più basso della scalademografica, un'assenza virtuale della società non agricola: aSannicandro, Binetto e Sammichele essa è costituita da alcuneunità suddivise tra pochissime categorie - calzolai e sarti,fabbri e muratori soprattutto, e, fra i professionisti, qualchenotaio e qualche medico. Ne risente profondamente il tono generaledella vita associata, così come ci viene restituito dalle fontinon quantitative. Secondo la Relatio ad limina inviata il 13aprile 1725 su un centro non dissimile da quelli succitati,Bitetto, il locale “populus” sarebbe “quasi totus villicus, rudised audax” e dello stesso clero, costituito da una cinquantina diunità, “magna pars ob senectutem, paupertatem, et ignorantiam,agrestes effecti sunt”.
Tabella 10.
Composizione professionale nella prima età moderna.
Fonti: elaborazioni su POLI, Società e struttura professionalecit., tab. P. 70 (Bari 1598-'99, Bisceglie e Molfetta); DI BARI,Monopoli Cit.; VITARELLI, L'economia di Palo del Colle cit., tab.P - 54. In questa come nella tab. 11 si sono considerati solo ifuochi il cui capofuoco ha il mestiere dichiarato nel documento, e
131
si sono eliminati, allo scopo di rendere raffrontabili i dati adisposizione, ecclesiastici, “civili” e nobili. Le cifre relativeal numero di professioni e mestieri non agricoli, data ladifficoltà di distinguere i sinonimi, sono approssimate epuramente indicative.
N° professnumero % addetti %marit- %artig. %profess
%servitori e mestieriBari fuochi agricoltura timi commerc. e funzionari non agricoli1598-99 2037 50,4 7,4 37,9 5,2 - 1101636 1934 45,6 9,6 37,7 5,4 1,6 90Monopoli1627 1346 62 4,4 27,8 5,5 - 60Biscegliesecondo '500 1027 77,4 3,5 16,3 2,4 - 50Molfetta1561 626 74,1 2,2 18,4 5,3 - 35Palo1633-34 445 85,6 - 13 1,3 - 18
Un giudizio che conferma quello di un'altra relazione dialcuni decenni precedente, secondo la quale “omnes quasi canonicoset cappellanos” sarebbero soliti “frequentare rura et Ecclesiam.deserere [...] Clerus enim - continua il vescovo relatore - estdurae cervicis [...] proclivis ad venationem, aut aucupium cumscoppetis, aut ferarum cum canibus et clamoribus, et ideo noncurant servire Ecclesiae”241.
Tabella 11.
Composizione professionale a metà Settecento.
Fonti: i dati relativi a Paio, Sammichele, Binetto eSpinazzola Sono elaborati Su RICCHIONI, Saggio sull'estensi . onecit.; quelli per Minervino su DAL PANE, Studi sui catasti onciaricit.; quelli per Bitonto e Trani su uno studio inedito di G. Poli;quelli di Giovinazzo e Rutigliano su uno studio inedito di A.Annarumma; quelli per Sannicandro su M. R. E. VALERIO, Movimentodemografico in Sannicandro di Bari dal 1586 al 1819, tesi dilaurea discussa presso la facoltà di Lettere e filosofiadell'Università di Bari, a.a. 1972-73; quelli per Molfetta su
241 L. PALUMBO, Terra, clero e miseria nella Diocesi di Bitetto tra Cinquecento eSettecento, estratto da S. PALESE (a cura di), Prime indagini e archiviparrocchiali, Bari 1985, pp. 111-12.
132
TULLIO, Molfetta cit., pp. 120-22. Per i catasti relativi aglialtri centri, cfr. ASBA, tranne quello di Mola che è in ASNA equello di Bisceglie in Bc Bisceglie.
N° profess.numero % addetti %marit- %artig. %profess.
%servitori e mestierifuochi agricoltura timi commerc. e funzionari non
agricoliBari 3296 43,9 12,3 33,3 4,5 3 140Barletta 2210 67,6 9,7 16,1 5,3 1,3 60Altamura 2021 78,3 - 15,8 4,9 0,9 46Bitonto 1943 84,5 - 13,2 2,3 - -Monopoli 1764 60 5 28,6 4,2 1,8 80Molfetta 1563 59,4 16 20,5 2,9 1,2 70Corato 1495 80,6 - 16,4 2 1 50Gravina 1488 80 - 17 1 0,7 40Bisceglie 1471 72,9 6 17,5 2,6 0,9 60Trani 1262 51,1 17,2 25,7 5,9 - -Mola 1149 65,6 11,5 20 2,4 0,4 45Giovinazzo 963 68,9 8,1 17,2 4,4 1,3 60Palo 775 85,7 - 11,6 2,7 - 23Santeramo 638 90,1 - 4,9 4 0,1 20Spinazzola 636 87,7 - 10,7 1,6 - 22Rutigliano 577 53,9 - 43,3 2,4 0,3 40Cassano 575 81,2 - 17,2 1,4 - 23Casamassima 452 85 - 10,8 4,2 - 17Minervino 396 81,1 - 17,6 1,3 - 25Triggiano 396 85,4 1 10,6 3 - 19Bitetto 395 87,3 - 10,9 1,8 - 23Bitritto 360 81,9 - 14,7 3,3 - 15Sannicandro 261 92,3 - 5,4 2,3 - 12Sammichele 178 97,2 - 2,8 - - -Binetto 131 96,2 - 2,8 - - 4
Centri di questa natura, lo ripeto, sono atipici nellaprovincia; la loro presenza tende però a concentrarsi nella concadi Bari, dove la maglia dell'insediamento diventa improvvisamenteconfusa e fitta: fra i grossi centri provinciali, avrebbe notatoGalanti, essa sola “ha un gran numero di piccole popolazionidisseminate all'intorno, che diconsi casali di Bari”242, un temposubordinati amministrativamente a Bari stessa, ma poi costituitisiin organismi feudali autonomi con la crisi tardo medievale dellacittà. Solo sotto il profilo dell'organizzazione ecclesiasticaquesto vincolo amministrativo non si è dissolto, e la maggior242 G. M. GALANTI, Relazione sulla Puglia Peucezia, in m., Della descrizionecit., vol. II, PP. 561-62.
133
parte dei casali continuano a dipendere dall'arcivescovo di Bari.Ma ben presto i vincoli economici iscritti nella geografiadell'insediamento sarebbero tornati a costruire un organismo inuna certa misura unitario, in cui si raccoglie più di un terzodegli insediamenti della provincia e poco meno del 20 per centodella popolazione totale provinciale, e il cui centro direzionalecostituisce a sua volta, fra metà Quattrocento e metà Ottocento,meno del 50 per cento degli abitanti dei casali. In questi ultimil'estrema scarsezza di addetti alla circolazione dei prodottiagricoli, di produttori di beni secondari e servizi, diprofessionisti e funzionari postula una 'città' esterna ad essi 'e questa, a sua volta, oltre ad offrire un ventaglio di funzionimercantili e direzionali alla sua campagna interna', agli addettiall'agricoltura ammassati dentro le sue stesse mura. deveprovvederne una consistente 'campagna esterna'.
Un indice globale, che suggerisca la natura di questi nessicoinvolgendo tutti i centri della conca, è disponibile solo per ilprimo Ottocento: della tassa sulle patenti per fitti di case ebotteghe istituita dal governo francese e ammontante per Bari ecasali a ducati 11904, Bari paga quasi l'80 per cento, cioè grana49,3 per abitante, mentre i centri dipendenti pagano solo grana 6per abitante243. Ma si tratta di un fenomeno già visibile nellaprima età moderna. Lo stacco netto segnalato dai catastidell'epoca e sostanzialmente riconfermato nell'onciario, tra laconsistenza e l'articolazione della società extragricola barese equella degli altri grossi centri della provincia, è in larga parteda attribuire al parziale ricostruirsi attorno a Bari di un giocodi rapporti 'normali' tra città e campagna, che la geografia ainsediamenti grandi e radi, e quindi difficilmente collocabili ingerarchie direzionali, ostacola altrove.
Anche negli onciari affiora comunque l'esistenza di spazi periniziative manifatturiere in qualche caso consistenti. ARutigliano, che interrompe la regolarità della tabella 11 con lasua percentuale altissima di “artigiani e commercianti”, un grossogruppo di “telajoli” agisce su un terreno di dignità economicanotevole, investendo capitali considerevoli, legandosi in societàdi negozio, occupando un territorio vasto, con fondachi aperti aloro nome fino a Foggia o a Melfi244. Ancora una volta, però,243 Elaborazioni sui registri dei Ruoli delle patenti, in ASBA.
244 Su Rutigliano è da vedere un lavoro di prossima pubblicazione di A.Annarumma.
134
iniziative di questa natura tornano a presentarsi in quell'areasud-orientale relativamente defilata rispetto allo scambio a lungadistanza fra i prodotti delle monoculture provinciali e gliinvadenti carichi di ritorno; e del resto non sembra che esseabbiano un futuro davanti a sé245. Dal punto di vista qui adottato èpiù interessante notare i mutamenti che sembrano farsi largo ancheliddove l'inserimento organico nel mercato internazionale rendel'ambiente poco favorevole ad iniziative autonome. Se ancora ametà Settecento il grande porto granario di Barletta o lo stessocentro di produzione olearia di Bitonto stentano a dotarsi dielementi di 'urbanità' che le distinguano nettamente da centrimurgiani come Altamura o Gravina, le cifre per Trani e Molfettaraccontano una storia differente. Molfetta in particolare, che ametà Cinquecento ha una composizione socio-professionaleindistinguibile da quella di una agrotown dell'interno, presentadue secoli dopo modfficazioni significative che contrastano con lasostanziale immobilità di un centro agricolo come Palo o dellastessa Bari.
Quest'ultima rimane certo sempre nettamente più 'cittadina',ma il ridursi di 15 punti della percentuale di capifuocomolfettesi impegnati in agricoltura e l'irrompere del mare dentrola sua società, nella forma ancora ambigua dei marinai dicommercio che sono anche pescatori, segnalano che pezzisignificativi del modello insediativo provinciale stanno saltando.La collocazione costiera non è più inessenziale alladeterminazione del clima sociale complessivo, segna profondamentele partizioni professionali e finisce per coinvolgere anche ilmicrocosmo ecclesiastico. Il clero molfettese, in contrastostridente con quello coevo di Bitetto, sembra aver recuperatol''urbanità', il cervello svelto, l'indifferenza morale el'affarismo levantino dei Donno Gianni da Barletta: nel 1736 aMolfetta “non mancano degli ecclesiastici i quali guidatidall'abbominevole desiderio del lucro illecito, non hanno rossoredi commetter controbandi”, né hanno “rispetto alcuno, e riverenzaper le Chiese immettendo in esse le più sordide merci, che
245 Cfr. le inchieste del 18o8 e del 1842 in ASBA, f. Agricoltura industriacommercio, h. 15, fs. 6, e h. 8, fs. 6o bis. Vedi anche più in generale M. A.VISCEGLIA, Lavoro a domicilio e manifattura nel XVIII e XIX secolo: produzione,lavorazione e distribuzione del cotone in Terra d'Otranto, in AA.VV., Studisulla società meridionale, Napoli 1978, pp. 233-7 1 - Per un centro della stessaarca di Rutigliano cfr. P. SISTO, «Arti» e «Mestieri» a Putignano tra Sette edOttocento, in Storia e cultura in Tema di Bari. Studi e ricerche, a curadell'Ammmistrazione comunale di Conversano, Galatina 1987, pp.147-51.
135
vogliono traficare”, secondo una pratica autorevolmente promossanegli ultimi decenni del Seicento dal vescovo Loffredo, che pareusasse per contrabbandare olio e mandorle il suo palazzo eaddirittura il santuario della Madonna dei Martiri246.
Qui il nodo che si propone come ormai ineludibile è quellodelle forme assunte dal rapporto tra mercato internazionale edeconomia provinciale laddove esso prende corpo, si organizza,produce ceti sociali, interessi, istituzioni. Ma, a,questoproposito, l'esposizione deve cambiar registro, non può più esseresistematica, bensì essenzialmente narrativa. Il tempo circolaredell'agricoltura coglie solo in parte le scansioni e i ritmi diquesta faccia quantitativamente minoritaria della realtà, nellaquale alcune esperienze, competenze, funzioni, riescono a nonandar perdute nelle crisi, ad accumularsi lungo un itinerariotemporale a suo modo lineare.
In questa sfasatura dei tempi delle città rispetto a quellidelle campagne, la trama della nostra vicenda trova faticosamentemodo di procedere anche nei secoli della storia della provinciasui quali, per dirla con Giovanni Macchia, “sembra che sia calatoil silenzio”247.
3. Tra centro e periferia: le città costiere nella prima età moderna.
Certo al primo Cinquecento, il punto dal quale occorreriprendere a dipanare la nostra vicenda, le articolazioni dellamaglia insediativa provinciale appaiono ancora modeste e scarsigli elementi di polarizzazione. Il quadro sembra dominato dalprecipitoso processo di riduzione dei fattori di urbanità tardo-medievali che sembra oscurare ogni spiraglio di futuro.
Ma anche qui c'è un'articolazione di situazioni e,soprattutto, un loro trasformarsi nel tempo, nell'ambito di unastoria forse piccola e marginale, come affermano gli storiciabbagliati dagli splendori urbani tardo-medievali, ma che vale lapena di seguire per rintracciare nella lunga parentesi 'buia'dell'età moderna gli andirivieni e la direzione di fondo di unpercorso altrimenti inspiegabile. In particolare nelle cittàcostiere, più esposte al controllo direzionale esterno ma al tempostesso più coinvolte nella circolazione di modelli diorganizzazione della vita associata dei mondi 'centrali', saràpossibile rintracciare aspetti rilevanti del lento accumularsi246 TULLIO, Molfetta cit., note alle pp. 45 e 52.247 G. MACCHIA, La 'mia' Puglia, in Puglia unita, suppl. a «RassegnaPugliese»,1984, n. 1 -2, p. 11.
136
delle condizioni per la rottura delle permanenze della regione dietà moderna che, come spesso accade, trovano spazi nelle'anomalie', negli aspetti della realtà di cui i modelliesplicativi non riescono a dar conto pienamente.
Nel circuito del grano di prima età moderna non sembra cisiano segnali importanti in questa direzione. Le quantità“estratte” dal porto di Barletta sono la risultante di forze cheagiscono in direzioni opposte: la destinazione di una quotacrescente della produzione cerealicola al soddisfacimento deibisogni annonari di Napoli e il conseguente restringersi relativodelle esportazioni tendono a ridurre il ruolo di Barletta avantaggio di quello di Taranto, la quale ultima, meglio collocatarispetto alla capitale, diventa il porto di imbarco più importantedei grani della Murgia centro-meridionale; d'altro canto, lavirtuale scomparsa del porto di Trani tende a consegnare aBarletta pressoché per intero il sovrappiù granario della Murgiasettentrionale, che continuerà a lungo, e ancora nei decennicentrali del Seicento con un certo successo, a cercare sbocchiall'estero.
Ma non sta qui il nodo della questione. Grani esportati egrani destinati a Napoli sono mossi dalla stessa organizzazionecommerciale che non lascia spazi consistenti, a Barletta comealtrove, alla conversione delle funzioni di polo granario infunzioni urbane più complesse e generali. La produzione, nel campodel commercio dei cereali, di attenzione politica, disposizionilegislative ed amministrative e di un apparato che le applichi,produce al contempo ceti che sanno districarvisi agendo a ridossodei tempi e dei luoghi delle decisioni, avendo carte da giocaresul terreno più propriamente politico, collocando l'iniziativamercantile in un gioco nel quale operazioni finanziarie grandi epiccole, prestiti a Stati o università, acquisizioni diarrendamenti e feudi svolgono un ruolo preminente. La conquista diuna tratta o la realizzazione di un “partito” per Napoli è sempremeno alla portata del giro di influenze e del personale didimensione provinciale, e se, quando si distribuisce grano lungola costa adriatica in carichi di poche carra, riesce ad emergerefra i mercanti un nome locale, quasi mai ciò accade per grossequantità248: nel 1509 ad esportare grano da Barletta sonosoprattutto il mercante napoletano Paolo Tolosa, la contessa diCaserta e quella di Francavilla rappresentata dal genovese Daniele248 Cfr. il Registro del Regio Secreto e portolano di Terra di Bari e Capitanataper il periodo 1° settembre 1533 - 9 aprile 1534 in ASNA, f. Dipendenze dellaSommaria, Il, b. 78, fS. 25.
137
Centurione249; nel 1537 ad accaparrarsi le tratte sono spagnoli,mercanti napoletani, enti ecclesiastici, baroni250; nel 1571 le navigranarie partite da Barletta e predate dai veneziani viaggiano inlarga parte per conto di genovesi, e solo 5 carra vi sono statecaricate dai tranesi Palagano251.
I genovesi in particolare, grandi finanziatori dell'impero,spagnolo, conquistano posizioni sia perché legati in mille modiall'apparato centrale, sia perché, quali titolari di feudisolidamente insediati in zone granifere, dispongono di importantiquantità di sovrappiù loro conferito nella forma di decime eterraggi. Non che gli interessi in questione formino un bloccocompatto capace di transitare senza danno nell'alta e bassacongiuntura. I flussi di investimenti speculativi che da Napoli sidirigono verso i produttori granari come anticipi “alla voce”,passando tramite Barletta252, nuova stanza di compensazione dopol'eclissi di Trani, si incagliano nella selva delle prammaticheannonarie dei decenni a cavallo tra Cinque e Seicento; al tempostesso, la crisi produttiva e la disorganizzazione delle rottegranarie tradizionali, come abbiamo visto, tendono a rilanciareanche al di là della volontà dei soggetti coinvolti il ruolo delbaronaggio provinciale vecchio e nuovo nella circolazione deiprodotti. Allo scopo di garantire m una qualche maniera unarendita feudale pesantemente attaccata dalla crisi, occorre che ibaroni assistano finanziariamente l'azienda evitando ai massari ilviaggio oneroso fino a Barletta a caccia di anticipi non sempredisponibili, si assumano l'onere di trovare un mercato al prodottodei propri massari, “facciano masseria” loro stessi che “conmaggior avvantaggio son serviti, rispettati” e riescono a nonpagare gabelle alle università, ad evitare i diritti di passo, amanovrare le tratte, a trasportare il grano ad esempio alla Doganadi Salerno con i propri muli e carri, quando Barletta si intasa digrani invenduti253. L'emergere nei decenni a cavallo tra Cinque eSeicento di personaggi come l'ebreo portoghese Michele Vaaz, dal1613 conte di Mola, fornitore dell'annona napoletana ed249 COLAPIETRA, Genovesi cit., p. 22.250 SANTERAMO, Il R. Secreto cit., pp. 233-354251 COLAPIETRA, Genovesi cit., P. 34.252 Il ruolo di piazza finanziaria di Barletta va al di là dei confini dellaprovincia: cfr. il contratto con cui alcuni massari lucani si dichiaranodebitori nei confronti di un privato napoletano per ben 200O ducati, da pagarein Barletta, in AS Potenza, notaio Marco de Amatis, Melfi, atto del 20 giugno1588. Contratti di anticipazione di denaro in cambio di grani futuri in VISTA,Note storiche cit., vol. XI, PP. 49-57.253 ZOTTA, Le vicende agrarie cit., pp. 264-65.
138
esportatore di grano254, e la sfida aperta portata negli anni '40all'affarismo mercantile napoletano degli Aquino e dei Medici daigrandi feudatari provinciali, con alla testa il principe diMinervino255, sono dal nostro punto di vista elementi emblematici.
In questa dialettica gli spazi praticabili dall'elementomercantile provinciale rimangono comunque estremamente limitati.Nei registri della tassa dell'arboraggio pagata a Barletta neidecenni centrali del Seicento o nei contratti di compravendita dicereali256, i locali appaiono marginali financo nel ruolo che nelCinquecento li aveva visti ancora attivi, di armatori e capitanidi imbarcazioni da commercio; e se nel fronte che nel 1641 ilprincipe di Minervino va organizzando contro i grandi monopolistinapoletani allo scopo di strappar loro un “partito” di 400 000tomoli, è presente, oltre al duca di Bisaccia, al principe di SanSevero, al conte di Conversano, anche qualche incettatore locale,questi si colloca in posizione del tutto marginale, e comunque nontale da dare il segno di un coinvolgimento consistente diinteressi provinciali. Nel clima confuso del 1648 lo stesso contedi Conversano si sarebbe presentato con i suoi armati sotto lemura di Barletta, ma le porte non gli sarebbero state aperte: egli“teneva impegnate in detta terra da 30000 ducati d'argento etgioie, per certe navi c'aveva esso fatte caricare due mesiaddietro per li bisogni di Napoli”, e si temeva che, entrando incittà, “avrebbe fatto una tassa tra tutti i nobili e personecommode [...] et riscattatesi le sue argenterie et gioie con listessi denari de' Barlettani”257. Quando sono manovrati da possentibaroni, i grandi flussi mercantili che attraversano Barletta nonvi lasciano tracce più consistenti di quelle lasciatevi dagliAquino e dai Medici.254 Cfr. M. SIRAGO, L'inserimento di una famiglia ebraica portoghese nellafeudalità meridionale: i Vaaz a Mola di Bari (circa 158o-1806), in «Archiviostorico pugliese», 1987, PP. 119-58.255 ZOTTA, Le vicende agrarie cit., p. 266; VISCEGLIA, Sistema feudale e mercatointernazionale cit., p. 81256 Vedine alcuni in VISTA, Note storiche cit., vol. XI, PP. 87 sgg. La naveSant'Andrea, capace di 400 carra di grano, in quarantena nel porto di Barlettanel periodo della peste, può essere emblematica della condizione di subalternitàdella provincia nel circuito cerealicolo: essa è comandata da Rinaldo de Nicolò,olandese, è di proprietà di Giovanni Vandeneynde, fiammingo abitante a Napoli,ed è stata noleggiata da Vincenzo de' Medici per caricare grano a Barletta oManfredonia (cfr. il documento VIII in appendice a S. SANTERAMO, La peste del1656-57 a Barletta. Monografia storica dedotta da documenti editi e inediti,Barletta 1912, PP. 148-50).257 G. E. PYRRIS, Cronaca della città e provincia di Bari negli anni 1647 e 1648,Trani 1894, P. 39.
139
Una situazione a prima vista non dissimile caratterizza ilcircuito dell'olio. Come abbiamo visto, le comunità marittimedella provincia olearia sono scarsamente specializzate econsistenti, cosicché, come accade nel porto di Santo Spirito nel1605-606258 navi e capitani veneziani e ferraresi sono protagonistipressoché esclusivi; e allo stesso modo, nel campo dei mercanti,gli spazi lasciati liberi da Annibale e Giovanni de Paú di Napolisono occupati solo in parte dai Bove, dai Rubino, e da altriesponenti della gloriosa tradizione mercantile bitontina, cheprobabilmente si situano in posizione ormai subordinata in unamacchina mercantile controllata da forestieri.
Con i catasti cinquecenteschi più discorsivi la subordinazionedell'elemento locale emerge senza incertezze: a Bisceglie unmastro Francesco Gesia “dispende de soi denari in comprar ogli,amendole et altre mercantie, circa 30o docati de soi denariproprij et anco dispende denari de diversi mercanti in detta cittàin grossa summa in ogli et altri frutti: quali se inviano perVenetia et altre parti; per li quali denari ne riceve esso per suefatiche dui per cento”; a Molfetta un Francesco Antonio de Bergamodichiara di “comprare ogli in nome di altri”259.
Gli esempi potrebbero moltiplicarsi, ma rischierebbero dicostruire un'immagine fuorviante, di offuscare le differenze fraquesto circuito e quello del grano. Le raggrupperei intorno a duenodi. In primo luogo la struttura dello scambio qui si presentapiù mossa: la geografia dei porti di imbarco è più policentricache nel settore cerealicolo, quella dei porti di sbocco - ancorain larghissima parte collocati all'estero - più variegata, ilventaglio delle merci imbarcate assieme a quella fondamentale piùampio.
I dati a disposizione sono troppo scarsi perché sia possibilefissare una gerarchia rigida dei porti oleari ai due capi dellerotte. Qualche indicazione ci viene dai dati del biennio 1554-56,nel quale poco meno della metà delle esportazioni di olioprovinciale passa da Bari (30287 salme su 68590). Ma non mancanonella provincia altri porti notevoli: Molfetta esporta, nellostesso biennio, 17453 salme, Giovinazzo 7070, Monopoli 6534, SanVito di Polignano, poi soppresso nel 1642, sottrae navi a Monopolie a Mola esportando 1845 salme260; e anche l'altro caricatoiosoppresso nel secolo seguente, quello di Santo Spirito di Bitonto,258 ARCHIVIO GENERAL DE SIMANCAS, Visitas de Italia, legajo 85, « Nota dell'ogliestratti dal porto di S. Spirito [...] in questo presente anno 16o5 ».259 POLI, Società e struttura Professionale cit., P. 79.260 MANTELLI, Burocrazia efinanze pubbliche cit., pp- 241-43.
140
non doveva essere trascurabile, dato che nell'anno 1605-606 vi siimbarcano 2538 salme261. D'altro canto, lo si è accennato, l'olionon viaggia da solo nelle navi che risalgono l'Adriatico. Fra ilsettembre 15 7 1 e l'agosto 15 7 2 dal porto di Bari escono, oltrea 9071 salme d'Olio, 2017 libbre di seta, 911 libbre di zafferano,133 cantaia di sapone bianco, 4934 tomola di seme di lino, 175libbre di manna, 366 botti di vino e 233 botti d'aceto. A partepraticamente tutto il lino e 76 botti di aceto destinati a Corfú eLepanto, il tutto va a finire nei porti dell'Adriatico centro-settentrionale. Ferrara e Venezia costituiscono lo sbocco piùimportante, essendo ad esse destinate rispettivamente 4114 e 3306salme d'olio più l'intero ventaglio delle merci minori; a unadistanza notevole si collocano Trieste e Ragusa (rispettivamentesalme 1029 e 448), e infine i porti dalmati - Lesina, Spalato,Veglia, Zara, Lagosta - nei quali vengono inviate 149 salme262.
Non paia, questo rimestare nelle poche acque del “golfo diVenezia”, un segno di marginalità rispetto ai grandi orizzontimercantili: l'Adriatico rimane nel Cinquecento una via maestra deitraffici che penetrano tentacolarmente, a partire da Venezia,nell'entroterra europeo. La provincia olearia è così in rapportodiretto col centro del mondo che risucchia pressoché per l'interoanche la produzione di Terra d'Otranto: non a caso la costa ionicadi quella provincia, con Gallipoli e Taranto, è a metà secolo diimportanza trascurabile rispetto alla costa adriatica, dove siaffacciano i porti di Ostuni, Brindisi, Otranto, e soprattutto ilcaricatoio di Lecce, San Cataldo, che con 40600 salme esportatenel biennio 1554-55 supera nettamente la stessa Bari.
Certo questa persistenza a ridosso dell'area centrale nelclima nuovo del Mediterraneo cinquecentesco ha costi pesanti:anche nel circuito dell'olio i rapporti mercantili si sonopoliticizzati, la dipendenza è più rigida, la presenza stranierain ruoli direzionali pressoché esclusiva.
E pur tuttavia - è questo il secondo elemento didifferenziazione sostanziale rispetto al circuito del grano -tutto ciò non disegna una situazione priva di spiragli perl'imprenditoria locale. Qui pure si crea un rapporto fra genovesie settori della società locale sul piano dell'intreccio trafinanza e politica, come in occasione dell'attribuzione della
261 14 Cfr. sopra, p. 126, nota 11.262 CONIGLIO, Il Viceregno cit., pp. 81-87; G. FENICIA, Le esportazioni di olioin un porto Meridionale in età spagnola: il porto di Bari nel 1571-72, in«Archivio storico pugliese», 1987, pp. 83-101.
141
percettoria provinciale a metà Cinquecento263 ma iniziative eaggregazioni diverse non ne risultano soffocate. Il rapporto tralivelli alti dello scambio e quelli inferiori non è stretto enecessitato; il movimento di capitali speculativi e influenzepolitiche non trascina sempre dietro di sé, in posizionesubordinata, il movimento delle merci, che è spesso nelle mani diprotagonisti diversificati. Il predominio di Venezia, che si eraespresso nel trattamento preferenziale accordato nei portipugliesi alle sue navi e alle sue comunità mercantili, nell'uso inPuglia delle unità di misura venete, e fin nell'occupazionemilitare di alcune città costiere della provincia, comincia avenir meno a metà Cinquecento, con la svolta anti-veneziana nellapolitica doganale dello Stato meridionale e con l'emergere nelloStato veneto di una normativa annonaria e fiscale che rende ancorapiù difficile reggere, nelle nuove condizioni, il suo secolareruolo di tramite mercantile fra coste lontane e vicine delMediterraneo. Gli spazi che si aprono nei porti oleari pugliesisul piano dell'imprenditoria specificamente mercantile vengonooccupati solo in piccola parte da imprenditori locali - solo il9,3 per cento dell'olio esportato nell'anno 1571-72 è controllatoda baresi e solo il 4,6 per cento si muove su navi locali, diMola; ma tutto il resto non è appannaggio esclusivo di genovesi efiorentini, bensì di una varietà di comunità forestiere chesembra far riemergere la secolare stratificazione di presenzerealizzatasi nei porti pugliesi, una condizione nella quale gliultimi arrivati non soffocano gli altri, ma vi si aggiungono. Igruppi mercantili forestieri che agiscono a Bari nel 1571-72ridisegnano quella situazione quattrocentesca di indefinizionedelle egemonie che sembrava tramontata col tramonto delpredominio veneziano.
Le presenze forti certo esistono: 3 ferraresi, 1 bergamasco e1 napoletano commerciano più del 50 per cento dell'olio barese,che però per il resto si disperde fra una miriade di acquirenti. Iforestieri che esportano derrate sono quell'anno 128, e fra diessi sono naturalmente consistenti le presenze correlate ai portidi sbocco: i ferraresi sono 43,1 veneziani 13, i triestini 11, iragusei 8, gli altri dalmati 9,2 di Corfú; ma accanto a costorotroviamo ben 20 mercanti di Bergamo e poi 8 di Milano, 5 diFirenze, 4 di Bologna, 2 di Modena e altrettanti di Brescia, einfine un solo genovese264.
263 COLAPIETRA, Genovesi cit., pp. 28-29. 264 Cfr. nota 15.
142
Gli esportatori attivi sono spesso immigrati recenti etemporanei che vivono nella città in una condizione intermedia frala società della madre patria, con la quale sono in continuocontatto per organizzare spedizioni, e le comunità forestierelocali, stanziate a volte da secoli, che coltivano la propriaidentità tramite un culto delle origini, il raccogliersi in vie equartieri stretti attorno alla propria chiesa. La città, perdutala sua arti colazione spaziale per mestieri, di cui a fineCinquecento rimane traccia nell'onomastica stradale, presenta unasua suddivisione, per così dire, per etnie, che però non harigidità, fondamenti ideologici, e fa riferimento all'esigenzalaica di salvaguardare privilegi mercantili e giurisdizionali, chea volte risalgono molto indietro negli anni265. Così nel mentre igenovesi si muovono pressoché esclusivamente nel circuitopolitico-finanziario incontrandovi solo gli strati più alti dellasocietà locale, i gruppi forestieri impegnati nella compravenditadell'olio sembrano tenere ancora saldo il filo di quellatradizione tardo-medievale che aveva costruito in ogni porto unacomunità articolata per provenienze ma unita da una koiné dipratiche mercantili, di valori, di comportamenti. Di qui il lorointrecciarsi reciproco e il percolare verso il basso della societàlocale oltre che lo scalare posizioni verso la condizionearistocratica, tramite alleanze matrimoniali e affaristiche, inpiccole imprese artigiane e soprattutto di distribuzionequalificata al dettaglio, sostenute dai carichi di ritorno dellenavi olearie.
Del resto questa permeabilità reciproca di forestieri eprovinciali è stimolata dal fatto che nella società locale, fra iceti protagonisti della caccia al feudo e della chiusuraoligarchica dei seggi da un lato, e le masse dei lavoratori deicampi dall'altro, continua ad agitarsi quello strato relativamenteconsistente al quale, come abbiamo visto, è affidatal'organizzazione essenzialmente urbana della vita produttivaagricola. A cercar bene al suo interno, anzi, ci si accorge cheuna qualche funzione non del tutto subalterna nellacommercializzazione dell'olio è rimasta nelle mani dell'elementolocale. La presenza diffusa, a differenza che nellacerealicoltura, del produttore minimo accanto al grandeproprietario, permette lo svolgersi di un gioco mercantile suquantità piccole e piccolissime che ci viene vividamente265 Cfr. T. PEDIO Bari tra il XVI e il XVII secolo (note e appunti ditoponomastica barese), in « Archivio storico pugliese», 1974, pp. 381-452;MASSA, La vita privata a Bari cit.
143
restituito dagli atti notarili266 un incrocio di scommesse sulprezzo futuro che non mette subito capo a forme ordinate diaccaparramento, ma che ha la funzione di realizzare una primacentralizzazione dei prodotti dalle mani delle migliaia dicontadini a quelle delle centinaia di sensali, di grandiproduttori che aggiungono olio altrui al proprio, di possessori dipiscine e trappeti, nella quale non necessariamente denari edagenti dei mercanti forestieri hanno una funzione preminente.
Né tutti i centri produttori minori ai margini delle zone acoltura intensiva sono coperti direttamente dalla rete mercantileche fa capo agli esportatori. Bari è solo un porto di imbarco peri mercanti forestieri e locali di un grosso centro oleario comeModugno, i quali nel primo Seicento “comprano ogli o altri fruttinascentino in lo territorio di ditta città tanto per loro proprioconto quanto per conto d'altri mercanti d'extra regno chedirettamente ad essi comettono comprare ogli ed altri frutti”; maessa costituisce una vera e propria piazza di contrattazione per i“vaticali” che partono dai casali della conca portando sul carroqualche soma d'olio lì acquistata, entrano in città lasciando unpegno alle guardie daziarie e lo recuperano all'uscita, mostrandoloro l'olio rimasto invenduto e, per quello finito nelle piscine odirettamente nelle navi degli acquirenti, i certificati dipagamento dei diritti di piazza267“.
Così questi flussi, pur sempre eterodiretti, investono unaparte della società urbana ben più consistente di quella investitadai flussi cerealicoli. Se le sorti di Barletta o di Gravina sonoconnesse all'andamento della produzione del proprio territorio piùche alle funzioni mercantili urbane, la crescita delle presenzealla fiera barese di San Nicola (cfr. fig. 5) e lo stesso slanciodemografico che porta la città nel secondo Cinquecento nelleposizioni di testa fra i centri provinciali, appaiono legati anchealla crescita della sua posizione di polo mercantile oleario.
Figura 5.
Introiti per fitto di botteghe ed altri diritti, esatti in
266 Cfr. l'appendice a L. PALUMBO, Aspetti della vita economica a Molfetta nel1535, in Atti del Congresso internazionale di studi sull'età del Viceregno Cit.,pp. 250 sgg.267 Cfr. la supplica contro le nuove « gravezze » fiscali imposte ai mercanti nelporto di Bari dal visitatore delle dogane di Puglia nel1612, in ARCHIVIO GENERALDE SIMANCAS, Visitas de Italia cit., legajo 85.
144
occasione della fiera di San Nicola di Bari, 1545-99 (numeri-indice).
Fonte: dati elaborati su Archivio della basilica di SanNicola, Bari, b. “Fiere 1500-1879”.
La fila di agrotowns costiere incapace di esprimere gerarchieforti al loro interno e nei confronti dei grandi centri produttorimurgiani presenta così una sua differenziazione. Qui la si èvoluta sottolineare vigorosamente perché essa allude a un futuroche, a leggere la realtà col senno di poi, pare in larga partescritto nelle articolazioni del presente cinquecentesco.
4. Le città costiere nel Sei e Settecento.
Nelle città olearie di Terra di Bari il Seicento porta, da unlato, una diminuzione della domanda internazionale, dall'altro,con la marginalizzazione dell'Adriatico e di Venezia, unoscivolamento della provincia al di fuori dell'area centraledell'economia mondiale, che Terra d'Otranto evita agganciandosi,tramite Gallipoli in particolare, ai traffici delle navi del nord,dove va dislocandosi il nuovo 'centro'. Le strade dei due pezzidella Puglia olearia si divaricano qui e ciascuna incontreràproblemi e opportunità diverse.
Quelli di Bari e degli altri centri costieri provincialisembrano nell'immediato di difficile soluzione. L'arretramentodemografico leggibile al di sotto della rigidità delle numerazionidei fuochi, la diminuzione del gettito delle gabelle268, il calodegli introiti della fiera di San Nicola269, esprimono una crisi noncompensata in alcuna maniera, come altrove, dal diffondersi diattività marginali e manifatturiere, un malessere di fondo che lefonti non quantitative ci restituiscono vividamente.
L'intera scena urbana si va modificando. Nel mentrel'articolazione dello spazio cittadino per etnie viene meno colritorno dei forestieri in patria e lo sciogliersi nella società diquanti rimangono, determinato dall'indebolirsi delle spinteall'aggregazione autonoma - i rapporti mercantili con lamadrepatria e i privilegi - esso si va minuziosamente268 A Bari fra il 1610 e il 1644 cala del 31 per cento (MASSA, Bari nel secoloXVII Cit., pp. 19-20)269 Archivio della basilica di San Nicola, Bari, b. «Fiere 1500-1879» Cit.
145
gerarchizzando e regolamentando perché vi risultino immediatamenteleggibili i valori e gli ordinamenti sociali antimercantilifattisi vigorosamente largo già nel Cinquecento e ora trionfanti.L'ordine spaziale aristocratico può essere impunemente trasgreditosolo dalle espressioni rituali della disperazione di massa e dellapietà barocca - i tumulti per la fame del 1622 o le processionidei flagellanti del 1648 per invocare la pioggia270 - per poitornare a regnare rafforzato. In esso un artigiano ha minorelegittimità di un “ciarmatore”accompagnato da un uomo assunto perun anno in cambio dell'apprendistato, vitto, alloggio, vestito,una scatola di serpi e una chitarra271, e una donna che si dia alla“vita lasciva” può essere condannata come “magara”dal vescovo,rinchiusa in un campanile e poi finire “sepellita dietro litrappeti al lido del mare”272.
I trappeti e il mare alludono a potenzialità che la crisi el'aristocratizzazione non escludono completamente, anche perchéalcune dimensioni della tradizione mercantile provinciale riesconoa trovare collocazione dentro il quadro dei nuovi valori. Per chiè nobile o aspiri ad esserlo, anche l'aver esercitato laprofessione di notaio può essere disonorevole, ma ci si puòdifendere efficacemente dall'accusa di aver avuto un avo venditoredi saponi. Un suo progenitore vissuto un secolo prima, afferma ametà Seicento Giovanni Antonio de Ildaris di Bitonto, che chiededi essere proclamato cavaliere di San Giovanni, l'aveva fatto “peressere ogli che si fanno nelli [suoi] possessi e non trovandosi asmaltire e ritrovandosi talora guasti è necessario per esitarliche [se ne facciano] saponi [...] e questo si fa da ogni personanobile, e ricca di stabile senza eccetione alcuna”273.
I due prodotti fondamentali di questa terra, olio e grano, noncontaminano, non disonorano, non sconsacrano: piscine, fosse etrappeti, spesso collocati sotto i palazzi nobiliari, al limite lechiese da usare come capaci magazzini, forse non sono più o nonsono ancora segno di 'avidità', di volontà di accumulazione, manon possono non rimanere attive in una congiuntura che non riescepiù ad assicurare rendite tranquille, che non ha più produttoridocili e acquirenti sicuri e impone, a sostegno della costosissimascenografia aristocratica, un impegno più diretto dei gruppi
270 MASSA, Bari nel secolo XVII cit., appendice, P. 48; PYRRIS, Cronaca cit., pp.48-53.271 Contratto riassunto in MASSA, Bari nel secolo XVII Cit., appendice, P. 71.272 ASNA, Archivio Volpicella, b. 2 1, miscellanea di Manoscritti, cc. 67r-68v.273 A. SPAGNOLETTI, Forme di autocoscienza e Vita nobiliare: il caso della Pugliabarese, in « Società e storia 1983, n. 19, pp. 56-57 e 66, nota.
146
dominanti nella produzione, trasformazione e circolazione deiprodotti monetizzabili, anche a costo di esporsi a rischi pesanti.Nel clima acceso del 1648 il fiandrese Giacomo della Palma, “perriscuotere molte migliaia di docati ch'esso aveva dati per oglio eper avere robbe”, va a Bitonto, riesce a farvi capopopolo il suoservitore e induce i popolani, in cambio della metà del ricavato,a sequestrare “tutte le olive da dentro li trappeti et tuttil'ogli et robbe delli suoi debitori, li quali, la maggior parte,erano nobili”. La situazione si fa incandescente e costororiescono a salvare i propri averi solo convincendo il popolo adattingere denaro direttamente dalle tasche capaci del fiandrese,il quale finisce - il nostro cronista è incerto in proposito -suicida o ammazzato274.
Le cose non sono sempre così truci. Il punto essenziale ècomunque che la crisi non induce solo passività, disprezzo per ladimensione economica, rassegnazione all'impoverimento; essa haeffetti ambigui, esiti non pre-determinati, anche perché asostenere e a far da contorno alle iniziative dei potenti c'èquella società urbana intermedia, di dimensioni ridotte maattivissima, che sosteneva i traffici cinquecenteschi e permettevaall'agricoltura commercializzata di funzionare, e che non èsvanita nel nulla. Crisi e marginalizzazione chiudono molteprospettive ma ne aprono altre, in un certo senso più alla portatadell'imprenditore non blasonato della nostra 'periferia interna'.
Già nel secondo Cinquecento le alterne vicende delle politicheannonarie e le difficoltà della comunità mercantile venezianaavevano cominciato a consegnare nelle mani dei mercanti regnicoliparti non inconsistenti delle “facende de ogli”275.
Ma è soprattutto l'impoverito mercato oleario dell'Adriaticoseicentesco ad offrire occasioni preziose. Nel mentre i mercantiveneti percorrono la parabola che da “monopolizzatori” delcommercio oleario pugliese li porta a diventare “incettatori especulatori per finire nelle posizioni di semplici importatori ecommissionari”276, un pugno di mercanti provinciali si arrischia nelgioco senza rete dell'esportazione in proprio, su marciliane efregadoni comprate dai cantieri veneti o su quelle noleggiate daFermo: nel 1669 sono 12 le barche pugliesi che trasportano olio aFerrara, nei primi anni '70 cinque proprietari pugliesi dimarciliane si impegnano a far transitare da Venezia invece che daFerrara 8000 salme di olio destinate in Lombardia in cambio di una274 PYRRIS, Cronaca cit., p. 26.275 MATTOZZI, Crisi, stagnazione e mutamento cit., p. 221.276 Ibid., p. 239.
147
riduzione delle tariffe doganali; sulla stessa rotta di Ferraranel 1694 si muovono, oltre a io bastimenti di Fermo e uno diFiume, due imbarcazioni di Bari, una di Giovinazzo e quattro diMolfetta277. E sono soprattutto i molfettesi ad approfittaredell'allentarsi della presa delle navi della “dominante” sul suomare: a metà Seicento marciglianette e tartanelle vanno e vengonoda quella Dalmazia che era stata gelosissimo presidio veneziano,trasportandovi, assicurate con ditte baresi, olio e legumi perconto proprio e in qualche caso per conto altrui, riuscendo avolte a smerciare quantità notevoli - ben 8000 salme d'olio nel1657 se la nostra fonte non ci inganna278.
Non sono certo, queste, iniziative che possono modificare idati di fondo della condizione economica della provincia, tantopiù che, afferma un documento veneto della metà del secolo, “licittadini nelle città marittime di regno [che] inclinano per lopiù alla navigazione d'ogli [...] non possedono per il più facoltàdi poter attendere a simil mistiero, se non fossero soccorsi dallecase di Venezia di denari che a non lieve interesse vengonoaccomodati”279. Con ciò il rischio altissimo iscritto nellecondizioni del mercato seicentesco si ingigantisce, e nelsuccedersi di fallimenti di case commerciali veneziane negli anni1650-52 può rimanere coinvolto anche chi fosse riuscito adiventare “mercante grossissimo”, come quel Nicolò Casino di Bari che “mancò in più di 100000 ducati essendone mancati molti inVenezia et Napoli”280. Ma c'è anche chi riesce a non soccombere, efinanco chi, avendo alle spalle un possente barone quale donGiulio Acquaviva, osa insidiare negli anni '70 l'ultimo presidiodella comunità mercantile veneta nel circuito oleario, quellodella redistribuzione del prodotto nella terraferma, offrendo incambio di rivitalizzare il porto languente della “dominante” conl'importazione di 20000 salme d'olio l'anno provenienti dai feudidell'Acquaviva281. Il tentativo fallisce, ma è indicativo dellepossibilità che il vuoto di potere creato dalla marginalizzazionedell'Adriatico e dal collasso di Venezia offre all'intraprendenzadi Terra di Bari anche in una situazione di difficoltà generale.
I modi in cui ciascun porto della costa olearia provincialeera andato occupando gli spazi apertisi diventano visibili nei
277 Ibid, pp. 252-53, 259.278 TULLIO, Molfetta cit., P. 43, nota; PALUMBO, Vicende agrarie edorganizzazione ecclesiastica cit., p. 90279 MATTOZZI, Crisi Cit., P. 271, nota.280 PYRRIS, Cronaca cit., p. 82.281 MATTOZZI, Crisi Cit., Pp. 271-72.
148
primi decenni del Settecento. A prima vista il quadro generale delcommercio di esportazione di olio della provincia si presentaincupito, irrigidito: non solo, come abbiamo visto, le quantitàcommercializzate complessivamente sono diminuite, ma gli sbocchisi sono ristretti ulteriormente, e la gerarchia dei porti risultamolto meno accentuata. Negli anni di slancio congiunturale delladomanda di olio tra il primo e il secondo decennio del Settecento,dal porto di Bari si esportano in media 5700 salme282 ben lontanedai dati cinquecenteschi disponibili, e d'altro canto, stando aidati per il 1721 e il 1732283 la sua egemonia sugli altri portiprovinciali è fortemente indebolita, minacciata in particolare daMonopoli (cfr. tab. 12).
Tabella 12.Olio esportato (in salme) dai porti di Terra di Bari.
1721 1732
Bisceglie 1409 3260Molfetta 3089 4712Giovinazzo 651 2486Bari 5175 5548Mola 325 1140Monopoli 4899 7979
E se gli sbocchi dell'olio imbarcato in quest'ultimo portopresentano ancora una qualche articolazione ed è possibile chequalche nave partita di lì vada a finire, con capitano genovese ofrancese, fino a Marsiglia, la preminenza di Ferrara è altrove, aBari in particolare, assoluta (cfr. tab. 13).
Tabella 13.282 A. DI VITTORIO, Gli Austriaci e il Regno di Napoli, 1707-1734. Ideologia epolitica di sviluppo, Napoli 1973, tab. p. 269.283 ASNA, f. Dipendenze della Sommaria, I, b. 348, fs. 3; f. Percettori etesorieri provinciali, fs. 5645.
149
Distribuzione delle navi e delle quantità esportate per porti didestinazione, 172 1 (A = numero navi; B = % salme).
Ferrara Trieste Venezia Porti DalmatiLivorno GenovaA B A B A B A B A B A B
Bisceglie 8 75 - - - - 1 1,8 - - 1 23,1
Molfetta 14 92 1 8 - - - - - - - -Giovinazzo 6 51 1 7 2 40 1 2 - - - -Bari 27 100 - - - - - - - - - -Mola 7 97 - - - - 1 3 - - - -Monopoli 11 67 - - 1 1,4 - - 3 29 - -
Totale 73 84 2 2 3 3 3 0,3 3 9 12
Tabella 14.
Navi e merci giunte a Trieste dai porti pugliesi, battentibandiera napoletana, dal 1° novembre 1776 al 31 ottobre 1778.
Fonte: HOFKAMMER ARCHIV, Wien, Kommen-Litorale, Rote Nummer582, “Tabel1a dei bastimenti distinti secondo le nazioni arrivatinel porto di Trieste dal io novembre 1776 sino li 31 ottobre 1777”e “Tabella... dal i' novembre 1777 sino il 31 ottobre 1778”.
Numeronavi
da Manfredonia 13 cappari, comino, lana, libri, manna, pellidi agnello, seta, stracci, altro
Barletta 9 sale, olio, moscato, fave, legumiTrani 1 legna da fuocoBisceglie 6 mandorle, tartaro, olio, legumi, carrube, fichi,
orzoMolfetta 27 olio, mandorle, carrube, stracci, pelli,
manna, tartaroGiovinazzo 17 olio, mandorle, carrubeBari 27 olio, tartaro, mandorle, carrube, pelli,anici, fichi, zizole, finocchi, aceto, comino, seterieMola 29 olio, mandorle, carrube, stracci, pelli, linoMonopoli 13 olio, mandorle, pelli, liquirizia, anici, carrube,
manifatture di cotone, manna150
Gallipoli 2 mandorle, biancheria di cotone, seteria
Quello di Ferrara appare come un lunghissimo interregno fra laprevalenza cinquecentesca di Venezia e il rapido emergere diTrieste a partire dalla metà del Settecento. L'imporsi di Triestenon comporta in alcun modo una diversificazione degli sbocchi edelle merci esportate, né un aumento delle quantità eun'accentuazione della gerarchia fra i porti, a parte forse unqualche ridimensionamento di Monopoli a vantaggio della vicinaMola (cfr. tabb.14-15). Il Settecento si conferma dunque come unsecolo sprecato sotto il profilo quantitativo.
Ma lo è anche sotto quello qualitativo delle forme diorganizzazione mercantile, dei modi di inserimento della provincianel mercato internazionale? Vista da quest'ultima angolazione, lasituazione dei porti oleari si presenta ampiamente diversificata,così come sono diversificate le aree di gravitazione di ciascunodi essi sotto il profilo delle egemonie sociali al momento dellacircolazione del prodotto.
Tabella 15.Olio esportato da Bari, Monopoli e Molfetta, vari anni
(salme).
Fonti: il dato del 1801 per Bari e Monopoli e quello del 1795per Molfetta sono tratti da ASNA, f. Dipendenze della Sommaria, b.381; gli altri riguardanti Bari da P. Trizio, Commercio e marinamercantile di Terra di Bari in Adriatico tra '70o e '80o, tesi dilaurea discussa presso la facoltà di Lettere e filosofiadell'Università di Bari, a.a. 1985-86; quelli di Molfetta daTULLIO, Molfetta cit., P. 41; quelli di Monopoli da CHORLEY, Oilcit., P. 29, nota.
Bari Molfetta Monopoli
1783 - - 2576....1788 - 2428* -1789 - 3458 -1790 - 6766 -...1792 3380 - -
151
1793 4615 - -1795 - 5145 4118....1801 3535 - 24031804 - - 180o1805 3500 - 20151806 5694 - -1807 9753 - -1808 7288 - -
*Parziale.
In quella del porto di Monopoli, la presenza baronale èsignificativa: spesso i feudatari dei luoghi vicini ed i loroagenti esercitano la funzione della centralizzazione del prodottogiungendo a toccare i singoli contadini, e lo trasformano intrappeti di virtuale monopolio baronale, cosicché lo spazio perfigure intermedie autonome appare ridotto già nella faseprecedente l'imbarco. In quest'ultima, data la dimensione notevoledelle partite, l'olio viene affidato a grossi mercanti forestierio locali o agli intraprendenti nuovi baroni di Polignano, inapoletani de Lieto: nel 1716 il sindaco di Polignano afferma che“tutti l'ogli nati dalli feudi dell'ecc.ma casa di Conversano,come altri d'assignamento”, sono stati venduti dal conte al baroneGiuseppe de Lieto, il quale, oltre ad avviare un'opera ditrasformazione fondiaria e di olivetazione delle terre del suofeudo, acquistate quando erano “quasi tutte incolte e sterili”,compra “ogni anno [...] tutti l'ogli che si sono raccolti neldistretto di detta città e tutti l'altri frutti, con far ancorcompra d'altri ogli e frutti forastieri”284. Così nel 1721 i deLieto esportano da Monopoli per Livorno e Ferrara ben 1620 salmed'olio, un terzo circa dell'olio complessivamente esportato daquel porto, e nel 1732, quando la contessa di Conversano inviadirettamente olio all'estero per 400 salme, essi esportano 620salme da Monopoli e 322 da Bari. Gli altri protagonisti dellavicenda mercantile della città sono i locali enti ecclesiastici,mercanti forestieri come il napoletano Bartolomeo Intieri (500salme nel 1721), o mercanti baresi come Nicola Introna, il qualenel 1716 è di gran lunga il maggior possessore d'olio della cittàdato che conserva nelle sue piscine 1100 salme su un totale di
284 ASNA, f. Attuari diversi, b. 188, fS. 28.152
4636 presenti a Monopoli285. Non che siano assenti figure locali, mail loro ruolo appare secondario e il loro profilo è quello, piùche del mercante, del proprietario che si arrischia a esportareper suo conto il proprio olio o quello incettato da una cerchiaristretta di contadini.
Uno spazio ben maggiore ha l'imprenditoria locale a Bari. Quipure sono presenti mercanti-baroni - i principi di Noja eTriggiano, gli stessi de Lieto - ma per quantità relativamentemodeste, mentre particolarmente forte appare nel 1721 la presenzaforestiera: un Domenico Cesena si presenta come il maggioreesportatore della provincia, muovendo1735 salme, e accanto a luiagiscono uno Stefano Fabri e un Giuseppe Nicola Ferri , che fa diBari la base di un'attività a più vasto raggio, esportando ancheda Monopoli e Bisceglie. Pur tuttavia fra i mercanti baresi, adifferenza che fra quelli monopolitani, sono immediatamentevisibili figure di imprenditori su larga scala: sempre nel 1721Sebastiano de Mola esporta 1409 salme più altre 150 imbarcate aMonopoli, e nel 1732, quando i mercanti forestieri sembranorifugiarsi nei porti minori di Giovinazzo e Bisceglie, GiovanniBattista e Sebastiano de Mola esportano 1560 salme, Michele Mele465 salme oltre a 142 da Monopoli e 260 da Bisceglie, Salvatored'Amelij 1327 da Bari e 380 da Monopoli.
Del tutto diversa la situazione dell'altro grande portooleario, quello di Molfetta. Qui, così come nella vicina Terlizzi,il processo di prima concentrazione del prodotto appare affidato auna democrazia di decine di accaparratori, sensali, proprietari dipiscine e trappeti, e non procede oltre: l'olio viene portato aFerrara frantumato in piccole partite intestate a quegli stessiaccaparratori, e affidato a padroni di tartane pescherecce etrabaccoli che tentano di venderlo all'arrivo a mercanti locali oaddirittura di smerciarlo al minuto. Il rischio del mancatorealizzo insito in questo tipo di operazione induce i possessoridi olio a contenere le dimensioni dell'investimento e aspezzettare la merce in un numero alto di imbarchi, e tutto ciò, asua volta, impedendo l'emergere di negozianti più consistenti,meglio collegati con i mercati di sbocco e dotati di maggior forzacontrattuale, mantiene alto il rischio. In questo circolo viziosol'onere della riuscita dell'operazione ricade in larga parte sullespalle dei “padroni”, figure di profilo confuso, conduttorianalfabeti di piccole imbarcazioni di cui posseggono spesso solouna parte, usate per pescare lungo le coste quando non c'è da
285 BN Napoli, Sezione Manoscritti, vol. XI-A-29, CC. 264r e v.153
trasportare olio e “saccarie”, a volte esportatori in proprio diminuscole quantità di derrate ad integrazione del nolo, semprecontrabbandieri abili. E sono proprio costoro i personaggi piùsignificativi di questo particolare milieu mercantile, quelli checonservano il monopolio indiscusso dei noli molfettesi dal momentoche il carattere delle operazioni loro richieste non è certo taleda allettare la concorrenza dei 'normali' armatori e capitaniforestieri, e riescono a ritagliarsi una fetta consistente deinoli della provincia: nel 1721 si possono contare 2 4 molfettesiagenti, oltre che a Molfetta stessa, a Bisceglie, Giovinazzo, Barie Monopoli, 8 molesi da Mola e Bari, 6 baresi da Bari e Monopoli,5 biscegliesi solo da Bisceglie.
Così il massimo di autonomia imprenditoriale si sposa a unasorta di smarrimento della civiltà secolare dello scambio, a undegrado dei profili professionali e delle operazioni mercantiliverso il livello dell'avventura ai limiti della legalità, centratasul “gettare all'estero a vil prezzo la derrata [... 1 prima delladomanda”, che, dirà un intenditore di queste faccende, “è lapeggiore delle condizioni di un paese agricolo”286. Molfettarappresenta da questo punto di vista la condizione estrema, mafette consistenti del commercio oleario 'autonomo', a Mola inparticolare, ma anche nei porti minori e a Bari stessa, sonoorganizzate secondo una logica non dissimile. Non appena ilmercato di Ferrara dà segni di vivacità, le navi olearie dellaprovincia vi si precipitano, nella speranza di essere lì in tempoprima che la domanda venga soddisfatta: nel maggio 1724 , adesempio, ne sono arrivate io da Monopoli, Bari, Giovinazzo,Molfetta e Bisceglie, e il corrispondente ferrarese scrive al“padrone” molfettese Leonardo Pansini che 9 mercato è ormai saturoed è il caso che rimandi a tempi migliori il viaggio progettato287.
Il commercio come scommessa e destrezza, gusto dell'imprevistoe gara contro il tempo e i propri concorrenti, in cuil'arricchimento avviene per un colpo di fortuna e la rovina è unesito previsto e normale: in orizzonti più ristretti in sensogeografico e sociale, i “padroni” della costa barese non sembranopraticare il mercato in maniera diversa da quel che era statosolito fare, parecchi secoli prima, Landolfo Rufolo, e capitafinanco che qualcuno di essi riesca ad emergerne con la sua cassadi gioie.
Il contrasto con la possente macchina che fa capo a Gallipoli,286 Considerazioni commerciali del sig, Ravanas, in G. BURSOTTI, Biblioteca dicommercio, III, Napoli 1845, P. 49.287 PALUMBO, Prezzi e salati in Terra di Bari cit., P - 42.
154
da cui nel 1732 si esporta più olio che da tutta la provincia diBari e più di cinque volte l'olio esportato da Bari stessa, nonpuò essere più stridente: lì il gioco dello scambio ha ruolidefiniti, gerarchie rigide, centri direzionali prefissati, sisvolge dentro un ritmico incrociarsi di anticipazioni aiproduttori da parte di grossi acquirenti situati nei 'centri' delmondo, e derrate destinate a mercati avidi, trasportate sullegrandi navi nordiche condotte da capitani ai quali, notava ilBroggia288, a differenza che ai napoletani era assolutamente vietatocommerciare in proprio. Certo non è facile che in quel mondochiaro e distinto residuino per il grande porto di imbarco quellefette di intermediazione mercantile che Terra di Bari riesce atrattenere nel suo interno; ma, d'altro canto, è questo risvoltopositivo dell"autonomia' un compenso sufficiente al prezzo che laprovincia paga in termini di limitatezza degli sbocchi e bassolivello qualitativo dello scambio? Le ricchezze accumulate daFrancesco Noya nell'ambiente dei “padroni” miserabili di Molasarebbero presto finite nell'acquisto di un piccolo feudo allespalle di Bari, e quel Grazioso Giovane che “ha fatto il padronea qualche tartana pescareccia, ed anco di viaggio carica di oglio,amendole et altre merci”, essendosi “fatto ricco” riconverte ilsuo denaro in proprietà immobiliari ed entra a far parte consussiego dell'aristocrazia molfettese289. In nessun porto sembranocostituirsi dinastie mercantili: i nomi apparsi nel Seicento nonsono gli stessi del primo Settecento e di questi nessuno èpresente a fine secolo.
L'inerzia dei valori aristocratici seicenteschi congiura colcarattere episodico, incerto, fluttuante del guadagno commerciale,a spingere fuori dal circuito del mercato oleario i capitali chevi si accumulano, verso la rendita e i fasti improduttivi dellanobiltà.
E, pur tuttavia, i margini di ambiguità presenti in ogni latodi una condizione in cui manovrano insieme i tradizionali grandifeudatari-mercanti e i microarmatori molfettesi e molesi, dove èpossibile rinvenire dipendenza coloniale dai mercati di sbocco eforme di autonomia estrema, aprono spiragli del tutto assenti inuna situazione di connessione e dipendenza organica dalle aree'centrali' europee come quella di Gallipoli.
Ad offrire occasioni preziose ai porti oleari baresi sono le288 C. A. BROGGIA, Risposte economico-politiche di comerzio e di finanza al sig.r D. Lodovico Balbiani console austriaco-toscano nelle Due Sicilie, a cura di A.Allocati, Napoli 1979, pp. 89-90.289 SPAGNOLETTI, «L'incostanza delle umane cose» cit., P. 55.
155
trasformazioni che cominciano ad investire, proprio a partire daidecenni in questione, il breve spazio economico in cui sonoinseriti. Da un lato la conquista dell'autonomia statale delMezzogiorno comincia a offrire qualche occasione per una politicamercantistica centrata su interessi e circuiti più vicini econtrollabili; dall'altro l'Adriatico settecentesco non solo sivivacizza, risentendo dell'accelerazione della vita economicaeuropea, ma si riqualifica, tende ad uscire dalla condizione dimarginalità in cui si era collocato con la crisi della funzione diredistribuzione mercantile di Venezia. L'emergenza di Trieste aspese di Ferrara, che pure, come abbiamo visto, non comporta unaumento significativo delle quantità esportate. dà sotto questopunto di vista un contributo decisivo, conferendo maggiore dignitàalla funzione mercantile con più raffinate istituzioni - la borsa,gli agenti delle case acquirenti, i sensali, le certificazioni - ecostituendo il tramite verso un mercato di nuovo vasto e, per ciòstesso, più regolare e prevedibile. Rispetto all'olio e allemandorle che continuano a risalire l'Adriatico con destinazioneincerta - “ove meglio [il capitano] riuscirà a venderle”290 - e cherichiedono “dei mesi”291 di blocco dell'imbarcazione edell'equipaggio nel porto di sbarco perché possano essere vendutepersonalmente dal capitano stesso, va aumentando sensibilmente lamerce esportata su “ordine” fatto pervenire al venditore da propriagenti a Trieste o contrattato nei porti di imbarco con sensali edagenti “imperiali”, con un incremento di efficienza, regolarità e,in ultima istanza, delle dimensioni del profitto mercantile cheriesce a essere trattenuto nelle città olearie provinciali.
Perché - ed è questo l'elemento più significativo - Triestesvolge questo suo nuovo ruolo di emporio di derrate e manufatti inmaniera particolarissima, senza avere capacità direzionali,essendo priva degli strumenti di condizionamento fondamentali neiconfronti delle aree 'coloniali', ovverossia i capitali daanticipare a produttori e mercanti e la flotta mercantile.Inventata in un certo senso dall'alto, dotata di tradizioniaffaristiche modeste soffocate dalla prevaricante vicinanza diVenezia, Trieste diventa una sorta di piazza franca in cui coloniedi greci giunti “sopra una nave di fichi secchi” riesconoimpunemente a “ismungere il denaro della nazione”e a “isnervaretutto il trafico de' bottegai del paese”292 in cui le navimeridionali possono essere accolte da agenti degli esportatori290 E. DI Ciommo, Il ceto mercantile barese durante la crisi dell'antico regime,in AA.vv., Economia e classi sociali Cit., P. 231.291 VISCEGLIA, Il commercio dei porti pugliesi cit., p. 207.
156
meridionali che riescono a trovare spazi di autonomiaimprenditoriale in un ambiente finalmente formalizzato edignitoso.
Lo stimolo che giunge da questo lato, come è prevedibile sullabase di quanto sappiamo già, non trova terreno fertile in manierauguale sulla costa olearia pugliese. La regolarizzazione dellerotte mercantili da un lato, l'emergere dall'altro della pesca“alla gaetana”293 che richiede un impegno a tempo pieno, inducono unprocesso di specializzazione delle imbarcazioni e del personale,fino allora promiscuamente addetto alla pesca e al commercio,esaltano il ruolo armatoriale di Molfetta, Bari e Mola, deprimendoulteriormente quello di Monopoli - nel 1801 non una sola delle 20navi che escono da quel porto ha capitani locali. A Molfettapressoché la totalità delle imbarcazioni è ancora di proprietà dei“padroni”, i quali vanno però assumendo ruoli più specificamenteimprenditoriali, cominciano a comprare l'olio da imbarcare dainumerosi accaparratori invece di trasportarlo diviso in partiteintestate a ciascuno di essi. Alcuni fra i “padroni” stessiallargano la scala delle operazioni mercantili fino al punto didover lasciare il comando delle imbarcazioni ai loro colleghi menointraprendenti, e negli anni '80 e '90 quello che era un portoprivo di egemonie mercantili è controllato da un pugno diesportatori locali294 i cui nomi denunziano una discendenza direttadai capitani, spesso una parentela con quelli che continuano adoperare come tali.
L'ascesa rapida di questi mercanti di umili origini li collocaal centro di transazioni finanziarie imponenti e in una certamisura sofisticate, che però rimangono qualitativamente diverse daquelle che hanno luogo nei porti 'normali', ad esempio aGallipoli. Se in quest'ultima il denaro anticipato da stranieri enapoletani giunge, attraverso intermediari locali, fin nelle manidel singolo produttore, legandolo direttamente agli acquirentifinali, a Molfetta sembra resistere quella incetta di primolivello che abbiamo visto controllata da proprietari locali. Il292 Osterreichische Nationalbibliothek, Wien, N. S. 1670, ff. 20-53, «Memoriaintorno al commercio del porto franco di Trieste... »293 B. SALVEMINI, Comunità «separate» e trasformazioni strutturali. I pescatoripugliesi fra metà Settecento e gli anni Trenta del Novecento, in «Mélanges del'Ecole Française de Rome, Moyen áge - Temps modemes », 1985, PP. 441-88.294 Sono 8 fra il luglio e il dicembre 1788, 11 nell'89, 19 nel 90 (Tullio,Molfetta cit., P. 41), 6 nel 1795 (ASNA, f. Dipendenze della Sommaria, b. 381),16 nel 1804,5 dei quali muovono il 7o per cento circa in valore del commerciooleario (ASBA, Sacra Regia Udienza, Affari diversi, b. 13, f. 110). Su questiprocessi di concentrazione cfr. anche CHORLEY, Oil cit., P. 54.
157
“padrone”-mercante, dunque, non dà lui anticipazioni “alla voce”,ma acquista olio dagli incettatori, con capitali prestatigli “acambio marittimo” da un secondo più ristretto livello di affaristilocali - 39 nell'onciario, di cui 7, appartenenti alle piùillustri e ricche famiglie molfettesi, impiegano il 60 per centodei 60000 ducati investiti in questo modo295 che all'incetta daiproduttori aggiungono il rischio finanziario ma non quello piùpropriamente mercantile. A questo punto, nel mentre l'olio vieneimbarcato, il mercante emette una cambiale su Trieste che, sullagaranzia dell'“ordine” in olio triestino, viene scontata a Napolida finanzieri che svolgono al contempo le funzioni dianticipazione e cambio valutario296 anticipano ducati in cambio difiorini futuri - e permettono al mercante stesso di tornare subitoad acquistare nuovo olio sulla piazza locale297“. La macchina sembrafunzionare efficacemente già a partire dagli anni '60298“ e consentel'emergere di figure imprenditoriali vivaci, capaci di controllareil mercato delle merci e quello degli olii, ma dotate di unalimitata autonomia finanziaria, e quindi relativamente fragili:non a caso quando nella congiuntura incerta dei primi anni delnuovo secolo i triestini cominceranno ad emettere “ordini” conmaggiore cautela e rifiuteranno di accettare le cambialimolfettesi scontate a Napoli prima di essere riusciti a rivenderel'olio sbarcato a Trieste, i fallimenti non risparmieranno anchemercanti di primissimo piano299.
In realtà i due decenni a cavallo tra Settecento ed Ottocentosono duri per tutti i centri oleari, e fallimenti e difficoltà nonmancano neanche a Bari”, dove il processo di selezione delpersonale mercantile ha avuto caratteristiche in parte simili aquelle di Molfetta: da un lato i gruppi proprietari che si sonoaffacciati nel primo Settecento alla mercanzia scompaiono dalcircuito oleario, a conferma del carattere episodico econgiunturale del loro impegno più propriamente imprenditoriale;dall'altro una parte dei “padroni”, dei capitani-armatori primosettecenteschi, riesce a farsi largo, ad arricchirsi e, tral'altro, a voler pesare negli equilibri politici locali. Nel 1785,quattro fra costoro riescono ad ottenere l'aggregazione allapiazza del popolo nonostante ci sia chi non li ritiene in grado di“esercitare con decoro una tal carica di decurione [... 1 per295 TULLIO, Molfetta Cit., p. 50.296 CHORLEY, 0il Cit., pp. 45 e 53-55.297 ASSENNATO, Eroi della trasformazione cit., PP. 52 S99. 298 CHORLEY, Oil cit., PP. 54-55.299 DI CIOMMO, Il ceto mercantile barese cit., pp. 228 e 247,
158
l'intervento che questi ci hanno nelle di loro proprie barche”300:fra i richiedenti, sostengono i loro difensori, MichelangeloSignorile, “figlio di un negoziante di olio, amendole e altrigeneri, oggi vive al pari di ogni altro gentiluomo”; EmanueleFanelli “ora fa il negoziante in cambiali e generi e si sostienecon la sua estesa proprietà”; Antonio Abbrescia “è un uomofacoltoso, ha un figlio laureato in legge e vive da gentiluomo”;Luigi Mola “vive da gentiluomo e ha dismesso il negozio”301.
Abbrescia e Mola sono per davvero diventati “gentiluomini”enon mettono più mano ad olii e trabaccoli, secondo un percorsoconsueto e tradizionale, ma ormai, come abbiamo visto perMolfetta, non più obbligato: Fanelli e Signorile e con loro iDiana, Capriati, De Tullio, Milella, Caricola, De Mona, non liseguono ma, al contempo, non percorrono l'itinerario delle élitesimprenditoriali molfettesi verso quella specializzazione spintacentrata pressoché esclusivamente sulla mercantilizzazionedell'olio, che va legando rigidamente il loro successo al buonandamento della domanda triestina.
In realtà il clima che si respira nel milieu mercantile baresetardosettecentesco è molto diverso da quello molfettese. Nel portodi Bari imbarcazioni molfettesi e forestiere e mercanti di nomeesotico continuano ad essere presenti fra mercanti e “padroni”locali; figure di agenti, commissionari, corrispondenti di caseestere e i finanzieri napoletani sgomitano fra commercianti perconto proprio, spesso legati fra loro e con marinai artigiani emercanti al minuto da “società di negozio”, le cui iniziativeesorbitano dal circuito dell'olio. Il tutto richiama la forzadelle permanenze della realtà provinciale, ma, al contempo, vi faapparire la dialettica tra passato e presente particolarmenteproduttiva. Bari si presenta certo meno 'autonoma' di Molfettasotto il profilo del controllo del mercato degli olii e dellacommercializzazione in senso stretto dei prodotti oleari, ma, altempo stesso, meno dipendente dal successo del prodotto dellamonocoltura costiera sull'unico mercato di sbocco, proiettata inun circuito più vasto e vario che impone profili complessi econfusi anche ai protagonisti locali. La figura del “negoziante”,l'imprenditore generico dei 'centri' dell'economia europea diantico regime in procinto di essere lì sostituito da unamolteplicità di figure imprenditoriali specializzate, diventa, inuna realtà come questa, una conquista preziosa, il segno di una300 Ibid, pp. 148-49, nota; SPAGNOLETTI, «L'incostanza delle Umane cose» cit., p.92.301 Ibid, p. 93
159
qualche capacità di controllo finalmente conseguita sulledinamiche complessive dell'economia provinciale da parte di forzelocali, e non a caso essa continuerà a caratterizzare a lungo learee meridionali più vivaci e aperte al mercato internazionale.
I “negozianti”baresi diventano “uomini di maneggio e didenaro” più che di “intervento nelle di loro proprie barche”,cominciano a mandare i propri figli a scuola e in giro per lepiazze mercantili ad acquisire competenze specifiche e aperturamentale, riescono a darsi valori, comportamenti, mentalità cheraccolgono ampio riconoscimento sociale e non alludono più allaloro condizione come a una fase di passaggio, quanto più brevepossibile, verso lo status nobiliar-proprietario302: le possibilitàdi dinastie mercantili finalmente stabili sono così costruite e sitradurranno in atto quando questa élite imprenditoriale riuscirànel suo insieme a percorrere il passaggio difficile tra Sette eOttocento senza danni irrimediabili, ed anzi rafforzandosi intermini relativi rispetto sia ai più tradizionali gruppi dirigentibaresi sia alle élites mercantili degli altri centri oleari.
Andare a caccia di spiegazioni per cause di fenomeni di questanatura è certo fuorviante. Non credo si possa comunque dubitareche l'investimento di capitali ed energie baresi, da un lato nelcontrollo dei carichi di ritorno e nella redistribuzione al minutosul mercato interno delle merci importate, dall'altro nellafunzione bancaria di deposito ed anticipazione, trovi a Bari unambiente meno ostile che nelle tipiche agrotowns provinciali, viriceva stimoli non secondari dall'aggiungersi alla domanda difunzioni direzionali e mercantili proveniente dalla 'campagnainterna', di quella della consistente 'campagna esterna' raccoltanella conca barese; dal conseguimento della massa critica dimercato potenziale capace di sostenere iniziative in una serie disettori merceologici e finanziari sostanzialmente preclusi aquelle élites urbane che possono far conto solo sul bacino didomanda coincidente con le masse contadine rinchiuse nelle muradei propri centri abitati.
Il fatto è, però, che una volta innescato il processo tende atracimare dai limiti segnati dalla geografia: gli imprenditoribaresi proiettano le proprie iniziative ben al di là dei casali,competono con stranieri e napoletani nell'occupare gli spazilasciati liberi dall'imprenditoria olearia degli altri porti,suscitano attivamente nuovi bisogni aprendo fondachi di merciqualificate a Gravina, a Monopoli, nel leccese, concedono mutui
302 SALVEMINI, Quadri territoriali cit., in particolare pp. 869 sgg.160
fin negli Abruzzi303 e, soprattutto, cominciano a costruire rapportifunzionali che fanno gravitare grossi centri provinciali su Bari,impongono loro l'adozione delle unità di misura baresi,determinano in definitiva forme di subordinazione che l'inchiestadel 1804304, volta ad accertare i redditi dei “negozianti” per poterdistribuire l'onere delle spese di guerra, già suggerisce conchiarezza.
A quella data sindaci e decurioni di Giovinazzo e Bisceglienegano che nei loro centri vi siano “negozianti” degni dei nome, equelli di Mola ne registrano 20, ciascuno titolare diinvestimenti modesti - solo in 5 casi uguali o superiori a 1000ducati - che assommano complessivamente a 1460o ducati. I tregrandi porti oleari, Molfetta, Monopoli e Bari, denunciano cifregrosso modo simili. A Molfetta 16 “negozianti”investono 45000ducati, in larga parte (73 per cento) concentrati nelle mani di 5investitori; a Monopoli, dove non sembra che i marinai-mercantisiano mai riusciti a trovare spazi consistenti, fra i 42investitori dei complessivi 70200 ducati emergono 4 proprietari e2società che rappresentano oltre la metà della cifra globale; aBari28 investitori, tra cui 11 “società di negozio”, muovono 59200ducati, distribuiti secondo un indice di dispersione molto basso.Si tratta, evidentemente, di un documento poco affidabile: nelquadro di una generale sottovalutazione dei capitali denunziati,le cifre riguardanti Bari appaiono grottescamente basse, adindicare l'influenza dei negozianti nel governo locale. Purtuttavia, alcuni elementi di fondo del nuovo quadro vi sonoregistrati inequivocabilmente. Bari è il solo centro in cui cisono “negozianti di ragione” impegnati, in maniera specifica sulterreno finanziario, in cui le “società di negozio” appaionoampiamente diffuse; e a Monopoli, accanto ai capitali dei“naturali”, circolano secondo le autorità locali altri 50000ducati “esteri, per lo più baresi, che trafficano per mezzo dicommissionati paesani”.
In quello che resta il massimo centro di produzione dellaprovincia, Bitonto, gli unici commercianti locali degni di notasarebbero 3 individui “li quali con li loro rispettivi traini,quando, e quando due per ciascuno, [...] traficano alla via diNapoli carrichi di olio e sapone”; ma accanto a questi, e su scalaben maggiore, agiscono “Innocenzo Di Tullio e Pasquale Di Siminedi Bari, che [...] comprano li generi di olio ed amandole,
303 DI CIOMMO, Il ceto mercantile barese cit., passim.304 ASBA, Sacra Regia Udienza, Affari diversi, b. 13, f. 110.
161
trasportandoli in detta città di Bari, e secondo la pubblicaopinione portano il negoziato di circa ducati10000 per ciascheduno[... 1, riferendosi il negoziato rispettivo de' medesimi allacolonna di altri negozianti baresi”.
Il diffondersi tentacolare della presenza barese nell'economiaprovinciale sembra fermarsi lungo i confini del circuito delgrano, sorvegliati, come sappiamo già, dalla prevaricante presenzafeudale e napoletana, che ha la sua base operativa a Barletta.Anche qui un fatto nuovo c'è: la messa in discussione nelSettecento della secolare egemonia del porto barlettano. Quandol'esportazione cerealicola provinciale si riprende negli anni 5 40dopo aver stagnato a livelli nettamente inferiori a quelliseicenteschi, a profittarne sembra essere Trani, dal cui porto,oggetto di un'attenzione particolareda parte dei Borbone, escononel 174 1 quasi 280000 tomola di grano e che si mantiene nel 1750-55 su una media annua di oltre 240 000 tomola. Nel 1757-58, quandoil raffronto diventa possibile, il vantaggio di Trani su Barlettasi presenta schiacciante: dalla prima vengono “estratti”708095tomola, contro i 218084 della seconda "305
Il catasto onciario misura una proiezione murgiana fortissimadi Barletta, una sorta di agrarizzazione totale che respinge ilmare ai margini della società: di contro ai 493 marinai baresi, ai369 molfettesi, ai 362 tranesi, a Barletta ne risultano registrati294, corrispondenti a una percentuale della popolazionedifficilmente precisabile ma comunque di gran lunga inferiore aquella degli altri centri marittimi; e, d'altro canto, se Traninon può competere coi porti oleari sul piano dell'armamento, puresi colloca in -una dimensione diversa rispetto all'altro portocerealicolo che registra solo 8 allibbi (cfr. tab. 16). Questadell'“allibbare”, del trasbordare grano da un'imbarcazione discarso pescaggio in grado di praticare il porto interrato dellacittà, sulle navi ancorate al largo, sembra ormai l'unico impegnomarinaro del popolo barlettano. Solo in qualche raro caso ci siavventura più in là: nel 1720-21 escono dal porto di Barletta,comandate da barlettani, una barca con 650 tomola di orzo direttoa Monopo li e un allibbo con 670 tomola di orzo per Napolidestinato ad essere trasbordato a Trani su una tartana diSorrento306“.
Tabella 16.305 Cfr. sopra, p. 65, nota 7.306 Cfr. il registro della tassa di alboraggio per Barletta del periodo 22 luglio1720 - 21 luglio 1721 in ASNA, Relevi, VOI. 2 21, ff. 1 - 10.
162
Imbarcazioni registrate nei catasti onciari.
Fonti: ASBA per gli onciari di Barletta, Trani, Molfetta, Bari e Monopoli;Bc Bisceglie per quello di Bisèeglie; ASNA per quello di Mola.
Barchette Barche Tartane TrabaccoliAllibbi
e barche bastardepescherecce
Barletta - - - - 8Trani - - 34 - 20Bisceglie 14 1 - 3 -Molfetta 43 6 - 11 -Bari 70 1 - 11 -Mola 27 - 2 4,5 -Monopoli 22 2 - 0,5 -
Oltre ai cereali, si trasborda attivamente il sale dellagrande salina a pochi chilometri a nord di Barletta. In questosettore, in ripresa a partire dal secondo Seicento, l'“estrazione”sembra in grande espansione, ma il suo ricasco positivo sullacittà è assolutamente modesto. Controllato da funzionari earrendatori, il sale esportato prende in proporzione sempremaggiore la via di Trieste, nel mentre Venezia, Mantova, lo StatoPontificio scompaiono con le loro navi lasciando il settore almonopolio armatoriale dalmata. Quando i dati sono disponibili -nel 1720-21 e nel 1767 - non una nave meridionale è presente suquesta rotta; ma, quel che è più, le stesse navi che esportanosale lo distribuiscono anche sulle coste abruzzesi, nel mentrearmatori campani controllano la quasi totalità del prodottodiretto a sud lasciando qualche limitatissimo spazio alle barchebarlettane nel rifornimento dei fondachi adriatici di Terrad'Otranto307.
Eppure i giochi non son fatti. La localizzazione strategica diBarletta alla saldatura di due grandi aree granarie torna a pesarequando, nel secondo Settecento, in anni resi difficili per laproduzione e il commercio cerealicolo meridionale dal vincolismoannonario napoletano, le terre salde del Tavoliere si dimostranoancora una volta una riserva di produttività preziosa. In questocontesto, che comunque non permette il recupero delle quantità307 Cfr. DI VITTORIO, Gli Austriaci e il Regno di Napoli Cit., Pp. 270-71 e 414-15, e ASBA, Carte Esperti, b. i, « Nota de' bastimenti spediti dalle RegieSaline di Barletta, dal io aprile 1767 a tutto dicembre1767 per extra Regno, perOtranto e per Apruzzo».
163
globali commercializzate prima della crisi del 1756-64, Barlettatorna a prevalere su Trani, ma quel che è più, ad attivare unacircolarità più consistente tra il porto e la piazza, fra il maree la società urbana. La pesca specializzata, che vapropagginandosi lungo la costa provinciale, sembra ricostruirecompetenze marinare che si riversano nel circuito del commerciogranario a partire dai livelli inferiori. Nel1793 il 74 per centodei 12080 tomola di grano redistribuiti da Trani lungo la costaadriatica naviga su imbarcazioni tranesi; a Barletta delle 22 499tomola partite per la stessa destinazione, già il 56 per cento ècondotto da capitani locali308 e nel 1795 trafficano fra Barletta eOrtona, Pescara, Vieste, Brindisi, Otranto, San Cataldo,Gallipoli, oltre a qualche imbarcazione dei soliti molfettesi etranesi, 5 barche “paranze” destinate alla pesca in grande, 3barche minori, e financo 3 trabaccoli barlettani309. E inoltre sicominciano a vedere imbarcazioni di Barletta in altri porti,persino in quello di Molfetta, e poi a Monopoli e a Bari, da dovei barlettani esportano piccole quantità di olio e qualche voltamandorle, adoperando anche “barchette a remi”, meno esposte aipericoli dei tempi di guerra.
Anche al lato opposto di questo brulicare di presenzesignificative, ma del tutto marginali rispetto al complesso delcircuito granario, le cose non sono immobili. Le rotte maggiorisono ora nelle mani di un gruppo ristretto di grandi finanziericon base nella capitale, che vanno emarginando il baronaggiolocale e si servono di imbarcazioni e capitani pressochéesclusivamente campani per il grano destinato a Napoli, e diarmamento campano ed estero per il grano esportato. Ma anche daquesta parte iniziative dotate di un qualche radicamento localeriescono ad emergere, anche se una parte consistente di esse non èil risultato di una crescita e selezione di forze autonome, ma hacome protagonisti armatori-mercanti campani immigrati allo scopodi ritagliarsi uno spazio nel vuoto relativo di imprenditorialità'alta' provinciale nel circuito granario. Il già citato documentodel 1804310, che registra a Trani la presenza di mercanti localipressoché esclusivamente nella funzione di commissionari di grandicase napoletane, e comunque in grado di reggere autonomamente ungiro d'affari non superiore a quello dei mercanti di cittàdell'interno cerealicolo come Ruvo o Corato, vede stanziati aBarletta 5 grossi imprenditori con un giro d'affari complessivo di308 ASNA, f. Finanze, b. 2817309 ASNA, Dipendenze della Sommaria, b. 381.310 ASBA, Sacra Regia UdienZa, Affari diversi, b. 13, f - 110
164
122000 ducati, che sembrano in grado di giocare un ruolo non deltutto trascurabile nella vicenda complicata del grano pugliese.
A fine Settecento, così, anche il circuito cerealicolo ritrovaun polo a cui far capo. Le sue caratteristiche sono ben diverse daquelle di Bari: in particolare a Barletta è relativamente pococonsistente il tessuto di iniziative intermedie fra la micro-imprenditorialità dei barchettai e l'alta finanza dei Cafiero eRuggiero, legata alle funzioni ed istituzioni direzionali diNapoli, e quindi inferiore è l'effetto urbano che questa suacollocazione produce. E però ogni possibile indicatore di'urbanità' primo ottocentesco dimostra inequivocabilmente che ladifferenziazione tra Bari e Barletta è meno consistente di quellache ormai le separa dagli altri centri costieri e soprattutto daquelle grandi città murgiane che erano giunte per molti versi aridosso dei porti con la crisi cinquecentesca del circuitomercantile tardo-medievale. Così, al di sotto di dati numerici,nel secondo Settecento particolarmente inespressivi, tendenti adappiattire sul piano della consistenza demografica come su quellodelle quantità esportate il gruppo relativamente numeroso dellemaggiori città provinciali, va avanti un processo didifferenziazione qualitativo e funzionale che allude a ricaschisugli altri piani, che contiene annunci insistiti di futuro.
Questo articolarsi per così dire discreto, strisciante dellarealtà tardosettecentesca non riesce ancora a dar forma aun'alternativa visibile con chiarezza da parte dei protagonistidelle vicende: la provincia, guardata dalle sue campagne, sembraper molti versi prigioniera del suo lungo tempo circolare, e lagravissima situazione sociale di fine secolo presenta, a unosguardo superficiale, caratteristiche non molto dissimili daquelle che esprimono l'accumulo di contraddizioni precedente lafase di ripiegamento verso il basso del sistema provinciale di etàmoderna. E però, agli occhi di chi sa dove queste vicende andrannoa parare, la più consistente presenza di qualità 'urbane' e leforme nuove di aggancio coi 'centri' del mondo da esse espresse,si riverberano sul malessere di questa 'periferia interna' e lorendono fecondo, lo caricano di domande a cui il tempo circolaredel sistema provinciale di età moderna non sa più dare rispostepossibili.
Toccherà all'Ottocento cercare di elaborarne di nuove.
V.“INCIVILITA, DOVIZIOSA, FERTILISSIMA PUGLIA” *.
165
L'OTTOCENTO FRA VECCHIO E NUOVO REGIONALISMO.
1. L'esplosione delle cifre globali.
L'Ottocento con cui Terra di Bari deve fare con piùimmediatezza i conti - com'è naturale, data la sua strutturaleestroversione mercantile - è quello delle grandi trasformazionidell'economia europea, degli effetti della prima rivoluzioneindustriale e della “rivoluzione commerciale”311 che si fannoevidenti con la fine delle guerre napoleoniche e rimodellano lerelazioni internazionali fino alla grande svolta dell'etàdell'imperialismo.
Nelle curve dei prezzi delle derrate strategiche esportatedalla provincia (cfr. fig. 6), le novità del secolo appaionochiaramente leggibili: la caduta precipitosa dopo l'impennataviolenta dei primi anni della Restau razione, che riporta i prezziai livelli tardo-settecenteschi, l'andamento incerto del terzo equarto decennio, la ripresa a partire dagli anni '40 fino aglianni '70-80, quando, nel clima creatosi con l'irruzione degliStati Uniti del gioco commerciale europeo, il crollo dei noli, leguerre doganali, il trend si inverte.
*F. DURELLI, Del banco istituito in Bari, s.a.i., p. 10.
Figura 6.Medie decennali dei prezzi del grano, dell'olio, del vino, della lana, e
dei salari (numeri-indice, 1671-80 = 100).Fonti: il grafico è costruito in maniera da essere leggibile insieme alla
fig. 1, con numeri-indice in cui il i co è riferito ai prezzi medi del decennio1671-80. Per il grano, 1801-61: prezzi 'fatti' in ducati per tomolo sul mercatodi Altamura, raccolti e tabulati da L. PALUMBO e G. ROSSIELLO inediti; 1862-90:prezzi medi in lire per quintale, ridotti a ducati per tomolo, sulla piazza diBari del frumento di prima qualità, pubblicati in F. ASSANTE, Città e campagnenella Puglia del secolo XIX. L'evoluzione demografica, Genève 1975, P. 217. Laseconda serie viene messa in sequenza con la prima riducendone sistematicamentei prezzi del 25 per cento, in modo da tener conto dei costi di trasporto a Baridel frumento dalle aree produttrici e del fatto che essi riguardano solo la
311 Il riferimento essenziale è a F. SIRUGO, La «rivoluzione commerciale». Peruna ricerca su Inghilterra e mercato europeo nell'età delRisorgimento italiano, in « Studi storici», 1961, pp. 267-97. Per i taglicronologici e interpretativi qui proposti e la relativa bibliografia rimando almio Note sul concetto di Ottocento meridionale, in « Società e storia », 1984,PP. 917-45.
166
qualità superiore (il coefficiente di riduzione è ricavato dal confronto delledue serie con una terza di Acquaviva che copre i periodi di entrambe, pubblicatain parte in PALUMBO, Aspetti di vita economica e sociale cit., p. 175, in parteinedita). Per l'olio, 1801-60: prezzi 'fatti' in ducati per salma di 165 rotola,raccolti da Palumbo e Rossiello, inediti; 1861-90: prezzi degli olii “chiari”sul mercato di Bari, in lire per quintale tradotti in ducati per salma di 165rotola, pubblicati in C. MASSA, prezzo e il commercio dell'olio di oliva diGallipoli e Bari, Trani 1897, PP. 18-20. I prezzi della seconda serie sono mediefra quelli degli olii di prima e di seconda qualità. Vino: prezzi 'fatti' sulmercato di Altamura; per il periodo 180I-50 sono stati raccolti e tabulati daPalumbo e Rossiello, inediti; per il periodo 1851-88 da G. ROSSIELLO, I prezzidel vino sul mercato di Altamura dal decennio preunitario alla crisi agraria del1887, in La Puglia nel Mezzogiorno dall'Unità alla caduta della Destra Storica(1861-1876), Bari 1986, pp. 185-91; tutti i prezzi sono tradotti in ducati persoma di ettolitri 2,2858. I salari, in grana al giorno, sono relativi agiornatieri di Altamura e sono stati raccolti da Palumbo e Rossiello; ineditiper il periodo 1801-29, e per il periodo 18301850 pubblicati in PALUMBO eROSSIELLO, Salari di contadini: Altamura 1830-50 cit., P. 582. I prezzi dellalana, in ducati per rubbio, sono “voci” di Foggia relative alla maggiorinabianca, pubblicate in S. RUSSO, Materiali per la storia del paesaggio agrariodella Capitanata nel XIX secolo, in MASSAFRA (a cura di), Problemi di storiadelle campagne meridionali cit., P. 469. I valori del grano, dell'olio e delvino sono stati sottoposti a perequazione a cinque termini con pesi binomiali.
Nulla di paragonabile, dunque, alle fasi ascendenti di etàmoderna. La domanda europea di derrate, in fortissima crescita,non impatta in un'offerta di elasticità limitata, provocandol'impennarsi pressoché simultaneo e parallelo delle curve, comenel Cinquecento o nel Settecento. Sulla scala del mercatointernazionale, la crescita di produttività del settoremanifatturiero nel suo complesso, nettamente più elevata di quelladel settore agricolo, si traduce, almeno fino alla metà delsecolo, in un miglioramento delle ragioni di scambio delle derratee materi prime nei confronti dei manufatti; ma A miglioramentodelle tecniche mercantili, la capacità di penetrazione deiprodotti della rivoluzione industriale anche in società a bassoreddito, i giochi diplomatico-militari richiamano nei circuiti delgrande commercio aree vicine e lontane che permettono unallargamento anche dell'offerta di derrate e un contenimento deiprezzi sul lungo periodo, fino a provocare, nella seconda metà delsecolo, un'inversione dell'andamento delle ragioni di scambio afavore dei manufatti312.
Il mondo ordinato degli scambi fra centri e periferie dell'età
312 Per una discussione della letteratura in proposito cfr. ora G. FEDERICO, Aproposito di centro e periferia: recenti studi sul commercio estero dei paesimediterranei nel secolo XIX, in « Meridiana », 1988, n. 5.
167
moderna ne esce sconvolto: secolari vocazioni geografiche allaproduzione e commercializzazione di derrate vengono messe indiscussione, rotte tradizionali si ostruiscono a favore di altreapparentemente meno favorite dalle circostanze naturali, si vannodelineando nuove gerarchie ed emarginazioni. Attorno ai 'centri'del mondo, la cui “nuova agricoltura” riesce sempre meno asoddisfare da sola la domanda dei settori extragricoli, sistringono aree limitate di agricoltura specializzata checonquistano un ruolo stabile nella divisione internazionale dellavoro tramite l'investimento diretto e la trasformazionecapitalistica dei rapporti di produzione, la creazione di unsistema di imprese difese dalla concorrenza soprattutto dalla piùalta produttività; ed aree sempre più vaste e sfrangiate, rimastenei secoli della storia moderna escluse o ai margini dei circuitimercantili europei come 'periferie esterne', e che riescono ora ainserire nei giochi del mercato in grande merci protette dai bassicosti di produzione assicurati da un'ampia disponibilità di lavoroe di terra salda richiamabile alla coltura. Problematica rimaneinvece la collocazione, nel sistema dei vantaggi comparati delcommercio internazionale, in particolare per le vecchie 'periferieinterne', incapaci di compiere il salto verso la “nuovaagricoltura” e, al tempo stesso, dotate di forza-lavoro e risorsefisiche che l'antica organica appartenenza ai grandi circuitimercantili e di civiltà ha reso relativamente scarse e comunque dicosto maggiore rispetto ai nuovi venuti.
Ed ecco che per le superfici di contatto del Mezzogiorno conl'economia mondiale, in particolare per le province pugliesi, ladomanda non è più un dato su cui far conto sul medio periodo, maun problema da risolvere raccolto per raccolto, carico per carico.La vecchia instabilità stagionale dei prezzi e quella annualecausata dalle vicende della produzione si vanno attenuando conl'irrobustirsi della macchina mercantile, con il crescere dellepossibilità di stoccaggio e l'ampliarsi della rete dellecomunicazioni, ma al contempo emergono nuove e più clamorose formedi instabilità che rendono relativamente autonome le curve deiprezzi di ciascuna derrata, provocano impennate improvvise ecadute clamorose che non sempre i prezzi medi annuali riescono adesprimere dal momento che spesso investono archi temporalibrevissimi. Le notizie che si diffondono rapidamente portate dai“pacchetti a vapore” o dal filo del telegrafo sul fallimento delraccolto nell'entroterra di Odessa o su un mutamento dellanormativa doganale spagnola, sul colera scoppiato in un angolo del
168
Mediterraneo o su una guerra lontana, sulla decisione delleautorità di una grande città nordica di sostituire il gas all'olioper l'illuminazione o sul diffondersi di una malattia della vite,modificano radicalmente le convenienze incidendo vistosamentesulle quantità commercializzate e sui prezzi. E poi ci sono quellefalse del tutto o in parte, diffuse ad arte dalle case commercialia fini speculativi. Il mercato diventa così un “mutabil Proteo”,un “enimma”313 che vecchie esperienze e furbizie secolari non sonopiù in grado di sciogliere.
Una volta che [.. .1 esercitavamo quasi un commercio esclusivo degli oli edei grani - afferma Mauro Luigi Rotondo - i calcoli di previdenza intorno aiprezzi di queste derrate non erano mal basati sul solo elemento de' raccolti delnostro paese. Adesso questo solo dato non basta, ma forma una piccola frazionedel gran calcolo statistico delle simili produzioni di tutti gli altri paesi, idi cui prezzi mercé la facilità delle comunicazioni e del traffico in poco temposi livellano da per tutto. I giudizi dunque de' nostri massari di Puglia intornoai prezzi de' grani e degli oli si trovano ormai quasi sempre fallaci314.
Il bon pix appare ormai un nostalgico mito proprietario in unarealtà di incertezze, fragilità, di “disastri* incombenti, di“prosperità [...] passeggere e temporanee”315. La possibilità disuccesso si misura sulla capacità di manovrare nella congiuntura,di coglierne i frutti a tempo opportuno e di non farsi travolgerequando le cose volgono al peggio.
In questo quadro un sistema regionale intessuto di rigidità,come quello di Terra di Bari in età moderna, non ha modo disopravvivere. Nel corso dei decenni di difficoltà e ostruzioni delcommercio fra Settecento e Ottocento e di fronte al crollo deiprezzi dopo il breve intensissimo boom alla fine delle guerrenapoleoniche, gli elementi di crisi accumulatisi nella faseascendente settecentesca esplodono. Non ne consegue però il solitoripiegamento dei grandi cicli della storia regionale. Già nell'etàdella restaurazione, per molti versi tormentata e difficilissima,non è questa la linea di tendenza che è possibile intravvedere, ela provincia ne emerge con un balzo in avanti che sconvolge le sue
313 BARONE DURINI, Sul commercio de'reali domini di qua del faro, in «Annalicivili del Regno delle due Sìcilie», vol. V, fs. IX, maggio-agosto 1834, P. 13;Bp Bari, 127/35-93, corrispondenza commerciale della casa Diana: lettera degliagenti di borsa Francesco e Pasquale Di Pompeo datata Napoli, 25 novembre 1826;la lettera di Carmine Sylos a G. M. Giovene datata Bitonto, 13 Ottobre 1832, inBN Bari, f. D'Addosio, 2616. Vedi anche i bollettini commerciali del « Giornaledi commercio arti industrie manifatture e varietà», ad esempio quello del n. 32,a. I, io aprile 1835.314 F. SAVOJARDI (pseudonimo), Memoria sulle negoziazioni che si fanno nellaborsa di Napoli, Napoli 1835, pp. 22-23.315 G. BURSOTTI, Biblioteca di commercio, vol. II, Napoli 1842, pp. 121 e 107.
169
permanenze secolari. La sfida dei tempi nuovi viene raccoltaattraverso un'accelerazione violenta della vita economicaprovinciale e uno straordinario allargamento dei propri spazi nelcomplicato mercato ottocentesco, spesso a spese di altre areeesportatrici meridionali.
Nel giro di qualche decennio le “estrazioni” travolgono ilimiti secolari entro i quali erano state trattenute dallerigidità della vecchia regione rurale.
Si guardi alle vicende delle derrate maggiori. In anni in cuile grandi città europee vanno sostituendo l'illuminazione a gas aquella ad olio, si diffondono gli oli di semi e si moltiplicano iconcorrenti, l'espansione del commercio oleario della provincia èclamorosa anche a voler considerare sottovalutati i dati di fineSettecento. D'altro canto il giudizio trova piena conferma sulpiano comparativo (cfr. tab. 17). Fra il 1781 - 1794 e il 1835-39il Mezzogiorno continentale accresce le sue esportazioni del 109per cento, conseguendo un risultato importante che però nascondecomportamenti opposti e bruschi mutamenti di gerarchie interne:nello stesso arco di tempo, mentre le estrazioni calabresistagnano e quelle di Terra d'Otranto aumentano del 56 per cento,quelle di Terra di Bari hanno un incremento del 337 per cento, checonsente alla provincia di conquistare un primato nel settore chenon le verrà più sottratto. Negli anni '40 e '50, nei quali leesportazioni olearie del Regno, stando ai dati di Graziani316, nonsembrano espandersi ulteriormente, quelle baresi continuano acrescere fino ad avvicinarsi, in termini di quantità, alla metàdel valore complessivo relativo al Mezzogiorno continentale, e arappresentare - data anche la crescita del valore unitario delladerrata ottenuto con il metodo di spremitura di Ravanas - lachiave di volta degli equilibri della bilancia dei pagamenti delloStato meridionale317. L'ulteriore espansione dei decenni a cavallodell'Unità porta le estrazioni della provincia a collocarsi suvalori altissimi non più superati in seguito, che giungono fino aldoppio di quelli corrispondenti di Terra d'Otranto.
Di molto anticipato rispetto al caso dell'olio è il
316 A. GRAZIANI, Il Commercio estero del Regno delle due Sicilie nella suacomposizione merceologica, in «Atti della Accademia Pontaniana», n.s., vol. VI,1956-57, in particolare tabella p. 255.317 Negli anni 1840-48, a fronte di un saldo commerciale negativo che per laparte continentale del Regno di Napoli ammonta a circa quattro milioni e mezzodi ducati annui, l'avanzo annuo di Terra di Bari col suo maggiore porto disbocco, Trieste, è in media di ducati 1294838 (Cfr. TRIZIO, Commercio e Marinamercantile cit.).
170
raggiungimento del tetto dell'espansione del commerciocerealicolo: dopo il balzo dai livelli settecenteschi a quellidegli anni '30, la curva delle “estrazioni”, pur disegnandooscillazioni fortissime, si colloca su un trend sostanzialmenteneutro fino al crollo repentino degli anni '80, che azzera lasecolare presenza pugliese nel mercato granario internazionale(tab. 18). Nel frattempo, però, nel commercio provinciale a lungadistanza va emergendo prepotentemente un nuovo protagonista. Ilvino, presente in età moderna solo sporadicamente a bordo dimarciliane e trabaccoli che risalgono l'Adriatico, anche perché imetodi tradizionali di lavorazione delle uve non gli permettono diresistere alla navigazione, cominciano a diventare “navigabili” ea rispondere efficacemente agli impulsi improvvisi della domanda:già ne gli anni '50, in corrispondenza dell'impennata dei prezzicausata dal diffondersi dell'oidio, l'“estrazione” sale a livelliconsistenti318, per poi prodursi in un altro spettacolare balzo inavanti, fra la fine degli anni '70 e la crisi doganale, quando lafillossera colpisce i vigneti francesi (tab. 19).
Tabella 17.
“Estrazioni” di olio in salme di 165 rotola (medie annue).
Fonti: per i dati relativi al periodo 1780-94 cfr. la tab. 5, P. 70, diquesto scritto, e le fonti ivi citate; quelli relativi al periodo 1835-39 sonostati elaborati da BURSOTTI, Biblioteca di commercio cit., vol. Il, “Specchio”alle pp. 18-19; gli altri da MASSA, il prezzo ed il commercio cit., pp. 50 e135-36, e da M. DE LUCIA e F. A. MASTROLIA, Società e risorse produttive inTerra d'Otranto durante il XIX secolo, Napoli 1988, P. 307.
Terra di Bari Terra d'Otranto1780-95 14100 367501835-39 61608 574861871-75 - 88091 1876-80 162422 1059071881-85 159637 83088318 Secondo F. S. Velasquez (cfr. la voce Barletta, in Il Regno delle due Siciliedescritto ed illustrato, sotto la direzione di F. Cirelli, vol.IX, fs. I, Napoli1853', p. 61), dalla sola Barletta si esportavano già più di 60000 some di vinol'anno verso Venezia, Trieste, Nizza e Marsiglia. Il vino, presente fra il 18 16e il 18 19 su qualche nave giunta a Venezia da Trani scompare del tutto nelcommercio fra Terra di Bari e la Serenissima, per poi ricomparire, in manieraben più massiccia, a partire dal 1847, in larga parte imbarcato a Barletta (cfr.AS Venezia, Console del Regno delle due Sicilie, registro n. 92). Una cronologiasimile indicano le polizze di carico della casa Barracchia, agente a Barletta digrandi case napoletane ed estere (Bp Bari 139/3).
171
1886-90 149757 -1891-95 206856 98044
La crescita delle “estrazioni”appare ancora piùsignificativa se letta sullo sfondo della dinamica molto più lenta- stando agli indizi e ai pochi
Tabella 18. “Estrazioni” di cereali dal porto di Barletta in tomoli (medie
annue).Fonti: per il dato di fine Settecento cfr. la tab. 3 a p. 66 e le fonti
citate nella nota 7 a p. 65 di questo scritto; per il dato del periodo 1832-41cfr. A. MASSAFRA, Campagne e territorio nel Mezzogiorno fra Settecento eOttocento, Bari 1984, p. 259; le medie per i periodi 1856-75 e 1866-78 sonoelaborate sui dati annui forniti da VISTA, Note storiche cit., vol. XI, P. 45,dalla Relazione della Camera di Commercio ed arti della provincia di Terra diBari sul movimento commerciale, di navigazione ed altri prospetti statisticiriguardanti la provincia per l'anno 1877 in rapporto del 1876, Bari 1878, nonchédalla Relazione della stessa Camera di commercio relativa al 1878 (Bari 1879);l'ultimo dato è ricavato da Movimento commerciale e di navigazione dellaprovincia di Bari pel biennio 1886.87, a cura della Camera di commercio ed arti,Bari 1888, e dalla analoga pubblicazione relativa al biennio seguente, Bari1889. La riduzione dell'importanza del porto di Trani nel commercio cerealicoloridimensiona in parte il balzo fra fine Settecento e anni '30 dell'Ottocento deidati globali provinciali.
fine Settecento ~ 300 0001832-41 ~ 930 0001856-65 10790111866-78 10769941887-88 9350
Tabella 19.“Estrazioni” di vino da Terra di Bari in ettolitri (medie annue).
Fonti: le medie sono elaborate sui dati annui forniti, per il periodo1875-96, da S. MARCIN e B. LORUSSO, Movimento commerciale della provincia diBari, in La Terra di Bari sotto l'aspetto storico, economico e naturale.Pubblicazione della provincia di Bari per l'esposizione universale di Parigi,vol. II, Trani 1900, prospetto pp. 258-59. I dati per il 1873 e il 1874 sonoricavati dalla già citata Relazione sul movimento commerciale relativa al 1878.
1873-77 1862591878-82 4800501883-87 10005761888-92 10732901893-96 869799
172
dati disponibili - della produzione globale e del paesaggioagrario, che attraversa l'Ottocento senza che i suoi quadrigenerali risultino sconvolti319. All'incertezza e instabilità deitempi la provincia risponde non rinchiudendosi in se stessa, maingigantendo rischiosamente la sua tradizionale esposizionemercantile, contenuta entro limiti ristretti dalle sue antichelogiche regionali. Il valore per abitante della parte di“estrazioni” provinciali che finisce fuori dei confini nazionali èvicina, fra gli anni '70 e '90, al doppio del valorecorrispondente calcolato per l'Italia nel suo complesso320, e mentreil peso delle derrate destinate al commercio in grande sulprodotto lordo viene accresciuto da un incisivo processo dispecializzazione, una porzione sempre più alta della produzione diqueste stesse derrate viene esportata e finisce per costituire asua volta una quota al tissima delle “estrazioni” complessive(cfr. tab. 20), destinate, per di più, a un numero ristretto digrandi acquirenti: fra il 1875 e il 1887 quattro paesi - Francia,Austria, Germania e Inghilterra - assorbono il 45 per cento invalore di tutte le merci che escono dai confini della provincia321.A questi acquirenti, e alle tre-quattro derrate ad essi destinate,la provincia affida per intero le sorti della sua economia.
1806 1856-57 1880Seminativo ha 204047 210860 250000 circaOliveto ha 51539 60877 91984Vigneto ha 41247 46927 74984
Ma, lo si vedrà più avanti, termini come “oliveto” o “vigneto” nel corsodell'Ottocento mutano radicalmente, di significato. I dati sulla produzione(medie annue), anch'essi discutibili, alludono a una vicenda molto meno linearedi quella disegnata dai dati sul paesaggio agrario, e comunque disegnano untrend contenuto:
319 Qualche indicazione in merito, probabilmente non del tutto fuorviante, puòricavarsi componendo dati per le colture maggiori ricavati, per il 18o6, daDEMARCO, La proprietà fondiaria cit.; per il 1856-57 da ASSANTE, Città ecampagne cit., p. 27; per il 188o da DE FELICE, L'agricoltura in Terra di Baricit., PP. 55, 137 e 152320 Per la provincia i dati di MARCHI e LORUSSO, Movimento commerciale cit.,confrontati con quel sulla popolazione di ASSANTE, Città e campagne cit., inparticolare tab. p. 276, danno un valore di 66 lire per abitante circa, rispettoalle 35 lire circa per abitante dell'Italia, i cui dati sono tratti da ISTAT,Sommario di statistiche storiche dell'Italia (1861-1975), Roma 1976, pp. 11 e113321 Elaborazioni sui dati di MARCHI e LORUSSO, Movimento commerciale cit.
173
Frumento Olio Vino(in tomoli) (in salme) (in hl)
1826-33 1580563 - -1854-63 1 716285 320000 10103651870-74 2 922960 182531 7528221879-83 1 671048 117242 9031021884-88 1 465077 226706 14716281889-93 1 347105 - -1894-98 1 282517 - -
(cfr. per il periodo 1826-33: ASNA, f. Interni, Il, b. 506, fs. 1 e 2 per glianni 1829, 1830, 1831, ed E. CERRITO, La produzione dei cereali nelle provincedel Regno delle due Sicilie dal1826 al 1833, in MASSAFRA (a cura di), Problemidi storia delle campagne meridionali cit., pp. 475-93, per gli anni 1826, 1832,1833; per il periodo 1854-63 G. PETRONI, Diciott'anni della AmministrazioneProvinciale di Terra di Bari dal 1861 al 1878, Napoli 1880, PP. 71-72; per ilperiodo 1870-74 M. OTTOLINO, I caratteri dell'economia pugliese nell'età dellaDestra storica (con particolare riferimento alla Terra di Bari), in La Puglianel Mezzogiorno dall'Unità alla caduta della Destra storica (1861-1876), Bari1986, P. 131; per i periodi successivi DE FELICE, L'agricoltura in Terra di Baricit., PP. 59, 138 e 154). I dati del Petroni relativi all'olio e al vino sonochiaramente sovradimensionati, mentre quello del frumento, forse già troppobasso, andrebbe ridotto di un 20-30 per cento perché comprende l'insieme dei“grani”.
Sembrerebbe fin qui, quello di Terra di Bari nell'Ottocento,un caso da manuale di “apertura” di un'economia regionale alcommercio neocoloniale: l'aggancio con i circuiti e i ritmi della“rivoluzione commerciale” sarebbero stati ottenuti - a seguire ilfilo di una lettura di questo tipo degli elementi interpretativisu riferiti - per via di una sorta di 'normalizzazione' dellaprovincia, del suo degrado, da area che prende parte al mercatointernazionale con logiche e coerenze sue proprie, alla condizionedi semplice snodo mercantile, di periferia senza qualificazione,la cui subordinazione - distrutta quella marginalitàdell'Adriatico che aveva permesso il crescere di iniziativeimprenditoriali locali - viene sorvegliata dai numerosiprotagonisti di quella seconda discesa di imprenditori forestieri,dopo quella tardo-medievale, che prende vigore in particolaredagli anni '30.
174
In realtà le cose appaiono molto meno semplici già a rimaneresul piano di questo ragionamento per grandi aggregati. Allude aprocessi di segno opposto rispetto a quella espropriazione didirezionalità che dovrebbe accompagnare i processi di 'apertura',alla costruzione di una rete estesa di interessi e ceti checrescono reinserendo nel circolo dell'economia locale i redditi daessa prodotti, il fatto che il valore delle merci entrate neiconfini della provincia, per quanto è dato di vedere, ha un passomolto più rapido di quello delle merci che ne escono (tab. 2 1):il clamoroso gap tradizionale fra “estrazioni” e importazioni,corrispondente alla taglia mercantile e alle rendite incanalateverso Napoli o all'estero, va vistosamente re
Tabella 20.Composizione merceologica delle “estrazioni” di Terra di Bari (percentuale
sul valore globale).Fonte: elaborazioni sui dati forniti da MARCHI e LORUSSO, Movimento
commerciale cit.
Olio Vino MandorleGrano Totale
1875-79 43,8 8,3 9,9 17,7 791882-87 27,7 33,2 8,2 5 741891-96 38,6 25 10,6 1 75
stringendosi, e anzi la provincia stessa comincia adalimentare la sua economia contro fitti mercantili e intermediari,riconvertendo la sua macchina commerciale e facendo debordare ibacini di raccolta delle derrate destinate ai suoi porti daiconfini amministrativi entro i quali si era definita la regionerurale. D'altronde l'irrobustirsi dei flussi e delleinfrastrutture per il commercio estero determina una piùefficiente allocazione e distribuzione delle risorse sulterritorio. La crescita relativamente contenuta del prodottointerno finisce per non essere una strozzatura, le risorsedisponibili si accrescono e permettono un allentarsi dei freni'preventivi' e 'repressivi', un allargarsi significativo delladistanza fra natalità e mortalità, pur nell'ambito di unademografia che rimane per tutto l'Ottocento ancorata a quozientiesasperatamente elevati.
Così anche la popolazione provinciale può partecipareall'esplosione delle cifre globali, conquistando ritmi diincremento quasi doppi rispetto agli anni di maggior sviluppo del
175
secolo precedente e nettamente più alti di quelli di ogni altraprovincia del Mezzogiorno continentale: fra il 1814 e il 1861 lapopolazione meridionale cresce del 29,7 per cento, quella di Terradi Bari del 62,04; e nel ventennio postunitario le cifre sono,rispettivamente, l'11,7 e il 22,3 per cento322.
Insomma, la fuoriuscita dalle coerenze e dai ritmi del vecchiosistema regionale che non è avanzamento trionfale verso ilprogresso, ma neanche supina subordinazione ai nuovi 'centri',disgregazione territoriale e sociale.
Tabella 21.Movimento commerciale esterno di Terra di Bari in valore, e
percentuale delle importazioni sulle “estrazioni”.
Fonti: i dati per il periodo 1865-68, con ogni probabilitàsottovalutati, sono tratti da PETRONI, Diciott'anni cit., p. 67;gli altri da MARCHI e LORUSSO, Movimento commerciale cit.
valore in lire percentualedel movimento delle importazionicommerciale sulle estrazioni
1865-68 35186610 31,61873-77 115625921 58,21878-82 140924682 65,61883-87 181401068 83,21888-92 150967668 84,8
Qui più che altrove le formule riescono inefficaci. L'immaginedi questa realtà in rapidissima trasformazione va conquistataattraverso un'analisi articolata che tenti di restituirne ichiaroscuri, le complessità, le ambiguità.
322 I dati per la provincia e per il Mezzogiorno al 18 14 sono tratti da s.MARTUSCELLI, la popolazione del Mezzogiorno nella Statistica di Re Murat, Napoli1979; quelli della provincia al 1861 e 1881 da ASSANTE, Città e campagne cit.;quelli per il Mezzogiorno al 1861 e al 1881 da SVIMEZ, Statistiche sulMezzogiorno d'Italia 186i-x953, Roma 1954,
176
2. Elites ed economia.
Per l'intanto, a guardare le cose più da vicino, la violenza ela rapidità della trasformazione non sembrano implicare unasemplice negazione del passato: proprio quando il tempo dell'etàmoderna tramonta definitivamente in Terra di Bari, diventa anzievidente che la capacità della provincia di porsi in sintonia coltempo nuovo, di assumerne i ritmi, di elaborare risposte efficacialle sfide proposte, hanno a che fare con l'accumulo dicompetenze, istituti, tradizioni, realizzatosi nella vicendasecolare della regione rurale.
I protagonisti dei processi, in primo luogo, non vengono fuoridal nulla, né calano sulla provincia da lontano. Gli imprenditoristranieri non vengono a fecondare un deserto di iniziative, noninventano servendosi di una borghesia 'compradora' la collocazionedell'area nel quadro delle esigenze strategiche ed economiche dei'centri' da cui provengono, ma vengono attratti dalle occasioni diprofitto promosse da quel variegato milieu affaristico locale cheabbiamo visto crescere nei porti e nelle piazze della città dellaprovincia di età moderna, farsi largo occupando gli spazilasciati liberi dalla vecchia imprenditorialità forestiera con lamarginalizzazione dell'Adriatico, sostenere l'impalcatura delvecchio regionalismo e, al tempo stesso, diventare elementopotenziale di crisi delle sue coerenze. Saldamente piantato nellaprovincia ma proiettato al tempo stesso, per ragioni intrinsechealla sua funzione economica, verso i 'centri' dell'Europa, essoera andato scambiando merci e valori, aveva assorbito erielaborato tecniche mercantili e abiti mentali, aveva praticato emesso in circolo elementi di civiltà europea, non escluso quelpercorso dal negozio alla terra che aveva impedito la costruzionedi dinastie imprenditoriali. Il mutamento che abbiamo visto farsilargo in questo ambito nel secondo Settecento, nel corsodell'Ottocento si consolida nutrendosi anche del flusso distranieri che si radicano in provincia stringendo alleanzesocietarie e familiari con le èlites locali; va investendo cerchiepiù ampie di quelle specificamente mercantili; approfitta delladistruzione delle barriere istituzionali cetuali per diffondersifra marinai arricchiti e aristocratici, accaparratori di terredemaniali, proprietari della costa e dell'interno: gruppi pursempre minoritari e diversamente situati rispetto alle grandiopzioni ideali e politiche, e che però, collocandosi per il lorostesso dinamismo in posizioni man mano dominanti in settori
177
consistenti della società e delle istituzioni, vanno segnandolecon un'impronta ben visibile.
A guardare la realtà da questo lato ci si imbatteimmediatamente nel problema intrattabile del modificarsi dellagerarchia dei valori di orientamento dell'agire sociale. Secondole categorie della scolastica sociologica applicata all'emergenzadella borghesia, l'obiettivo della promozione dello status e dellariproduzione del consenso tramite strategie specifiche -paternalistiche, personali, comunitarie - andrebbe cedendo ilpasso, in questo torno di tempo, a quello della massimizzazionedel reddito, che da un lato finirebbe per promuovere anche lostatus, dall'altra assicurerebbe la pace sociale in un processo'automatico' di atomizzazione ed integrazione. Si tratta, come sachiunque abbia provato a pensare questi problemi sul terrenodell'indagine storica, di una metafora estremamente ardita dellarealtà. Se in qualche comunità puritana il denaro ha davveromisurato i meriti conseguiti davanti a Dio da chi lo haguadagnato, nelle società capitalistiche ottocentesche esso si èspesso vergognato di se stesso, ed in cima alle gerarchiedell'immaginario collettivo è rimasto saldamente insediato ilsignore di campagna, cacciatore di volpi e dispensatore dibenevolenza nei confronti dei contadini. E purtuttavia la ormairigogliosa ed importante 'storiografia delle qualificazioni'applicata alle borghesie ottocentesche europee non mi pare siariuscita a svuotare di valore ermeneutico lo schema weberiano.
Per quanto riguarda la nostra area, per la quale la ricerca inmerito è ancora da avviare, gli elementi disponibili convergono inquesta direzione. Se si evita, adoperando una qualche attenzionecomparativa, di prendere per pietra angolare dell'arretratezzacomportamenti diffusissimi anche fra i protagonisti dello sviluppoindustriale europeo - il fatto, ad esempio, che chi commercia consuccesso continui a voler comprare la terra - l'impressione che siricava è che qui Weber e Sombart riescano ad inviduare il sensogenerale del mutamento, l'emergere di atteggiamenti che gli stessicontemporanei avvertono come novità sconvolgenti e finiscono, comevedremo, per polarizzare la vicenda politica dell'area: a segnareil nuovo mondo che emerge dalle rovine della feudalità, per usaregiri di frase diffusissimi nella pubblicistica pugliesecontemporanea, è l'affermarsi irresistibile dello “spiritospecolativo del secolo”, di una sorta di “febbre” a cui “è vanaopera opporvisi” se non per “attenuarne l'ardore”, la quale“spinge i ceti più alti a conquistare, e talvolta senza ritegni,
178
guadagni ed utilità anche a danno del giusto e dell'onesto” efinisce per “invadere” pericolosamente perfino “la gentecampagnola”323; di “quell'interesse materiale che sventuratamentenell'attual degradazione morale della società è divenuto il numetutelare del mondo”324 e che sembra a volte segnare i “borghesiarricchiti” di queste parti ben più che quelli dei 'centri'dell'Europa. “La vita di codesti signori - afferma un osservatorenei primi anni Ottanta - si condensa nell'avidità dell'avere, delpossedere. Il denaro è il loro Dio; l'avarizia il loro culto.L'amore pel denaro non è già l'aspirazione tutta naturale elegittima negl'individui come ne' popoli, a disporre di moltimezzi pe' fini della civiltà. E' l'amore del denaro pel denaro.Massimo e unico godimento loro è d'avere a sguazzar nell'oro […]Che enorme divario tra un Gentieman-Farmer o un Cotton-Lordinglese e un quattrinaio delle Puglie!
Quegli sente tutti i bisogni della civiltà; ne pregia alcunavolta sin le finezze e le eleganze. Questi non adora che le suevecchie abitudini, e tira a vivere nella sua casa, fra le suemeschine suppellettili, come il contadino, come il bracciante, dalquale, con tutta l'opulenza, non si distingue pressoché innulla”325.
C'è una evidente esasperazione polemica in questorovesciamento di giudizio, per il quale la puritana rinuncia alconsumo viene attribuita, con valutazione inversa rispetto aquella canonica, invece che al cotonieri inglesi, ai proprietari-negozianti pugliesi: guardata dall'Italia mezzadrile, la societàdella Puglia mercantile appare barbaramente semplificata, poveradi ceti, linguaggi, istituti, simboli preposti alla mediazionesociale ed all'incivilimento dei costumi, e per questo tende amostrare nella sua nudità la trama dei nuovi atteggiamentisociali. Su questo punto occorrerà tornare. Ciò che interessa perora sottolineare è che tale trama emerge anche in questo angolod'Europa e produce conseguenze evidenti nei ritmi e nelle formedella vita sociale. Ma non una omologazione rispetto alle società'centrali', un avvicinamento progressivo ai modi di funzionare
323 Atti della Giunta per la Inchiesta agraria e sulle condizioni della classeagricola, vol. XII, fs. 1, Relazione del Commissario Barone Giuseppe AndreaAngeloni ( .. ), Roma 1884, P. 486.324 Così scrive nel 1859 l'Intendente di Terra di Bari a proposito delle manovrespeculative di proprietari e commercianti di grano, in ASBA, f. Agricolturaindustria commercio, b. 104, fuori fascicolo.325 R. MARIANO, Puglia e Pugliesi. Noterelle di viaggio del traduttore, in F.GREGOROVIUS, Nelle Puglie, Firenze 1882, P. 31.
179
delle economie della prima rivoluzione industriale, secondograduazioni che misurerebbero il diverso tasso di arretratezzadelle singole situazioni.
C'è una sfasatura strutturale nell'Ottocento fra la capacitàdiffusiva delle mentalità e quella dei comportamenti concreti. Ilself-interest, esaltato dalla schiera numerosa di epigoni e diffusoridell'economia politica classica come motore universale diprogresso materiale e civile, tende a ricucire l'Europaottocentesca, diffondendo simili valori di orientamento dell'agiresociale in gruppi di diversa consistenza a seconda delle realtàlocali ma presenti anche in aree 'arretrate'; ma, al tempo stesso,ne divarica la capacità di produrre sviluppo ed egemonia sociale.Proprio perché animati da un self-interest sostanzialmente simile,i gruppi dominanti europei devono avere comportamenti concretiqualitativamente diversi ma pure tutti in qualche modo'razionali', adeguandoli ad una struttura delle convenienze che halimiti di plasticità ristretti, segnati da rapporti di forzamilitari e politici, oltre che economici, che solo nei libri diSchumpeter l'imprenditore è capace di travolgere.Nel caso di un'area come la nostra, la variabilità edimprevedibilità con cui il mercato ottocentesco si presenta aititolari delle decisioni economiche impone ad essi di evitareimmobilizzi pesanti nel momento della produzione, possibili soloin una condizione di visibilità del futuro, di sicurezzanell'esito dell'investimento; induce a diffondere il rischio su unarco ampio di iniziative agricole, commerciali, finanziarie, coninvestimenti sempre leggeri e relativamente liquidi, smobilitabiliai primi segnali negativi del mercato; a usarne le'disuguaglianze' intrecciando profitti commerciali e speculativi;a escogitare forme di centralizzazione delle derrate destinate almercato in grande che riescano a evitare loro il rischio sempreincombente dei grossi stock invenduti; a stringere rapporti diproduzione fondati sull'autosfruttamento contadino più che sullosfruttamento diretto, cosicché i costi delle inerzie inevitabilidel paesaggio agrario nel rapido modificarsi delle convenienzevengano scaricati in larga parte sugli stessi contadini.L'obiettivo di fondo è quello di trovare, per fasiirrimediabilmente più corte dei respiri dell'età moderna, gliinterstizi di mercato in cui collocare derrate ormai prive dimargini strutturali di competitività, di 'forzarlo' dal momentoche non si può aspettare passivamente che i suoi automatismiproducano reddito, di cercare volta per volta atti di domanda per
180
ciascuno dei propri atti di offerta. E' dunque sul crinale delmercato, nel sorvegliarvi occhiutamente le occasioni diinserimento che si aprono improvvise consentendo guadagni unitaria volte altissimi che continuano a svilupparsi capacità,competenze, profili professionali anche sofisticati, che da unlato costruiscono lo stereotipo dell'affarista provinciale animatoda spirito levantino, speculare rispetto all'immagine canonica delgalantuomo meridionale infingardo; dall'altro connotano unapratica imprenditoriale priva di punti di gravitazione stabili,per così dire 'scentrata'. Nelle aree forti d'Europa nei corsodell'Ottocento la figura complessa del “negoziante” di anticoregime si va scomponendo in quelle chiare e distinte del mercanteall'ingrosso e di quello al minuto, dell'armatore, del finanziere,del produttore che anticipa salari in cambio di forza-lavoro,lungo un processo di specializzazione e semplificazione cheimplica la riconquista di una visibilità del futuro, di un marginestrutturale di competitività fondato sull'economia, dopo iltramonto della stabilità di età moderna fondata sulla separazionedei mercati e le vocazioni naturali; nell'entroterra dei porti e aridosso di alcuni centri interni della provincia si fanno largo,al contrario, figure imprenditoriali con connotati ancora piùcomplessi e molteplici di quelli del vecchio “negoziante”, sianoessi mercanti di grano che acquistano latifondi e li trasformanoin sintonia strettissima con gli umori del mercato, siano grossiproprietari che imparano a fare i conti con la borsa e i listini.
Io credo che l'olio avrà prezzo - scrive uno di questi ultimi, unesponente 'reazionario' dell'aristocrazia di Bitonto, a proposito delle manovrespeculative generate dal colera del 1836 - quantunque da Francia fanno icontegnosi sotto il pretesto della malattia corrente. Ma i gattini hanno apertigli occhi, e tutti oggi e da per tutto la sanno lunga. Bisogna decidersi apreparare idonee piscine per conservar così l'olio fine, come il comune; riporloattentamente, lasciarlo riposare, come fanno in Toscana, ed in Genova, edaspettare che i Francesi vengano a chiederlo. I forti capitalisti cheprenderanno questo partito, si emanciperanno da ogni servitú forestiera: io losto dicendo dall'anno passato, e qui incominciano a sentirmi326.
E in questo “incominciare a sentire”che il segreto delsuccesso imprenditoriale sta nel saper praticare accortamente ilmercato senza affidare il compito ad altri, nel riversarsi anchein strati proprietari di competenze e furbizie mercantili maturate
326 Lettera di Carmine Sylos al Giovene del 26 novembre 1836, in BN Bari, f.D'Addosio, 26/6. Su questa figura importante ed in qualche modo tipica Cfr. L.sylos, I tempi e la vita di Carmine SyIos, Bitonto 1926
181
nei secoli, aggiornate e applicate alla situazione nuova senza lapretesa di rovesciarla, il nocciolo dell'emergenza di unaborghesia della Puglia barese, che invano si cercherebbe frugandonel mondo dei produttori in senso stretto, fra contadini emassari. Il momento della produzione non solo non riesce adiventare, a differenza che nei modelli canonici, il momentocentrale e decisivo della vita economica, quello che determinaaccumulazione, egemonia sociale e politica, valori diffusi, ma vaperdendo quella pur limitata autonomia che aveva conservato in etàmoderna. Anche allora la produzione si svolgeva in un quadro incui la domanda, le risorse finanziarie, il comando politico eranoin altre mani; purtuttavia un ambito preciso di decisionieconomiche era affidato ai produttori, alle loro praticheripetitive, al loro rispetto delle permanenze che garantivano aiceti dominanti margini consistenti e relativamente sicuri; ora, inuna condizione di flusso continuo delle convenienze, l'anticadistinzione fra momento della produzione e momento dellacircolazione salta, quest'ultimo tende a subordinare il primo, asoffocarne l'autonomia, ad aggredirne le permanenze e asubordinarne le scelte alle mutevolezze del mercato.
L'economia ottocentesca ha come protagonisti non più contadinie massari, ma mercanti e proprietari che, risultando in largaparte impediti di 'fare come l'Inghilterra', dovranno comunquesconvolgere assetti produttivi ed equilibri sociali secolari.
3. La crisi del regionalismo rurale.
Non ci si può certo aspettare, da protagonisti della vicendaeconomica con un profilo come quello su delineato, atteggiamentidi contestazione presuntuosa della divisione internazionale dellavoro che assegna alla nostra area un ruolo di produttrice diderrate da scambiare con i manufatti della prima rivoluzioneindustriale. Evidente è, nell'arco di tempo qui considerato, lacrisi delle già deboli forme di manifattura domestica e dei nucleidi produzione secondaria specializzata che si erano strutturatinel corso dell'età moderna327, e comunque fra questi ultimi e leiniziative manifatturiere ed industriali che vanno realizzandosinell'ultimo Ottocento c'è una soluzione di continuità, unafrattura in termini di personale, strutture, luoghi. Non è certoquesta una patria della protoindustria.
La consistenza relativamente alta che ciononostante hanno i
327 Cfr. VISCEGLIA, Lavoro a domicilio cit182
settori extraagricoli di Terra di Bari non solo rispetto asituazioni rurali scarsamente mercantilizzate come la Basificata,ma anche rispetto alle altre province pugliesi (cfr. tab. 22) nonè un dato nuovo, e fa riferimento all'apparato preposto allacircolazione all'interno di una realtà composta di aree fortementespecializzate, ed all'esportazione, nella quale, come vedremo, itradizionali margini di indipendenza del ceto mercantile localevanno accrescendosi nel corso dell'Ottocento.
I dati censuari confermano, comunque, che è attornoall'agricoltura che la partita continua a giocarsi.
La distruzione della feudalità, il venir meno del vincolismoannonario e mercantile, le censuazioni ed affrancazioni, gli spaziconcessi alle usurpazioni a danno delle terre comuni edall'aggressione al bosco ed all'incolto; in sostanza le grandinovità prodottesi nell'Ottocento nel rapporto fra stato e società,costituiscono, qui come altrove, il quadro di riferimento deiprocessi di trasformazione nell'economia e negli equilibriterritoriali. Ci sono però delle specificità che la storiaconsegna a questo Ottocento provinciale: la trasformazione trovaqui modo di dispiegarsi aggredendo, accanto al vincolismoregolamentato, alle forme di tutela sulla società esplicite etipiche dell'antico regime, su cui ruota la vicenda politicaufficiale, il vincolismo 'sommerso', non regolamentato e specificodel vecchio regionalismo rurale, cioè l'insieme dei limiti allamercantilizzazione integrale, delle cuciture interne, delle formedi ammoffizzazione che schermavano in qualche modo i produttoridall'impatto del mercato, garantivano loro forme di autonomia, celi presentavano come figure complesse e sfuggenti.
Alla fine dell'Ottocento, a guardare i dati quantitativicomplessivi, la società rurale barese appare al contrariostraordinariamente 'semplice', segnata da un rapporto altissimofra lavoratori “dipendenti” e “indipendenti” non lontano da quellodelle altre province pugliesi ma lontano dalle medie meridionaleed italiana (cfr. tab. 23). Certo nell'ultimo ventennio del secoloi dati descrivono un ispessirsi significativo degli strati dicoltivatori m conto proprio, ma questo si accompagna ad unacrescita ulteriore della distanza delle province pugliesidall'Italia contadina, che si presenta ormai clamorosa: losvuotarsi della categoria dei salariati fissi finisce peringigantire, invece che gli “indipendenti”, come nella penisola ingenerale, il numero ed il peso relativo degli avventizi, di quellemasse bracciantili che identificheranno il panorama culturale,
183
sociale e politico della Puglia agricola novecentesca.Come si è accennato, non si tratta di un caso classico di
proletarizzazione, di società che va ricomponendosi in formeriassumibili nella coppia lavoro salariato - capitale. I dati deicensimenti pertengono, come si sa, più alla autorappresentazionedei corpi sociali che alla realtà 'oggettiva'.
Tabella 22.Composizione professionale nelle province pugliesi secondo i censimenti
della popolazione (percentuali).La tabella è costruita in modo da essere confrontabile con le tabelle 10 e
11 alle pp. 119 e 120 di questo scritto, raggruppando mestieri e professioni ingrandi partizioni grosso modo simili a quelle usate per l'età moderna eprendendo in considerazione i soli maschi di età superiore agli otto anni. Fra icosti di questo procedimento c'è quello di occultare fenomeni importanti: adesempio la caduta verticale fra 1881 e 1901 della manodopera femminile impegnatanel comparto tessile.
Fonti: MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. DIREZIONE GENERALEDELLA STATISTICA, Censimento della Popolazione del Regno d'Italia al 31 dicembre1881, volume III, Roma 1884; ID., Censimento della Popolazione del Regnod'Italia al 10 febbraio 1901, volume IV, Roma 1901.
Terra di BariCapitanata Terra d'Otranto Italia1881 1901 1881 1901 1881 1901 1881 1901
Agricoltura e pastorizia 59,3 62,8 68,3 67,3 66,3 65,3 58,558,8
Pesca e caccia 0,4 1,6 0,2 0,5 0,9 1 0,5 0,5Navigazione 2,3 1 0,8 0,6 0,6 0,6 1 0,8Industria, commercio, trasporti 32 28,4 24,6 24,8 26,2 26,5 32
31,4Professioni e pubblico impiego 4,7 6,1 4,2 6,7 4,1 6,2 5,2
7,8Servizio domestico 1,2 0,1 1,8 0,2 2 0,4 2,8 0,7
La figura dell'avventizio, in particolare, non esclude unrapporto con la terra, e presenta profili sociali e culturali eprocessi di formazione tutt'altro che omogenei; d'altronde lemedie nascondono situazioni divergenti, nuove articolazioni chesolo nel loro intreccio individuano il senso della trasformazionein atto.
Per coglierne le caratteristiche occorrerà perciòriattraversare le tradizionali zone agricole, appuntarespecificità e tratti comuni.
La costa olivicola è in un certo senso la meno attrezzata adaffrontare la mutevolezza dei tempi nuovi a causa dell'elevatarigidità di un paesaggio agrario centrato su una pianta di alto
184
valore e a produttività differita. La trasformazione è comunqueampia, anche se deve farsi largo per linee interne.
La sproporzione secolare tipica di quest'area fra popolazioneabbondante e terra scarsa, acutizzatasi dopo l'espansionedemografica settecentesca, avrebbe dovuto attenuarsi, secondo lelogiche del regionalismo rurale, nel corso della successiva crisi;ma, come sappiamo nell'Ottocento l'incremento della popolazione sifa ancora più rapido che nella fase precedente e finisce perrompere definitivamente il tradizionale meccanismo di contenimentodella 'proletarizzazione' tramite la frantumazione degliappezzamenti di dimensione media. Un numero in proporzione sempreminore di lavoratori riesce a conquistare in fitto o in proprietàterra in frammenti sempre più piccoli a prezzi sempre più alti, euna quota crescente dei tradizionali “bracciali” si trasforma inbraccianti, contadini senza terra non più per fasi e ciclivitali, ma in forma stabile. Il nesso fra lavoro in conto terzi elavoro in proprio, che aveva costituito la chiave di volta degliequilibri sociali e produttivi dell'agricoltura dell'albero, nonriesce più a garantire alle famiglie contadine margini di manovraconsistenti, capacità di difesa dai rigori del mercato dellebraccia.
Tabella 23.
Composizione professionale degli addetti all'agricoltura nelle provincepugliesi secondo i censimenti (percentuali).
I dati riguardano maschi e femmine di età superiore agli 8 anni e non prendonoin considerazione le categorie, del resto di scarsissima consistenza, che nonesplicitano il loro rapporto con la terra (esempio: giardinieri, boscaioli,ecc.).
Fonti: cfr. tabella 22.
Terra di BariCapitanata Terra d'Otranto Italia1881 1901 1881 1901 1881 1901
1881 1901
Agricoltori in proprio 13,3 15,5 12,2 15,8 15 16,6 16,2 28Mezzadri, coloni,
enfiteuti, fittavoli 2,7 8,2 3,3 8,2 3 11,4 1829,9
Salariati fissi 39,7 10,3 36,9 11,7 38,4 10,8 34,411,4
Giornalieri 44,3 66 47,6 64,3 43,5 61,3 31,330,7
185
Anche perché il possesso della terra, nelle fasi sempre piùbrevi in cui si riesce a conquistarlo, garantisce una coperturasempre minore dai rischi della mercantilizzazione.
Ancora una volta, negli anni di blocco del commercio per marecausato dalle guerre napoleoniche e ancora negli anni '20, quandoil prezzo dell'olio crolla fino a livelli infimi, il soprasuoloviene aggredito, gli alberi dei minifondi concessi in fittosoprattutto dagli enti ecclesiastici vengono usati per legnare oaddirittura svelti per far posto ai prodotti del suolo daautoconsumare328. Ma i tempi sono cambiati e questa vicenda non stapiù dentro i cicli chiusi dell'età moderna. Le clausolecontrattuali a salvaguardia del valore della terra siinaspriscono, e questa volta il loro successo sembra pieno perchécominciano a incontrare una tendenza a sciogliere la secolareambiguità colturale del minifondo: la via d'uscita a unasituazione di fitti sempre più esosi e di indebitamento crescentecausato dal lievitare del prezzo della terra comincia ad essereintravista dallo stesso coltivatore nella 'razionalizzazione'dell'uso del suolo, nella massimizzazione del reddito monetariotramite una concentrazione del suo impegno di lavoro in manierasempre più esclusiva sugli alberi, in una sorta di scommessa sullaspecializzazione integrale dell'azienda che l'inversione sia purtimida del trend dei prezzi e la nuova facilità di smercio delprodotto, propiziata dai nuovi trappeti capaci di trasformarlo inolio da tavola, rendono in una certa misura vincente.
I tempi di questa trasformazione sono tutti da precisare, mail risultato è evidente: se anche nell'area di massimaspecializzazione si era rimasti per secoli di gran lunga al disotto di una media di 100 alberi a ettaro, e ancora alla finedegli anni '20 dell'Ottocento l'olivicoltura provinciale presentail volto di una coltura promiscua, a fine Ottocento si è già a unamedia provinciale, sostanzialmente simile a quella odierna nellearee non irrigue di 125 piante per ettaro, contro le 110 dellaCapitanata e le 84 di Terra d'Otranto329: la pratica diffusissimadella semina sotto gli alberi diventa, ai tempi dell'Inchiesta
328 Cfr. per questi problemi PALUMB0, Una piccola azienda agricola cit. e ID., IlPrezzo delle derrate agricole sulla piazza di Molfetta dal 1806 al 1861, in«Archivio storico pugliese », 1968, pp. 242-69.329 ASSANTE, Città e campagne cit., p. 35. Per le caratteristiche del paesaggioolivicolo nel 1829 cfr. ASBA, f. Agricoltura industria commercio, b. 163, fs.163.
186
Presutti, del tutto eccezionale330.Così il rilancio del ruolo del minifondo nel reddito
complessivo della famiglia contadina viene cercato rinunziando aquella sorta di ammortizzatore sociale, capace di offrire unqualche respiro quando l'annata riusciva cattiva o i prezzicedevano, costituito dai prodotti del suolo. Una scelta tanto piùsignificativa in quanto è parte di un quadro di generale erosionedelle voci secondarie del reddito familiare tipico: la diffusionedi intermediari mercantili specializzati, parallelaall'allungamento del raggio del commercio interno e allaspecializzazione per aree anche di derrate come il vino e gliortaggi, riduce il reddito derivante dalla vendita in proprio, neimercati settimanali o in casa, dei residui prodotti integrativi;il trappeto di Ravanas riduce da 4-6 mesi a 2 mesi circa i tempidi spremitura delle olive e la connessa domanda di braccia; lacapacità di penetrazione nelle abitudini di consumo degli stratisociali bassi delle merci della prima rivoluzione industrialeriduce ulteriormente lo spazio, tradizionalmente ristretto, dellaproduzione domestica femminile331. La redditività dell'olivicolturava affidandosi, senza più residui, alla vendita sul mercato delprodotto degli alberi, cioè, in sostanza, alla domandainternazionale di olio conquistata, organizzata, filtrata eripartita da un ceto composito di mercanti, armatori, mediatori,banchieri e assicuratori, agenti e corrispondenti di casecommerciali, proprietari di piscine e trappeti, quasi maiimpegnati in uno solo di questi fronti e dotati di appendici,legami, contatti che si diramano per ogni dove nel corpo sociale.
Alla testa di questa società non c'è più una casta, comepoteva sembrare per certi aspetti il ceto mercantile chepresiedeva al commercio a lunga distanza di antico regime, quandoil controllo sui mezzi di trasporto idonei a movimentare unaderrata di valore relativamente basso rispetto al peso e destinataa pochi grandi acquirenti come prodotto intermedio, bastava aconsegnare ad esso un potere monopolistico: la conversione di unaparte crescente della produzione provinciale in olio da tavola“emancipa” questo circuito dal “monopolio dei piccolinegozianti”332, lo popola di figure nuove e più numerose, allarga ilventaglio degli acquirenti, dirama la derrata anche per le vie330 Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle provinciemeridionali e nella Sicilia, vol. III, Puglie, tomo I, Relazione del delegatotecnico Prof. Errico Presutti, Roma 1909, p. 82.331 Cfr. B. SALVEMINI, I circuiti dello scambio: Terra di Bari nell'Ottocento, in«Meridiana», 1987, n. 1, PP. 47-79
187
terrestri su cui, diventando economico spedire piccole quantità,riesce a commerciare anche chi dispone solo di qualche salma;contamina reciprocamente la figura del mercante e del proprietariotradizionali.
Purtuttavia, forte rimane per costoro la centralità delmomento della circolazione, netto il loro profilo 'urbano', e, diconverso, scarso l'impegno diretto nell'investimento agricolo,caricato in larga parte sulle spalle di contadini che riesconoraramente a riscattarsi dall'urgenza dei bisogni elementari.
Liberandosi dei suoi secolari ammortizzatori sociali,l'olivicoltura contadina compie nell'immediato un salto in avantisul piano della produzione, ma la sua capacità espansiva siesaurisce presto, limitando drasticamente il diffondersi dellosviluppo dai pochissimi centri in cui si concentrano i redditi daintermediazione all'insieme delle campagne, e mettendo a nudo inuovi più acuti squilibri sociali determinati dallaspecializzazione integrale. I terreni poco profondi e aridi,eccessivamente sollecitati dall'infoltimento, non riescono areggere un livello di produttività stabilmente più elevato diquello tradizionale e offrono il fianco al diffondersi dellemalattie dell'olivo, che infieriscono nell'area soprattutto neidecenni postunitari333. Chi conquista un minifondo scommettendotutto sull'olio da vendere rimane sempre più di frequente deluso edeve aggiungere l'offerta delle sue braccia per lavoro in contoterzi a quella alimentata dall'espansione demografica e dallaspecializzazione, facendola crescere ben al di là della purcrescente domanda di braccia espressa dagli oliveti infoltiti e332 Il sindaco di Bitonto all'Intendente, 8 dicembre 1836, in ASBA, f.Agricoltura industria commercio, b. 15, fS. 22. Su questi problemi cfr., oltrealle efficaci pp. 110-11 di MASSA, Il prezzo e il commercio cit., l'ampiamemoria dello stesso Ravanas inviata al ministro dell'Interno nel settembre1831, Précis des motifs qui m'ont amené dans le Royaume, et de mes travauxpendant six années pour créer une bonnefabrication d'huile fine si necessaire etsi importante pour tous le pays d'oliviers, et indispensable pour la prosperitéde la province de Bari, in ASNA, f. Interni, Il, b. 571. Un quadro vivace diquesto milieu imprenditoriale, del ruolo che vi hanno gli stranieri, dei suoinessi con la Società provinciale, emerge dall'appendice documentaria di m.VITERBO, Un fratello di Garibaldi commerciante in oli a Bari, estratto da«Archivio storico pugliese », 1970.
333 Cfr. A. CORMIO, Le campagne pugliesi nella fase di 'transizione', inAA.VV., La Modernizzazione difficile. Città e campagne nel Mezzogiorno dall'etàgiolittiana al fascismo, Bari 1983, in particolare p. 166. Tengo presente questosaggio di Cormio, ed il suo altro Note sulla crisi agraria e sulla svolta del1887 nel Mezzogiorno, in MASSAFRA (a cura di), Problemi di storia delle campagnemeridionali cit., PP. 539-67, per tutta la materia di questo paragrafo.
188
provocando un crollo clamoroso del salario medio in termini reali.L'agricoltura dell'olivo aveva sempre avuto bisogno del sostegnodel reddito della mietitura, ma era comunque riuscita per secoli adominare l'orizzonte sociale dei centri costieri, a definirne iprofili sociali, complessi ma riconoscibili, della grandemaggioranza della popolazione.
Ora la situazione si fa più confusa e squilibrata. Le fasi didisoccupazione stagionale, trovando un compenso sempre minore neiredditi integrativi estraibili nella zona stessa, si fanno piùestese, provocano situazioni di disagio sociale acutissimo anchein inverno, d'estate determinano un intensificarsi ulteriore dellemigrazioni temporanee verso le aree del grano, richiamanol'intervento preoccupato degli organi amministrativi334, nel mentresi diffondono fenomeni di marginalità massiccia, che spingono la“poveraglia”335 a convergere nelle città in cui la ricchezza va aconcentrarsi e affollano attività collocate in maniera incerta sulcrinale fra il lecito e l'illecito: già negli anni '40 e '50 “unnumero immenso di operai”vive bruciando alghe con legna rubataagli oliveti e vendendo la cenere ai fabbricanti di sapone e ilsale di contrabbando; altri si danno a forme di pesca da terra cheprovocano una conflittualità acuta e disperata con i pescatoridelle barchette; altri ancora alimentano il fiorente circuito'nero' degli attrezzi agricoli, rubandoli nei depositi e neicasini di campagna e rivendendoli, magari, a chi è costretto aportare i propri al Monte dei pegni336. E poi ci sono quelli che, innumero crescente, lacerano ogni rapporto con gli ingrati boschi diolivi e trasformano le migrazioni stagionali verso le areegranifere in emigrazioni definitive, preparando il terreno allagrande emigrazione transoceanica dei decenni fra Otto e Novecento,che troverà nei centri olivicoli tradizionali uno dei suoi luoghi334 Il 27 febbraio 1853 i decurioni di Molfetta lamentano «la posizionelacrimevole di 2000 famiglie che, composte di individui addetti esclusivamenteal mestiere di braccianti, offrono il dispiacevole caso di essere minacciati dalpericolo di morire d'inedia » (AC Molfetta, Conclusioni decurionali, categoriaXVI, VOL. 21). Essendo la disoccupazione estiva mitigata dalle migrazioni per lamietitura, è d'inverno che si organizzano lavori pubblici a sollievo deibraccianti senza lavoro (cfr. ibid., vol. 23, 26 novembre 186o). Sul degradorelativo di Molfetta nella prima metà del secolo cfr. anche le lettere delGiovene del 21 novembre 1819 e 28 giugno 1833 in BN Bari, f. D'Addosio, 35/12-29e 26/2.335 E' l'espressione che usa il governatore dell'ospedale civile di Bari nel 1864a proposito dell'inurbamento determinato dalle «vicende dell'industria e delcommercio»; cfr. E. DI CIOMMO, Bari 18o6-I940. Evoluzione del territorio esviluppo urbanistico, Milano 1984, P. 118.336 SALVEMINI, I circuiti dello scambio cit., PP. 55-56.
189
di elezione; oppure emigrano. per così dire, verso l'internostesso delle città costiere, verso la società 'separata' dellapesca d'altura che, a partire dai primi dell'Ottocento, vaassorbendo braccia in quantità ben maggiore di quante riesce aimpiegarne il commercio per mare337. I centri olivicoli che riesconoin qualche maniera a tenere il passo, sul piano della crescitademografica, delle agrotowns dell'interno, devono somigliaresempre meno a queste ultime: il corpo sociale di centri comeMolfetta o Mola va ormai lacerandosi fra gente di terra e gente dimare, ciascuna dotata di mentalità, forme di comportamento,strategie economiche distinte. La piazza contadina e gli apparatiprofessionali che sovrintendono allo scambio dei fattoriproduttivi e delle merci agricole non riescono più a contenere lastoria del borgo. La contrapposizione fra costa e interno non stapiù solo nelle forme del paesaggio ma morde finalmente nellarealtà sociale e mentale.
Nella prima metà del secolo una proporzione ancora maggioredelle migrazioni stagionali rispetto a quelle del Cinque-Seicento,e probabilmente anche di quelle definitive, si concentra nell'areaa cavallo del corso meridionale dell'Ofanto - 28 dei 52 contrattidi anteneria rinvenuti fra i notai molfettesi nel periodo 1779-1856338 riguardano terre a grano di Andria, Barletta e Casal
337 ID., comunità 'separate'cit., in particolare PP. 449 sgg.338 ASBA, sez. Trani, notai roganti in Molfetta: Luigi Antonio Massari, atti 4novembre 1779 (due atti), 6 maggio 1781, 6 gennaio 1784, 26 novembre 1785, 8settembre 1787 (due atti), 15 aprile 1792, 26 gen naio 1794, 17 maggio 1794, 20maggio 1795, io giugno 1795, 28 febbraio 1796, 13 marzo 1796, 28 agostO 1796, 25dicembre 1797, 11 maggio 18oo, il febbraio 18oi, 15 ottobre 1804, 12 gennaioi8o6, 2 febbraio 18o8, 22 dicembre 18o8, 2 maggio 1825; Domenico Visaggio, atti6 marzo 1797 (descritto in repertorio ma non rinvenibile nei protocolli), 28gennaio 1821 (id.), 14 maggio 1822, 28 gennaio 1823, 11 marzo 1836 (due atti delrepertorio); Domenico Minutillo, atti 20 maggio 1798, io aprile 1818(repertorio), 2 febbraio 1818 (id.), 14 luglio 1819 (id.), 5 agosto 18iq (id.),22 luglio 1820 (id.), io settembre 1821 (due atti, repertorio), 3 settembre 1821(id.), 9 febbraio 1823 (id.); Vincenzo Raffaele Massari, atti 18 giugno 18oo, 18agosto 18oi, io agosto 1802, 6 luglio 1803, 22 dicembre 1803, Io dicembre 18o4,6 maggio 1811; Onofrio Bartoli, atti tutti descritti in repertorio ma nonrinvenibili nei protocolli: 23 febbraio 1818, 25 gennaio 1826, 3 dicembre 1826,3 marzo 1828, 5 gennaio 1839, 17 settembre 1841; Domenico Minutillo, attidescritti in repertorio ma non rinvenibili nei protocolli: 1 aprile 1818, 2aprile 1818, 14 luglio 1819, 5 agosto 1819, 22 luglio 1820, il settembre 1821(due atti), 3 settembre 1821, 9 febbraio 1823; Vitantonio Tripaldi, attodescritto in repertorio 19 maggio 1824; Ferdinando Spadavecchia, atto descrittoin repertorio 18 maggio 1831; Francesco Saverio Pomodoro, atto descritto inrepertorio 22 giugno 1854; Domenico Antonio Pomodoro, atto descritto inrepertorio 19 marzo 1856.
190
Trinità, nel mentre l'area cerealicola fra la Puglia e laBasilicata sembra avere un ruolo ormai del tutto marginalenell'integrazione del reddito dei contadini costieri. Ma, aguardar meglio, lungi dall'essere la sanzione di un processosecolare, questo intensificarsi dei flussi fra la costa olivicolae quella cerealicola settentrionale copre un modificarsisostanziale degli equilibri e dei nessi interni alla provincia. Ilmutamento di clima è immediatamente visibile già nella forma nuovaassunta dai rapporti di lavoro alla mietitura. Il tradizionalecontratto a cottimo garantiva la rapidità dell'esecuzione, maprovocava un residuo notevole di spighe lasciate al suolo daimietitori339 a volte volutamente allo scopo di permettere aifamiliari condotti con sé di raccoglierne in abbondanza egratuitamente, protetti dal secolare diritto alla spigolatura, ecomunque a sufficienza da giustificare i massicci flussi, inparticolare femminili, verso i campi appena mietuti. A partiredall'inizio dell'Ottocento anche questo elemento integrativo delreddito contadino è fatto oggetto di un attacco deciso da partedei conduttori: il contratto di mietitura a cottimo è sostituitoda quello a giornata, la rapida esecuzione del lavoro vieneaffidata a un inasprimento della sorveglianza, e le spighe rimasteal suolo, anche se meno numerose di quelle lasciate dalle“paranze” che lavoravano “a staglio”, vengono valorizzate,raccolte per conto del massaro da squadre di “ragazzi” assuntiall'uopo.
Nel contempo il prevalere di questa destinazione dei flussimigratori stagionali va smarrendo, proprio in questa fase diaccelerazione, le sue basi strutturali. Fino ai decenni centralidel secolo la spinta a emigrare dagli uliveti è bilanciata dalladomanda stagionale di braccia verso la cerealicoltura dellaprovincia settentrionale e della Capitanata meridionale in rapidaespansione, anche perché nelle “locazioni” di Andria, Canosa eCasal Trinità vengono svincolate dalla destinazione pastorale lameestese e terre nere in piano capaci nell'immediato di unaproduttività altissima340, ricostruibile, in assenza di investimentimassicci, solo rinsaldandole dopo averle 'stancate', restituendoleall'azione di lungo periodo della natura. Ma questo ciclo tipicodelle permanenze dell'agricoltura pugliese viene interrotto daquella sorta di ansia di immediata valorizzazione prodotta dal339 Calcolabile in 3-4 tomoli di grano a versura (CIMAGLIA, Della natura e sortecit., P. 53; DE CESARE, Delle condizioni cit., p. so, nota; ASSANTE, Città ecampagne cit., p. 243).340 DE CESARE, Delle condizioni cit., PP. 45-46.
191
diffondersi fra i proprietari dello “spirito specolativo delsecolo”, che li porta a mettere in discussione le forme diorganizzazione della produzione strutturatesi insieme all'“anticacorrispondenza delle colture”341.
Come sulla costa olivicola si destruttura la logica internadella cellula produttiva fondamentale, il minifondo olivicolo,così comincia qui ad essere attaccato l'organismo produttivo piùimportante dell'area, la “massaria grossa”. A partire dagli anni'20 e '30 grossi proprietari spesso rafforzatisi nelle vicendedell'eversione della feudalità, usando come bussola delle propriedecisioni il mercato e le sue bizzarrie, cominciano adeformalizzare e a rendere più elastico il processo produttivo,sottoscrivono nei contratti di concessione in fitto di masserieclausole generiche sulle rotazioni, cominciano a concedere libertàdi coltura purché non si “pervertisca” la natura del suolo,lasciano che si metta mano, al di fuori delle regole canoniche,alle “terre di portata”, strappano le “mezzane pascolatorie”, chenutrivano gli animali da lavoro al servizio della cerealicoltura,alla loro condizione giuridica semipubblicistica e ne permettonoil dissodamento. Quel che è più, il titolo proprietario sullemasserie comincia ad essere spezzettato a ogni successione e laproprietà si ricompone su terre non organizzate al propriointerno, cedibili in fitto in appezzamenti di dimensioni'irregolari', né grandi a sufficienza da sopportare le vecchielogiche colturali 'ecologiche', né polvere di latifondo coltivatanelle fasi morte del ciclo agrario da contadini che traggono dallavoro salariato alla masseria la parte più sostanziosa delproprio reddito342.
Non ingombra, come la costa centrale, di una coltura rigida edifficilmente sostituibile come l'olivo, non più incasellata inorganismi produttivi che tendono a stringere un nesso con il granoe l'incolto, dotata a tratti di terre profonde più produttive diquelle che ricoprono la roccia calcarea dominante nella provincia,l'agricoltura di quest'area si fa più variegata, cerca, insintonia con gli impulsi del mercato, forme di valorizzazione più
341 S. FIORESE, Storia della crisi economica in Puglia dal 1877 al 1897, in LaTerra di Bari sotto l'aspetto storico cit., P. 74.342 Cfr., in particolare, la tesi di laurea di C. SCARDIGNO, Evoluzione dellaproprietà fondiaria e patti agrari a Barletta dal 1800 al 1840, facoltà diLettere e filosofia dell'Università di Bari, a.a. 1970-71; per la questionedelle « mezzane » cfr. la relazione della delegazione per le operazionidemaniali di Barletta del 17 Settembre 1832 in ASBA, f. Demani comunali, b. 16,fs. 180.
192
intensiva che ripaghino il costo altissimo della terra eutilizzino al meglio il fattore abbondante e a buon mercato, illavoro; accetta una sorta di divisione del lavoro col Tavolierecentro-settentrionale e le sue grandi riserve di terra coltivabiledi prezzo ormai clamorosamente inferiore rispetto a quello dellacontigua provincia343.
Seguiamo un valente agronomo, Achille Bruni, nel suo viaggionelle campagne fra Andria, Canosa, Barletta e Trani344 in una fasein cui i processi di trasformazione appaiono ormai in pienosvolgimento, nei tardi anni '50.
Il tratturo parallelo al mare e i pascoli sono ancora una notaincisiva del paesaggio, ma elementi di novità vanno emergendodovunque si posi lo sguardo. “L'ingordigia di dissodare glierbaggi [...] per seminare grano” giunge ormai a intaccare gliargini dell'Ofanto provocando allagamenti rovinosi, e il“ristretto” che nel secondo Settecento rimaneva attaccato allemura di Barletta si incunea ora in profondità fra i suoli nudi.Vecchie colture integrative del reddito contadino imperniato sullavoro fisso o saltuario erogato nelle masserie, si dotano dilogiche proprie, creano specializzazione, cercano sbocchimercantili. A sud delle foci dell'Ofanto per quattro miglia, e poiancora fra la consolare da Barletta a Trani e il mare, sui terreniarenosi delle “paludi”, crescono ortaggi che trovano mercato nonpiù solo nelle piazze vicine ma si irradiano per la provincia permezzo di intermediari specializzati, insieme a cotone in quantitàgià notevole ma pronto a uno spettacolare quanto effimero balzo inavanti in coincidenza del blocco delle esportazioni americanecausato dalla guerra di secessione. E dal lato opposto, versoCanosa e Andria, i mandorli, da sempre associati sulla costacentrale agli olivi allo scopo di fornire reddito nei mesidifficili fra la mietitura e la raccolta delle olive, danno vita a
343 Alla vigilia dell'Unità, secondo DE CESARE, Della condizione cit., p. 66, ilprezzo della terra in ducati in ciascuna delle province pugliesi è il seguente:
Terra di Bari Terra d'OtrantoCapitanata
una versura di I classe 120 80 90una versura di II classe 90 60 70una versura di III classe 70 40 50una versura vitata 1000-1200 300-400
200-300344 A. BRUNI, Descrizione botanica delle campagne di Barletta, Napoli 1857, pp.9-26 e 204-5.
193
colture specializzate; e poi, soprattutto, un “oceano di vignetibassi” interrotti da boschetti di olivi piantati insieme aivitigni perché entrino in piena fase produttiva dopol'invecchiamento di questi ultimi, e da piccole macchie di terrenia grano che si avvicenda alla vite ogni 15-20 anni.
In questo generale fervore produttivo, il plurisecolare ordineagronomico e paesaggistico sembra smarrirsi: il reciprocosostenersi di colto e incolto e di grano e vino, nell'ambito diuna gerarchia facilmente riconoscibile che collocava in posizionedi comando la cerealicoltura mercantilizzata, non funziona piùcome chiave di volta degli equilibri dell'area. La rigidità delpaesaggio agrario della regione rurale di età moderna si rovesciaqui in una flessibilità estrema rispetto alla congiuntura e aiprezzi, nel mentre assoluta rimane la sua sordità alle “spintesuperiori”, ai “verbosi incoraggiamenti, i manuali, i regolamenti,le istruzioni” stilate da chi pretende di insegnare agliagricoltori il loro “tornaconto”345: l'espansione cerealicola fragli anni '30 e gli anni '70, il balzo in avanti della vite neglianni '50 in sintonia con l'impennarsi dei prezzi a causadell'oidio, l'effimero dilagare del cotone negli anni della guerradi secessione americana346 la grande trasformazione vinicola degliultimi anni '70 e degli anni '80 causata dal diffondersi dellafillossera in Francia, sono gli episodi di grande risonanzaindividuabili fra una miriade di altri minori e minimi.
Nel procedere disordinato e tumultuoso della vicendaagronomica gli spazi che si aprono a uomini nuovi, a produttoridiretti accorti e tenaci sono consistenti, ma comunque limitatidal fatto che la rendita parassitaria, il lasciare che massari econtadini privi di capitale e terminali mercantili ed armati solodelle loro pratiche secolari affrontino direttamente il giocosenza rete del mercato ottocentesco, è scelta pericolosa e quasisempre perdente: nel mentre grandi e illustri fortune crollano,mercanti forestieri e locali arricchitisi alle spalle dellaproprietà parassitaria accedono alla terra347 e integrano i cetiproprietari che hanno imparato a convivere con i tempi nuovi345 M. CARACCIOLO, Poche osservazioni alla circolare della commissione reale perla coltivazione del cotone in Italia, Bari 1863, PP. 4-5.346 Cfr., in particolare, ASBA, f. Agricoltura industria commercio, b. 120, fs. «1873. Coltivazione e produzione del cotone in Italia ».347 Emblematica fra tutte la vicenda dei Pavoncelli, sui quali cfr. S. LA SORSA,La città di Cerignola nel secolo XIX, Bari-Roma 1931, PP. 130 sgg.; cfr. anche,sulla loro azienda, C. PASIMENI, Un esempio di capitalismo agrario: l'aziendaPavoncelli a Cerignola (188o-1892), in O. CONFESSORE (a cura di), Mezzogiorno ecrisi difine secolo, Lecce 1978, Pp. 233-300.
194
mantenendo saldamente il controllo della produzione non tramitel'intensificazione dell'investimento e la conduzione diretta, mal'accorta ripartizione delle colture fra le terre disponibili,l'identificazione delle quote di proprietà da condurre in economiae quelle da affidare a terzi, la realizzazione delletrasformazioni impegnative e rischiose tramite il contratto amiglioria, che riesce in misura notevole a schermare i concedentidal rischio delle scelte colturali nel quadro del mercatoottocentesco.
La razionalità di queste scelte e la loro incisivitàsull'ambiente naturale e sociale sono indubitabili, ma altrettantoindubitabili sono i limiti di una trasformazione condotta suqueste basi. Il contratto miglioratario, a differenzadell'enfiteusi che si va diffondendo nell'area sud-orientale dellaprovincia, è uno strumento spuntato quando si tratta di aggredirele pendici rocciose, di acquistare suolo alle colture tramite loscasso, dal momento che mantiene il nesso fra la terra e ilcontadino in un clima di precarietà e riesce a indurloall'autosfruttamento entro limiti presto raggiunti. Di qui, inprimo luogo, la sconfitta - alla lunga decisiva sul piano dellacapacità egemonica dei nuovi ceti sulla compagine sociale da essistessi rinnovata - del grande disegno di diffusionedell'insediamento sulla pietraia murgiana in via ditrasformazione, apertamente enunciato e promosso negli anni '30.
In quel torno di tempo Giuseppe Carcani da Trani, a suo direimitato da altri proprietari, spezzetta 500 ettari in agro diBarletta fra 500 contadini legati da contratto di miglioria apiantare viti, ulivi e mandorli, e vi fa fabbricare palmenti,officine per fabbri, una fabbrica di spirito, un forno, un molino,una chiesa e abitazioni in cui i contadini si sono in gran partestabiliti con le loro famiglie348: insomma un tipico villaggiorurale che, replicandosi, dovrebbe cominciare a svuotare legrandi tradizionali agrotowns e a spargere le case per i campiattaccando un'altra permanenza del paesaggio dell'area, quelladella geografia dell'insediamento.
Per questa via la trasformazione produttiva potrebbecoincidere con la creazione di una società contadina finalmente'normale', dove le forme più minute ed efficaci del controllosociale circolino e l'egemonia proprietaria, a dispetto delle348 ASBA, f. Agricoltura industria commercio, b. 153, fs. 48. Tentativi di questanatura vengono portati avanti anche a Ruvo, Corato e Terlizzi nello stesso tomodi tempo: cfr. JATTA, Dell'antichissima città di Ruvo cit., PP. 3o6-7, e S.FENICIA, Discorso sull'economia politico-agraria ( .. ), Bari s.d., P. 42.
195
nuove “avidità”, ritrovi una base solida. Ma la volontà deiproprietari di mantenere saldo nelle proprie mani il controllo deiprocessi in atto, il rifiuto di rendere autonomi i contadini difronte alla terra vanifica ben presto questi proponimenti.
Il carattere pur sempre temporaneo del rapporto contrattuale ela specializzazione produttiva da esso imposta impediscono a chilavora i campi di stanziarvisi stabilmente rompendo con tradizionie mentalità secolari sviluppatesi con il vivere “in città” e liporteranno disarmati di fronte alla grande crisi degli anni '80:la condizione di contadino miglioratario, di per sé contiguaculturalmente e socialmente a quella del bracciante più cheall'altra del contadino indipendente, diventa di conseguenzatramite non dell'ascesa verso la proprietà autonoma, ma delladiscesa verso quella figura dell'avventizio che si va diffondendodopo la crisi. Le agrotowns continuano così a crescere ammassandocontadini in mezzo alle campagne deserte, e il panorama socialeandrà man mano componendosi in forme idealmente semplici eminacciose, che troveranno una metafora efficace nelle grandipiazze costruite nei borghi oltre le vecchie mura, dominate daipalazzi degli agrari e occupate, dopo la fine della giornatalavorativa, da un mare di 'coppole'.
E in secondo luogo lo stesso sviluppo produttivo a riuscirnein parte ridimensionato. Sui dossi di Andria e Canosa, Ruvo eCorato si vanno arrampicando faticosamente magri vigneti frammistia olivi e mandorli; ma il grosso della trasformazione avviene dovela redditività naturale è più alta, nelle lame e nelle terreprofonde in piano, e quando queste cominciano a divenireeconomicamente scarse, la competizione fra le colture si faserrata. Nel nuovo clima ottocentesco, non esistendo più coltured'elezione collocate al punto di incrocio fra le caratteristichefisico-geografiche e quelle economiche e antropologiche dell'area,ogni elemento del paesaggio agrario entra in gioco, può esseremesso in discussione sulla base delle convenienze di mercato;perfino il seminativo, intorno al quale aveva ruotato da sempre lastoria della provincia settentrionale: l'arrivo dei graniamericani in Europa a prezzi nettamente inferiori a quelliremunerativi per la Puglia piana, e poi la fillossera in Francia,provocano un'invasione massiccia della vite sui campi cerealicoli,le cui superfici subiscono un vero e proprio tracollo - ilseminativo che all'inizio dell'Ottocento occupava il 51 per centodell'agro di Barletta si riduce un secolo dopo al 9 per centocirca, mentre il vigneto passa nel frattempo dal 12 al 45 per
196
cento; a Corato il seminativo passa dal 50 al 10 per cento e ilvigneto dal 6 al 60 per cento”; nella stessa Cerignola, dove leterre a grano dagli 11000 ettari della metà degli anni '60giungono ai 30000 ettari del 1880-81, cinque anni dopo lesuperfici seminate si dimezzano a favore del vigneto349.
Ed ecco che, a partire da questa fase cruciale, crescono lemigrazioni temporanee dalla costa olivicola sovrappopolata versola provincia settentrionale alla vendemmia, ma si riduconodrasticamente quelle della mietitura, ben più importanti estrategicamente collocate nel calendario della disoccupazioneolivicola stagionale. Gli olivicoltori devono di conseguenzacambiar cielo, allungare il raggio dei propri spostamenti,raggiungere i campi a grano che si sono enormemente estesi conl'abolizione della dogana nel Tavoliere centro-settentrionale e -data la grande disponibilità di terra salda e la scarsa pressionedemografica - subiscono in maniera meno diretta la concorrenza delvigneto in espansione: Terra di Bari conquista così il primatoassoluto fra tutte le province italiane della mobilitàinterprovinciale350 e si lega indissolubilmente alla Capitanata,alludendo a forme e dimensioni nuove della territorialità.
Al lato opposto il “prodigioso cambiamento” che investe lecampagne di Brindisi351, trasformate, anche grazie ad iniziative ecapitali lombardi, da “steppe deserte e spesso paludose” qualierano ancora negli anni Trenta dell'Ottocento352 in vigneti eseminativi rigogliosi su cui “nuovi aratri” ed “estirpatori”,“seminatrici e trebbiatrici a vapore” fanno sentire “l'alito delvero progresso”353, e quello non meno intenso che investe l'agrotarantino, richiamano braccia per lavori stagionali dallaprovincia meridionale354 provocando migrazioni certo nonparagonabili a quelle fra la costa olivicola e la Capitanata, mapur sempre significative ed importanti per gli equilibri economici
349 Cfr. ASBA, Registro riassuntivo dei catasti provvisori e PRESUTTI, Inchiestaparlamentare cit., p. 114. 14 S. RUSSO, Paesaggio agrario e assetti colturali inCapitanata dall'Unità agli anni Ottanta, in La Puglia nel Mezzogiorno dall'Unitàalla caduta della Destra cit., in particolare PP. 423-25.350 Cfr. PRESUTTI, Inchiesta parlamentare cit., pp. 706 sgg351 F. ASCOLI, La storia di Brindisi scritta da un marino, Rimini 1886, P. 447.352 Cfr. CH. DIDIER in c. DOTOLI C F. FIORINO (a cura di), Viaggiatori francesiin Puglia nell'Ottocento, vol. I, Fasano 1985, p. 268.353 C. DE GIORGI, La provincia di Lecce. Bozzetti di viaggio, vol. I, Lecce 1882,p. 68. Cfr. anche, dello stesso, Geografia fisica e descrittiva della provinciadi Lecce, Lecce 1887, PP. 78-79.354 Cfr., in particolare, c. NITTI, Della povertà di Taranto e de'mezzi permitigarla, Napoli 1857, p. 23.
197
e sociali della Murgia sud-orientale. Ma qui questa integrazionedel reddito familiare contadino sostiene una trasformazione lungolinee profondamente diverse da quelle che abbiamo giàtratteggiato.
La Murgia sudorientale era stata lungo l'età moderna l'areameno esposta agli stimoli del mercato e, al tempo stesso, almalessere che ne conseguiva; la crescita demografica vi era stata,nelle fasi positive della domanda internazionale, meno intensa, male cadute conseguenti più contenute; le forme dell'insediamentoerano meno esasperatamente accentrate, il rapporto degli uominicon l'ambiente meno teso, la divisione del lavoro fra i sessi menorigida, e la policoltura e la manifattura per l'autoconsumo e peril circuito mercantile breve avevano meglio resistitoall'invadenza dei mercati lontani. Il carattere distintivodell'Ottocento in quest'area è quello di collocarsi in un rapportodi maggiore continuità con i secoli precedenti. La policolturaresiste all'invadenza della vite, e quella che era stata la zonadi maggior produzione vinicola della provincia va assumendo unruolo secondario nel settore; resistono forme di autoconsumo ecircuiti mercantili tradizionali centrati sul mercato domenicale,secondo moduli che richiamano il Salento meridionale. L'analogiatiene però entro limiti ristretti. A cavallo dei confini con Terrad'Otranto, dalla cimosa costiera di Monopoli, Fasano ed Ostuniverso l'interno di Ceglie, Martina, Cisternino, Locorotondo,Alberobello, Noci, Casamassima, Putignano fino a toccare l'agro diGioia, e poi a Sud, fino a Francavifia ed Oria, i nodi della reteinsediativa rimangono molto più consistenti e radi che nell'altrocaso, ma le ville del diporto proprietario cominciano a diventarecentri per la colonizzazione, richiamano i contadini sui campi perperiodi che si vanno allungando al di là dell'autunno affollato dilavori campestri, inducono alla diffusione delle tecnichedell'architettura povera dei trulli, fino a provocare forme didisseminazione dell'insediamento sui campi e a disegnare, nellaPuglia delle agrotowns, un'“oasi” in cui finalmente la societàsembra assumere la coerenza di un mondo contadino”355.355 Il processo, già avviato nel Settecento, si intensifica nell'Ottocento: ilsindaco di Alberobello afferma nel marzo del 1827 che la metà circa dellapopolazione vive quasi tutto l'anno nei campi, e nel giugno del 1854, secondo ildecurionato della stessa città, «la maggior parte della popolazione vive incampagna e rientra in paese solo nei giorni di doppio precetto per acquistare ilnecessario » (cfr. ASBA, f. Contenzioso amministrativo, h. 39, fs. 98, e f.Agricoltura industria commercio, h. 88, fs. 18). Su quest'area cfr. fra l'altroDE GIORGI, La provincia di Lecce cit., I, PP. 72 sgg., 176-84, 28o, 297-302; Il,pp. 181-82; C. MARANELLI, La Murgia dei Truffi. Un'oasi di popolazione sparsa
198
Non si tratta, comunque, di un ritorno in Arcadia. Nonstimolati dalle vicende della storia lunga a darsi forme dicoscienza e qualità imprenditoriali aggressive e dovendosimisurare con una natura particolarmente aspra, i ceti proprietaririnunziano in sostanza alla direzione dei processi e vanno cedendola terra tramite forme contrattuali enfiteutiche, che pongononelle mani dei contadini le decisioni produttive in rapporto almercato ottocentesco. I risultati sono scritti ancor oggi nelpaesaggio della zona. Le sfide mercantili che giungono fin liattraverso i centri costieri e i ceti imprenditoriali iviinsediati, vengono accolte non tramite l'esasperazione dellaspecializzazione, ma, al contrario, circondando il reddito dellafamiglia contadina di strumenti di ammortizzazione, praticando lamobilità stagionale non come fonte di straniamento nei confrontidella propria terra, ma come fonte di reddito indispensabile perconsolidare i legami con essa, arricchendo le compensazioni deglisbalzi del reddito - dalla policoltura che assedia la colturaprincipale al piccolo allevamento al lavoro femminile cherichiedono una sua presenza continuativa sui campi e consentono adessa di aggredire la pietraia con quantità straordinarie di lavoroposto in buona parte al riparo dalle bizzarrie del mercato.Producendo una quantità di beni ben maggiore di quella affidata alcircuito del commercio in grande, un “popolo di formiche”356 riescea inserire quest'area per così dire di sbieco, ma in forme menoesasperate e precarie di quelle diffuse sulla costa centro-settentrionale, nei flussi di merci e di valori che 'modernizzano'la Puglia.
Non dovunque la rinuncia al protagonismo proprietario sirovescia, come in quest'“oasi”, in protagonismo contadino, inincisività dei processi di trasformazione del paesaggio e dellasocietà.
L'agricoltura dell'albero riesce a risalire in manieralimitata le Murge di Acquaviva, Cassano, Sammichele, ed ancorameno le Murge Tarantine ed i rilievi pietrosi di Altamura,Santeramo, Gravina357“. Qui in particolare la vite non esce dainel Mezzogiorno, ripubblicato in in., Considerazioni geografiche sulla questionemeridionale, Bari 1946, pp. 63-105; V. RICCHIONI, Un'oasi di popolazione sparsain pieno latifondo, estr. da Accademia Pugliese delle Scienze, Classe di scienzemorali, «Atti e Relazioni», 1950-51.356 Faccio naturalmente riferimento alle pagine ispirate dedicate da TommasoFiore a questa « strana terra »: in particolare le pp. 6 sgg. dell'ed. U. L.,Bari 1978, di Un popolo di formiche.357 Cfr. ASBA, Registro riassuntivo dei catasti provvisori e PRESUTTI, Inchiestaparlamentare cit., pp. 127 e 158.
199
“ristretti” e il grano dai canali seminatori, nel mentre la crisidella pastorizia riduce le occasioni di lavoro e gli ingrassi perla cerealicoltura e i “verbosi incoraggiamenti” di governanti eintellettuali illuminati verso colture più ricche - la robbia, labarbabietola, il gelso358 si risolvono in buona parte nel nulla.
E' in questo ambiente che il ruolo della vecchia'imprenditoria' dei massari riesce a perpetuarsi più a lungo, e lemasserie a sopravvivere al venir meno della loro funzione secolaredi cerniera fra natura, antropologia e mercato, emergendo agliocchi degli osservatori in tutta la loro crudele povertà tecnica estrutturale359. In termini di produttività per unità di superfide -che in tempi di mercantilizzazione integrale della terra è ilparametro rilevante e va espungendo dall'osservazione quello delrapporto seme/prodotto - il divario fra masseria “di murgia” eaziende cerealicole in piano si fa clamoroso, e.il grano murgianodeve sempre più cercare spazi in circuiti interni, interstiziali,da tenere quanto più possibile schermati da quelli del grandecommercio. Già negli anni '30 un'Altamura intristita e impoveritarispetto a quella tardo-settecentesca360 vede nelle “colonnemercantili”, nelle grandi case commerciali non uno sboccopossibile al proprio grano, ma una minaccia alla sopravvivenzadella sua cerealicoltura in crisi, e avanza la proposta -sdegnosamente respinta dal Consiglio provinciale con un altopanegirico per l'allargamento degli orizzonti commerciali dellaprovincia da esse promosso - di scioglierle d'autorità361; e nelmentre centri grandi e piccoli si agitano per l'allargamento dellarete stradale, il decurionato di Gravina esprime nel 1853 il suodisimpegno per la costruzione della strada che la connetterà allaBasilicata, la quale porterà a suo dire i commercianti adapprovvigionarsi lì e a ridurre ulteriormente l'acquisto dei suoi
358 Cfr., ad esempio, il progetto del 1855 del Sottintendente di Altamura dimettere a dimora 122 48o alberi di gelso e altrettanti di olivo nelle terresoggette a servitù di compascuo (ASBA, Agricoltura industria commercio, h. 79,fs. « 1854. Per la filatura della seta ad aspa lunga»). Cfr., anche, Statutodella fratellanza degli operai dell'Unità italiana di Altamura, Firenze 1864, inparticolare p. 6.359 Cfr., ad esempio, F. D'ADDIEGO, La produzione del frumento e del vino nelBarese, Conegliano 1899, passi m.360 Cfr. Archivio - Biblioteca - Museo Civico, Altamura, f. Serena, h. 128,«Memorie principali, ossia notabili, della vita di me Luca de Samuele Cagnazzi»,C. 26o. Il brano, non riportato in L. D. S. CAGNAZZI, La mia vita (1764-1852), acura di A. Cutolo, Milano 1944, è del 1836.361 ASNA, f. Interni, 11, h. 4o69, Atti del Consiglio provinciale di Terra diBari, seduta del 4 maggio 1836.
200
cereali362“.Una tendenza alla riarticolazione della società, a una
trasformazione delle forme prevalenti di erogazione del lavoro edei ruoli familiari e sessuali sembra farsi largo anche inquest'area. La quotizzazione delle terre comunali e la vendita diquelle ecclesiastiche dopo l'Unità sembrano determinare unacrescita relativa del ruolo del microfondo seminatoriale opromiscuo, incontrano la crisi della produzione domestica difilati e tessuti e attaccano il secolare “ozio” femminile, quellaestraneità al lavoro dei campi sempre biasimata come fonte divizio e povertà. Quelle donne che negli anni '50, dopo un invernovissuto “a spese della pubblica e privata beneficienza nelle cittànatie”, d'estate “a carovane corrono nei campi mietuti dellaPuglia piana, e nelle estese campagne del Monteserico e delGaragnone a spigare, apportando non pochi danni alla nutrizionedei figli [...] e alla propria salute”363, le ritroviamo alcunidecenni dopo impegnate quotidianamente a fianco dei propri uomini:la donna del circondario di Altamura, dice Netti, “è dedita allacoltivazione della terra; zappa, semina, coltiva le ortaglie,attende alla fasciatura dei fieni, alla coltivazione delle patate,tutto fa e, stando sul campo, alleva il suo bambino, che se loguarda a poca distanza in un cesto”364. La conquista di unacondizione contadina per l'intero nucleo familiare haprobabilmente un'importanza non secondaria negli equilibriproduttivi e sociali, ma essa non riesce a incideresostanzialmente, come nella Murgia sudorientale, sui colori e leforme del paesaggio, non rovescia la preminenza dellacerealicoltura estensiva né mette in discussione l'insediamentoaccentrato. Ai tempi nuovi le agrotowns murgiane sembrano cercarerisposte in una sorta di spaesata ruralità che ne segna il degradorelativo, la perdita di contatto con le aree più dinamiche.
Il fenomeno è tanto più evidente in quanto non c'è bisogno diandare a cercare queste ultime alle foci dell'Ofanto o attorno aBrindisi e Taranto. Qualche chilometro più a nord la Spinazzoladescritta negli anni '50 da Carlo De Cesare ferve di attività e ditraffici anche se, nel paesaggio su cui essa domina, l'agricolturadell'albero rimane del tutto marginale365. Nella vasta fossariempita di terre quaternarie fra l'ultima propaggine delle Murge362 ASNA, f. Interni, III, h. 562, fS. g.363 DE CESARE, Intorno alla ricchezza pugliese cit., p. I 14.364 L. NETTI, Monografia agraria del circondario di Altamura, Napoli 1882, P. 54;cfr. anche, di questo stesso lavoro, le pp. 16-18, nonché, di s. FIORESE, Ilcontadino nella Terra di Bari, Bari 1878, p. 101.
201
e la Basilicata, dove massicci dissodamenti vanno richiamando allaproduzione vaste superfici già vincolate alla pastorizia, lacerealicoltura si fa forte di condizioni naturali propizie e dellasua piena integrazione, tramite strade presto costruite e una retefitta di mercanti, agenti e vaticali, nel circuito che fa capo aBarletta, tanto da delineare, come in alcune aree dellaCapitanata, convenienze a tentativi non del tutto isolati diconduzione diretta delle aziende da parte dei proprietari, a formedi gestione che al tradizionale 'imprenditore' rurale vannosostituendo figure che richiamano il modello classicodell'imprenditore moderno. Anche per questo le difficoltà dimercato del grano e la congiuntura favorevole del vino negli anni'70 e '80 non provocano qui sostituzioni massicce di vigneto aseminativo, ma stimolano risposte in termini di innovazionetecnologica, di concimazione, di meccanizzazione366. All'inizio delNovecento la specializzazione cerealicola dell'area appare piùaccentuata che mai, ma questo non identifica ancora unacollocazione inferiore sul piano dello sviluppo rispetto alle areea colture prevalentemente arboree. Al contrario la cerealicolturadella fossa premurgiana, connessa per contiguità territoriale eforme del paesaggio alla grande cerealicoltura della Puglia piana,segnala per contrasto l'emarginazione ineluttabile, da un lato,del mondo della collina lucana e del Subappennino Dauno, che si vadisgregando e produce flussi massicci di emigrazione verso lapianura e l'estero, dall'altro della vasta pietraia murgiana chesi estende fino alla cimosa costiera imprigionando centri digrande passato e condannandoli a uno sviluppo stentato.
La territorialità ottocentesca non procede solo perallargamenti, inclusioni, omologazioni, ma anche per esclusioni,provocando emarginazioni di pezzi della vecchia regione ruralerispetto alla linea principale delle trasformazioni in atto, coneffetti di disarticolazione e gerarchizzazione che rimbalzano dalpaesaggio sociale a quello fisico. Non più inseriti in logiche diequilibrio e compensazione fra colto e incolto, i vasti spazipietrosi sono ormai inutili, hanno il solo effetto di isolare, diallontanare dai fuochi della crescita. I segni che gli uomini viavevano inciso nei secoli vanno cancellandosi: i “commodi” dijazzi e masserie cominciano ad avere forme diutilizzazione impropria e saltuaria, i pagliai non vengonoricostruiti, specchie e pareti si disfano, i pozzi si prosciugano,365 C. DE CESARE, Spinazzola, in Il Regno delle Due Sicilie cit., vol. IX, fs. I,PP. 31-45366 PRESUTTI, Inchiesta parlamentare cit., pp. 153 sgg.
202
e l'umanizzazione si concentra in aree ristrette, investite daforme febbrili di trasformazione.
La territorialità del regionalismo rurale si va scompaginandosenza che appaia immediatamente evidente ciò che va prendendo ilsuo posto.
4. Nodi, gerarchie, immagini urbane.
Purtuttavia è questa una questione di assoluta centralità. Nonessendo qui lo sviluppo semplice diffusione nello spazio di attidi acquisto di forzalavoro sempre uguali a se stessi, non èentrando nelle cellule produttive e descrivendone il funzionamentoche è possibile, come si è fatto per il capitalismo ottocentesco'normale', riassumere il senso dei processi in atto in parti~ion1consistenti del territorio. Nelle aree 'centrali' le ineguaglianzeinerenti allo sviluppo capitalistico tendono a venire scaricate'sottosviluppando' aree lontane, nel mentre i margini esterni aifuochi dello sviluppo non hanno la dignità di oggetto autonomo dianalisi, dal momento che sono in procinto di essere a loro voltainvestiti da processi di trasformazione sostanzialmente omogenei aquelli già verificatisi; nel nostro caso, al contrario, non avendonessuna delle forme di mutamento riscontrabili una consistentecapacità espansiva, il territorio, le sue articolazioni, i suoiinnumerevoli rimandi interni devono rimanere l'oggetto di indagineda privilegiare, l'unità di analisi capace di restituire il sensodelle cose.
Una volta tornati a concentrare lo sguardo sul territorio e lesue logiche, ci si accorge subito che il tentativo di ricomporrecome in un puzzle zone agricole dotate di omogeneità interna ereciprocamente complementari, secondo il metodo di analisiadottato per la regione rurale di età moderna, porta in un vicolocieco.
La zonizzazione usata per il vecchio regionalismo ruraleriesce, sul piano dei comportamenti demografici, a segnalare ildrastico mutamento di peso relativo fra i diversi pezzi dellaprovincia verificatosi nell'Ottocento (tab. 24). Tutte le altrezone perdono posizioni in favore della Murgia settentrionale, che,come nelle fasi positive del ciclo in età moderna, cresce a unritmo molto più alto di quello medio provinciale, e della concabarese. Particolarmente significativi sono il tracollo in terminirelativi della parte sudorientale della provincia (zone 3 e 8) e
203
l'inversione della tendenza secolare alla crescita del pesodemografico dell'insieme della Murgia e Premurgia meridionale(zone 7 e 8), che erano andate conquistando posizioni lungol'intero arco dell'età moderna fino a contare nell'ultimoSettecento oltre un quarto della popolazione provinciale.
Tabella 24.Popolazione di Terra di Bari per zone agricole (numeri-indice).
Fonti: i dati sono elaborati sull'appendice di ASSANTE, Città e campagnecit.
D'altro canto la zonizzazione non riesce a mettere a fuocoalcuni elementi di novità essenziali dell'Ottocento provinciale,individuabili cambiando la scala dell'osservazione e guardando aisingoli centri. A distribuirli per classi di ampiezza e a seguirnel'evoluzione lungo i decenni qui considerati (tab. 25), siripropone con forza la singolarità del fenomeno della diffusionedell'insediamento nell'“oasi” a cavallo fra Terra d'Otranto eTerra di Bari, dal momento che i dati medi provinciali descrivonoun'esasperazione ulteriore del carattere accentratodell'insediamento, il virtuale annullamento del peso dei centricon meno di 5000 abitanti - la popolazione lì residente passa dal25 al 4 per cento del totale provinciale - e la crescita ulterioredella quota spettante ai comuni con più di 10000 abitanti, chepassa dal 42 al 74 per cento: all'interno delle “paradossali”367
forme insediative accentrate tipiche dell'area mediterranea, larete dei centri della Puglia barese mantiene e accentua i suoiprimati, richiamando interesse e meraviglia di osservatori fornitiormai delle complesse griglie concettuali delle nuove scienzesociali.
Ciò che sfugge a costoro, dato che comparano nello spazio manon nel tempo, sono gli elementi di tensione e di crisi chepercorrono la rete delle agrotowns provinciali. Un datosignificativo da questo punto di vista è il rovesciarsi delsecolare processo di riduzione del peso demografico relativo deiprimi io centri della provincia, la cui popolazione guadagna frail 1815 e il 1881 oltre 4 punti (tab. 26), suggerendo, all'internodella tendenza all'ulteriore accentramento, disparità notevoli e
367 A. DEMANGEON, La géographie de l'habitat rural, in «Annales de Géographie »,1927, P. 4.
204
il definirsi di centriguida a sviluppo altissimo.
Tabella 25.Distribuzione dei centri di Terra di Bari per classi di
ampiezza.Fonte: cfr. tabella 24.
1796 18151861 1881
% abitanti numero % abitanti numero % abitanti numero %abitanti numero
sul totale centri sul totale centri sul totale centri sul totale centri
provinciale provinciale
1-500 0,06 1 - - - -- -501-1500 1,23 5 0,93 3 0,5 3 0,42 31501-3000 8,17 12 4,5 8 1,41 3 3,38 13001-5000 15,16 12 14,9 13 6,79 921,89 65001-10000 33,56 15 35,63 18 23,42 1828,36 2010001-20000 41,82 9 44,73 11 33,91 1336,6 1320001-40000 -- - - 33,96 7 36,6 9oltre 40000 - - - - - -8,93 1
Sulla figura 71 singoli centri, distribuiti per classi diampiezza dell'incremento demografico, identificano un complessointreccio di crescita e decadimento relativo, che, non essendogiustificabile sulla base dei differenziali dell'incrementonaturale, fa riferimento a flussi massicci di mobilità interna chesi accompagnano a quelli diretti verso l'esterno della provincia.Solo all'estremo sud-est la coincidenza dei centri a sviluppobasso con quelli che vanno spargendo l'insediamento fa pensare auna demografia che va facendosi più coerente con il voltocontadino che la zona assume, meno esasperata di quella checontinua a caratterizzare il resto della provincia almeno fino aiprimi decenni del secolo seguente e ne segna un altro primato. Allato opposto, al contrario, l'immigrazione si aggiunge a unanatalità altissima e determina lo sviluppo eccezionale di un
205
gruppo di centri attorno a Barletta, la quale ultima rimane inveceancorata a un tasso di crescita inferiore a quello provinciale. Lasituazione si fa confusa nell'area centrale della provincia, doveBari, grazie soprattutto alla violenta accelerazione del ventenniopostunitario, cresce fra il 1815 e il 1881 a un ritmo di granlunga maggiore di ogni altro centro provinciale e di ogni altrocentro meridionale di dimensioni consistenti (+219 per cento) manon riesce a individuare una sua area metropolitana e atrascinarla nella sua crescita; al contrario - ed è questo un datodi grande rilevanza - l'ingrandirsi a balzi del capoluogo sembranutrirsi della stagnazione di molti centri vicini, e, nelcomplesso, la sua demografia si divarica a forbice rispetto aquella dell'area in cui è inserito: i piccoli centri della Concaseguono andamenti contraddittori, ma nel complesso crescono menodella metà di Bari stessa e ancora meno della media provinciale, etassi di crescita ancora inferiori caratterizzano la costaolivicola settentrionale e meridionale.
Tabella 26. Indici di concentrazione.Fonte: cfr. tabella 24.
Dimensione Dimensione %abitanti
media Numeri- media Numeri- primicentri indice dei primi indice 10
centri(abitanti) 10 centri sul
totale1796 6093 93 13760 96 41,81815 6562 100 14381 100 41,31861 I0460 159 24303 169 43,81881 12795 195 30908 215 45,6
La zonizzazione di età moderna riesce inefficiente anche perun'altra ragione: essa dà per scontato che le dimensioni deifenomeni territoriali restino immutate, che la partita continui agiocarsi all'interno dei confini della provincia, nel mentre giàle trasformazioni e le tensioni che abbiamo visto percorrere ilpaesaggio agrario alludono a uno spazio diverso.
A dare uno sguardo alla demografia delle province pugliesicontermini emergono novità di grande rilievo, che mettono in lucediversa quanto avviene in Terra di Bari. Quest'ultima, nonostante
206
la densità notevolmente maggiore, cresce fino al 1881 a un passoleggermente più rapido di Terra d'Otranto e di gran lunga piùrapido di quello della Capitanata (tab. 27). Ma, ancora una volta,i dati complessivi nascondono comportamenti divaricati. Si provi adistinguere, in Capitanata, la zona collinare e montana dalTavoliere, e, in quest'ultimo, la parte a ridosso di Terra di Barida quella centro-settentrionale.
Figura 7.Distribuzione dei centri di Terra di Bari per classi di
incremento demografico (1815-81).
Nel periodo considerato nella tabella 28, drastica è lamodificazione degli equilibri in favore della pianura, e,all'interno di quest'ultima, a favore del Tavoliere meridionale,che abbiamo visto partecipare alle stesse trasformazioni dellacontigua zona settentrionale di Terra di Bari, con sfasaturerispetto alla demografia di quest'ultima che rimandanoprobabilmente a processi di diffusione delle trasformazionirisalenti dal nord Barese all'altra sponda dell'Ofanto: cosi,mentre nella Murgia settentrionale è il ventennio 1821-41 quellodella crescita più intensa (+ 38 per cento contro il + 24 percento del Tavoliere meridionale), il ventennio preunitario vede unbalzo in avanti del Tavoliere meridionale e un contenimento dellacrescita della prima (rispettivamente + 43 e + 25 per cento), incoincidenza della crisi delle aree collinari e montane diCapitanata, che perdono il 9 per cento degli abitanti; e a tassisimili il Tavoliere meridionale torna nel ventennio 1881 - 1901,ma nel diverso contesto di una crisi che colpisce con particolaredurezza Terra di Bari e ingigantisce le migrazioni da quest'ultimaverso l'intera Puglia piana. Alla divaricazione dello sviluppo peraree non corrisponde, in Capitanata, la divaricazione per centriche abbiamo visto caratterizzare settori importanti di Terra diBari. La crescita di Foggia fra il 1815 e il 1881 (+ 95 per cento)è nettamente più veloce di quella media provinciale e della stessapianura, ma rimane relativamente modesta; nel Tavolieremeridionale il centro più importante, Cerignola, cresce a un ritmoeccezionale (+ 139 per cento) e comunque inferiore a quello deivicini borghi rurali.
207
Tabella 27.Rapporto fra la popolazione di Terra d'Otranto e Capitanata e
quella di Terra di Bari.
Fonte: cfr. tabella 24.1821 1841 1861 1881 1901
Terra d'Otranto 0,87 0,84 0,81 0,810,85
Capitanata 0,73 0,65 0,560,52 0,51
Terra di Bari 1 1 1 1 1
Tabella 28.Lo sviluppo demografico della Capitanata* (numeri-indice). Fonte: cfr.
tabella 24.
1815 1821 1841 1861 1881 1901Collina e montagna 100 104 116 106 117 126Tavoliere centro-settentrionale 100 106 118 143 168 223Tavoliere meridionale 100 120 149 213 265 380Capitanata 100 105 119 121 138 165
*Colloco nel “Tavoliere centro-settentrionale” i seguenti centri: Foggia,Manfredonia, Lucera, Ortanova, Stornarella, Poggio Imperiale, San Severo,Torremaggiore; nel “Tavoliere meridionale”: Cerignola, San Ferdinando,Margherita, Trinitapoli. Tutti gli altri elencati dalla ASSANTE (Città ecampagne cit.) vengono assegnati alla partizione “Collina e montagna”.
Ben diverso è il comportamento demografico di Terra d'Otranto(cfr. tab. 29), che non ha zone di degrado come la collina e lamontagna foggiana e riesce per questo a tenere un passo simile aquello di Terra di Bari, ma presenta un ampio ventaglio di ritmidi sviluppo in particolare fra i centri maggiori. Si guardi aiquattro capoluoghi di circondario nell'arco di tempo 1814-81: allademografia modesta di Lecce (+ 84 per cento) e a quella pressochéstagnante di Gallipoli (+ 32 per cento) si contrappone la crescitaesplosiva di Brindisi e Taranto (rispettivamente + 171 e + 141 percento), superata in Puglia solo da quella di Bari.
Nell'ultimo ventennio del secolo, in coincidenza con la crisiagraria, la crescita di Bari si ridimensiona, collocandosi sulivelli pur sempre notevoli (+ 28 per cento) e nettamente
208
superiori alla media pugliese, ma inferiori a quelli dei centri diimmigrazione agricola (Foggia + 32 per cento, Cerignola + 40 percento, San Severo + 47 per cento) e ben distanti da quelli ancoraaltissimi di Brindisi e Taranto (rispettivamente + 51 e + 79 percento). Le dimensioni di Bari, all'inizio del Novecento vicinaagli 80000 abitanti, sono ormai irraggiungibili, ma questi duecentri si vanno staccando anch'essi dal panorama affollato deigrandi borghi pugliesi, trascinano lo sviluppo della parte dellaprovincia a ridosso di Terra di Bari accrescendone ulteriormenteil peso rispetto a quell'area meridionale caratterizzata da'città' demograficamente stanche, meno dinamiche delle 'campagne'circostanti, finiscono per introdurre elementi di novità negliequilibri di un'area più ampia di Terra d'Otranto. Alla fine delSettecento non molto più che un gruppo di capanne sparse dentro unacquitrino368, Brindisi si colloca cento anni dopo a ridossodell'illustre capoluogo della provincia, e Taranto giunge ormai adavere il doppio degli abitanti della stessa Lecce e, avendosuperato nettamente Foggia, è la seconda città delle tre provincepugliesi.
Tabella 29.Lo sviluppo demografico di Terra d'Otranto (numeri-indice).Fonte: cfr. tabella 24.
1814 1861 1881 1901Circondari di Lecce e Gallipoli 100 141 173
217Circondari di Taranto e Brindisi 100 157
195 254Terra d'Otranto 100 149 183
234
All'interno della vecchia regione rurale e nelle aree che lastringono da nord e da sud, i fenomeni demografici segnanodeclassamenti ed egemonie nuove, sconvolgono rapidamente vecchiequilibri, individuano una centralità non più solo fisica dellaPuglia barese riducendo nettamente il peso delle aree periferiche
368 Cfr., fra gli altri, A. DE LEO, Dell'antichissima città di Brindisi e suocelebre porto, Napoli 1846.
209
e centrifughe delle province contermini, modificano il rapportocittà-campagna, inducono a configurazioni dello spazio diverse daquelle individuate dai confini amministrativi.
L'immagine del territorio regionale restituitaci dallademografia è comunque approssimativa e in parte fuorviante, oltreche per le ragioni ovvie, in particolare perché - ed è questo unodegli elementi caratterizzanti della trasformazione ottocentesca -vengono meno le regolarità che in età moderna correlavanopositivamente dimensioni demografiche degli insediamenti ecomplessità del tessuto sociale. Ora il numero degli abitanti nonallude più automaticamente al livello di articolazione sociale,urbanità, nodalità. Il concetto di agrotown usato per l'etàmoderna deve diventare ora più specifico e pregnante, individuacentri che, ingigantendosi, cedono elementi direzionali, tendono asemplificare in termini relativi la propria composizione diclasse, le forme di autorappresentazione e le immagini checostruiscono.
I dati dei censimenti (cfr. tab. 30), confrontati con quellitratti dai catasti di età moderna, individuano già in manieranetta questa divaricazione fra grossi centri che come Bariassumono ormai in maniera inequivocabile il volto di città evedono i contadini, rimasti per secoli la componente fondamentaledel loro panorama sociale, ridursi in qualche decennio a uncomparto secondario e ininfluente, e altri sempre più schiacciatisul suolo di insediamenti rurali. Ma la differenza è ancora piùnetta di quel che raccontano i dati.
Negli immensi borghi della Murgia settentrionale e dellaCapitanata piana la vita associata, il clima mentale, la formaurbana vanno assumendo un tono particolarissimo. Andria oCerignola, Corato o Spinazzola, Minervino o San Severo continuanoa presentare agli osservatori l'immagine di una diversitànettissima rispetto agli insediamenti 'normali', ma i contenuti diquesta diversità, nel corso dell'Ottocento, vanno mutandovistosamente.
Dall'ultima propaggine dell'Appennino il lembo di Puglia acavallo fra la pietraia murgiana e le terre nere della Capitanatasi presenta a Edward Lear nel 1847 come uno dei luoghi “piùsoprendenti [...] e completamente diverso da qualunque altra parted'Italia”; ma poi la città che si alza di botto nella campagnaspoglia e desolata, Minervino, è grande, pulita e prospera: “laquiete”, “il torpore” dei centri abruzzesi o calabri “contrastadecisamente con le comunità della Puglia, tutte movimento e
210
animazione, dove le strade ben lastricate, le buone case e lelunghe file di muli carichi, denotano un progresso in campocommerciale”. Non a caso l'ospite che accoglie gentilmente ilviaggiatore inglese - un 'nuovo ricco', si mormora - conversa “distatistiche, affari commerciali, strade ferrate ed altre cosepratiche”369.
Qualche decennio dopo centri di questa natura “mettonostupore” per ragioni del tutto diverse. “Si pensi un momento -scrive Gregorovius in riferimento ad Andria, dove i due terzidegli attivi si dichiarano nel igoi braccianti agricoli - ad unacittà di più di trentacinquemila abitanti ovunque, in Toscana onell'Alta Italia, per non parlare della Germania odell'Inghilterra.
Sicurissimo è questo, che vi si troverebbe una vitaorganizzata in forme varie e complesse, la quale andrebbeesplicando l'energia sua in unioni ed associazioni del capitale edel lavoro, in istituti molteplici, destinati a svolgere lasociabilità o a promuovere i bisogni artistici e scientifici.Nulla di tutto ciò in Puglia”370.
Tabella 30.Composizione professionale in alcuni centri pugliesi secondo i censimenti
(percentuali). Per le fonti e il metodo cfr. tabella 22.
Agricoltura industria com- professioni eServizio
e pastorizia pesca e caccia navigazione mercio, trasporti pubblico impiegodomicilio
1881 1901 1881 1901 1881 1901 1881 1901 1881 1901 18811901
Bari 15,3 12,3 0,5 0,6 5,6 3 60,4 64 15,3 19,42,8 0,7
Barletta 45,8 53,8 0,3 0,2 5,6 2,7 40,9 34,3 5,2 8,72,2 0,2
Molfetta - 44 - 7,8 - 5,1 - 38,3 - 4,6- 0,1
Bisceglie - 68,1 - 0,6 - 2,4 - 24,2 - 4,6 - -
Trani - 42,5 - 0,2 - - - 42,3 -12,4 - 0,5Bitonto - 67,7 - 0,1 - 1,2 - 24,5 - 6,5
- 0,05Andria - 74,4 - - - - - 21,2 - -
4,3 -Corato - 78,5 - - - - - 18,1 - 3,4
- - - Altamura 72,5 - - - - - 23 - 3,2 - 1,2 -Taranto 29,7 23,4 8,4 6 4,8 1,1 47,2 46,7 7,4 22,2
369 E. LEAR, Viaggio in Basilicata 1847, Reggio Calabria 1974, pp. 25-27.370 GREGOROVIUS, Nella Puglia cit., p. 264.
211
2,4 0,5Brindisi 44 - 3,7 - 3,9 - 35,7 - 9,3 -
3,3 -Lecce 20,4 22,1 - - - 0,1 52 52,6 21,7 22,8
5,9 2,4Gallipoli 21,4 - 8,6 - 4,1 - 57,2 - 5,9 -
2,7 -Foggia 19,9 38,7 - - - - 64,8 45,1 10,1 15,7
5,2 0,4S. Severo 56,9 59,6 - - - - 34,4 31,3 4,4 8,7
4,3 0,3Cerignola - 69,3 - - - - - 24,3 - 6,1
- 0,3Bovino 69,2 - - - - - 24,1 - 5,2 -
1,5 -Puglia 64 64,7 0,5 0,8 1,3 0,8 28,1 27,1 4,3 6,3
1,6 0,2
Né questo è sorprendente se si pensa, afferma il traduttoredello stesso Gregorovius, che qui “nessuno sembra accorgersi delcome abbiano ad ordinarsi, secondo i concetti moderni, lerelazioni tra proprietari e contadini.
Che in un paese agricolo per eccellenza non sia traccia di unaclasse contadinesca, organicamente composta, agiata, indipendente,in possesso di una parte del suolo, è tale una mostruosità, che, araccontarla, non dico in Francia ma [...] nella feudale Germania[...] e nelle province Baltiche, dove prevale un sistema veramentearistocratico, nessuno vi presterebbe fede”371.
In questo mondo in cui si affrontano “da un lato alquantisignori, borghesi arricchiti, possessori di latifondi, spessomilionarii, dall'altro moltitudini di giornalieri e bracciantipezzenti, abbandonati, senza conforti e senza speranze372“, ènaturale che Gregorovius non riesca ad individuare alcun carattereurbano: “Nelle botteghe di merciai ed artigiani si nota per tuttoun grado affatto primitivo di cultura, rispondente appena aibisogni della plebe contadinesca”373, e la “sociabilità” si esplicaunicamente nell'immenso incontro serale all'aperto di un “popolo[...] di una classe sola, contadini e lavoratori dei campi”, tuttiuguali con le loro “facce abbronzite” e le “giubbe paesane difustagno color cilestro”, il cui “riposo non ha l'impronta di ungodere consapevole”, ma “rivela [...] uno stato apatico sotto ilpeso di condizioni di esistenza inveterate”374 che cova ribellioniesplosive. Anche perché qui non è questione di cercare contro chiribellarsi. La stessa scena urbana che va organizzandosi nei
371 Ibid., p. 40372 Ibid., p. 30373 Ibid., p. 263374 Ibid., p. 261-62
212
borghi fuori le mura, invece che avviluppare la trama dei rapportisociali in simbologie e forme continuistiche, scimmiottando, comespesso nell'Inghilterra vittoriana o nell'Italia mezzadrile, unacampagna arcadica, esibisce sfacciatamente il nuovo potereeconomico e le sue distanze incolmabili dalla società bassa, nellacomposta e solenne architettura dei palazzi degli agrari che fannoda quinta alle piazze bracciantili o, per converso, nel bizzarro econtorto linguaggio 'internazionale' dei cimiteri, dove - e sipensi al caso di Ruvo - le grandi tombe egizie o assiro-babilonesidelle famiglie dei potenti dominano un gruppo ristretto disepolcri bassi e le croci innumerevoli piantate nella terra per ilpopolo.
L'impoverirsi in termini relativi delle funzioni urbane deigrandi borghi contadini e l'irrigidirsi delle immagini che offronoe delle loro forme di autorappresentazione, è parallelo alconcentrarsi delle stesse funzioni urbane in punti del territorioche non coincidono con l'insieme delle città costiere. L'Ottocentoprovoca anzi lo sciogliersi definitivo del nesso immediato edelementare fra porti ed entroterra, la fine del funzionamentodella commercializzazione come scorrimento su di un pianoinclinato di derrate dall'interno verso il mare per la viafisicamente più breve ed agevole, dai campi ai loro porti naturaliallineati sulla battigia. Ora le derrate vanno convergendo in polimercantili che offrono organizzazione, personale, strutture capacidi navigare i mari difficili della “rivoluzione commerciale”,ponendo ai centri che non riescono a compensare con la crescitadelle funzioni mercantili le difficoltà dell'agricoltura ed anascondere l'esubero di forza-lavoro riprodotto da un tasso dinatalità persistentemente elevato, problemi pesanti diriconversione economica e controllo sociale. Processi molteplicidi ascesa e degrado si determinano all'interno dei centri e fra icentri. Se Molfetta o Trani riescono, con la pesca d'altura el'avvio di un certo processo di sviluppo manifatturiero a tenertesta in qualche modo ai tempi ed a riprodurre una qualchecomplessità sociale ed urbana375, Bisceglie finisce per somigliaread una agrotown dell'interno e Mola e Giovinazzo perdonovistosamente terreno, in termini di peso demografico ed economico,rispetto ai centri contermini.
Ma nemmeno la conquista di funzioni di polarità commerciali divasto raggio riesce a garantire, nelle nuove condizioni, una375 Su Molfetta cfr., fra gli altri, il saggio classico di G. SALVEMINI, Uncomune dell'Italia meridionale: Molletta, ora in ID., Movimento socialista equestione meridionale, a cura di G. Arfè, Milano 1963, PP. 9-26.
213
collocazione non subalterna nelle nuove gerarchie urbane, dalmomento che quello che diventa decisivo è il modo in cui lapolarizzazione ha luogo, le forme ed i contenuti delladirezionalità, la capacità di questa di tradursi in reddito,complessità sociale, sviluppo urbano. Cosi, all'interno dei duegrandi comparti tradizionali dell'area, quello cerealicolo e quello olivicolo,questi processi mettono capo ad esiti del tutto diversi.
Barletta è, in un certo senso, un porto emblematico dei tempinuovi, che esaspera alcuni caratteri di fondo delle trasformazioniottocentesche della Puglia centrale376. Essa emargina dal commerciocerealicolo Trani, che era risorta nel Settecento, sottrae spaziai suoi concorrenti secolari, Taranto da un lato e Manfredoniadall'altro, si crea un “bacino” esteso fino all'area foggiana ealla Basilicata, riuscendo a sopportare una variabilità altissimadelle quantità esportate e delle destinazioni, occupandoimmediatamente i vuoti di offerta del mercato internazionale,diventando il centro granario a cui da Londra o Marsiglia ci sipuò rivolgere quando i circuiti normali si ostruiscono. Non avendoa disposizione cereali prodotti “sforzando la terra” con i metodidella nuova agricoltura e quindi vendibili a prezzi concorrenzialie dotati di sbocchi sicuri, Barletta deve “sforzare il mercato”:da un lato essa si dota di infrastrutture imponenti - strade chescendono a raggiera sulla città, la flotta mercantile più grandefra quelle dei porti pugliesi e una delle più importanti del Regno(tab. 31), magazzini e fosse innumerevoli che permettono disciogliere il nesso fra produzione e immediatacommercializzazione; dall'altro diventa il riferimento mercantiledei frenetici “giochi di carta” della borsa napoletana, la baseoperativa delle grandi case commerciali che, tramite manovrespeculative sugli ordini di derrate, rendono elastiche le lorooperazioni di raccolta e stoccaggio, si assicurano ladisponibilità di grani necessaria a rispondere prontamente alleoccasionali richieste impegnando capitali effettivi solo quandotrovano un compratore, e in questa maniera riescono a crearsiconvenienze a stare su un mercato imprevedibile.
Tabella 31 Bastimenti da commercio registrati nei porti pugliesi al 31dicembre 1852.
376 Cfr., su Barletta, PALUMBO e SALVEMINI, Aspetti del mercato del grano cit.;MASSAFRA, Campagne e territorio cit., passim; J. DAVIS, Società e imprenditorinel regno borbonico 1815/1860, Bari 1979, passim.
214
Fonte: i dati sono tratti dafio Specchio della navigazione commerciale de'bastimenti mercantili de' Reali Domini di qua del Faro pel 1852, in “AnnaliCivili del Regno delle Due Sicilie”, luglio-agosto 1853, in particolare pp. 235-36. Si sono considerate imbarcazioni non da commercio, e quindi eliminate dalcomputo, “paranze”, “paranzelli”, le “barche di 20 tonn. o meno”, i “gozzi di 26palmi in sotto”.
Numero Tonnellaggiocomplessivo
Rodi 15 601Peschici - -Vieste - -Manfredonia 1 59Barletta 54 5371Trani 41 2054Bisceghe 12 162Molfetta 19 1080Giovinazzo - -Bari 44 3757Mola 7 330San Vito - -Monopoli 11 994Ostuni - -Brindisi 10 756Otranto - -Gallipoli - -Taranto 2 41
Il gioco, evidentemente, ha dei costi pesanti che vengonoscaricati sui produttori e si intrecciano agli stimoli positiviloro trasmessi dalla capa cità di questa macchina complessa ditrovare prima o poi sbocchi alla produzione locale: l'induzioneagli immobilizzi pesanti, all'investimento diretto in agricolturaviene così ridotta, e si riproduce il circolo vizioso chedetermina la prevalenza dell'imprenditore 'scentrato', la limitatacompetitività del grano locale, la precarietà dell'inserimentodell' area nella “rivoluzione commerciale” e, in ultima istanza,l'egemonia di Barletta e della macchina mercantile che riesce dilì a controllare e sfruttare quell’inserimento. Naturalmente, finoa che riesce a durare. La riconversione e la riqualificazionedella città, del suo personale e delle sue strutture, che laportano al punto più alto della sua secolare carriera di portogranario sotto il profilo delle quantità medie imbarcate,costituiscono in definitiva un tentativo estremo e disperato diadeguarsi ai tempi: ben presto, come abbiamo visto, la capacità di
215
espansione delle “estrazioni” di cereali si esaurisce, e il granoamericano degli anni '70 e '80 spazza via dal mercatointernazionale quello barlettano: la cerealicoltura pugliese,all'ombra delle tariffe doganali, dovrà imparare a muoversi inorizzonti più modesti, in circuiti più ristretti ma al contempomeno precari.
Per l'intanto, però, Barletta va giocando con successoun'altra carta che le permette di prolungare il suo Ottocento,quella del vino. Già nella prima metà del secolo, mentre laproduzione cresce significativamente, in particolare nell'area adagricoltura 'flessibile' in cui la città è inserita, la grandefiera enologica di Barletta377 funge da elemento organizzatore eordinatore di un circuito reso tradizionalmente confuso easfittico dalla sua emarginazione dal mercato internazionale,prigioniero di una rete di scambi di raggio corto,onnidirezionale, scarsamente specializzata, dipendente da unadomanda eccezionale o da un'offerta eccessiva che sorgonoall'improvviso in questo o quell'angolo della regione a causadelle vicende meteorologiche. Questa sorta di apprendistato delvino a una condizione di più alta dignità mercantile nell'ambitodel commercio regionale centrato in misura cospicua su Barletta,fa sì che la domanda intensissima riversata sulla regione dallevicende di mercato negli anni '50 e poi negli anni '80 vi trovifinalmente una risposta efficace, che è naturalmente Barlettastessa ad organizzare in larga parte, convogliando nelle sue navi,e poi nei suoi vagoni ferroviari, vino prodotto non solo suentrambe le sponde dell'Ofanto, ma anche in zone lontane diCapitanata e Terra di Bari.
Che questo protagonismo prepotente della città sul pianomercantile si accompagni a uno sviluppo demografico di gran lungainferiore a quello delle agrotowns che le fanno da contorno e, piùin generale, a una crescita modesta di elementi di urbanità edirezionalità, non è poi sorprendente se si riflette sui modi e leforme della polarizzazione su Barletta del circuito granario evinicolo della Puglia centro-settentrionale. I “giochi di carta”si traducono dopo molte e complesse mediazioni in movimento dimerci a Barletta anche perché lì erano andate creandosi, sindall'età moderna, competenze professionali, figure armatoriali,intermediarie, imprenditoriali capaci di far funzionare il377 Dati e notizie sulle fiere di Terra di Bari, in particolare per il triennio1848-50, in ASBA, f. Agricoltura industria commercio, bb. 87-9 1. Per il periodopostunitario cfr., in particolare, ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Ministero diAgricoltura, industria e commercio, divisione industria e commercio, b. 150.
216
circuito. Ma non erano costoro i protagonisti veri. La crescitadel ruolo della città a scapito dei porti regionali concorrenti èin un certo senso il risultato della rinuncia da parte del milieucommerciale locale al controllo della macchina mercantilebarlettana in cambio della sua assunzione negli orizzontivastissimi della “rivoluzione commerciale”. L'incrociarsi digrandi flussi di merci e grandi flussi finanziari avviene in largaparte sulla sua testa, capitali ingenti corrispondenti allamassiccia taglia di commercializzazione e intermediazione pagatadai produttori scivolano sulla città dirigendosi verso Napoli e i'centri' dell'Europa. E anche quando fette di questo girovorticoso di valori, intercettate da mercanti locali o forestieri,vengono reinvestite in loco, esse trovano sbocchi non tantonell'economia più propriamente urbana, ma nei campi, in quellaparticolare forma di agricoltura 'flessibile' che travolge gliequilibri secolari del paesaggio a cavallo dell'Ofanto. Strettafra un'organizzazione mercantile che pompa capitali locali versodestinazioni lontane e un'agricoltura in vivacissimatrasformazione, Barletta non riesce a elaborare una sua urbanità,una sua economia capace di crescere su se stessa, e rimaneirrimediabilmente appiattita sul suo vasto entroterra, a fare da“scolatoio” di pochissime derrate affidate a pochissimi mercati disbocco. Vecchie logiche e partizioni territoriali ne risultanosignificativamente manomesse, ma i ricaschi di questetrasformazioni non riescono a trovare qui un punto su cuicoagularsi, un principio di organizzazione nuovo, e finiscono peralimentare la definizione di egemonie centrate su circuiti, spazi,economie apparentemente del tutto distinte.
Più a sud l'altro paesaggio a forte mercantilizzazione, quellodell'olivo, appare ben più invischiato nelle sue rigidità,sottolineate dalle mutevolezze del mercato ottocentesco. Anche acausa dei limiti relativamente stretti entro i quali il prodottoglobale commercializzabile riesce a crescere, i processi dipolarizzazione hanno qui conseguenze particolarmente vistose e diraggio lungo.
In Terra di Bari, sotto l'impulso della crescita continua edesponenziale, per tutto il nostro Ottocento, dell'oliocommercializzato dal capoluogo e della quota di Bari stessa sulleesportazioni olearie delle province pugliesi (tab . 32), portirimasti per secoli accomunati a un clima di modesta operositàvedono divaricarsi rapidissimamente le proprie condizioni. Unprocesso di segno opposto si verifica in Terra d'Otranto, dove il
217
grande porto oleario di Gallipoli, dominato dalle grandi casenapoletane ed estere non solo, come Barletta, sul pianopropriamente mercantile, ma anche su quello dell'armamento, cedequote significative di mercato ai due porti settentrionali dellaprovincia, Taranto e Brindisi. Ma in questa sorta di'depolarizzazione' del circuito oleario della Puglia meridionale,la stessa Bari ha un ruolo determinante.
Tabella 32. Olio esportato dai principali porti pugliesi in salme di 165rotola (medie annue).
Fonti: per la prima colonna, i cui dati sono solo indicativi eapprossimati, cfr. p. 136, tab. 15; la seconda e la quinta sono elaborate daMASSA, il prezzo e il commercio cit., PP. 42-43, 54-55 e 134-36; la terza daBURSOTTI, Biblioteca di commercio cit., vol. Il, “Specchio”alle pp. 18-19. Perquel che riguarda infine la quarta: i dati annuali di Bari per il periodo 1851-54 sono tratti da TRIZIO, Commercio e marina mercantile cit.; quelli del periodo1855-65 da MASSA, Il prezzo e il commercio cit., P. 50: per i dati di Gallipolicfr. ibid., pp. 40-41; per i dati di Molfetta cfr. AC Molfetta, categoria 3,vol. 16, fS. 2, sottofs. 9, e fs. 3, sottofs. 5; vol. 17, fs. 1, sottofS. 9, efs. 2, sottofs. 3 e 9; ivi, cat. 4, vol. 105, fs. 6; ASBA f. Porti e fari, b.15.
Fine 1818-32 1835-39 1851-651875-95 Settecento
Bari 4500 - 23413 43569 136520Molfetta 4500 - 12472 9234 15372Monopoli 4500 - 17470 - 13515Bisceglie 1500 - 2868 - 5543Mola 1500 - 3635 - -Gallipoli 22000 34350 44326 50531 46672Brindisi 8154 4450 -Taranto (12000) 15292 8389 - (69939)
Tabella 33.Olio importato in Terra di Bari (in quintali) distinto per provenienza e
percentuale dei totale importato sul totale “estratto” dai porti dellaprovincia.
Fonti: elaborazioni sui dati tratti, oltre che dalle citate pubblicazioniannuali della Camera di commercio ed arti sul movimento mercantile provinciale(1875 sgg.), da CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI DI BARI, Movimento della città diBari. Anno 1874 col confronto del 1873, Bari 1875.
1873 1874 1875 1876 1877 1878 1887 1888Calabria 933 70 - 7196
218
Abruzzi - - - 3000Basilicata - 1133 162 3237Capitanata 5159 2722 1672 18054Terra d'Otranto 29704 30406 12950 57442
Totale 5534 23382 35796 27602 34371 14838 88929 56958
% sulle estrazionida Terra di Bari 4,8 16 11,7 11,9 13,2 8,9 34,6 27,6
Già negli anni '40 è evidente la maggiore concorrenzialità delsuo prodotto sul mercato di Marsiglia rispetto a quello diGallipoli, e negli anni '80, quando la produzione olearia di Terradi Bari non riesce più a rifornire le navi baresi, quoteconsistenti dell'olio leccese si concentrano tramite ferrovia aBari, insieme alla gran parte di quello prodotto nei nuovi olivetidi Capitanata (tab. 33):
Tabella 34.Composizione merceologica delle “estrazioni” dai principali centri
mercantili di Terra di Bari.Fonti: elaborazioni sulle citate pubblicazioni della Camera di commercio
ed arti barese sul movimento mercantile, ad annum.
1873-74 1877-78 _______ 1887-88__________
% sulle % sulle % sulle % sulle %sulle
"estrazioni" "estrazioni" "estrazioni" "estrazioni" "estrazioni"
totali totali provinciali totaliprovinciali
della città della città della merce della cittàdella merce
Bariolio 51,5 50,4 79,2 40,4 77,5vino 0,6 0,9 7,4 12 22,8grano 2,7 6,7 19,2 1,5 77,7mandorle 21,1 16,6 92,4 16,3 94,1totale 75,9 74,6 70,2
Barlettaolio 0,2 0,1 0,3 0,2vino 19,8 66,8 89,4 59,3grano 62,8 75,6 0,6 10,1mandorle 0,7 1,6 0,04 0,1
219
totale 83,5 90,3
MolfettaOlio 45,4 8,4 45,1 8,1vino 6,8 6,4 11,1 2grano 0,5 0,2 0,1 0,5mandorle 8,5 5,6 5,6 3totale 61,2 61,9
Traniolio 11,5 0,9 2,1 0,3vino 28,3 11,7 52,2 7,8grano 15,3 2,3 0,3 1mandorle 0,6 0,2 0,5 0,2totale 55,7
alla fine del decennio, una quota fra un terzo e la metà dell'olio“estratto” dalla città è stato prodotto fuori della sua provincia378
cosicché le dimensioni dell'entroterra oleario di Baririconfermano quell'inadeguatezza della territorialitàamministrativa rispetto ai processi reali che l'entroterracerealicolo e vinicolo di Barletta, collocato fra Terra di Bari eCapitanata, ha già evidenziato.
Ma il dato di novità più interessante dal nostro punto divista è che, proprio mentre il dominio di Bari sul circuitooleario pugliese e meridionale si fa assoluto, il nesso fra lesorti della città e quelle della vicenda produttiva e di mercatodell'olio si va sciogliendo. Bari comincia a non essere più unsemplice “scolatoio”, sia pure di un entroterra dilatatosi adismisura. Mentre la quasi totalità delle esportazioni diGallipoli è costituita, come da sempre, di olio, e alla fine deglianni '80 il solo vino rappresenta in valore quasi il go per centodelle “estrazioni” di Barletta, l'olio costituisce in quegli anninon più del 40 per cento delle “estrazioni” baresi (tab. 34),lasciando spazio ad altre derrate e a una varietà di prodottisemilavorati e lavorati. Ma è in particolare tramite la suafunzione di redistribuzione dei prodotti della rivoluzioneindustriale su un ambito territoriale che deborda ancora una voltadai confini della provincia, che Bari va rimodellando lo spazioregionale. Mentre le navi olearie giungono a Gallipoli in largaparte vuote e a Barletta l'importazione ha un ruolo secondario nelmovimento mercantile, una quota fra il 60 e il 70 per cento delvalore delle merci che entrano nella provincia passa dal porto di
378 Più precisamente, il 43,6 per cento nel 1887 e il 32,6 per cento nel 1888.220
Bari o dal suo scalo ferroviario (cfr. tab. 35), subitoaffermatosi come di gran lunga il più importante della provinciastessa379“.
In Puglia anche Brindisi e Taranto, che abbiamo visto crescereimpetuosamente sul piano demografico e ritagliarsi un ruoloconsistente nel commercio oleario nonostante la prepotenteespansione di Bari, riescono ad avere una funzione redistributivasignificativa380 che alimenta la loro vita mercantile e gonfia idati quantitativi, ma non permette loro di attingere la dimensionebarese: un indicatore estremamente grossolano come il movimentoportuale (tab. 36) esalta il ruolo del porto di Brindisi, oggettoprivilegiato della progettualità e dei favori dello Statoborbonico e unitario e divenuto dal 1871 punto di transito dellaValigia delle Indie, ma non nasconde il tasso di crescitanettamente più alto di Bari che, d'altronde, in termini di valoredelle merci imbarcate e sbarcate, è fuori della portata dei duecentri salentini emergenti.
379 Negli anni 1877-78, per i quali abbiamo i dati disaggregati, il trasportoferroviario aveva già assunto un ruolo di grande importanza nel movimentocommerciale della provincia, in particolare nel commercio di importazione. Ilprimato di Bari è, anche in questo comparto, indubitabile, anche se menoassoluto che nel commercio per mare:
% del movimento commerciale % dei singoli scali per ferrovia sul movimentosul movimento commerciale commerciale globale,provinciale per ferrovia, nei singoli centri in valore ed in Terra di Bui, in
valoreimportazione «estrazioni» importazione «estrazioni»
Bari 57,9 47,3 41,5 23,3Barletta 25,4 22,4 81,9 26,1Molfetta 7,4 12,6 48,4 52,9Trani 3,4 6,1 48,8 58,1Monopoli 1,6 4,8 48,5 50,4Bisceglie 1,7 2,9 56,3 74,4Gioia 1,4 1,8 100 100
Terra di Bari 100 100 49,1 29,3
380 Cfr. P. PALMA, L'attività commerciale dei porti di Tetra d'Otranto nellaseconda metà dell'Ottocento, in La Terra d'Otranto nella secondo metàdell'Ottocento, Oria 1984, PP. 197-216.
221
D'altro canto, così come per Barletta, anche nel caso diBrindisi e Taranto i ricaschi in termini di polarità edirezionalità urbana sono meno che proporzionali alla lorocrescita impetuosa in termini quantitativi. L'inconsistenza dellacompagine insediative brindisina ancora negli anni Trenta delsecolo, la debolezza dei suoi nessi con la campagna, degliinteressi e degli equilibri sociali e geografici consolidati rendelì possibili accelerazioni violentissime della vita economicaimpensabili in casi di più complessa e lunga sedimentazionestorica, determinate da occasioni irripetibili la cui persistenzanel tempo è fuori dal controllo delle forze locali.
Tabella 35.Percentuali del movimento commerciale delle principali piazze mercantili
di Terra di Bari sul movimento commerciale provinciale (medie annue).Fonte: elaborazione sui dati di MARCHI e LORUSSO, Movimento commerciale
cit.
1875-79 1882-87 1888-93
A B C A B C AB CBari 70,4 60,7 64,3 66,5 53,9 59,6 63,2
56,9 59,8Barletta 12 22,2 19,6 8,9 24,4 17,5 11,1
14,2 12,8 Molfetta 8,3 7,1 7,5 7 6,3 6,67,3 7 7,2
Trani 4,5 3,8 4 6,3 4,8 5,5 5,5 6,3 5,9Monopoli 1,3 3,1 2,5 2,1 3 2,6 2,1 4,7 3,5Bisceglie 1,2 1 1,1 4,4 3,6 4 4,9 5,1 5Mola e Polignano 0,7 0,8 0,7 1 0,7 0,8 1,2 0,5 0,8Giovinazzo e S. Spirito 0,4 0,2 0,3 1,4 1,7 1,6 2,1 1,4
1,7Fasano - - - 1,4 1,5 1,4 0,6 2 1,3Gioia e Acquaviva 0,6 0,9 0,8 1 0,4 0,7 0,8 1 0,9
A = importazioni; B = “estrazioni”; C = totale
Non che Brindisi sia una invenzione del favore borbonico edella valigia delle Indie381; è però indubitabile che le dimensionidemografiche e mercantili da essa assunte nel secondo Ottocento
381 Cfr. la polemica dell'ASCOLI, Storia di Brindisi cit., P. 483, nota, controle annotazioni di Charles Yriarte, sprezzanti nei confronti della città.
222
non trovano giustificazione nella pur importante trasformazioneagricola del suo entroterra e nel ruolo di polo mercantile deiprodotti di quest'ultimo assunto dalla città. A Taranto lacrescita determinata dal suo ruolo di polo commerciale di unentroterra in trasformazione si accompagna ad una crisigravissima della sua illustre produzione manifatturiera tessileattaccata dalla penetrazione dei prodotti della prima rivoluzioneindustriale, e ad un inurbamento che crea problemi solubili solotramite la reinvenzione della sua 'vocazione' urbana, unaaccelerazione artificiosa del suo sviluppo che la emancipi dairitmi organici alle sue funzioni mercantili, incapaci di attenuarele contraddizioni di continuo risorgenti: di qui le spinte allacostruzione della Taranto Militare e l'ulteriore “sviluppopreventivo”382 che le speranza suscitate provocano, in una sorta dicircolo vizioso spezzato solo parzialmente dalla realizzazionedell'arsenale.
Tabella 36.Tonnellaggio delle navi arrivate e partite e riscossioni di conto dogana e
diritti marittimi nei porti di Bari, Brindisi e Taranto (medie annue).
Fonti: i dati della prima colonna sono tratti, oltre che dal citatoSpecchio della navigazione commerciale relativo al 1852, dall'analogo Specchioper il 1853 in “Annali Civili del Regno delle Due Sicilie”, settembre dicembre1854, PP. 97 sgg.; gli altri da Atti Parlamentari, Camera dei Deputati,Legislatura XVI, terza sessione 1889, Documenti, Disegni di legge e relazioni,n. I07-A, Allegati n. 17 e 19. I dati sono forniti dal documento per annialterni.
1852-53 1865-71___ 1873-79 1881-87___
tonnel- diritti tonnel- diritti tonnel- dirittitonnel- diritti laggio (in lire) laggio (in lire)
laggio (in lire) laggio (in lire)Bari 46096 - 150255 1310154 368184 1876751 946254 2875551Brindisi 132385 - 335898 291732 843437 535653 1230919791892Taranto 59354 - 91119 211607 155462 334922 275166850565
Tutto questo emerge nella qualità urbana di questi due centriassolutamente antitetica e quella ordinata, curata, rigorosamente
382 R. NISTRI, Dinamica politica e sociale dall'avvio dell'industrianavalmeccanica alla guerra, in AA.VV., La città al borgo, Taranto fra '8oo e'900, Taranto 1983, P. 167
223
strutturata dalla nemica e vicina Lecce, nell'immagine diprovvisorietà e disorganicità che essi dànno di sé,nell'atteggiamento distruttivo nei confronti delle testimonianzedi un passato illustre dei loro gruppi dominanti, nel carattere“americano”383 di uno sviluppo urbano che denuncia “la fretta di unadecisione subitanea, un partito preso di violentare il tempo”384 eperciò incapace di creare sociabilità, stratificazione diinteressi, nessi minuti con mestieri e competenze; in definitivanella loro capacità relativamente scarsa di manomettere,organizzare, conformare il territorio.
Lo sviluppo di Bari, al contrario, si mantiene in larga partea ridosso del suo ruolo di polo mercantile, sorvegliato edincrementato dai ceti imprenditoriali che dominano l'orizzontesociale e politico della città. All'interno dell'imprenditoria'scentrata' di questo angolo di Mezzogiorno, i mercanti baresipresentano una loro specificità che abbiamo visto strutturarsinella seconda età moderna e permette loro, con l'aiuto deicapitali e dell'iniziativa dei forestieri calati nell'Ottocento,una sorta di quadratura del cerchio risultata impossibile in altriporti pugliesi: quella di praticare con successo e in larga scalail mercato internazionale senza pagare il prezzo di unasubordinazione alle grandi case organizzate intorno alla borsanapoletana. Dialogando con queste ultime, organizzando una rete diagenti e corrispondenti collocati negli sbocchi strategici,manovrando capitali ingenti senza smarrire, all'inseguimento dei“giochi di carta”, il rapporto con la città, le merci, gli uominie le navi che le muovono, i commercianti d'olio baresi riescono atrovare un proprio spazio di mercato, a difenderlo e allargarloanche contro le ragioni della geografia che tendono a rinchiuderlinell'Adriatico385; ad attraversare la fase difficilissima della
383 L'espressione è di un articolo del 1912 citato in R. NISTRI e L. SARDI,Cafoni, arsenalotti e galantuomini. Taranto dalla prima industrializzazioneall'avvento del fascismo, Bari 198o, P. 33.384 Paul Bourget (1890), in G. DOTOLI e F. FIORINO (a cura di), Viaggiatorifrancesi in Puglia nell'Ottocento, vol. II, Fasano1986, P. 245. Su Brindisi eTaranto cfr., nel vol. I, P. 268 di questa raccolta, le notazioni di Ch. Didier;nel vol. II quelle di Palestra (pp. 7o-8o), Gourdault (pp. 103-4),Yriarte (pp.144-47 e 150-151). Ma cfr., su questi temi, i saggi contenuti in AA.VV., Lacittà al borgo cit.385 La destinazione dell'olio imbarcato a Bari nel periodo 1848-54 è la seguente:
% sul totale imbarcatoTrieste 53,7Venezia 18,1Fiume e Ferrara 0,9
224
Restaurazione e poi quella postunitaria, segnata dalla crisi dellavela e dall'aggressività delle società armatoriali inglesi,traendone stimoli a riadeguare tecniche, istituti societari emercantili, mentalità.
Il processo va avanti a strappi, cosicché spesso, dall'altodegli ultimi risultati conseguiti, il passato anche recentissimosembra ai protagonisti di queste vicende un'epoca di miseria eoscurità: alla fine degli anni '40 i padri di quei “cospicuisostenitori del patrio fioritissimo commercio”, che hannocominciato a farsi “dotti e colti” per poter annusare gli sviluppidel mercato, paiono nulla più che “gretti speculatori”386, e acostoro, a loro volta, quanti riusciranno a guadagnare a Bari unacollocazione non subalterna nella rivoluzione dei trasportimutando “l'umile barchetta in alto vascello e quindi invelocissimo vapore”, guarderanno come agenti di un “meschino egretto contrabbando”387. Ma alcuni caratteri di fondo di questeélites, trasmesse insieme al negozio di padre in figlio lungocatene dinastiche che mantengono immutati i cognomi che contano,permangono e ripropongono un rapporto fra città ed il suoentroterra, ad un tempo aggressivo e fecondo.
% sul totale imbarcatoMarsiglia 10,7Nizza 11,8Genova, Livorno, Porto Maurizio 1,4Porti del Mediterraneo centro-settentrionale 23,9Porti nordici (Bordeaux, Rouen, Falmouth, Londra,
Scilly, Flessingen, Rotterdam, Stettino, Cronstadt) 2,9Porti del Regno delle Due Sicilie (Napoli,
Castellammare, Messina, Gallipoli, Bisceglie) 0,4
Fonte: elaborazioni SU TRIZIO, Commercio e marina mercantilecit.
Nettamente più ristretti sono gli sbocchi degli altri portioleari della provincia. Nel periodo 1840-48 le navi arrivate aTrieste, Venezia e Marsiglia da Terra di Bari e il loro
Porti dell'alto Adriatico 72,7386 L. TRAVERSA, Brevi cenni sulla vita di Raffaele di Giuseppe Milella, Bari1849, PP. 10-11387 Le citazioni, tratte rispettivamente da un discorso di Antonio De Tullio del1884 e da un articolo de «Il Bari» del 1877, sono in Di Ciommo, Bari 18o6-I940cit., PP. 151 nota e 145 nota.
225
tonnellaggio medio annuo si distribuiscono in questo modo fra isingoli porti provinciali:
a Trieste a Venezia a Marsiglia arrivi tonn. arrivi tonn. arrivi
tonn.Bari 58,6 4829 46,8 3569 5,6 803,7Molfetta 42,1 2593 1,9 99,9 - -Barletta 4,4 292 2 148 18,4 4699,3Bisceglie 26,9 1264 1,2 55 - -Trani 17,4 793 1,3 55,1 - -Mola 16,5 807 2,7 173,3 - -Monopoli 3,6 231,8 18,1 1271 1,4 219,3Terra di Bari 169,5 10810 74,4 5371,3 25,4
5722,3
Fonti: per gli arrivi a Trieste cfr. TRIZIO, Commercio e marina mercantilecit.; per gli arrivi a Venezia, AS Venezia, f. Console del Regno delle DueSicilie, registro n. 92; per Marsiglia, Archives Départementales des Bouches-du-Rhóne, Dépositions de santé, serie 20o E i. I dati di Trieste e Venezia prendonoin considerazione solo le navi battenti bandiera napoletana, che sono peraltrola grandissima parte di quelle che trasportano derrate pugliesi in quei porti; idati di Marsiglia sono stati elaborati sul periodo 1840-46.
La taglia di intermediazione che Bari fa pesare sulle suecampagne non è meno pesante di quella napoletana e straniera chegrava sui 'bacini' di Barletta e Gallipoli; anzi, la difficoltàdella produzione olearia ne fa risaltare l'“avidità”, fa sembrareiniquo lo scambio fra ricerca di spazi di mercato condottadall'élite urbana e l'appropriazione da parte di quest'ultima diuna parte rilevante del magro sovrappiù contadino.
L'elemento di differenza sostanziale è che, al contrario che aBarletta e a Gallipoli, la mercantilizzazione non comporta unasottrazione secca di risorse locali incanalate verso centridirezionali lontani, ma una loro riaflocazione sullo stessoterritorio, una loro concentrazione nelle mani di ceti che hannoradici nella città e vi reinvestono una parte consistente deiprofitti così estratti, provocandovi sinergie, dinamiche intenseche finiscono per riflettersi sullo stesso territorio eimpediscono che il gioco risulti a somma zero.
A risentirne è, in primo luogo, l'articolazione professionale,il tessuto minuto dell'economia urbana. E a Bari che, accanto agliesportatori di derrate, cominciano presto a trovare un ambienteidoneo grossisti, rivenditori di coloniali, commercianti di beninon di prima necessità che vanno allargando il loro giro d'affari
226
in riferimento a un mercato potenziale di dimensioni economiche eterritoriali sempre più largo. I circuiti mercantili interni,rimasti da sempre meschini, subordinati a quelli a lunga distanza,affidati a personale, istituti, tecniche meno nobili edefficienti, incapaci di produrre ricchezza e prestigio, vanno oraacquistando autonomia e consistenza. Gli incontri saltuari fraproduttore diretto e consumatore finale, le fiere e i mercati,vedono restringersi il proprio spazio a favore delle botteghe edei magazzini baresi, che distruggono la fiera secolare dellacittà, quella di San Nicola, svuotano quelle dei centri vicini,riducono quelle murgiane sostanzialmente a mercati di bestiame, edanno vita, nelle strade del borgo costruito al di là dellevecchie mura - per riprendere una lettera dell'intendente alministro dell'Interno del 1847 - a “un emporeo perenne dimercanzie e di tessuti esteri del più scelto lavoro e di genericoloniali in tanta copia, da provvederne le province limitrofe”388,dalle quali giunge quotidianamente una miriade di acquirenti alminuto e all'ingrosso. I flussi di traffico fra i centri di questoentroterra in continua espansione si vanno così riducendo eriordinando in senso polare, collocandosi su una raggiera che, apartire da ciascuno di essi, mette capo a Bari389. Così, agli inizidegli anni Ottanta, l'Almanacco stolico-statistico commerciale diBari e provincia redatto da Domenico Mele390 elencando comune percomune le iniziative mercantili, segnala distanze ormaiincolmabili fra il capoluogo ed ogni altro centro della provinciae presenta il processo di polarizzazione come ormai concluso ancheal livello della rete distributiva interna.
Il riversarsi di traffici e risorse nello spazio ristrettodella città vi crea occasioni di guadagno e convenienzeimprenditoriali in direzioni diverse da quelle originarie,comincia finalmente a indurre qualche elemento di specializzazionenella vecchia indistinta élite olearia, permette alcune iniziativemanifatturiere che cominciano a sostituire quelle spazzate viadalla “rivoluzione commerciale” e dalla liberalizzazionepostunitaria, pone le basi per imprese coraggiose come lacostituzione della società di navigazione a vapore “Puglia” chereinserisce la città nel mercato dei noli391 fa di Bari un polo nonsolo del circuito delle merci, ma anche di quello del denaro: il388 ASBA, f. Agricoltura industria commercio, h. 89, fs. « Bari1846 al 1866 ».389 G. DE VINCENTIIS, Sommario delle condizioni economiche e tecniche di untronco di ferrovia economica a costruire tra Grumo, Altamura e Barletta, Tranis.d. (1871)390 Anno 1, 1881-82, Bari 1882; anno 11, 1882-83, Bari 1883.
227
credito, per secoli frantumato in innumerevoli atti di anticipo“alla voce” stipulati fra individui, si va organizzando in societàbancarie dirette spesso da discendenti di capitani e mercanti diolio, che raccolgono capitali baresi e h diffondono ben al di làdel paesaggio dell'olivo, legando nel bene e nel male le sortidella città agli esiti delle trasformazioni produttive che vannomutando il volto di gran parte della Puglia392.
Al contrario che a Barletta, questa crescita mercantile nonpuò non produrre una crescita demografica sostenuta da flussi diimmigrazione, che nulla hanno a che fare con la tradizionalemobilità prodotta dalle caratteristiche e dalle vicendedell'agricoltura. La lunga carriera di agrotown di Bari si chiudequi, con la sua autonomizzazione dall'entroterra immediato, lacostruzione di un'imprenditoria che valorizza merci 'astratte', ladefinizione di una urbanità capace di crescere in una certa misurasu se stessa, concentrando risorse dal territorio ma, al tempostesso, arricchendone la dotazione di strumenti di civiltàeconomica, strappandolo a una ruralità senza spiragli e, ormai,senza più prospettive.
Alla fine di questo processo le tre province storiche non sonocerto state cancellate e continuano ad indurre gli osservatoriall'esercizio della costruzione di immagini a contrasto: quelladella “Capitanata triste” rassegnata a “disfarsi e rifarsi”393, aconsegnare la sua grande agricoltura ai capricci del mercato nonmitigati da una qualche articolazione settoriale consistente,raccolta attorno ad un capoluogo del quale è possibile ricordaresolo la piazza delle fosse da grano ed i marciapiedi gremitiperiodicamente di mietitori calati da lontano; quella di Lecce“noiosa” e “superba”, “sonnacchiosa”e “civettuola”394, che riflettenell'infingardaggine dei suoi abitanti e nel loro attaccamento alpassato le cautele di quel mondo salentino policentrico,appartato, che tenta di “rimanere felice” negli sconvolgimentidell'economia e del costume evitando la “megalomania economica”391 M. OTTOLINO, Commercio e iniziativa marittima in Puglia 1876-1914, Napoli1981392 Su questi temi cfr. ora L. DE ROSA, Tra liberismo e protezionismo, in c. D.FONSECA (a cura di), La Puglia e il mare, Milano 1984, pp. 277-94. Dello stessoautore cfr. anche le numerose indicazioni e riferimenti alla situazionepugliese in Il Banco di Napoli nella vita economica nazionale (1863 -1888),Napoli 1964.393 Cfr. G. GOYAN, Lendemains d'Unité, Parigi 1900, in DOTOLI e FIORINO (a curadi), Viaggiatori francesi cit., PP. 383-425, in particolare P. 400.394 Rispettivamente ibid., vol. I, P. 264 (Didier) e vol. III, P. 392 (Goyan); DEGIORGI, La provincia di Lecce cit., I, p. 144; GOYAN, Lendemains cit.
228
dell'altra Puglia, rifuggendo da rapporti sociali che “mettono acontatto brutale la libertà di entrambe le parti”, preservando “uncerto equilibrio di coltivazioni”, “una certa stabilità diinteressi”395; quella di Terra di Bari che, al contrario, “s'èlasciata coinvolgere in tutte le agitazioni e in tutti i pericolidelle mischie economiche”, che non “previene le catastrofi con latimidezza nell'evolvere”, come fa il Salento, ma “ne ripara glieffetti con l'infinita varietà di occupazioni e di risorse dilavoro messe a disposizione degli abitanti”, dominata da uncapoluogo “orgoglioso di ingrandirsi, di aprirsi, di arricchirsi”,che “pretende di essere una grande piazza industriale ecommerciale”396 ed è piena di gente operosa “poco curante [...] dititoli senz'autorità”397, ottimista.
Come spesso accade, c'è molto di vero in questi stereotipi,che però, come la nottola di Minerva, spesso si diffondono e siirrigidiscono quando i giochi sono fatti e le cose stanno giàcambiando. Dentro ciascuna delle tre province pugliesi sono andatiavanti, nel corso dell'Ottocento, processi di differenziazione, diinclusione ed esclusione, di emarginazione e ricuciture tramitefenomeni di flusso di uomini e merci sempre più intensi, checominciano a far emergere, dentro il disegno del territorio agrandi pennellate, una trama più minuta e confusa.
Lo spazio che va in questa maniera prendendo forma si presentacomplesso, sfrangiato, percorso da una molteplicità di linee diforza che si incontrano in nodi di diversa grandezza ed influenza,ingombro di spinte e forme di aggregazione minori, ma, lo abbiamovisto, non illeggibile. Bari non può né vuole unificarlo esubordinarlo come un contado, ma la sua presenza tentacolarecomincia a proporsi come un nuovo principio di selezione edorganizzazione col quale anche i pugliesi del Salento cauto edella Daunia triste devono imparare a fare i conti.
VI.EPILOGO. LA POLITICIZZAZIONE INCOMPIUTA.
395 Ibid., pp. 294-97396 Ibid., pp. 398 e 400397 G. PETRONI, Della storia di Bari dagli antichi tempi fino all'anno 1856 libritre, vol. Il, Napoli 1858, P - 399. Fra la diffusa letteratura sul «caratteredei baresi » e su quello opposto dei leccesi cfr., ad esempio, H. VON RIESEDEL,Nella Puglia del '700 (lettera a I. I. WinckeImann), a cura di T. Pedio,Cavallino di Lecce 1979, PP. 83-84 e 103; G. FRANCIONI VESPOLI, Viaggio daNapoli a Otranto,, a cura di A. Ventura, Cavallino di Lecce 1986, P. 52; C.MALPICA, Il giardino d'Italia. Le Puglie, a cura di M. Spagnoletti, Cavallino diLecce 1985, PP. 164 Sgg.; DE GIORGI, La provincia di Lecce cit., Il, P. 337.
229
I. La regione voluta.
Lo scomporsi e il ricomporsi degli aggregati spaziali inquesto angolo di Mezzogiorno ha luogo in un tempostraordinariamente contratto, di qualità diversa rispetto aquello che abbiamo visto dipanarsi in età moderna: procedure nuoveportano a esiti che rimangono incomprensibili fino a quando lì siinseguirà con la stessa strumentazione usata per la lunga faseprecedente.
Un punto di rottura decisivo della continuità della nostrastoria è il rifluire sulle vicende del territorio del gioco degliinteressi e delle volontà organizzate, della lotta politicalocale, la cui marginalizzazione era stata un elemento fondantedel vecchio regionalismo provinciale. La regione rurale era natanel quadro di una ristrutturazione istituzionale che, in quellaPuglia centrale priva di “capoluoghi” e povera di aggregatifeudali territorialmente e politicamente possenti, avevaricacciato la dialettica politica in larga parte dentro le muradelle agrotowns, affidando la definizione della territorialitàall'economia, alle forme di produzione e di scambio elaboratesinel gioco fra la collocazione subordinata della provincia nelmercato internazionale e i suoi equilibri interni agronomici esociali: che era poi un esempio pregnante di“provincializzazione”, di rinuncia a ogni forma robusta didirezionalità agente dall'interno del territorio, nel quadro di uncoinvolgimento nella circolazione di elementi di civiltà europeache Napoli rilanciava di continuo nei circuiti del Mezzogiorno. Laregione rurale funzionava cosi per sedimentazioni secolari,'automatiche', lungo quei percorsi delle permanenze che entranonel secondo Settecento in tensione acuta, espressasi anchenell'emergere all'evidenza dell'inadeguatezza delle istituzioni digoverno locale di antico regime a rappresentare, mediare,organizzare la società398.
Sotto questo profilo le trasformazioni istituzionaliottocentesche - da quelle del periodo francese in buona parteconservate dai Borboni alle altre prodotte dall'Unità -costituiscono una novità di grandissimo momento. Larazionalizzazione amministrativa, con la creazione di unamolteplicità di gradini pertinenti a circoscrizioni man mano più
398 Cfr. SPAGNOLETTI, «L'inconstanza delle umane cose» cit., in particolare PP.79 sgg.
230
vaste, ognuna dotata di un suo capoluogo e di forme più o menosignificative di rappresentanza delle forze sociali dominanti,ridà fiato all'organizzazione degli interessi e all'elaborazionedi strategie non più solo nell'ambito asfittico di ciascun centroma su aree consistenti, rilancia la competitività fra le città,ripropone la politica come elemento di organizzazione delterritorio399. Anche perché, all'altro capo della catenaistituzionale, ci sono i nuovi contenuti della statualitàcentralistica. Il ritrarsi del vincolismo statale - come si samolto cauto nel periodo borbonico, impetuoso nell'Italia unita -,allo scopo di lasciare spazi all'azione trasformatrice del self-interest, si accompagna a un interventismo estremamente incisivosul piano della ridefinizione dei quadri di riferimentoambientale, della rete infrastrutturale, degli spazi fisici edeconomici entro i quali il se1f-interest stesso deve giocare, efinisce per influire sulle sue caratteristiche. Lo Stato - siaquello del periodo francese e borbonico sia quello unitario -opera scelte territoriali drastiche, che implicano esclusioni edemarginazioni quanto stimoli allo sviluppo e, a seconda dei casi,si scontrano in maniera dura o si incontrano con le volontà localiorganizzate ed espresse tramite i nuovi canali del 'decentramentocentralistico'. La territorialità nuova va così prendendo formanel gioco complicato di processi profondi, interessi in qualchemaniera organizzati, volontà e progettualità confuse o esplicite,nell'immaginario collettivo e nei suoi stereotipi, nei piani diuna mente lucida come quella di Afan de Rivera, nelle iniziativestatali che trascelgono fra le forze in campo, sanzionano processiin atto o li forzano verso uno degli esiti possibili.
I tempi e i modi delle trasformazioni già delineate, a tenerconto di tutto questo, acquistano una ben maggiore perspicuità. Lanuova collocazione di Terra di Bari prende forma nella crisivoluta delle due forti polarità storiche che stringevano da duelati la regione rurale barese a polarità interne deboli. A nord loscioglimento della Dogana, secondo scansioni illustrate da SaverioRusso in questo volume, sposta equilibri territoriali ed egemoniesociali in Capitanata dalla montagna alla pianura, dove il primatodi Foggia sul piano dell'organizzazione della produzione e delcommercio granario può essere messo in discussione da Cerignola edalla stessa Barletta; a sud, la scelta degli anni '30, dopo uno399 ID, Centri e periferie nello stato napoletano del primo Ottocento, inMASSAFRA (a cura di), Il Mezzogiorno Preunitario cit., PP. 379-91- Più ingenerale, per la linea interpretativa qui adottata, cfr. P. VILLANI, Italianapoleonica, Napoli 1978, PP. 117-33.
231
scontro durissimo che vede in campo interessi locali e opzionistrategiche contrapposte, di puntare sul recupero del porto diBrindisi invece di potenziare quello di Gallipoli, e di bloccare aquesto scopo una parte rilevantissima delle risorse destinate alleinfrastrutture di Terra d'Otranto400, accelera l'emarginazione delSalento centro-meridionale a favore, ancora una volta, dell'area aridosso di Terra di Bari. E sull'insieme di questo territorio nonpiù lacerato da spinte in opposte direzioni - quella pastorale,che connetteva la Puglia piana agli Abruzzi, quella mercantile cheproiettava il mondo di ritmi lenti di Lecce e del suo 'contado',tramite il grande porto 'coloniale' di Gallipoli, verso il mercatonord-europeo - agisce la rete stradale, che i Francesi comincianoa progettare e i Borboni e lo Stato unitario realizzano a passospedito, secondo un disegno vigorosamente decisionistico matutt'altro che astratto, efficace perché incontra trasformazioni eforze già agenti nella realtà, e di respiro chiaramente pugliese,che punta sin dall'inizio alla “prosperità del commercio” diquelle tre province considerate un'entità territorialepotenzialmente unitaria a causa del “bisogno vicendevole in cuisono costituite fra loro” e “per l'immediata relazione che hannocon la capitale”401.
Ed ecco che le strade, invece di continuare a “passare per leosterie e per ogni meschino abitato”402, cominciano finalmente atirar dritto, trascegliendo ed escludendo, raccogliendol'opposizione sorda o esplicita degli innumerevoli interessicolpiti, ma anche l'appoggio - decisivo in particolare sul pianodella realizzazione delle opere progettate403 - di quei particolarigruppi sociali emergenti, chiamati a misurare le proprieconvenienze non più sulle questioni del tornaconto quotidiano, masu alcuni dei nodi dello sviluppo. La Capitanata e Terra d'Otrantorestano così nettamente più indietro rispetto a quella Pugliabarese, che appare già nel 1840 tagliata “da strade amplissime chesi piegano, s'incrociano, si succedono per ogni verso”404,conferendole un altro dei suoi primati. Ma la provincia è un'unitàdi osservazione ormai inutilizzabile.
All'interno di Terra di Bari la Murgia centrale presenta una
400 ASCOLI, Storia di Brindisi cit., PP. 410 Sgg.; MASSAFRA, Campagne eterritorio cit., in particolare pp. 278 sgg401 Così recita il decreto murattiano del 7 maggio 1813 (ibid., p. 195, nota).402 Afan De Rivera (ibid., p. 188, nota).403 Ibid. Importanti, in proposito, in questo stesso studio di A. Massafra, lepp. 155 sgg-, 168-69 e 3o6-8.404 MALPICA, Il giardino d'Italia cit., p. 8
232
rete stradale a macchie larghissime, nel mentre le grandi arterievanno convergendo su Barletta e Bari in particolare, attraversandoin più punti i confini provinciali, solcano la pianura lontano dairilievi e dai loro presepi, giungono rapidamente a Brindisi eTaranto procedendo a stento verso Sud.
La ferrovia, quando verrà, non farà che ricalcare le lineegenerali di un disegno del territorio già in larga partetracciato405.
Così la centralità fisica di Terra di Bari, che siaccompagnava a una sostanziale marginalità rispetto ai flussi chesi svolgevano in direzioni opposte a partire dalle due province aisuoi lati, può trasformarsi in centralità direzionale edeconomica, e Bari, nel mezzo di quest'area, cresce provocandorichieste e concessioni di nuove infrastrutture e quindiespandendosi ulteriormente in un processo presentato da quanti visono coinvolti in posizione dirigente come benefico per Pinteronuovo territorio che si va delineando. Già nel 1836 il consiglioprovinciale di Terra di Bari, constatato che “la navigazione [...]uscendo dai brevi termini dell'Adriatico si è messa ora per marilontani”, crede sia giunto il momento di una riclassificazionepiramidale, da formalizzarsi per via amministrativa e da sostenerecon sovvenzioni appropriate, di quella catena di città portualifra le quali non era possibile nel Settecento rinvenire supremazieindiscusse: al vertice i consiglieri collocano il porto di Bari“come primo emporio di ricchissimo commercio interno e marittimo,non solamente per questa provincia, ma anche per le tre finitimedi Basilicata, di Terra d'Otranto e di Capitanata”; seguono“quelli di Monopoli e Barletta come necessarissimi, il primo agliolj di questa provincia e di buona parte di quella di Lecce, ed ilsecondo alle derrate non pure della provincia ma anche diBasilicata e di Foggia”; ed infine “i due intermedi di Molfetta eMola, siccome quelli che particolarmente servono al vantaggio de'distretti ove son posti”406. Non tutti gli elementi di questagerarchia si riveleranno aderenti alle tendenze in atto, ma inessa appaiono già fissate, in forme che diverranno stereotipe, leparole d'ordine di una battaglia politica che punteràsostanzialmente con successo a concentrare a Bari sedi consolari eapparati giudiziari, scuole pubbliche e approdi dei vapori dilinea, banche e infrastrutture.
Che non si sia trattato di un processo neutro, indolore, lo405 Cfr., in proposito, L. MASELLA, La difficile costruzione di una identità(188o-198o), in questo volume, pp. 279-438406 ASNA, f. Interni, Il, b. 4o69, seduta dell'8 maggio 1836.
233
dimostra, se ce ne fosse stato bisogno, il lungo catalogo deirisentimenti, delle proteste, in qualche caso delle disperazioniche accompagnano e commentano le vicende: da quelle degliAbruzzesi espulsi con le loro pecore dai pascoli del Tavoliere aquelle dei Lucani che oppongono vanamente la parola d'ordinedell'equilibrio agro-pastorale alla “stolta voce” della “ciurma dimonopolisti sparsi sulle coste dell'Adriatico specialmente”,“sordidi speculatori” che tutto misurano dal “particolare lorovantaggio”407; da quelle espresse dai grandi insediamenti murgiani edai porti declassati dallo sviluppo di Bari408 alle altre dei gruppidominanti più tradizionali di Terra d'Otranto, che nell'emergenzadi quella porzione settentrionale di provincia priva di identitàed aloni che non siano quelli vacui di età grecoromana, vedonomessa in discussione la loro stessa identità ancora vistosamentepresente nelle elaborate scenografie urbane leccesi, e la stessaintegrità della provincia che ormai rimane l'unico possibileelemento di legittimazione dei vecchi primati.
Noi per inveterata esistenza - scrivono 42 salentini al re d'Italia almomento dell'Unità - sentiamo così della nostra autonomia, che il perderlapercuoterebbe fortemente la coscienza del popolo, da temerne scatenamenti erivolture. Lecce1 ... 1 è geograficamente il centro della provincia nostra, comen'è amministrativamente la capitale. Lecce intanto non ha un agricoltore, edappena qualche negoziante. Questa città, che è tanto innanzi per civiltà ecostumi, non da che professori, proprietari, ed artigiani, cioè un popolo diconsumatori che nulla aggiungono alla produzione materiale. La sua vita sta neipubblici stabilimenti, Governo, Tribunali, liceo, ospedali, orfanotrofi,amministrazioni, forza pubblica ed altri. Così la produzione di altre città ede' contadi va quasi tutta ad esaurirsi nella capitale. Talché, se per avventurai confini della nostra provincia mutassero, e tutti i suoi piccoli centri diconseguenza traslati, noi torneremmo poveri adun'ora ed imbarbariti409.
La disgregazione formale della provincia di Terra d'Otranto sirealizzerà sessant'anni dopo, ma - da questo punto di vista 142Salentini hanno lo sguardo acuto - si tratterà solo della sanzionedi un processo che all'Unità è pienamente in atto.
407 Dal discorso del presidente della società economica di Basilicata nellatornata del 30 maggio 1842, in «Giornale economico-letterario della Basilicata»,1842, f5. IV, p. 16o.408 Molte indicazioni in merito in E. DI CIOMMO, Elites provinciali e potereborbonico. Note per una ricerca comparata, in MASSAFRA (a cura di), IlMezzogiorno preunitario cit. , pp. 965-1038. 409 VISCEGLIA, Territorio feudo e potere locale cit., PP. 341-42.
234
2. Vincitori e vinti.
Guardati su questo sfondo, gli atteggiamenti dei gruppidominanti pugliesi di fronte agli appuntamenti canonicirisorgimentali riescono ad acquistare senso, possono esseredescritti con categorie meno generiche di quelle, comeopportunismo e simili410, usate per sottolineare la difficoltà diindividuare raggruppamenti precisi, 'partiti' definiti dallegrandi opzioni ideali e politiche. Nel 1820-21, nel '48, nelladialettica fra Destra e Sinistra dopo l'Unità, i processi digerarchizzazione ed emarginazione trovano modo di esprimersi nellecautele dei 'vincitori' e nel ribellismo dei vinti' del nuovoregionalismo; le scelte politiche incontrano elaborazioni idealirobuste e si dispongono lungo discriminanti nettissime chetagliano trasversalmente i gruppi sfrangiati formatisi attornoalle opzioni ideali della politica 'alta'. L'atteggiamentoaccomodante ed opportunistico si rovescia, da questo punto divista, in una contrapposizione frontale interna alle élitesregionali, fondata in primo luogo sul giudizio intorno alla grandetrasformazione ottocentesca.
In contrasto col futuro cupo disegnato dai salentini nellalettera a Vittorio Emanuele, quello proposto vent'anni primadall'avvocato barese Carlo D'Addosio di fronte alla SocietàEconomica di Terra di Bari è senza ombre di sorta:
chiunque, dopo di aver senza prevenzioni osservato lo stato attuale dipopolazione del nostro Regno, quello delle nostre manifatture, lamoltiplicazione dei nostri prodotti in tutti i diversi rami delle industrieagrarie, la superiorità de' cambi in tutte le diverse piazze di Europa, lafacilità delle comunicazioni interne, lo stato infine delle nostre relazionicommerciali e della navigazione della nostra marina mercantile, non può nonconvenire esser noi [...] pervenuti a tal punto di progresso e di floridezza dapoter senza iattanza prender posto tra le più incivilite nazioni d'Europa411.
Il giudizio si rifrange sull'intero Mezzogiorno a partire,naturalmente, da quello sulla provincia e sul suo capoluogo inparticolare. L'agricoltura provinciale - affermano i decurionibaresi nel 1841- è “abbondevolissima di frutti di straordinaria
410 Cfr. G. MASI, La partecipazione della Puglia alla rivoluzione liberaleunitaria, in «Archivio storico per le province napoletane», 196o, pp. 137-6o.411 Atti della Reale Società Economica della provincia di Terra di Bari ( ),Bari1842, pp. 13-14 (d'ora in poi questa pubblicazione annuale verrà citata comeAtti, più l'anno di edizione, che corrisponde all'anno della « tornata solenne »di cui si pubblicano i discorsi principali).
235
grandezza” e non ha bisogno alcuno di “immeliare”412; e la città chevi presiede, Bari, è già ora “floridissima, popolosa,procacciante413“, “piena di uomini spigliati e ingegnosi [...] ,doviziosissima di capitali”, ed è destinata a una “immensaprosperità 414“.
Non che questa immancabile prosperità debba essere, da partedei protagonisti, solo fiduciosamente attesa: all'azione dipromozione attiva del progresso resta uno spazio delimitato maconsistente, che va praticato evitando in ogni modo di inseguire iprincipi generali, lo “spirito di sistema”. Sul piano dellapolemica antideologica i ceti dominanti baresi trovano munizioniabbondanti nella tradizione riformatrice settecentesca,soprattutto nelle forme particolari in cui essa era penetrata inPuglia; ma è evidente lo scivolamento di piano, in mutamento diprospettive nel frattempo intervenuto. Il glorioso empirismonaturalistico e il tecnicismo agronomico pugliese avevano agitonel quadro del tentativo genovesiano, rivelatosi presto senzasbocchi, di promuovere un self-interest provinciale autonomo dallespeculazioni mercantili napoletane e di indirizzarlo verso laproduzione agricola, di dare fondamenta sociali al processoriformatore diffondendo la figura del “filosofo di campagna”,capace di riscattare il lavoro dei campi dall'ignoranza atavicacontadina e al contempo la cultura dalla pastorelleria arcadica415;il concretismo ottocentesco considera al contrario benefico ecomunque irrifondabile il self-interest dato e cerca spaziulteriori per la sua affermazione nelle “concessioni”, neiprivilegi, nel favore dall'alto. Il progresso non derivadall'affermarsi di condizioni generalissime che hanno spessoeffetti contraddittori - ad esempio un indiscriminatoliberoscambismo - ma dalla conquista di condizioni specifiche perla promozione di attività specifiche in punti determinati dellospazio, sui quali far convergere gli sforzi per non disperderli evanificarli. Essendo lo Stato che agisce erga omnessostanzialmente inefficace quando non dannoso, il suo interventonon può che essere speciale, discriminante.
Sotto questo profilo le scelte sono drastiche. E' il commerciolo “spirito motore dell'ingegno umano, dell'industria, delle arti
412 ASBA, Deliberazioni decurionali del Comune di Bari, 3 novembre 1841.413 D'ADDOSIO, in Atti 1850, P. 26.414 G. CHIAIA, in Atti 1841, P. 17.415 Cfr. su tutto questo B. SALVEMINI, Propaggini illuministiche. Intellettuali'nuovi' e sviluppo dipendente in Puglia fra Settecento e Ottocento, in «Lavorocritico», ottobre-dicembre 198o, PP. 145-98.
236
e sorgente inesauribile di ricchezza di ogni civil comunanza”416;“in paragone dell'agricoltore e dell'artefice il commerciante ècollocato in una condizione più alta e civile; talché stando eglidi mezzo tra il produttore e il consumatore le sue attinenze lolegano a tutti gli ordini della società, e le permutazioni e lesue svariate intraprese lo sottopongono a mille casi di dubbiafortuna”417. Dunque non di scuole di agricoltura, come vuole ilgoverno borbonico c'è bisogno, ma di scuole di pilotaggio418; non dimonti di pegni, che rischiano di indurre nel contadino“imprevidenza”e “infingardaggine”, ma di istituzioni creditizie asostegno dell'intrapresa mercantile419. E dato che questa fioriscesoprattutto a Bari, è lì che bisogna concentrare le risorse scarsedisponibili. Toccherà poi ai mercanti, una volta messi in grado diperseguire il proprio tornaconto, diffondere il benessere dallaloro città sul territorio.
Col che l'agenda dello Stato amministrativo nel campo dellapromozione del “ben vivere sociale” non è vuota, come nelliberalismo dottrinale, ma neanche smisurata e informe come erastata in certi esponenti di primo piano dell'alta burocraziamurattiana - il pugliese Cagnazzi in primo luogo -, i qualiavevano avuto la pretesa di rimodellare dall'alto, a fini diprogresso, la miriade di figure agenti nella società meridionale420.
Interventismo statale e automatismi benefici del “tornaconto”devono coabitare in forme necessariamente flessibili,pragmaticamente definite, contrattate fra amministratoriilluminati e forze sociali emergenti.
Su questo terreno i gruppi dominanti, quelli baresi inparticolare, incontrano le istituzioni operando vigoroseoperazioni di 'semplificazione', scelte drastiche lungo una lineache colloca in una sostanziale continuità amministrazioni eamministratori pre e postunitari. Nei ceti mercantili eproprietari dominanti nella città in periodo borbonico econvertiti al liberalismo, rappresentati efficacemente da GiuseppeCapriati, commerciante di olio, primo presidente della Camera diCommercio, sindaco negli anni 1859-60 e poi fra il 1864 e il 1872,nettissimo è ad esempio il rifiuto dell'ipotesi dello sviluppo
416 D'ADDOSIO, in Atti 1842, P. 4417 CHIAIA, in Atti 1841, P. 5.418 ASBA, Deliberazioni decurionali del comune di Bari, 3 novembre 1841419 D'ADDOSIO, in Atti 1850, PP. 11-12.420 B. SALVEMINI, Economia politica e arretratezza meridionale nell'età delRisorgimento. L. d. S. Cagnazzi e la diffusione dello smithianesimo nel Regno diNapoli, Lecce 1981, in particolare pp. 63 sgg.
237
industriale come risposta alle difficoltà che il commercio bareseattraversa nella fase della prima affermazione del vapore, edeciso è il tentativo di rilanciarlo tramite la promozionecoraggiosa di “opere colossali”, il nuovo porto in primo luogo,all'inseguimento dell'obiettivo megalomane, avrebbe affermato la“sinistra” barese, di “voler [...] di Bari creare d'improvviso unacittà di primo ordine”421, nell'ipotesi tutta da dimostrare che diquesto avrebbe in ultima istanza beneficiato il vasto territoriodella circostante agricoltura mercantile.
Già negli anni '70 il vigoroso pragmatismo 'commercialista'barese va smarrendo la propria carica innovativa ed egemonica, ele amministrazioni cominciano a seguire i meandri di una linearesa più cauta dai timori e incertezze che percorrono l'economiaeuropea, dalle più complesse figure sociali prodotte dallo stessosviluppo mercantile, dall'ampliarsi del gioco politico; ma lamentalità collettiva urbana impastatasi nei decenni precedenti diottimismo operoso, spregiudicatezza, laicismo di valori,indifferenza verso la politica ma attenzione verso il potere ecompetenza minuta dei suoi meccanismi di funzionamento, più chedei meccanismi di funzionamento della produzione, riuscirà asopravvivere alle vicissitudini spesso drammatiche che attendonola regione e riemergerà, riadeguandosi ai tempi, nelle giunturedecisive della vicenda contemporanea.
Il punto è che tutto questo non può né potrà diventareelemento di identità pugliese: la capacità di Bari di innervare diflussi il territorio va ben al di là della sua capacità di creareconsenso, autoidentificazione. I pugliesi non riescono araccogliere le loro coscienze attorno a un sentire collettivo, auno stereotipo unificante; anzi, uno degli aspetti fondamentalidella loro storia ottocentesca è la tendenza dei ceti urbani acreare 'scissione', opposizione violenta non solo nelle areesociali e territoriali emarginate e condannate, ma all'internostesso dei fuochi della crescita.
Nel nostro periodo 'vincitori' e 'vinti' appartenenti allestesse classi coabitano negli stessi luoghi, negli stessi campi,nelle stesse istituzioni. In quella stessa Società Economica cherisuona dell'oratoria ottimista dei D'Addosio, dei Chiaia, deiPetroni, il Segretario perpetuo Francesco Santoliquido vadenunciando per decenni, sessione dopo sessione, i caratteri diuno sviluppo che rompe equilibri consolidati senza apprestarne di
421 DI CIOMMO, Bari cit., p. 141. Cfr. anche, su questi terni, ibid., pp. 118sgg., 136 sgg., 145 e 151.
238
nuovi, che precipita fasce di società rurale in una condizione diinstabilità e miseria che è condizione dei rapidi e faciliarricchimenti di pochi; che “seduce” i contadini, con le“prospettive lusinghevoli dell'agio” e col “falso calcolo dimigliorare la propria condizione”422, a disertare le campagne perrifugiarsi in città e viverci di espedienti, sul crinale fra illecito e Fillecito: l'odierno cosiddetto incivilimento - affermaSantoliquido nel 1850 - lungi dall'immeliar le sorti dellaprovincia, le ha fatte indietreggiare, perocché ha espulso gliuomini dai campi [...] li ha impigriti, resi sensuali, corrotti[...] ; quindi fuorviati, li vede a vicenda o per licenza infami,o per corruzione spregevoli; e distrutta così la bilanciaeconomica delle famiglie, vanno tosto o tardi a cadere in gremboad una miseria, dalla quale riesce difficile e talora impossibileil risorgimento423.
Il successo della “lusinga” urbana è fondato sulla crisi dellaciviltà dei campi. Il giudizio sull'agricoltura provinciale ingenerale è nettamente negativo tanto quanto è entusiasta quellodei 'commercialisti': “di tutto siam ricchi in questa provincia,meno di certa industria campestre”, afferma il Moscatelli424.Arretratezza tecnica, ignoranza di contadini e massari, scarsezzadi capitali aggravano gli effetti dello stravolgimento degliequilibri tradizionali, creando una situazione precaria,pericolosa. Dall'età della Restaurazione fino ai Fiorese, jatta equanti altri potranno ripensare lo sviluppo ottocentesco dagliesiti di fine Ottocento, il filo rosso che percorre la riflessione'agriculturista' è la preoccupazione suscitata dalle colture chesi estendono “rompendo gli argini della proporzione colle altrecoltivazioni”425 e “la equilibrata varietà della produzione”426 dalla“mania di piantare alberi [...] fino ad abusarne”427 dall'alterarsidell'“antica corrispondenza” verso quella “soverchiaspecializzazione” che “avvelena [...] il nostro sistema agrario
422 F. SANTOLIQUIDO, in Atti 1844, PP. 23-24423.14 ID., in Atti 1850, PP. 49-50.424 In Atti 1852, p. 25.425 Memoria letta, ed indirizzata al Sig. Intendente della Provincia Cavaliere D.Gennaro di Tocco, nel giorno 30 maggio 1821, dal Vice Presidente della SocietàEconomica, in Le relazioni alla Società Economica di Terra di Bari, a curadell'Amministrazione della Provincia di Bari, vol. 1, 1810-22, Molfetta 1959, P.2o8.426 S. LOFFREDO, Storia della città di Barletta, vol. Il, Trani 1893, P. 243.427 Santoliquido, che riferisce l'opinione dei socio C. Palmalà di Montrone, inAtti 1845, P. 15.
239
pugliese”428. Anche la produttività relativamente alta dellacerealicoltura della provincia settentrionale e della Pugliapiana, sottolinea De Cesare”429, ha basi fragili, è da attribuirealla naturale fertilità della terra dissodata, che è risorsa nonrinnovabile data la crisi della pastorizia e la conseguenteriduzione degli ingrassi disponibili e delle sinergie possibili.Il rigoglioso progettismo agriculturista ottocentesco - dalleproposte di rilancio della pastorizia vagante alle altre sui pratiartificiali, sulla gelsicoltura, sul rimboschimento, sullemanifatture domestiche - vuole in qualche modo risarcire lelacerazioni prodotte dalla grande trasformazione dell'economiaagraria, ripristinare l'antica centralità del momento dellaproduzione, ristabilire quella “progressione dall'agricoltura allearti al commercio”430 che eviterebbe di consegnare le sorti dellaregione solo alle sue città e ai traffici che vi si annodano:
Anche perché, agli occhi degli 'agriculturisti', le funzionidirezionali espresse dalle città appaiono carenti e spessoperverse. “Il commercio barese - afferma De Cesare riprendendo untema diffusissimo - non è che spacciato monopolio, spoliazioneusuraia, rovinoso aggiotaggio”. “Dalle piazze di Barletta e diBari partono a guisa di locuste tanti commessi delle case dicommercio ivi stabilite, i quali si diramano per la provincia[...] , e in tempo d'inverno, quando l'industrioso ha maggiorebisogno di danaro per la coltivazione dei campi, si pongono comevampiri in agguato, aspettando che l'infelice agricoltore venga achiedergli somme a prestanza”, per poterlo ricattare con tassi econdizioni usuraie431. La funzione creditizia esercitata dallecittà, lungi dal sostenere l'agricoltura, contribuisce a tenerlain condizione di precarietà, ne riduce i margini diprofittabilità e la costringe a inseguire, nella ricerca disperatadel guadagno immediato che la emancipi dalla tutela degli usurai,la congiuntura spesso bizzarra della domanda internazionale,cercando di adeguarvi le scelte colturali.
Ed ecco l'altro elemento essenziale dello sviluppo trainatodalle città: quella sovraesposizione commerciale, quel condannarsi“a patire sovente quelle convulsioni che l'arbitrio di [Trieste e
428 E' l'opinione del Froio riferita da A. Jatta, in DE FELICE, L'agricoltura diTerra di Bari cit., P. 149.429 DE CESARE, Intorno alla ricchezza pugliese cit. e ID., Delle condizionieconomiche cit.430 SANTOLIQUIDO, in Atti 1844, P. 25.431 DE CESARE, Intorno alla ricchezza pugliese cit., p. 89.
240
Venezia] gli suscita e muove”432 quel tagliarsi i ponti alle spallepuntando tutto su un ventaglio ristrettissimo di prodotti,mancando i quali “le più belle provincie del Regno, quali sonoquelle pugliesi, precipitano in una desolante e commoventemiseria”433. E nella stessa Camera di Commercio barese, negli annidello sviluppo travolgente della vite, la sensazione di camminaresull'orlo del baratro si sarebbe fatta acutissima:
noi siamo addivenuti stranieri in casa nostra - afferma Columbo nellatornata del 13 settembre 1879. - Nella nostra provincia non vi sono opifici,manifatture, industrie estrattive, laniere, cotonifici, tessuti, bachicoltura,industrie seriche, fabbricerie, e niuna delle tante e tante industrie che fannoanimato e vario il commercio di altre regioni; noi non abbiamo che tre o quattroarticoli di produzione agricola, ricchi articoli, non vi è dubbio, ma soli, esui quali si avvolge e si sviluppa l'intero nostro commercio434.
Tutto dipende così dai prezzi di quelle derrate, sui quali,però, non è possibile fare alcun affidamento:
da noi - scrive L. Gentile nel 1885 - i prezzi dei cereali, dell'olio edora del vino non furono prezzi normali, ma di occasione e si errò nel ritenerliduraturi: sull'alto prezzo del grano influì la mancata produzione danubiana perla guerra turco-russa e risalì l'olio perché mancarono le qualità superiori nelGenovese e in Marsiglia; come il rincaro del vino oggi nasce dal momentaneodifetto dell'Italia superiore. Ieri da tutti si produceva olio, poi grano, oggivino, guardando non ai bisogni della nazione produttrice, ma ai mercati esteri435
Al centro di tutto, al posto del mitico proprietario che,protetto dai “residui degli ordinamenti feudali”, aveva un“operare superiore al semplice calcolo di commercio”436, c'è ilnuovo imprenditore 'scentrato' che sacrifica la “morale” alle“avventure produttive”, che alla “calma amministrazione delle[...] antiche grandi e piccole masserie” sostituisce quella“coltura intensiva” che mette in discussione la “pace sociale” efa sì che tutti siano “travagliati dalla mobilità dei fattimercantili e dalle grandi incertezze dei profitti e degli averi”437.Non si tratta comunque solo di nostalgie reazionarie. L'odio neiconfronti degli 'uomini nuovi' dell'economia pugliese salda ilvariegato fronte 'agriculturista' aggiungendovi anche chi, come432 MOSCATELLI, in Atti 1852, P. 15.433 DE CESARE, Delle condizioni cit., p. 89.434 ASBA, Deliberazioni camerali, 13 settembre 1879.435 DI CIOMMO, Bari cit., p. 102, nota.436 G. ROMANAZZI, Note e considerazioni sull'affrancazione de' canoni e sullibero coltivamento del Tavoliere di Puglia, Napoli 1834, P. 109437 FIORESE, Storia della crisi economica cit ., p. 9
241
Carlo De Cesare, secondo un modulo tipico del moderatismomeridionale, riprende e aggiorna la linea genovesiana, accetta lasfida delle nuove istituzioni, dell'individualismo economico,dello sciogliersi della società in una miriade di interessiindividuali ingaggiando al tempo stesso una lotta senza quartierecontro le forme concrete in cui quei self-interest si vannosviluppando.
Ad un ceto di antichi proprietari laboriosi, istruiti in certomodo delle cose agrarie, leggitori assidui dei libri dell'anticaagricoltura, onesti e patriarcali, - scrive De Cesare a propositodegli effetti della legge sul Tavoliere del 1817 ma conriferimento ai processi generali di trasformazione, -sottentrarono i mercatanti, gli speculatori, gli uomini del dolcefar niente, avvezzi a traricchire coi negozi della Borsa e con leusure: gente avversa all'agricoltura, ignorante e superba, laquale si considerava come sacrificata dai debitori coll'esserdiventata possidente, coll'aver dovuto prendere suo malincuore incambio del denaro mutuato le più belle possessioni di Puglia!438.
Di qui il diffondersi di un rapporto strumentale coi campi,quel “non saper valutare la terra in se stessa”439, quell'incapacitàdi intendere l'agricoltura come mondo, come civiltà di rapportifra uomini, che finisce per far emergere nella sua crudezza, al dilà del velo trasparente del contratto miglioratario, il deficit dicontrollo sociale che l'emergenza della regione ottocentesca portacon sé. Condizione indispensabile perché abbia successol'esperimento, avviato con l'abolizione della feudalità e lacostruzione dello Stato amministrativo e poi liberale comecoronamento della politica di “riforma”, è che nella società,ormai sempre meno sotto tutela, torni in posizione di comando, informe che tengano conto dei tempi, il “filosofo di campagna”, ilproprietario che crea al contempo ricchezza e consenso, che mettein circolo merci e valori, che costruisce insieme al benessereindividuale i collanti ideali, tanto più indispensabili quando sivanno disfacendo i nessi e gli istituti che tenevano assieme lavecchia società organica. E quando si accorge che l'esempiofornito nelle sue aziende modello e la battaglia delle idee nonspostano gli equilibri in campo, anche De Cesare va, in un certosenso, a raggiungere l'"agriculturismo' antindividualistico:
dopo tante esperienze fatte, - egli scrive nel 1875 a Silvio Spaventa, -dopo tanti ammaestramenti che ci han dato le società industriali, ci vuole una438 DE CESARE, Delle condizioni cit., p. 103.439 Ibid.
242
bella faccia tosta a sostenere che le società fanno meglio del governo [...] .Se il Regno italiano negli entusiasmi del suo Risorgimento sperò moltonell'azione economica”dei privati, volgendo lo sguardo a ciò che si è fatto in15 anni bisogna pur confessare che il bene si è fatto dal solo governo. Ilrimanente L ... 1 non è che un mucchio di macerie, e fu l'opera dei privati,delle società, dell'interesse individuale440
Già a quest'epoca il terreno di coltura del salandrismo, conla sua capacità di raccogliere le fila di una tradizione, dirappresentare timori diffusi del nuovo e interessi colpiti dallatrasformazione, e al tempo stesso di interpretare e precorrere itempi, è pronto.
3. In bilico sul precipizio
Anche per questa sua collocazione ambigua, la riflessione'agriculturista', ben più che il vigoroso ottimismo 'barese',coglie alcuni elementi di fondo dei processi in atto. Nel climanuovo della “rivoluzione commerciale” Terra di Bari era uscitadall'impasse tardo-settecentesca tramite una deflagrazioneclamorosa di energie accumulatesi nel corso della vicenda secolaredella regione rurale e al tempo stesso compresse dalle suerigidità, ridefinendo i suoi quadri territoriali e aggiungendonuovi primati a quelli antichi. La aree decisive della nuovaPuglia ottocentesca - il Salento settentrionale, la costaolivicola barese, le zone ai due lati dell'Ofanto - sono fraquelle segnate dal maggior sviluppo della popolazione, dai piùalti quozienti demografici, dall'insediamento più accentrato edalla più alta mobilità interna dell'Italia intera; fra quelle amaggiore “apertura” e sviluppo mercantile, al servizio del qualeagiscono strutture di servizio - dai porti alle imbarcazioni allestrade e ferrovie - seconde nel Mezzogiorno solo a quelle delnapoletano; fra quelle in cui si verificano le trasformazioniagricole più travolgenti e i processi di polarizzazione piùintensi, che portano alla costruzione del più importante fenomenourbano del Mezzogiorno continentale dopo Napoli; fra quellecaratterizzate da una polarizzazione sociale più accentuata, dauna particolare debolezza degli strumenti, degli istituti, degliatteggiamenti, delle figure sociali preposte alla mediazione e alcontrollo sociale.
Ma nello stesso carattere 'eccessivo' della regione nascente,esaltato dai 'commercialisti' e guardato con grande preoccupazione440 Citato in F. DI BATTISTA, L'emergenza ottocentesca dell'economia politica aNapoli, Bari 1983, P. 128.
243
dagli 'agriculturisti', si annidano le ragioni di fondo della suaprecarietà: da un lato la sua sovraesposizione mercantile rispettoalla relativa debolezza di uno sviluppo produttivo concentrato insenso settoriale e spaziale; dall'altro la sua sovraesposizionesociale, che affida le funzioni dell'egemonia in sostanza almercato, come se questo fosse in grado di annegare il malcontentosociale nel moltiplicarsi delle prospettive individuali e dellerisorse collettive determinato da uno sviluppo travolgente quantoquello dei 'centri' della prima rivoluzione industriale.
Saranno i decenni fra Otto e Novecento - la crisi agraria, lamigrazione transoccanica, il vigore e i particolari caratteriideologici e organizzativi del socialismo pugliese - a dimostrare“la fragilità di tutto il nostro edificio economico, cosìsplendido, eretto in fretta e furia”441. Il regionalismoottocentesco, con il suo economicismo, la sua aggressività, i suoicaratteri nodali precoci, derivanti non tanto da una modernitàdirezionale di Bari quanto dalla scarsa espansività dello sviluppocentrato su di essa, si rivela in un certo senso una falsapartenza. La regione contemporanea riuscirà a darsi connotati menoprecari cominciando a praticare il terreno complicato del governodei processi in atto, assumendosi il problema di gestire inqualche modo il territorio e la società dopo averne sconvolto lecoerenze, cominciando ad affrontare nodi secolari come l'acqua ela malaria, e costruendo al contempo forme di organizzazione emediazione degli interessi, incontrando lo Stato in maniera benpiù intensa e organica rispetto alla contrattazione ottocentescadi misure di promozione dello sviluppo mercantile; trovandoinsomma, finalmente, un rapporto organico con la politica. In unaqualche maniera le invettive dei 'vinti' finiscono per coglierenel segno.
Su un punto - ma assolutamente centrale - la visione'agriculturista' si dimostra fuori centro: nonostante ilsalandrismo e i suoi tentativi di rilancio nei tempi nuovi delruolo proprietario, la crisi non restituisce il comando deiprocessi ai “filosofi di campagna”, né ricolloca la regione nellesue permanenze, nei suoi tempi circolari rassicuranti.
I tempi storici hanno assunto definitivamente un altro passo,sintonizzato ancora una volta con quello dei 'centri' del mondo,che i vituperati ceti urbani sono, ormai, i soli in grado ditenere.
441 G. TAMMEO, I contratti agrarie la crisi pugliese, Napoli 1890, p. 134.244