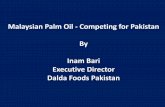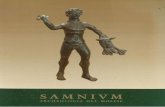Studio di alcune forme di degrado della facciata di Palazo Fizzarotti in Bari
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Studio di alcune forme di degrado della facciata di Palazo Fizzarotti in Bari
1
UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO”
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E
GEOAMBIENTALI CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN
SCIENZE E TECNOLOGIE PER I BENI CULTURALI
TESI DI LAUREA IN
APPLICAZIONI MINERALOGICHE E PETROGRAFICHE PER I BENI CULTURALI
STUDIO DI ALCUNE FORME DI DEGRADO DELLA FACCIATA DI PALAZZO FIZZAROTTI IN BARI
RELATORI: LAUREANDA: Ch.ma Prof.ssa Marra Annalisa Di Cosola Iolanda Ch.mo Prof. Eramo Giacomo Ch.mo Prof. Laviano Rocco
ANNO ACCADEMICO 2013/2014
2
INDICE INTRODUZIONE - Tesoro nascosto della città di Bari: Palazzo Fizzarotti pag.3
CAPITOLO 1 - Palazzo Fizzarotti: Storia tecnico-architettonica pag.5
1.1 – La nascita del Borgo Murattiano pag. 5
1.2 – La costruzione di Palazzo Fizzarotti pag. 6
1.3 – Il progettista: Ettore Bernich pag. 8
1.4 – La facciata e gli interni pag. 9
1.5 – Lo stile eclettico pag. 14
CAPITOLO 2 - Degrado delle facciate lapidee pag. 15
2.1 – Degrado ambientale pag. 15
2.2 – Alterazione meteorica ed antropogenica delle rocce
pag. 20
2.3 - Alterazioni su calcari e marmi pag. 21
CAPITOLO 3 – Indagine macroscopica e mappatura del degrado pag. 25
3.1 - Stato di Conservazione della facciata di Palazzo Fizzarotti pag. 25
3.2 – Mappatura del degrado pag. 31
CAPITOLO 4 – Indagine Diagnostiche pag. 33
4.1 – Campionamento pag. 33
4.2 – Microscopia ottica pag. 36
4.2.1 – Osservazioni petrografiche pag. 37
4.3 – Difrattometria a raggi X pag. 45
4.3.1 – Osservazioni difrattometriche pag. 46
4.4 – Microscopia elettronica a scansione (SEM) pag. 50
4.4.1 – Osservazioni con microscopio elettronico a scansione pag. 51
4.5 – Osservazioni conclusive pag. 61
CONCLUSIONI pag. 63
BIBLIOGRAFIA pag. 64
3
INTRODUZIONE – Tesoro nascosto della Città Di Bari: Palazzo Fizzarotti
Nell'estremità del centralissimo Corso Vittorio Emanuele II, ai limiti nord–ovest del Borgo
Murattiano, sorge un palazzo dalle eleganti forme gotico-veneziane: e' l'imponente Palazzo
Fizzarotti. La scelta stilistica nell’edificazione del palazzo si pone in continuità con l’influenza
ed i reciproci rapporti che la Serenissima ha avuto con le città costiere del Mediterraneo sin dal
Medioevo, e si colloca in quel momento particolare della storia architettonica a cavallo fra ‘800 e
‘900 nota come “revival gotico”.
Palazzo Fizzarotti è un esempio di “tesoro” nascosto nel cuore della città di Bari ed il suo fascino
veneziano e le sue facciate decorate così diverse dalle costruzioni a blocco della scacchiera
murattiana, hanno attirato la mia curiosità ed il mio interesse, spingendomi a documentarmi sulla
sua origine e sulla sua evoluzione storica.
Le forme esteriori del palazzo, la sua ricca decorazione scultorea portano a pensare, all’occhio
non allenato, che si tratti di una costruzione antica, vicina storicamente a palazzo Ducale o ai
palazzi che con le proprie porte d’acqua si affacciano sul Canal Grande: si tratta, invece, si una
costruzione di pieno inizio ‘900 commissionata da un mercante leccese come simbolo del suo
potere commerciale e della sua ricchezza. Da allora è sempre stato di proprietà privata passando
dalle mani di diversi proprietari.
La presente ricerca si concentra soprattutto sullo studio della facciata e sulla individuazione delle
principali forme di degrado che la interessano: quella che è l’elemento più rappresentativo della
costruzione è al tempo stesso il suo “tallone d’Achille” proprio in virtù della sua collocazione nel
centro cittadino, in una delle strade che da sempre è stata un’arteria principale per il traffico
veicolare, esponendola in tal modo, oltre che agli agenti atmosferici, anche all’inquinamento
urbano.
Su apposita autorizzazione della Soprintendenza dei Beni Architettonici e Storici della Puglia e
della attuale proprietaria del palazzo, la Dott.ssa Vera Poli, è stata fatta in primo luogo una
indagine macroscopica dei fenomeni, che ha trovato conferma attraverso le indagini diagnostiche
operate sui campioni rappresentativi dei principali fenomeni di degrado prelevati in facciata.
Tali analisi potranno essere propedeutiche alla stesura di un futuro intervento conservativo
rispettoso delle caratteristiche materiche che compongono la facciata.
La ricerca è stata condotta sotto la costante giuda del Prof. Rocco Laviano, prof. di Applicazioni
mineralogiche e petrografiche presso l’Università di Bari e della Prof.ssa Annalisa Marra,
docente di Storia e Tecnica del Restauro, e del Prof. Giacomo Eramo, docente di Archeometria
delle Ceramiche.
4
Le tecniche di analisi scelte in base agli ambiti di indagine da esplorare sono state le seguenti:
Diffrattometria a raggi X per il riconoscimento dei materiali che compongono il campione;
Microscopia ottica per osservare la stratificazione del materiale sul supporto lapideo;
Microscopia elettronica a scansione per un osservazione più accurata sia dei minerali
presenti che del loro modo di relazionarsi tra di loro.
5
CAPITOLO 1 - Palazzo Fizzarotti: storia tecnico-architettonica
1.1 – La nascita del Borgo Murattiano Il cuore moderno del capoluogo pugliese è il Borgo Murattiano che si estende, aldilà di Bari
Vecchia, tra la costa e la ferrovia, con la sua scacchiera ortogonale. Il quartiere prende nome da
Gioacchino Murat, maresciallo di Napoleone Bonaparte e marito della sorella minore Carolina.
Ma la sua vicenda urbanistica prende le mosse durante il dominio ferdinandeo 1.
Il documento ufficiale che segna l’avvio della vicenda della fondazione del "borgo nuovo", e il
conseguente progressivo processo di emarginazione del centro antico è l’istanza portata nel 1789
a re Ferdinando IV dai due sindaci, Michelangelo Signorile per il Popolo Primario e Carlo Tanzi
per i nobili: si parlava della creazione di un borgo in espansione all’impianto urbano originario.
Dopo la concessione dell’autorizzazione del Re dei Borboni, il 26 febbraio 1790, l’architetto
barese Giuseppe Gimma venne incaricato dell’esecuzione del Piano e la zona scelta per la
realizzazione del borgo fu quella a ridosso del nucleo storico, compresa tra gli allineamenti di
Porta del Castello e Porta della Marina. Le principali istanze di rinnovamento erano dettate da
esigenze di salubrità dei suoli e dell’aria. Il Piano venne approvato il 18 dicembre 1790, ma
trovò opposizione mista ad eccessiva prudenza da parte dei nobili proprietari dei suoli non
disposti a vendere fruttuosi terreni extra moenia per scopi edificatori. Solo qualche decennio più
tardi, con l’avvento rivoluzionario napoleonico e l’arrivo, al governo in sostituzione dei Borboni,
di Gioacchino Murat, nel 1812, l’architetto Gimma venne incaricato di studiare una nuova pinata
del borgo, approvata di seguito l’8 aprile 1813, giorno in cui lo stesso Gioacchino pose la prima
pietra all’angolo fra gli attuali corso Cavour e corso Vittorio Emanuele II.
Il borgo, oltre le mura della città storica, si sarebbe esteso tra due elementi prefissati: il convento
dei Padri della Missione e la cappella dei Sartori, ed annullate le necessità militari che ancora
giustificavano il limite delle mura, Bari poteva affacciarsi sul territorio. Nel 1819 veniva
definitivamente autorizzata la demolizione della cinta muraria e della porta Castello al fine di
poter realizzare una reale connessione con il nuovo borgo. Il Piano così ideato, presto divenne
uno schema di sviluppo, un meccanismo di crescita illimitata, che trova solo nei propri limiti
fisici le ragioni del proprio esaurimento.
La realizzazione del borgo prese avvio di fatto il 28 febbraio 1815, quando venne rilasciata la
prima concessione di suolo. Gli assegnatari delle prime due concessioni non erano di estrazione
nobile, e ciò ci consente di fare una considerazione di carattere generale. Fu proprio il nuovo
popolo, cioè i nuovi proprietari, che avvertì fortemente l’esigenza di espandersi oltre le vecchie 1 Guidoni E. “Bari moderna: 1790 – 1990: rivista internazionale di storia urbana e territoriale”, Elmond, Milano, 1990, pp. 13 – 32, 76 – 77.
6
mura, mentre le famiglie di antica nobiltà e del popolo primario rimasero ancora per parecchio
tempo abbarbicati ai loro palazzi nella città vecchia. L’edificazione ebbe uno sviluppo veloce: le
isole a pianta regolare, con l’aranceto centrale come stabilito negli “Statuti murattiani”, approvati
nel 1814, costruite erano già tre nel 1818, dieci nel 1826.
Fra il 1829 ed il 1830 si iniziarono gli edifici pubblici rappresentativi collocati sugli assi
principali della griglia ippodamea: la Camera del Commercio, la Biblioteca, ora perduta; nel
1840 veniva posta la prima pietra del teatro Piccinni su corso Vittorio Emanuele.
L’abbattimento della cinta muraria introduceva nello sviluppo di Bari il tema classico della città
ottocentesca. Il superamento del perimetro murario, con la sua possibile conservazione o
distruzione stabiliva il momento cardine del rapporto tra la struttura antica e quella nuova, in
quanto la soluzione di questo problema, in un modo o nell’altro, determinava la maniera in cui
queste due parti della città sarebbero entrate in comunicazione.
A Bari la distribuzione spaziale contrapposta delle due parti (città vecchia e nuovo borgo) e la
assenza di tracciati emergenti nel fitto tessuto del nucleo antico capaci di proiettarsi nella città di
nuova edificazione, determinò la naturale formazione di un asse viario strutturante,che
contenendo la città vecchia ed introducendo alla nuova, metteva a confronto le due parti alla
scala urbana definendone la differenza e l’autonomia. Su Corso Vittorio Emanuele divenne la
tipica della "strada – corridoio", centrata sulla coppia funzionale e rappresentativa: Palazzo
dell’Intendenza – teatro. Il Corso era destinato a diventare l’asse privilegiato di una
rappresentatività tutta interna al "corridoio", interamente misurata sul carattere privato e
borghese delle residenze. Tra la vecchia classe aristocratica, che restava ancorata ai valori della
città storica, e la borghesia emergente esisteva lo stesso divario e la stessa incomunicabilità che
caratterizzava la crescita della città nuova.
1.2- La costruzione di Palazzo Fizzarotti Edificato sul lato ovest del Corso Vittorio Emanuele II - "strada – corridoio", riveste un notevole
interesse storico ed artistico per i suoi particolari caratteri architettonici propri del Neo Gotico.
La concessione edilizia per la edificazione del palazzo fu rilasciata dal Comune di Bari nel 1850
al sig. Nicola Lagattola, che nel 1858 vendette il terreno al sig. Nicola Loiacono: quest’ultimo
costruì il pianterreno ed il primo piano.
Determinante per il futuro del palazzo fu l’acquisto nel 1904 da parte di Emmanuele Fizzarotti,
un ricco banchiere di origine leccese, vissuto a Bari, membro attivo della vita politica,
economica ed amministrativa, fondatore dell’omonima banca e consigliere della Camera di
Commercio.
7
Il 17 giugno 1905 egli presentò il progetto, redatto dall’ingegnere Ettore Bernich e dell’architetto
Augusto Corrandini, per la realizzazione del secondo piano e per la ricostruzione di tutta la
facciata e degli interni in stile gotico veneziano. L’anno successivo fu presentato un secondo
progetto del Bernich sulla realizzazione del quarto piano con il loggiato con colonne binate e più
ricche soluzioni decorative su tutto il prospetto 2.
Articolo tratto dal “U Corriire de BBàre” 1984
L’intero palazzo si configura come omaggio a Venezia, a cui Bari era molto legata da rapporti di
amicizia sin dal XI secolo. Ne è la prova a tal senso la raffigurazione dell’arrivo del Doge Orsolo
II e della sua flotta in soccorso della città di Bari, assediata dai Saraceni nel 1002. L’intero
apparato decorativo del fabbricato è l’emblema della personalità del committente Emanuele
Fizzarotti 3.
Particolarmente interessante risulta la singolarità dello stile del palazzo, sicuramente legata alla
sua committenza, capace di incidere sia sul disegno della città che nello scenario della
produzione teorico-pratica dell’architetto romano. Nei fondi dell’Archivio di Stato di Bari sono
custoditi interessanti grafici di progetto che attestano le fasi di costruzione del Palazzo Fizzarotti.
In base al provvedimento del 1903, per la concessione dei permessi edificatori nel borgo
murattiano, furono presentati dal proprietario Emanuele Fizzarotti all’Ufficio Tecnico Comunale
2 Berrino A., “Ettore Bernich 1850/1914. Storia, progetto, restauro”, Ed. Prospettive, 2006, pp. 162. 3 E. Fizzarotti, “Bari nel presente e nel suo avvenire”, Bari, stab. Avellino & C., 1913
8
di Bari il “tipo o disegno dell’erigenda fabbrica”, che in genere si limitava al prospetto, gli
elaborati grafici, redatti da Bernich per il “restauro” del palazzo sito in Corso Vittorio Emanuele
II al civico 193.
Cartolina che ritrae Palazzo Fizzarotti
1.3 – Il progettista Ettore Bernich nacque a Roma 1850 e si formò nell’ambiente classicista dell’Accademia di San
Luca, svolgendo il praticantato presso lo studio di Felice Cicognetti, architetto, incaricato dagli
archeologi Panthon e Parker di rilevare i più importanti monumenti romani. Questa fu
l’occasione per studiare dal vero e con spirito critico lo studio dell’arte antica, appassionandosi
contemporaneamente alla ricerca storica.
Dal 1874 ricevette molti incarichi professionali nel campo dell’edilizia residenziale urbana
sperimentando nuovi stili:
cinquecentesco rinascimentale (casa Stabbinelli in San Francesco Ripa)
dorico (casa Vannucci)
romano classico (Palazzo delle Colonne in Via Claudia)
italico (via Nomentana)
medievale (via Alessandria)
pompeiano (casa Salvatori)
Partecipò a vari concorsi di progettazione per la realizzazione degli edifici pubblici della
Capitale rappresentativi dello stato centrale tra cui il Vittoriano come cenotafio di Vittorio
Emanuele II, il Palazzo di Giustizia realizzato su progetto di Calderini, il Tempio israelitico.
9
Prese parte al gruppo degli “Architetti Attivi nell’Urbe” verso la fine dell’800 che erano alla
ricerca di un nuovo linguaggio architettonico di respiro internazionale che, con l’occhio attento
al passato desse forma alle istanze di rappresentatività della classe borghese.
Nel 1892 Bernich arrivò in provincia di Bari e si espresse come un architetto che eliminava le
sovrastrutture, per esempio la veste barocca conferita alle chiese romaniche, per riscoprirne la
facies originaria.
Egli voleva esaltare la produzione regionale e quindi rivalutare il medioevo pugliese, aprendo un
dibattito circa l’originalità dell’architettura locale. Nel 1894 Bernich fu invitato da un gruppo di
intellettuali, fondatori della Società degli Studi Storici Pugliesi ed impegnati da un decennio
nella pubblicazione della Rivista “Rassegna Pugliese di Scienze, Lettere ed Arti”.
Col tempo venne considerato “restauratore dello stile greco-romano” e divenne più incisivo nei
suoi interventi tanto da essere visto con un atteggiamento “falsificatore” ed un “manipolatore
dell’illustre architettura medievale”.
L’attività svolta dall’architetto Ettore Bernich, fino alla morte a Napoli nel 1914, nel restauro dei
monumenti medievali pugliesi costituisce un utile banco di prova per la maturazione di
quell’esperienza che lo condurrà alla realizzazione del Palazzo Fizzarotti a Bari, ovvero la sua
principale opera di “progettista”, in Puglia, nonché uno dei suoi lavori più rilevanti anche per
l’impegno profuso negli interni 4.
1.4 – La facciata e gli interni Il Palazzo si presenta come un imponente edificio dalla facciata eclettica: molti degli stilemi del
romanico pugliese vengono fusi con diverse tradizioni architettoniche 5.
veduta frontale
4 Guarnieri A. “Pietre di Puglia: Il restauro del patrimonio architettonico in terra di Bari tra Ottocento e Novecento”, Gangemi Editore, 2007, pp. 83 – 93. 5 Signorile N., Gismondi F.P., “Atlante’900”, Editrice Laterza, 2009.
10
Gli interni, accessibili mediante un suggestivo androne marmoreo, in asse con la facciata,
presentano diverse decorazioni che richiamano l’epoca federiciana, allegorie delle attività
economiche della Puglia e simboli esoterici.
La facciata è composta da tre livelli sovrapposti in stile veneziano sui quali si apre una loggia
colonnata, come detto omaggio alla liberazione della città di Bari occupata dai Saraceni
compiuta dalla Serenissima nel 1002 6.
La facciata é rivolta a mezzogiorno ed é strutturata in cinque arcate ogivali, affiancate,
all’estremità, da due torri, sormontate da cupolette finemente decorate, con mosaici a foglia
d’oro, raffiguranti il “sol levante”.
Al di sotto, entro nicchie sono collocate due statue nelle quali si possono individuare le
figurazioni della Giustizia e del Commercio, poste al di sopra di due medaglioni musivi
raffiguranti Federico di Svevia e suo figlio Manfredi.
Quattro medaglioni disposti fra le arcata ogivali e realizzate a mosaico policromo con fondo a
foglia d’oro, rappresentano:
la Fenicia;
l’eroe toponimo della città di Bari “Barinon” o Barion;
lo stemma della Città di Lecce, da cui la Famiglia Fizzarotti proveniva;
lo stemma personale di Emanuele Fizzarotti recante la scritta “quamquam fractae
vulnerant” (malgrado siano rotte feriscono ancora).
Stemma di Emanuele Fizzarotti
6 Melchiorre V.A. “Bari”, Mario Edda Editore, 2001.
11
I balconi, le finestre, trifore e bifore, sono in pietra abilmente scolpita come tutta la facciata.
Quest’ultima manifesta un armonioso contrasto tra la compatta ma semplice pietra e le linee
degli archi, a sesto acuto che, insieme ai pilastri in rilievo, con relativi basamenti e capitelli,
incorniciano tre livelli di finestre bifore rastremate, a salire, nella loro luce. Lo stesso dicasi per
la luce delle arcate ogivali snellite dalle due slanciate torri laterali.
Un effetto ottico di prospetto complessivo ”sfondato” sia orizzontalmente che verticalmente.
II quarto livello (piano terzo sopra il piano terra) é percorso, per tutta la sua lunghezza, da una
loggia con colonnine binate che sostengono una cornice di coronamento.
Foto dei primi del ‘900 del piano del loggiato
Dal portale, in massello di quercia intarsiato, si accede all’androne, con veduta sulla fontana del
Nettuno, sita nel retrostante cortile, da cui é diviso con artistica inferriata, in ferro battuto, in stile
liberty.
Fontana del Nettuno
L’armonia del pavimento, un’armonica spina di pesce in pietra, basaltica e calcarea, é completata
dalle monastiche panche e dalle colonne in porfido che anticipano la raffinatezza delle pareti e
12
del corpo scala, interamente affrescate, rivestite con pregevoli marmi lavorati, abbellite dalle
porte di accesso agli ambienti, anch’esse in noce a massello, finemente intarsiate in cui é
incastonata la testa del Mercurio.
La balaustra é interamente in marmo di raffinata fattura con colonnine in porfido. II leone a
“guardia” della scalinata, e anch’esso in rosso porfido. I corpi illuminanti sono in ferro battuto,
nell’androne e lungo la scalinata.
Il piano terra presenta ampie sale con volte a botte e pregevoli vetrate, infissi, porte interne e
boiseries.
Raffigurazione dell’arrivo del Doge Orsolo II in Bari nel 1002
II primo piano col salone trecentesco, salone rosa, salone del caminetto, salone delle arti e del
lavoro merita particolare attenzione per il carattere di alta rappresentatività che lo rende unico
nel suo genere per l’elevata raffinatezza degli stili decorativi, degli arredi parete ed in quanto
riveste e riflette il particolare periodo dell’eclettismo che ha lasciato pregevoli esempi in Italia,
purtroppo per la maggior parte andati distrutti ed in tutta la Mittel Europe; comprende quattro
saloni centrali, dei quali tre collegati tra loro, ed il quarto, raggiungibile attraverso il saloncino
d’attesa. Detti saloni, meglio descritti nelle varie sezioni, sono affiancati da altri sei saloncini,
decorati nei diversi stili, com’é tipico dell’eclettismo.
Il Secondo piano é stato recentemente rinnovato e presenta saloni e saloncini con soffitti
decorati. In particolare, il salone dell’appartamento a destra salendo, presenta un pregevole
pavimento in battuto veneziano con rosone e mosaico centrale.
Il Terzo piano, anch’esso lussuosamente restaurato, presenta porte e serramenti in massello,
pavimenti in marmo di Carrara con inserimenti a “tappeto” di antichi impiantiti di
condizionamento, impianti d’allarme, i collegamenti con fibre ottiche ed in rete, impianti
telefonici con centralino. É caratterizzato da un monumentale loggiato che percorre tutta la
facciata, ad archetti ogivali con pareti e soffitto dipinti e pavimento in marmi pregiati. Si affaccia
sul panorama cittadino ed il Corso Vittorio Emanuele II.
13
L’immenso apparato decorativo che abbellisce la struttura architettonica fu affidata ai fratelli
Nicolangelo e Giovanni Favia, eseguito con rilevanti capacità, data da una tradizione secolare di
abile lavorazione della pietra in forme dalle culture del Mediterraneo che fluivano a Bari da
attività politiche e commerciali. Invece, gli elementi pittorici furono realizzati da Francesco
Rega. Per le opere musive, oltre alle maestranze locali, non mancarono artigiani provenienti da
Venezia e Ravenna. Le influenze culturali sono responsabili della varietà di tecniche e la loro
realizzazione fu possibile grazie alle evidenti disponibilità economiche del committente.
Caduto in abbandono alla morte del proprietario nel 1926, il palazzo passò nel 1936 alla Banca
del Fucino 7.
Durante la seconda guerra mondiale, fu preso in considerazione come sede degli Alti Comandi
del Ministro della Guerra (1938), ma non fu ritenuto adatto per la sua pianta e la distribuzione
interna, anche se ottimale come posizione strategica 8.
Nel contesto dell’eclettismo storicistico della seconda metà dell’800, Bernich riuscirà ad
accostare alla sua passione per l’arte e l’architettura storica pugliese lo stimolante
approfondimento di temi bizantini e romanici richiesto dalla committenza, attingendo nel
contempo ai fondamenti del medievalismo di stampo veneziano. Bisogna del resto considerare
che, nella seconda metà del XIX secolo, proprio a Venezia si pubblicavano i più importanti studi
sull’architettura medievale e si traducevano i principali saggi sul gotico e sul romanico.
Diversamente dai precedenti lavori, in tale opera le influenze di matrice gotico – bizantina
vengono mutate con l’utilizzo, nell’ornamentazione e nella scultura locale, di motivi formali e
tettonici di matrice romanica e proto rinascimentale. In tal senso Bernich si spinge oltre una
semplice ripresa stilistica, traducendo nell’architettura e in ogni elemento della decorazione del
palazzo lo splendore dell’arte normanno-sveva con particolare riguardo anche a fattori
celebrativi, come nel caso dei mosaici in facciata con le effigi di Federico II e Manfredi.
Il palazzo è, quindi, il segno tangibile del bisogno di legittimazione di una classe borghese che
andava allora acquisendo una propria dignità riservata in precedenza alla sola aristocrazia.
Dovendo misurarsi con tale tematica l’architetto Bernich, profondo conoscitore e divulgatore dei
caratteri del romanico pugliese nei suoi progetti, in questo caso deve ricorrere a modelli
esplicitamente veneziani arricchiti con stilemi ricavati dalle architetture pugliesi del XIV secolo,
che sottolineerà sia nelle partiture lapidee che nelle opere scultoree che adornano l’edificio.
Si è notato che il desiderio del Bernich di modernità è mitigato fortemente dalla Commissione
Edilizia la quale definisce con toni forti il grado di libertà di espressione del progettista e
dell’intraprendenza delle classi emergenti.
7 Berrino A. “Ettore Bernich 1850/1914. Storia progetto restauro”, Ed. Prospettive, 2006, pp. 159 – 169. 8 Archivio di Stato di Bari (ASba), Archivio Storico del Comune di Bari, Busta 20, Fasc. 6.
14
1.5 – Lo stile Eclettico
Si basa sullo studio di fonti diverse accogliendo da ciascun di esse gli elementi ritenuti migliori.
Ha caratterizzato la seconda metà del XIX secolo. Con lo stile eclettico si identifica pertanto nel
periodo storico immediatamente successivo al neo-gotico e gothic-revival caratterizzato
dall’intento di ricorrere agli stili del passato scegliendo quello più consono alla destinazione
dell’edificio da progettare ed erigere; ricercando scrupolosamente nell’ architetture del passato
precisi suggerimenti, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto esterno, nell’illusoria fiducia che
rievocando gli stili passati potesse davvero scaturire un’architettura italiana autenticamente
innovativa e valida. Si sviluppo nei primi anni del secolo perché non aveva ancora un suo
linguaggio. Venne definita eclettica perché senza un indirizzo, ma che mira all’armonia “dei
principi” che ritiene i migliori di sistemi e indirizzi diversi.
Stili antichi fusi insieme ma con spirito moderno. Il filone neo-ecclettico di fantasia con
reintegrazioni in stile e ricostruzioni medievali (soprattutto di ispirazione toscana) si affermerà
dopo il 1910, nel recedere del Liberty, accentuando i caratteri individualistici nella ricerca di
forme irripetibili su larga scala e del pezzo unico eccezionale.
Il medioevo è visto come segno dell’estetica libera e l’amore degli artisti e degli architetti è
verso modelli del ‘300 ‘400, libertà che si vede nello stile medievale è nei volumi asimmetrico
ricchi di particolari e decorazioni policrome, fu motore di audacia interpretativa.
Lo storico Alfredo Meloni:
“ il nostro paese è tanto ricco di arte antica da scoraggiare i più arditi sognatori di forme nuove
[...]. Quando si hanno delle tradizioni così alte, è difficile abbandonare il vecchio per il nuovo”.
La disinvoltura e libertà degli architetti mira a concentrarsi sul mattone e le pietre caratteristiche
locali (come nel medioevo) oltre ai materiali decorativi propri del brillante artigianato locale. La
decorazione è importante: fatta di merlature, loggiati.
Dai bugnati a bozze in “granitone” della zoccolatura del piano terreno si passa al finto bugnato
dipinto o in cemento dei piani superiori. Varie applicazioni in ferro battuto completano gli edifici
(in contrasto con la rustica edilizia). Intorno all’architetto abbiamo importanti figure quali
artigiani ed operai di elevato livello qualitativo. È da molti considerata un’architettura di lusso o
comunque di grande impegno economico, perché rivolta ad una clientela ricca soprattutto
imprenditoriale (già presente nel Liberty). Questo ceto cresceva di potere e ricchezza
assomigliando all’aristocrazia, non mancò un ritorno allo stile ‘700 neo-barocco che fosse da
esibire come simbolo di pregio 9.
9 Carra F. “La conservazione delle facciate. Materiali e tecniche per il recupero”, Ed. Tecniche Nuove, 2004, pp. 88 - 92.
15
CAPITOLO 2 - Degrado delle facciate lapidee
“Principale obiettivo del progetto di conservazione è quello di favorire la trasmissione futura di
un manufatto preservando la permanenza dei suoi materiali originali e limitando le sostituzioni
ai soli casi inevitabili dove il degrado è irreversibile”. (Feiffer, 1997)
“Il progetto di recupero costituisce ormai un segmento importante dell’attuale progettazione
architettonica, nonostante la contraddizione delle due parole: “progetto” significa proiezione in
avanti nel futuro, nel futuro, attraverso uno strategia di azione che rende possibile ciò che
ancora non lo è; “recupero”, al contrario, rimanda a qualcosa che è, alla conservazione
del’oggetto arcitettonico, alla sua fisicità”. (Zorgno Trisciuglio, 2001)
Un’opera edilizia è composta da un’alta varietà di componenti, materiali e tecnologie costruttive
che obbligano a studiare la composizione materica prima di proporre qualsiasi metodo di rimedio
del degrado ed assicuransi che questi in un futuro non siano nuova causa di degrado.
“Si restaura solo la materia dell’opera d’arte”.
Da quest’assioma fondamentale della teoria del restauro di Brandi discende l’impostazione
metodologica del restauro 10. L’evoluzione che il materiale ha nel corso della sua storia dipende
dal rapporto di questi, preso in considerazione come un sistema che ha una sua struttura
materica, con l’ambiente in cui è immerso. Sono diversi i parametri che regolano la dinamica,
che solo in via teorica sono individuabili e misurabili. Tuttavia le varie trasformazioni che
l’interazione genera sul manufatto a livello micro e macro-strutturale, sono l’effetto del
contributo globale di ogni parametro, ma non necessariamente dalla loro combinazione lineare.
Qualsiasi tipo di intervento effettuato sul materiale e/o sull’ambiente, rappresenta pertanto un
evento non trascurabile e che può modificare l’equilibrio dinamico instauratosi tra manufatto ed
ambiente, e deve essere valutato come tale, anche in considerazione delle conseguenze che
comporta su detto equilibrio. Il manufatto non può essere isolato dall’ambiente, tanto meno
quando questi non può essere spostato fisicamente, come nel caso dei monumenti architettonici.
Manufatto ed ambiente costituiscono un “sistema termodinamico”, che rappresenta in maniera
ideale e generale la maggior parte dei fenomeni osservabili nel processo di degrado di un
qualsiasi manufatto. La struttura materiale evolve dallo stato A allo stato B.
A B
10 Brandi C. “Teoria del restauro”, Roma, Piccola Biblioteca Einaudi, 1977, pp. 39 – 47.
16
Questo schema termodinamico apparirebbe sia reversibile che non reversibile, dipende
esclusivamente dalla natura dei due stati A e B, non dal modo in cui si è svolto il processo.
È chiaro che lo stato B sarà diverso da quello A per qualche proprietà, inoltre il passaggio da A a
B è spontaneo, perché la natura possiede una preferenza per lo stato B, questa “preferenza” della
natura è descritta dall’ entropia, una grandezza fisica che cresce o rimane costante durante tutti i
processi che si svolgono nel sistema per lo stato in questione. I processi reversibili sono un caso
limite, puramente ideale, nel quale la natura manifesta uguale probabilità o preferenza per lo
stato iniziale e finale.
Ritornando al sistema termodinamico manufatto-ambiente, si può considerare lo stato originario
dell’opera come lo stato iniziale A, invece quello attuale lo stato finale B. Questa assegnazione
degli stati valida il concetto di irreversibilità del processo del restauro, per il semplice motivo
che non può essere invertito il segno del tempo. Ciò sembra chiarire il limite fisico di qualsiasi
intervento a voler riportare qualsiasi opera al suo stato originale. Da quanto detto si comprende
come qualsiasi materiale, inserito in un determinato ambiente, tende a mettersi in equilibrio con
esso; se i parametri ambientali cambiano nel tempo, essi provocano di conseguenza la perdita
dell’equilibrio raggiunto e la necessità, per l’oggetto , di “mutare” a fronte del cambiamento
ambientale.
Queste inevitabili trasformazioni sono il risultato di un cambiamento più o meno rapido ed
evidente delle caratteristiche originarie del materiale che , in conclusione, portano a quella che
abitualmente chiamiamo alterazione. La conoscenza dei meccanismi di alterazione e delle cause
che l’hanno determinata è fondamentale per una corretta programmazione di ogni intervento
conservativo e fornisce indicazioni utili sulle possibilità di impiego ottimale per ogni
determinato materiale lapideo. In particolare nel campo della conservazione della pietra si
procede seguendo particolari fasi di studio:
identificazione dei materiali e delle loro caratteristiche intrinseche
studio della morfologia, dei processi e delle cause di alterazione
scelta dell’intervento conservativo
2.1 – Degrado Ambientale
Si intende definire quel tipo di reazione che si instaura tra i materiali e gli elementi dell’ambiente
naturale, quali l’acqua, l’aria e gli organismi viventi, che nel tempo possono modificare la
struttura, la morfologia e la stessa composizione chimica. Qualsiasi pietra esposta all’aperto
subisce l’effetto del clima, della pioggia, della neve e degli inquinanti presenti nell’atmosfera che
17
ne causano una trasformazione, lenta ed inevitabile, modificandone la composizione geometrica,
fisica e mineralogica 11.
Il deterioramento è una fase importante del ciclo geochimico delle rocce che ha come effetto la
produzione di soluzioni e sedimenti, attraverso l’azione di agenti atmosferici (pioggia, vento,
neve ecc.)e biologici (batteri, alghe, organismi superiori).
Il deterioramento naturale delle rocce che compongono la facciata di un edificio rientra nello
stesso meccanismo di evoluzione lenta e continua. Va considerato come un adattamento dei
materiali rocciosi ai diversi ambienti in cui vengono a trovarsi dopo la loro genesi 12.
Per “degrado chimico” su supporti lapidei si intende una trasformazione più o meno radicale e
completa dei componenti mineralogici della roccia. Le trasformazioni chimiche principali a cui
sono soggette le rocce sono l’ossidazione, l’idrolisi e la solfatazione. Le modalità e i tipi di
alterazioni sono da mettere i relazione con la composizione chimica della roccia di partenza.
L’alterazione chimica produce quindi una profonda modificazione in materiali argillosi,
soluzioni saline e minerali insolubili, mentre il deterioramento fisico porta a un residuo di
materiale roccioso per lo più chimicamente inalterato. Un importante fenomeno di alterazione
chimica comune a tutte le rocce affioranti in qualsiasi luogo della Terra, è quello
dell’ossidazione che avviene all’interfaccia litosfera – atmosfera. Ricevono acqua per lo più dalle
precipitazioni piovose o nevose, e calore radiante dal sole. I risultati variano per intensità con il
clima, il tempo geologico, la topografia e l’attività biologica, e sono in funzione del tipo di roccia
di partenza.
Si parla di “degrado fisico” quando le rocce vengono ridotte in frammenti più o meno grandi
senza che questi abbiano subito cambiamenti chimici. Esso è prevalente nei climi molto freddi,
dove il degrado è legato a fenomeni di gelo-disgelo, espansione dovuta alla formazione di
cristalli di ghiaccio all’interno delle microfratture esercitano delle forze meccaniche sulle pareti
interne che comportano un aumento della porosità del materiale che diventa più soggetto ad
infiltrazioni di soluzioni acquose. O in quelli molto caldi e secchi, dove la frantumazione delle
rocce è dovuta a sbalzi termici da insolazione.
Fattori che influiscono direttamente sui fenomeni di deterioramento fisico sono la composizione
mineralogica della roccia, la grana e la sua tessitura. Il deterioramento fisico porta proprio ad
una diminuzione della grana con un aumento della superficie specifica disponibile per
l’eventuale alterazione chimica sempre possibile.
11 Amoroso G.G., Fassina V., “Stone decay and Conservation atmospheric pollution – clearing – consolidation and protection”, Elsevier, Amsterdam, 1983. 12 Carra F. “La conservazione delle facciate materiali e tecniche per il recupero”, Ed. Tecniche Nuove, pp. 102 – 116.
18
Il degrado ambientale non può prescindere dal prendere in considerazione i problema dei
biodeterioramento. Non esiste infatti materiale lapideo che ne sia sicuramente immune o
condizione ambientale che assicuri l’impossibilità di sviluppo di un qualunque agente biologico.
Naturalmente il biodeterioramento assume un’importanza diversa a seconda delle caratteristiche
della pietra e dell’ambiente. In condizioni di inquinamento dell’aria e in climi con periodi
piovosi e freddi, come quelli che caratterizzano la maggior parte dei paesi europei,
probabilmente il danno provocato dall’instaurarsi di meccanismi fisici come il gelo-disgelo e la
cristallizzazione dei sali è rilevante rispetto a quello di origine biologica, almeno nella
maggioranza delle situazioni.
Si definisce il biodeterioramento :
“Qualunque tipo di alterazione irreversibile, conseguente all’attività metabolica di una o più
popolazioni viventi, qualunque sia l’ordine di grandezza degli individui da cui esse sono
composte”.
Vanno comprese in questa categoria non solo i danni provocati da organismi microscopici, ma
anche quelli dovuti ad insetti e mammiferi(come pipistrelli), alla crescita di piante superiori, agli
uccelli.
L’ACQUA è il principale fattore ambientale responsabile del degrado perché innesca reazioni
chimiche sia da sola che attraverso il suo trasporto di soluti. L’acqua è veicolo di ossigeno che
può innescare reazioni chimiche di ossidazione, che essere un agente fisico di degrado attraverso
cicli di gelo e disgelo 13.
Il contatto con la superficie può avvenire per via esterna attraverso la pioggia, la condensazione
di vapore acqueo e neve, o per risalita capillare dalle fondamenta o falde acquifere, o per risalita
“orizzontale” dalla perdita di acqua durante la fase di cementazione delle malte o da sottostanti
tubature mal funzionanti. L’acqua piovana è carica di CO2 che reagendo con le molecole d’acqua
forma acido carbonico che diventa un fattore responsabile della solubilizzazione del carbonato di
calcio, principale componente delle superfici lapidee, e anche una modificazione fica della
struttura più interna conducendo all’indebolimento della tessitura della roccia, favorendo la
perdita di grani di calcare.
Il contatto con l’acqua può avvenire sulle superfici riparate dal dilavamento meteorico attraverso
la condensazione di un film di acqua. Il fenomeno di condensazione avviene quando si raggiunge
la temperatura di rugiada, al di sotto della quale il vapore acqueo passo dallo stato di vapore al
stato liquido, diventando substrato di adesione di particelle idrofile e sali.
La temperatura di rugiada varia in base all’igroscopicità permeabilità del materiale e varia in
base alla stagionalità. Macchie, erosioni, efflorescenze e muffe sono il risultato del rapporto tra 13 Amoroso G.G., “Trattato di Scienza della Conservazione dei monumenti”, Alinea Editrice, 2002, 45 – 60.
19
l’acqua assorbita e quella rilasciata attraverso l’evaporazione delle pareti della muratura, sono un
degrado dovuto ad umidità visibile. Invece il processo ciclico di condensa ed evaporazione nei
pori è invisibile ma causa importanti tensioni nel materiale.
Il migliore rivestimento deve essere impermeabile all’acqua, ma deve permettere la traspirazione
del vapore. Solfati e ossalati di calcio sono responsabili della formazione di Gesso, trattiene
acqua che rimanendo in superficie viene assorbita dal substrato e diventa base per la formazione
i croste nere.
Materiali lapidei naturali: si definiscono materiali lapidei naturali quei materiali che non sono
sottoposti al trattamento tecnologico che ne modifica i parametri fisici e meccanici. Rimangono
identici a come vengono estratti. In ogni caso rimangono differenti all’aggressività ambientale.
La loro resistenza al degrado ambientale è solamente dovuta alla loro composizione materica che
ne caratterizza il comportamento: il più durevole è il materiale siliceo, il meno resistente è il
materiale argilloso e i meno deteriorabili è quello di origine calcarea.
Il carbonato di calcio è un componente essenziale di molte rocce, come i marmi, ed è presente
soprattutto in arenarie e rocce calcaree. I silicati sono i più presenti nei graniti, sieniti, borati,
porfidi ed alcune rocce sedimentarie (arenarie). Le arenarie sono formate da clasti di quarzo,
mica, ossido di ferro, presentano elevata porosità ed un’ elevata sensibilità all’acqua ai sali e
all’inquinamento. Le rocce magmatiche intrusive (graniti, dioriti) e le rocce magmatiche effusive
(porfidi e basalti) di struttura cristallina sono resistenti agli acidi e no vengono attaccati dagli
agenti atmosferici ed inquinanti, resistono all’abrasione e al gelo e questa loro caratteristica
diventa un parametro tecnico per il loro utilizzo per rivestimenti esterni.
Pomice è usata per la preparazione di calcestruzzi leggeri;il tufo invece per costruzioni compatte.
Essere una roccia carbonatica non vuol dire essere sempre sensibile all’azione atmosferica,
perché ognuna si comporta in maniera diversa. Molto usato nei rivestimenti esterni è il
travertino, che si presenta molto poroso e facilmente attaccabile chimicamente, invece la pietra
d’Istria è una roccia dura che è stata adoperata a Venezia, un ambiente ricco di Sali.
Materiale lapidei artificiali: nacquero verso la fine dell’800, sono rocce modificate che sono il
frutto dell’eclettismo e dello stile Liberty, abbandonando la pietra per un più ampio uso del
cemento. Si usava mescolare materiali diversi per l’impasto del cemento in base alla sua
funzione. Un esempio è il cemento decorativo che può essere colorato con latte di calce e
coloranti organici, la loro combinazione era propria di ogni bottega, causando una varietà di
fenomeni di interazione che diventano la causa di ampi fenomeni di degrado.
20
I cementi decorativi rappresentano elementi decorativi delle facciate, che arrivano come pezzi
prefabbricati che sono spesso scomposti e da montare in loco. Sono ancorati con grandi ganci
metallici, zanche, graffe ed arpioni o per incontro e legato con malte. Creando così un
differenziale sia dal punto di vista del contenuto di umidità e per dilatazioni termiche. Spesso per
mettere in evidenza la “vera” faccia della facciata si tende ad eliminare il cemento decorativo,
ma il più delle volte questa operazione diventa pericolosa perché espone il materiale non pronto
ad un confronto can l’ambiente esterno 14.
2.2 – Alterazione meteorica ed antropogenica delle rocce
La cosiddetta alterazione delle rocce non è altro che una trasformazione della materia minerale
dovuta al disequilibrio esistente tra ambiente in cui le rocce si sono formate e dove vengono
posizionate. Le reazioni chimico – fisiche tra la litosfera e l’atmosfera , l’idrosfera, la biosfera
costituisce l’evoluzione o “l’alterazione” meteorica delle rocce. Quindi sia all’esterno che
all’interno, ogni roccia si comporta in maniera diversa rispetto all’ambiente in cui si trova.
L’alterazione è comunque un processo spontaneo quindi irreversibile.
Con l’avvento dell’era industriale, alle cause naturali di degrado dei monumenti si sono aggiunti
gli effetti dell’inquinamento atmosferico. Già nel 1861 venne creata a Londra la prima
commissione incaricata dello studio del degrado delle Houses of Parliament e fu talmente
immediata la presa di coscienza del problema che uomini illustri della scienza Humprey Davy e
Michael Faraday se ne occuparono. Con la legge Clean Air Act del 1956 si studiarono i livelli
di inquinamento da fumo e il loro effetto sui materiali 15.
Non solo l’accumulo di polveri carboniose venne sottolineato come nocivo, ma anche la “piogge
acide”. Queste furono il risultano di uno studio effettuato nel 1872 da Robert Angus Smith
raccolto nel testo Air and Rain: the beginning of Chemical Climatology, tra l’altro fu lo
stesso Smith ha coniare il termine piogge acide. Benché la relazione tra alterazione ed
inquinamento non è ancora provata al 100%, sono stati evidenziati negli ultimi 70-80 anni un
aumento esponenziale dell’alterazione del materiale lapideo 16.
Bisogna chiarire che la pietra non è immutevole, cambia naturalmente per contatto con
l’ambiente ciò che si può fare è rallentare il processo di alterazione attraverso uno studio attento
della pietra delle sue caratteristiche fisiche, chimiche e mineralogiche.
14 Carra F., “La conservazione delle facciate materiali e tecniche per il recupero”, Ed. Tecniche Nuove, 2004, pp. 102 – 116. 15 Clean Air Act, 1956, 4&5 Eliz.2, Ch.52 16 Odén S. “The Acidification of Air and its consequences in the natural environment”, Ecology Committee Bullettin, n°1, Stockholm, 1968
21
Sintomatologie delle alterazioni lapidee
de coesioni, fessurazioni e frantumazioni dovuto ad effetti meccanici, a cicli di gelo e
disgelo, all’alternanza di umidità ed essiccamento, a pressioni di cristallizzazione e di
idratazione.
Stress da carico e dilatazione termica.
Esfoliazioni, scagliature, rigonfiamenti causati da reazioni con inquinanti atmosferici,
legati a fenomeni di condensazione e gelo, derivanti la risaliti di Sali solubili.
Disgregazione, polverizzazione per azione chimica, biologica e termica.
Incrostazioni, concrezioni, efflorescenze, placche, patine, pellicole, depositi di materiale
differente che reagisce cristallizza o per metabolismo biologico.
Alterazioni cromatiche e spotting derivanti da dilavamento, impurezze della roccia,
ruggine da ferri (ganci), alterazione di materiale protettivo o di consolidamento, azione
batterica.
Corrosione, erosione, alveolizzazione, pitting legati ad attacchi chimici, degrado
biologico, usura meccanica del vento
L’usura meccanica del vento svolge una funzione diversa a seconda della velocità, del tipo e
dimensione delle particelle e dell’umidità del’aria.[10]
< 100 µm le particelle sono incrostanti ed abrasivi
100/600 µm provocano solo corrosione (azione per lo più alla base ed ad altezze limitate)
600 µm non hanno una forza abrasiva importante
2.3 - Alterazioni su calcari e marmi
Sia la calcite che la dolomite sono solubili in acqua in presenza di una elevata percentuale di
acido carbonioso, quindi abbiamo un effetto di alterazione differenziata, cioè avviene il
fenomeno di degrado che non coinvolge tutta la roccia, ma solo determinati minerali sensibili a
quella determinata condizione ambientale. I cicli di umidificazione ed essiccamento modificano
la forma, il volume e le dimensioni del minerale, provocando un aumento delle pressioni interne
alla pietra dovuto alle forze apposte che si scontrano tra i cristalli con effetto di sfarinamento o
perdita di granuli o, nel caso di biocalcareniti, degli elementi fossiliferi presenti, modificando in
ogni caso la struttura della roccia nella suo complesso 17.
I depositi di sporco distribuiti in strati più o meno spessi sulle superfici degli immobili sono
composti da agglomerati solidi e da particelle semi solido. La natura di queste “croste” dipende
17 Frattini F., Manganelli Del Fà C., Pecchioni E., “Le pietre nel patrimonio monumentale italiano: processi e cause d’alterazione”, L’Edilizia e l’Iindustrializzazione, Nr 9, Dicembre 1987, pp. 474 – 483.
22
molto dall’ambiente in cui il manufatto si trova ossia se esso è di tipo industriale, urbano, rurale
o marino.
In base a ciò posso classificare le particelle in funzione della loro origine:
Industriale: ceneri, residui di combustibile, catrame, leganti minerali, fly ash.
Minerale: terra, fango, argilla, sabbia.
Marino: aerosol marino
Vegetale: residui vegetali, polline, fibre, alghe, licheni.
Animale: residui organici, insetti, batteri.
Gli ambienti che più danneggiano sono le zone urbane ed aree inquinate. Perdita di materiale
litoide dalle superfici dei monumenti in marmo e in calcare sono stati registrati in varie parti del
mondo, questo accerta che il fenomeno delle “croste” non è solamente europeo come
affermavano i primi studiosi del fenomeno.
Il calcale di Solnhofen ha mostrato una perdita di 0.54g per una superficie esposta di 2.5m2
durante un periodo di 3 anni 18 . Il monumento in pietra calcarea di Abraham Lincoln a
Washington sembra perdere 8mm in 60 anni 19.
Le osservazioni hanno rafforzato l’idea che nelle zone industriali la perdita di forti
concentrazioni di inquinanti atmosferici è la principale causa dei progressi di degrado accelerato,
rincontrabili negli ultimi decenni 20.
Taj Mahal è vicino ad una raffineria di Mathura , ad una distanza di 30km dal 1973, la quale ha
causato l’opacizzazione delle bianche superfici a causa del particolato atmosferico in SO4-2 e
NOx- e Cl- e metalli pesanti quali Pb, Mn, Zn che catalizzano la conversione di SO2 in SO3 21.
Venezia presenta un elevata aggressività marina, la quale si è innalzata contando anche l’attività
antropica legata all’attività dei solfati 22.
Le incrostazioni causano importanti modificazioni chimiche e fisiche sul supporto. Quelle di
natura bituminosa sono idrorepellenti e la loro presenza può essere dovuto al degrado di
interventi protettivi del passato. Desquamazioni ed alveolizzazioni sono le forme di degrado più
comuni sulle statue calcaree del Louvre 23. Ciò che si evidenzia è un’erosione della matrice
cristallina ed un aumento della porosità, associati al dilavamento ed a successive 18 North F.J., “Limestone their origin, distribution and uses”, London, 1930 19 Sorlini C. “Effetti ambientali delle Piogge Acide, Carbone e Ambiente”, Quaderni Le Scienze, 11, Dic. 1983, pp. 79, 87. 20 Lorusso S., Troili M., Biondi F., Marabelli M., Santamaria U. “Caratterizzazione delle qualità dell’aria in siti storici con differente tasso di metanizzazione”, 1st International Congress on Science and Tecnology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Bacin, Catania, 1995, pp. 1151 - 1156 21 Sharma R.K., Gupta H.O., “Dust pollution at the Taj Mahal. A Case study. Conservation of Stone and other materials”, UNESCO – Rilem, Paris, 1993, pp. 11 – 18. 22 Fassina V., Lazzarini L., Biscontin G. “Effect of atmospheric pollutants on the composition of block clusts deposited on venezian marbles and stones”, Athens, Sept. 27 – Oct. 1, 1976, pp. 201 – 211. 23 Martinet G., Guedon J.S., Leroux A. “L’altération d’un calcaire lutetién dans un milieu urbain”, Conservation of stone and other materials, UNESCO – RILEM, Paris, 1993, pp. 336 – 343.
23
ricristallizzazioni. La presenza di solfati e cloruri è accompagnata da depositi metallici di natura
diversa (Zn, Fe, Ti).
AREE NERASTRE
Una maggiore attenzione negli ultimi anni è stata riservata alle pellicole i ossalati composte a
whedellite e weddellite. Le patine giallo-brune sono ossalati sulle pietre dell’Arco di Augusto a
Susa (Torino) 24 con whedellite e wedellite e gesso aghiforme ed inclusioni di granuli minerali
arrivati con apporto eolico quali calcite, quarzo, granato, k-fedspato, cloriti, miche bianche
potassiche.
Dai dati analizzati in varie zone europee possiamo dire che sulle pietre calcaree le croste nere
hanno uno spessore variante da 0.5 a 3 mm ed hanno una tendenza a formarsi in aree esposte ad
inquinamento atmosferico, ma protette da un intenso dilavamento da parte delle acque piovane.
Il legante delle incrostazioni è “gesso” principalmente in forma di cristalli aghiformi con crescita
perpendicolare alla superficie di alterazione 25.
Nella matrice gessosa sono inglobate particelle di varia natura quali: particolato atmosferico,
polline, ossalati, sostanze bituminose e carboniose di forma sferica e molto porose responsabili
della colorazione grigio-nerastra, frammenti di calcite di origine primaria o derivante dalla
diminuzione di CaCO3 e successiva ri-precipitazione. Sono presenti anche cristalli di quarzo e
meno abbondanti fedspati, entrambi portati per via eolica, più ossidi metallici FeO3 e TiO2 (sulla
facciata in travertino della chiesa di S. Susanna a Roma).
L’accumulo di inquinanti e i prodotti di trasformazione della stessa pietra danno luogo col tempo
ad incrostazioni (soprattutto sui parametri calcarei) che in alcuni casi si rigonfiano o producono
esfoliazioni e scagliature.
Il meccanismo di questo degrado è dovuta alla trasformazione della calcite in gesso ed alla
formazione di nuovi cristalli che con la loro crescita creano forti tensioni provocando un iniziale
decoesionamento della pietra sotto la crosta nera fino al distacco di essa.
CaSO4•H2O (GESSO) tra un volume doppio del carbonato ed un coefficiente di espansione
termico cinque volte superiore. Questo vuol dire che un aumento della temperatura si hanno
contrazioni e dilatazioni differenziate dei due minerali che causano una “laminatura” della
superficie lapidea ed un distacco della pietra sottostante.
24 Chiari G., Fiora L., Compagnoni R. “Studio dell’alterazione della pietra dell’Arco di Augusto a Susa (Piamonte, Italia), Le piete dell’architettura, struttura e superfici”, Bressanone, 1991, pp. 344 – 353. 25 Camuffo D., Del Monte M., Sabbioni C. “Influenza delle precipitazioni e della condensazione sul degado superficiale dei monumenti in marmo e calcare”, Bolletino d’Arte, Supplemento al Nr. 41, Materiali Lapidei, 1987, pp. 15 – 36.
24
AREE BIANCASTRE
Molto spesso le superfici dei monumenti calcarei oltre a mostrare delle zone ricoperte da spese
incrostazione nere, possono presentare delle aree biancastre che sono quelle esposte direttamente
al dilavamento delle piogge in cui i depositi di sporco sono continuamente asportati.
Il dilavamento evita la formazione di incrostazioni “per accumulo”, quindi sembrano queste aree
non aver subito modificazioni, ma possono essere ricoperte da uno strato di calcite di
ricristallizzazione che altera le proprietà fisico-meccaniche originali della superficie lapidea.
Infatti le rocce calcaree presentano un’importante solubilità all’acqua piovana perché contiene
elevate concentrazioni di anidrite carbonica.
Si ha così la formazione di bicarbonato di calcio in soluzione che si allontana con le piogge
Ca(HCO3)2. È un sale instabile perché tende a precipitare come carbonato di calcio per
evaporazione dell’acqua.
Mentre nella roccia originale il carbonato di calcio è presente in forma cristallina con una piccola
area superficiale, quando ricristallizza esso si trova sotto forma di una polvere fine a più elevata
area di superficie e quindi più suscettibile agli attacchi acidi. L’acqua può erodere la superficie e
far risaltare le vene di calcite ed evidenziare il letto della pietra.
L’erosione è data dal suo raccogliere particelle che con il loro scorrere sulla superficie causano
abrasione. Quando la velocità diminuisce, lascia un deposito superficiale che successivamente
ricristallizza come calcite antigenica. La superficie risulterà ondulata e con cariature . anche se la
superficie è sottoposta a dilavamento si forma uno sottile strato di calcite di neoformazione.
AREE GRIGIE
È uno strato che si definisce intermedio tra quelle bianche dilavate e quelle nere incrostate. È un
deposito sporco simile alla crosta. La morfologia della pietra originale non sembra alterata, e di
durezza e spessore minore. Sono l’inizio del degrado: si deposita l’inquinante, ma non ancora ha
reagito 26.
26 Amoroso G.G., “Trattato di Scienza della Conservazione dei Monumenti”, Alinea Editrice, 2002, pp. 42 – 60.
25
CAPITOLO 3 – Indagine macroscopica e mappatura del degrado
Operazione prioritaria, per un corretto approccio alla conservazione di un manufatto, è
l’individuazione delle cause che hanno determinato la patologia di degrado. Spesso il degrado è
legato alla scarsa manutenzione del Bene e a fattori quali il cattivo funzionamento dell’impianto
di raccolta delle acque meteoriche, la presenza di piccioni, che devono essere eliminati in via
preventiva, agli agenti atmosferici. Un controllo regolare e sistematico degli elementi di
protezione - tetti, cornicioni, aggetti - e interventi manutentivi possono preservare gli apparati
decorativi, la vita degli intonaci e delle superfici lapidee. Al fine di comprendere quale fosse lo
stato di conservazione della facciata di palazzo Fizzarotti, è stata eseguita un’indagine
macroscopica visiva, come osservazione preliminare, per individuare le principali forma di
degrado. Infatti il corretto e approfondito esame visivo delle opere e delle caratteristiche
morfologiche delle loro superfici, è di fondamentale importanza nella diagnosi del degrado,
perché costituisce la base per la corretta programmazione delle indagini: ovviamente l’esame
visivo consente un’analisi superficiale e non può che rilevare difetti macroscopici superficiali.
3.1 - Stato di Conservazione della facciata del palazzo Fizzarotti In seguito all’indagine macroscopica si è osservato che la facciata versa in un cattivo stato di
conservazione, dovuto alla mancanza di interventi sistematici e programmati, infatti è interessata
in maniera diffusa da depositi superficiali incoerenti di spessore variabile costituiti
prevalentemente da polveri, particellato, depositi carboniosi, e guano di piccione.
I paramenti lapidei appaiono uniformemente ricoperti da questo strato di deposito incoerente con
addensamenti in corrispondenza del piano di calpestio e dei sottosquadri, questo strato compatto
e giallastro altera l’aspetto estetico originale e la godibilità del manufatto e deriva da un’elevata
stratificazione di particellato atmosferico e polveri carboniose concentratisi a causa della
localizzazione dell’immobile, inserito all’interno di una strada estremamente trafficata.
Al di sotto dello sporco si intravede una patina giallastra che potrebbe essere dovuta alla
presenza di ossalati e solfati, oppure alla colorazione dell’intonaco, solo le indagini ne
chiariranno la sua composizione.
Le forme di degrado individuate principalmente sono state le croste nere che hanno causato un
profondo cambiamento dell’aspetto complessivo della facciata, queste interessano soprattutto le
zone in cui non è presente l’azione di dilavamento, le superfici scolpite, come i capitelli delle
colonnine che scandiscono la facciata, gli aggetti, i sottosquadri dei cornicioni e delle cornici
delle finestre.
26
Oltre alle croste nere, sono molto visibili fenomeni di incrostazione di materiale adeso
all’intonaco originario rendendolo particolarmente scabro e quindi facilitando l’accumulo di
nuovo materiale sulla sua superficie.
Alle zone giallastre, interessate da depositi coerenti e incoerenti, si alternano zone più chiare
dovute al dilavamento delle acque meteoriche: quantità di acqua di una precipitazione
atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici. Il fenomeno risulta molto
evidente soprattutto in corrispondenza dei lati dei balconi, e si presenta sotto forma strisce
biancastre.
In alcuni punti sono state individuate aree di distacco di materiale, perlopiù intonaco, è
ipotizzabile che tale fenomeno sia causato dall’assorbimento di acqua, causa di rigonfiamento
differenziale rispetto al materiale lapideo sottostante, che produce il distacco.
Sono state individuate numerose fessurazioni verticali in corrispondenza delle colonnine,
probabilmente dovute alla costruzione del piano superiore con loggiato e al conseguente
aumento di carico sulla struttura sottostante.
In un solo punto è stata verificata la presenza dell’alveolizzazione all’altezza della zoccolatura di
pietra, in prossimità della torre di destra, il fenomeno potrebbe essere dovuto all’azione abrasiva
delle polveri provenienti dalla discrezione del materiale lapideo della facciata, e dagli edifici
circostanti.
Dunque l’osservazione macroscopica della facciata di Palazzo Fizzarotti ha permesso di
ipotizzare l’origine dei fattori che hanno modificato l’aspetto estetico del monumento e il suo
stato di conservazione.
Le principali forme di alterazione e degradazione osservate macroscopicamente sulla facciata
sono state descritte utilizzando il lessico NorMal 1/88:
Deposito superficiale: accumulo di materiali estranei di varia natura, quali ad esempio,
polvere, terriccio, guano, ecc. a spessore variabile e, generalmente, scarsa coerenza e
aderenza al materiale sottostante.
Il materiale che compone il deposito superficiale aderisce al substrato lapideo attraverso un
sottile strato di film d’acqua, oppure a causa di un velo di condensa che causa un’attrazione
elettromagnetica del particolato atmosferico, il quale rimane intrappolato nella struttura
dell’acqua. Il deposito superficiale individuato sulla facciata lo ipotizziamo principalmente
composto da polveri carboniose che ne hanno caratterizzato la cromia nerastra.
27
Croste nere: strato superficiale di alterazione del materiale lapideo o dei prodotti
utilizzati per eventuali trattamenti. Di spessore variabile, è dura, fragile, distinguibile
dalle parti sottostanti per le caratteristiche morfologiche e, spesso, per il colore.
Può distaccarsi anche spontaneamente dal substrato che, in genere, si presenta degradato
e/o polverulento.
Le croste nere rappresentano un peggioramento dello stato di conservazione del materiale
lapideo e tendono ad avere uno spessore omogeneo che replica la morfologia del substrato. Sulla
facciata si presentano molto adese soprattutto sugli elementi scolpiti protetti dal dilavamento,
sulle colonnine protette dei parapetti dei balconi del piano nobile, sotto i balconi e tra le
colonnine del portale. Le croste nere sono il prodotto della dissoluzione del carbonato di calcio
che compone il substrato lapideo, a causa della sua interazione con acque meteorologiche ricche
in anidride carbonica ed anidride solforosa. Queste reazioni chimiche terminano con la
precipitazione di calcite e gesso; quest’ultimo, in particolare, trattenendo molta acqua all’interno
della sua struttura cristallina, ha un comportamento elettrostatico nei confronti del particolato
atmosferico che ne rimane inglobato e trattenuto.
Fig.1 particolare colonnina tortile interessata da deposito superficiale incoerente
28
Fig.2 particolare croste nere sul capitello della colonnina del portale
Dilavamento delle acque meteoriche (voce assente nelle NorMal): presenza di zone
biancastre, dovute all’azione dilavante e alla dissoluzione del materiale lapideo ad opera
delle acque meteoriche.
Il fenomeno del dilavamento si presenta in prossimità dei balconi e degli elementi aggettanti,
come cornici e capitelli. È causato dalle acque meteoriche che provocano una parziale
dissoluzione del materiale superficiale e loro trascinamento lungo la facciata. La cromia
biancastra lo ipotizziamo sia dovuta alla assenza di polveri carboniose che vengono allontanate
durante l’azione di dilavamento.
Fig.3 particolare del fenomeno di dilavamento meteorico in prossimità dei balconi
29
Alveolizzazione: “Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forma e
dimensione variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi ed hanno distribuzione non
uniforme . Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in
profondità con andamento a diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a
cariatura”
La facciata di Palazzo Fizzarotti, come specificato, presenta un solo punto in cui è possibile
individuare una forma di alveolizzazione , in corrispondenza della torre destra al livello stradale,
in cui la superficie non è protetta dal comune strato di intonachino che caratterizza l’intera
facciata. La roccia è “alveolata” presenta cavità di diverse forme e dimensioni interconnesse
dell’ordine del centimetro.
Fig.4 particolare del processo di alveolizzazione sul materiale lapideo in prossimità della torre di destra
Distacco: “sollevamento del rivestimento dal supporto murario o di uno strato rispetto a
quello sottostante”
Nel nostro caso questa forma di alterazione è limitata al distacco di intonaco, il quale non
presenta una visibile formazione di efflorescenze o sub efflorescenze, ciò ci porta ad ipotizzare
che il fenomeno sia causato dal comportamento differenziale dello strato di intonaco rispetto alla
pietra sottostante.
30
Fig.5 particolare del distacco di intonaco e messa in luce del materiale sottostante
Patina: “Alterazione strettamente limitata a quelle modificazioni naturali della superficie
dei materiali non collegabili a manifesti fenomeni di degradazione e percepibili come una
variazione del colore originario del materiale. Nel caso di alterazioni indotte
artificialmente si usa, di preferenza, il termine, patina artificiale.
La colorazione giallastra che interessa l’intera superficie del paramento murario e che si
intravede al di sotto dello strato di sporco potrebbe essere causata dalla reazione chimica tra i
componenti del materiale lapideo e il particolato atmosferico o essere il colore originale
dell’intonaco.
Fig. 6 particolare della patina giallastra
31
Fessurazioni: degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità
nel materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.
Sono localizzate alle basi delle colonne che definiscono gli arconi del secondo piano
probabilmente dovute all’aumento del carico del peso in seguito all’innalzamento del
secondo piano e del loggiato.
Fig.7 particolare del fenomeno di fessurazione alla base di una delle semi-colonne del secondo piano
3.2 – Mappatura del degrado All’esame macroscopico è seguita la compilazione di mappature in cui i vari retini e le campiture
rappresentano il tipo di degrado presenti sulla facciata, queste hanno permesso la determinazione
spaziale, qualitativa e quantitativa dei fenomeni degenerativi della superficie del manufatto. Tali
indagini possono diventare un importante strumento per la pianificazione e per la messa a punto
degli interventi di conservazione.
È stata eseguita l’individuazione delle differenti tipologie di degrado dell’opera secondo quanto
riportato nelle tavole seguenti distinguendo i degradi con perdita di materiale, di morfologia e di
resistenza meccanica, dai degradi con formazione di prodotti secondari.
32
Mappatura del degrado della facciata di Palazzo Fizzarotti. (scala 1:50)
Realizzata con il programma Autocad© ricostruendo la facciata ed i suoi elementi architettonici studiando i disegni
originali conservati presso l’Archivio di Stato in Bari 27.
27 Archivio di Stato di Bari (ASBA), Archivio Storico del Comune di Bari, Busta 20, Fasc. 6.
33
CAPITOLO 4 – Indagini diagnostiche
4.1 – Campionamento Le tecniche di indagine analitiche e diagnostiche applicabili alle opere d'arte, vengono di solito
distinte in due grandi classi:
invasive, che richiedono il prelievo di un campione, cioè l'asportazione di quantità minime di
materia dell'opera da sottoporre ai vari esami (cromatografia, colorazione istochimica, etc.);
non invasive, che, come la radiografia ai raggi X o la riflettografia infrarossa, possono essere
eseguite direttamente sull'opera interagendo con le superfici attraverso varie forme di
energia.
Il campionamento è un metodo invasivo ma nell’ effettuarlo, si terrà conto di danneggiare il
meno possibile il manufatto non arrecando alcun danno all'estetica e alla consistenza materica
dell'opera. Si cerca infatti di sfruttare la morfologia del degrado per l’asportazione, meno
violenta possibile, dei campioni (croste già sollevate, materiale già fessurato e in via di distacco,
ecc.)
Si possono ottenere campioni rappresentativi, ovvero porzioni di materiale la cui composizione
rispecchia completamente quella dell’insieme da cui è stata estratta, e campioni selettivi, cioè
porzioni definite la cui composizione non rispecchia quella di insieme (esempio: inclusioni,
prodotti di degrado, superfici, ecc.)
Esistono diversi modi di prelievo scelti in base alla tipologia di studi che si vuole eseguire:
P. globale, per studiarne la stratigrafia (policromie, ridipinture, dorature,ecc.);
P. selettivo, se si vuol concentrare lo studio su un unico strato o fase;
P. multigraduale, prelievi selettivi in sequenza, condotti a profondità discrete e
significative per il tipo di informazioni che si vuol raggiungere.
Fig.8 Rappresentazione grafica delle tipologie di prelievo; le righe sottostanti scure
rappresentano la malta carbonatica, gli starti sovrastanti sono quelli oggetto di analisi.
34
Le indagini di laboratorio richiedono, in genere, il prelievo di un campione e la sua preparazione
per renderlo idoneo alle analisi. Sono quindi, tecniche distruttive in quanto esigono
l’asportazione di materiale (per quanto piccola) e l’ esecuzione delle indagini, va perciò
attentamente pianificata.
La base di un programma diagnostico dovrà includere:
Diverse forme di raccolta informazioni (notizie sulle vicende storiche dell’ edificio,
osservazione diretta, dialogo e confronto con esperti di altre discipline, ecc.);
Tipo e numero di campioni;
Ordine di esecuzione delle indagini.
Il lavoro in questione ha previsto un prelievo di campioni in maniera globale per poter
apprezzare la successione dei diversi strati di intonaco, la caratterizzazione del materiale lapideo
e l’individuazione delle diverse forme di degrado.
Dopo un attento esame ad occhio nudo, sempre il primo a cui un’opera viene sottoposta e, se
condotto da un occhio esperto, utile a fornire moltissime informazioni sullo stato di
conservazione dell'opera, è stato possibile eseguire il prelievo di 7 campioni, denominati con la
sigla P.F., in punti significativi della facciata e di dimensioni sufficienti per l’esecuzione delle
analisi stratigrafiche e composizionali.
Gli strumenti utilizzati sono stati bisturi e contenitori di plastica per riporre il materiale
prelevato. Ogni campione è stato contrassegnato da una sigla come è riportato nella seguente
tabella:
Campione Materiale Zona del prelievo
P.F.1
Crosta nera Zona sottostante al capitello
della colonnina sinistra del
portale principale
35
P.F.2
Intonaco Superficie esterna della
parete destra all’altezza del
balcone del piano nobile
P.F.3
Crosta nera Zone della torre dell’estrema
destra della facciata
P.F.4
Intonaco Superficie esterna della
parete adiacente alla prima
finestra sulla destra del
portale
P.F.4/1
Crostra nera e Calcare Superficie esterna della
parete adiacente alla prima
finestra sulla destra del
portale
36
P.F.5
Intonaco Superficie esterna della
parete sinistra adiacente al
portale principale
P.F.6
Crostra nera e Calcare Raccolto nella via di fuga tra
due conci situati vicino alla
torre dell’estrema sinistra
rispetto al portale principale
4.2 – Microscopia ottica
Generalità
La microscopia ottica è una metodologia di analisi che consente di ottenere informazioni riguardanti i caratteri composizionali tessiturali o diagenetici di una roccia.
Preparazione delle sezioni sottili
Per poter osservare le rocce e nel mio caso particolare le rocce calcaree al microscopio ottico, i
campioni devono subire una serie di passaggi, che portano alla realizzazione di una sezione
sottile, attraverso la quale procedere all’analisi dei campioni al microscopio ottico.
Tagliando con troncatrice a disco diamantato a corona continua ed impregnando il campione ben
asciutto con resina epossidica.
È importante nominare i campioni con una sigla di appartenenza (nel nostro caso con la sigla
P.F.) e levigare e lavare in una vasca ad ultrasuoni e successivamente asciugato in stufa, per circa
2 ore, alla temperatura minima di 50°C.
Il retro taglio non deve essere inferiore a 400µm riportando sul vetrino la sigla del campione.
Il campione di roccia viene ulteriormente ridotto di spessore da macchine chiamate lappatrici.
37
Si effettua una pre-lucidatura levigando la sezione in tre fasi, utilizzando per ogni fase un diverso
abrasivo a granulometria decrescente. Tra la levigatura e l’altra viene effettuato un lavaggio;
infine la sezione sottile è pronta per essere analizzata al microscopio ottico.
4.2.1 - Osservazioni petrografiche L’indagine petrografica è stata effettuata su quattro campioni ed è stata eseguita studiando le
componenti principali dell’intonaco che riveste il materiale lapideo della facciata e i depositi
presenti sulla superficie. E’ stato altresì descritto lo stato di alterazione del materiale lapideo,
riportando dimensioni, composizione, tessitura e struttura dei depositi superficiali
L’individuazione delle fasi mineralogiche principali ed accessorie hanno permesso di definire il
materiale lapideo come “calcarenite”, una “pelbiosparite” costituita da calcite come unica fase
mineralogia con una struttura che però varia, in particolare confrontando P.F.2 e P.F.6, pur
mantenendo identica la tessitura.
P.F.4.1, P.F.2 e P.F.6 presentano sul bordo uno strato di calcite ricristallizzata e gesso che ha
alterato le caratteristiche fisico-chimiche della superficie lapidea. La loro formazione è legata
probabilmente alla solubiltà di questo tipo di materiale nei confronti dell’acqua piovana
contenente anidride carbonica.
Per quanto riguarda le croste nere, lo studio al microscopio ottico ha dato la prova della presenza
costante di ossidi di ferro e di particelle carboniose in quasi tutti i campioni.
P.F. 2: presenta una visibile stratificazione segnata da limiti caratterizzati da una linea nerastra e
netta per possibile accumulo di materiale particellare disperso nell’atmosfera. Gli strati non sono
paralleli tra di loro ed ognuno si differenzia per spessore. I due strati più bassi presentano ampi
pori che ci portano a stabilire una porosità del 20%. Sono individuabili in entrambi gli strati di
intonaco anche la presenza di bioclasti, individuabili come foraminiferi e pellets
Tra lo strato2. e lo strato3. si riconosce la presenza di cristalli molto più definiti probabilmente
trasportati dall’esterno e rimasti intrappolati tra la crosta nera e il substrato.
Lo strato più alto a sua volta è divisibile in ulteriori due strati. Ciò che domina è l’irregolarità
degli strati e la loro alta birifrangenza. Il più basso è costituito da gesso cripto cristallino, che si
poggia sul substrato attraverso un’ interfaccia poco netta, ma regolare.
Lo strato più alto, invece, è costituito da calcite bruna (individuabile dai colori di interferenza di
3°grado), granuli di quarzo e polveri di carbone.
38
Fig. 1: (2.5x SP) si individuano sia gli strati di intonaco, che gli strati della crosta relativa. Tra i due intonaci è
evidente una zona di forte ricristallizzazione di calcite e materiale organico di deposizione.
Fig. 2: (20x SP) particolare dello strato inferiore di intonaco in cui si individua la presenza di pellets con
un’aureola di calcite di ricristallizzazione.
1
2
3
39
Fig. 4: (20x SP) particolare della stratificazione della crosta. Si nota che lo strato più superficiale presenta una
colorazione rossastra composta da calcite ed ossidi di ferro. Invece, lo strato inferiore ad alto rilievo è costituito da
gesso cripto cristallino.
P.F. 4.1: anche in questo caso siamo di fronte ad una stratificazione di materiale, ma in questa
sezione gli strati più alti definiscono una crosta nera che poggia su un substrato costituito da una
roccia carbonatica di tessitura cripto cristallina, costituita da pellets e foraminiferi.
Fig. 3: (20x SP) particolare dello strato inferiore di intonaco in cui si nota la presenza di foraminiferi. In questo
ingrandimento si nota che le camere sono occluse da calcite di ricristallizzazione.
Ox Fe Carbone
Calcite
Gypsum
40
In base ai bioclasti possiamo definire la roccia come “pelbiosparite”. I bioclasti sono immersi in
una matrice costituita da calcite spatica ricristallizzata cripto cristallina con una distribuzione
trimodale.
La superficie di adesione della crosta nera sul substrato è poco alterato. La crosta è costituita da
uno strato più basso di calcite bruna e gesso compatto, ma con ampie lacune ed uno strato
superiore irregolare costituito da gesso cripto cristallino e dalla presenza di ampi pori.
L’osservazione a nicol incrociati ha permesso di individuare la presenza di cristalli quarzo,
polveri carboniose ed ossalati.
Fig. 5: (2.5x SP) descrive la stratificazione della crosta sul materiale lapideo, che è identificabile come calcarenite
cristallina.
41
Fig.6: (2.5x SP) particolare che mette in evidenza la struttura e la tessitura del materiale lapideo, costituito da
matrice cripto cristallina di sola calcite spatica che si presenta di più alta granulometria all’interno dei pori. Ricca di
bioclasti, pellets (di colorazione nerastra e dalla forma tondeggiante) e foraminiferi.
Fig. 7: (20x SP) particolare che isola un foraminifero tagliato trasversalmente con le cavità interne occluse da calcite spatica di ricristallizzazione. Il bioclasto è a sua volta immerso in una matrice di calcite cripto cristallina.
pellets
42
Fig. 8: (20x NX) immagine a nicol incrociati che mette in evidenza gli strati che compongono la crosta nera. In
particolare si nota solo a NX la presenza di minuti cristalli di quarzo che contornano la crosta nella zona più
superficiale.
Fig. 9 (20x SP) particolare della crosta nera costituita da gesso (ad alto rilievo) e materiale carbonioso.
P.F. 5: questa sezione presenta due strati di intonaco molto diversi tra di loro sia per
granulometria che per la percentuale di pori presenti. Lo strato più basso è compatto, omogeneo
e ha uno spessore uniforme.
43
È costituito da intonaco di tessitura cripto cristallina con ampi pori pieni di calcite spatica.
L’interfaccia di separazione è poco netta e non si evidenzia, come nel vetrino P.F.2, la presenza
di materiale deposizionale. Lo strato superiore è irregolare, costituito da materiale grossolano
formato da calcite e bioclasti, individuabili come serpulidi e pellets. Lo strato più alto presenta
anche delle fessurazioni che lo attraversano e senza raggiungere lo strato sottostante. Sono
presenti tracce di calcite bruna nelle fessure.
Fig. 10: (2.5x SP) mostra la stratificazione di due strati di intonaco che si distinguono per la differente tessitura e
struttura.
Fig. 11: (20x SP) particolare di un bioclasto, un “serpulide” contenuto nello strato di intonaco superiore.
44
P.F.6: la sezione è costituita da roccia carbonatica criptocristalina poco omogenea, perché
presenta una differente distribuzione della porosità. È molto lontana come aspetto a quella della
sezione di roccia carbonatica visibile nel campione P.F.4.1. Un lato presenta una porosità pari al
30% in cui sono presenti cristalli di calcite spatica. Invece, l’altro lato si presenta compatto, ma
sempre di tessitura cripto cristallina, con la sola presenza di “pellets”. Sul substrato si nota la
presenza di una sottile crosta nera formata da calcite bruna e gesso. Anche in questo caso, a nicol
incrociati è individuabile la presenza di granuli di quarzo e polveri carboniose.
Fig. 12: (2.5x SP) mostra una sottile crosta nera che si è formata a contatto della calcarenite, con elevata porosità.
45
Fig. 13: (2.5x SP) particolare che mostra una netta variazione della porosità del campione di calcarenite e la
matrice di calcite è di più alta granulometria all’interno del poro.
4.3 – Diffrazione a raggi X su polveri
Generalità
Il diffrattometro analizza polveri fini naturali oppure ottenute macinando il campione di
dimensioni comprese tra 1 e 50µm e consente di identificare le fasi cristalline presenti. La
diffrazione a raggi X è una metodologia di indagine che sfrutta il fenomeno per cui, una
radiazione viene diffusa dalla materia e le onde elettromagnetiche ad esse associate cambiano
direzione di propagazione.
Preparazione delle sezioni sottili
Il campione da sottoporre alla diffrazione ai raggi X deve essere trasformato nella forma più
opportuna per effettuare l’analisi, cioè da solido deve essere trasformato in polvere delle
dimensioni del talco.
La polverizzazione è stata effettuata manualmente con l’utilizzo di mortaio e pestello in agata
per ottenere una polvere da 1 a 50µm, requisito indispensabile per una buona riuscita dell’analisi.
Successivamente le polveri sono state posizionate su un vetrino la cui struttura cristallina verrà
letta come zero “zero background” sparse affinché non si sovrappongano. Posizionando il
vetrino nel porta campione è possibile eseguire l’analisi.
46
Zero-background (ZBH) è un monocristallo di silicio tagliato secondo una direzione
cristallografica non diffrangente; riduce gli effetti di iso-orientazione e di trasparenza, permette
la lettura i campioni polverulenti di pochi milligrammi di composizione granulometrica ≈ 1µm;
il contributo del fondo è molto basso.
4.3.1 – Osservazioni diffrattometriche L’analisi diffrattometrica ha permesso di conoscere le fasi mineralogiche presenti in quantità
minore che non erano riconoscibili attraverso la sola osservazione con microscopio ottico.
Le informazioni ottenute sono valutabili solo da un punto di vista qualitativo e non quantitativo a
causa del peso inferiore al grammo dei campioni.
Diffrattogramma P.F.1
50
I risultati dell’analisi diffrattometrica ai raggi X (XRD) sono riportati nella tabella seguente, che
rende più chiara la presenza di determinate fasi mineralogiche dei campioni analizzati.
Campione Calcite Gesso Quarzo Weddelite Wavellite
P.F.1 x x x x x
P.F.2 x x
P.F.3 x x x
P.F.4 x x
P.F.4.1 x x
P.F.5 x x x
P.F.6 x x
Dai risultati si evince che la fase mineralogica più diffusa è la calcite, che costituisce sia il
legante, che l’aggregato dell’intonaco, oltre che la fase mineralogica costituente la roccia
carbonatica e parte delle croste nere, come prodotto dell’alterazione.
Per quanto riguarda i risultati dell’analisi in diffrazione dei campioni costituiti da croste nere, a
parte la calcite che è presente in tutti i campioni, si è riscontrata la presenza di gesso in quasi tutti
i campioni sia in forma a più alta idratazione che a basso livello di idratazione. Il particolare il
campione P.F.1 rivela la presenza di ossidi di titanio, fosfati di alluminio ed ossalati di calcio
idrato.
Continuando a considerare soltanto i campioni costituiti da croste nere, possiamo affermare che
le quantità di quarzo rilevata risulta molto più alta per il campione P.F.1 e scarsa nei campioni
P.F.2, P.F.4.1 e P.F.5 in cui è rilevabile solo in traccia.
4.4 – Microscopia elettronica a scansione (SEM)
Generalità
La microscopia elettronica è un mezzo di indagine che permette l’analisi qualitativa e
quantitativa circa la composizione dei singoli minerali in granuli o di minerali di rocce. La
conoscenza della composizione chimica dei minerali o della variazione all’interno di uno stesso
minerale è di primaria importanza, soprattutto per ricerche di tipo mineralogico, petrografico e
geoarcheologico etc.
La sorgente di elettroni è costituita da un filamento di tungsteno o di esaboruro di lantanio
(LaB6). Il fascio degli elettroni accelerati, diretto verso il basso della colonna, viene deflesso
lungo il cammino da campi magnetici generati da due lenti elettromagnetiche.
51
All’uscita della seconda lente, il diametro del fascio è ridotto da un’apertura finale. Gli elettroni
del fascio (elettroni primari) interagendo con il campione possono rimbalzare (elettroni retro
diffusi) o possono scalzare gli elettroni degli atomi del campione osservato, con conseguente
emissione di elettroni secondari; il riequilibrio energetico degli atomi a cui sono stati sottratti
elettroni provoca l’emissione di raggi X.
Gran parte degli elettroni che impattano sul preparato, vengono scaricati a massa da un
opportuno strato di grafite con cui viene resa conduttiva la superficie del campione. L’entità di
queste scariche viene quantificata da un opportuno misuratore di corrente sul campione.
Preparazione dei campione
L’analisi al microscopio elettronico a scansione è stata eseguita sulla crosta nera. Il preparato
prima di essere analizzato al microscopio ottico viene sottoposto a metallizzazione, un processo
che rende conduttiva la superficie, in modo che gli elettroni del fascio primario che colpiscono il
preparato, siano scaricati a massa e non carichino elettricamente il campione, formando uno
scudo repulsivo nei confronti del fascio primario. La metallizzazione prevede il deposito di uno
strato conduttivo, il cui spessore può variare da qualche decina a qualche centinaia di Angstrom.
Nel nostro caso è stata usata grafite e montati i privino su basi metalliche inseribili in una piastra
forata, che è il porta campione dello strumento.
Prima della metallizzazione è importante assicurarsi che il campione sia privo di umidità.
Successivamente il preparato viene posto su una base all’interno di una camera da vuoto, e al di
sopra del preparato tramite un apposito alloggiamento della camera, viene montato un filamento
di grafite. Si pompa aria nella camera fino ad ottenere valori di vuoto idonei alla metallizzazione.
Infine si fornisce al filamento corrente meccanica affinché il filamento raggiunga
l’incandescenza ed evapori. La grafite così vaporizzata potrà ricoprire la superficie esposta del
preparato rendendola conduttiva. Una volta effettuata la metallizzazione del campione, si è
proceduto all’analisi SEM.
4.4.1 – Osservazioni con Microscopio elettronico a scansione Le microanalisi al SEM hanno costituito un passo fondamentale per il raggiungimento di
determinate informazioni riguardo la crosta nera. Sono state scelte delle zone della sezione da
indagare che destavano un maggiore interesse. Ovviamente eseguendo l’analisi su una crosta
nera, le zone analizzate sono quelle in cui è presente una grande quantità di gesso, sostanze
organiche, ossidi di ferro etc.
52
P.F. 4.1 L’indagine al SEM ha permesso di focalizzare l’attenzione sulla variazione della
crescita granulometrica dei cristalli di calcite in prossimità dei pori e di conoscere la
composizione media della crosta nera.
Fig. 14: (550x) particolare della crescita dei cristalli di calcite spatica all’interno dei pori. Notiamo un forte aumento della granulometria dei cristalli all’interno delle cavità, tanto da raggiungere un aspetto euedrale.
Foto 15: (1740x) l’immagine isola un pellets. Si distingue il contorno nerastro dovuto all’accumulo di materiale organico. All’interno di questo perimetro la calcite spatica presenta una granulometria più elevata rispetto alla matrice della roccia calcarea.
53
Foto 16: (191x) l’immagine al SEM fa perdere la stratificazione della crosta, ma riusciamo ancora a notare la sua composizione interna costituita da dei relitti del materiale lapideo
Lo spettro EDS 1 mostra la composizione media della crosta, ma quello che più rivela è la
elevata presenza di calcio, silice e componente organica che ne determina la caratteristica
colorazione “nerastra”. Sono bassi, invece, i contenuti di Fe, Na, Cl, K, e Al. Questi elementi
compongono Sali e metalli che determinano fenomeni di degrado del supporto lapideo e
colorazione della crosta verso il rosso.
Spettro EDS 1
54
Foto 17: (4420x) sono visibili nell’immagine al SEM alcuni corpi luminescenti, che solo attraverso un’ indagine mirata ci ha permesso di individuare come”solfato di bario”. Vedi spettro EDS 2
Spettro EDS 2
P.F. 5: l’analisi composizionale degli intonaci che compongono il campione P.F.5 hanno portato
a determinare l’uso di intonaco a base di calce e sabbia e l’interfaccia di separazione è data da
55
calcite spatica e polveri di carbone che fanno ipotizzare una sua esposizione all’ambiente esterno
prima della deposizione del secondo intonaco più grossolano.
Foto 18: (52x) Immagine panoramica del campione. Sono ben distinguibili le due tipologie di intonaco, differenti per tessitura e struttura.
Foto19 (634x) L’interfaccia di carbonatazione è stata possibile analizzarla nella sua composizione (vedi spettro EDS 5)
Lo spessore dell’interfaccia è di circa 10µm ed è principalmente composto da Ca e lo ritroviamo
come calcite spatica.
56
Spettro EDS 5
Foto 20(227x): mostra un particolare dell’intonaco superiore in cui si notano bioclasti e fessure profonde.
L’intonaco presenta una composizione media data da calce e sabbia ricca di materiale fossilifero
per lo più foraminiferi e come smagrante miche alluminose. Profonde fessure attraversano lo
strato di intonaco superficiale.
57
Il campione P.F.5 presenta una sottile crosta nera che è stato possibile individuale dal punto di
vista composizionale. Quest’ultima risulta formata da calcite e con alcune tracce poco
riconoscibili di Na, Cl, K, Fe. (Vedi spettro EDS 6)
Foto 21: (x1100) particolare delle ampie fratture dello strato superficiale e mette in evidenza le differenze
granulometriche del materiale che compone l’intonaco.
Foto 22 (1910x) particolare di un cristallo di calcite fortemente alterato per degrado fisico, si notano fratture lungo i piani di sfaldatura.
58
Spettro EDS 6
P.F.6: è un campione principalmente costituito da calcite, fase mineralogica che costituisce le
rocce carbonatiche.(vedi spettro EDS 7) Presenta sul bordo superficiale una pseudo crosta nera
ricca in cristalli di quarzo, invece è molto basso il contenuto di Sali e metalli.
Spettro EDS 7
59
Foto 23 (50x) Mette in evidenza la differente porosità del campione
Foto 24 (208x) Particolare della pseudo crosta nera presente sulla superficie composta da calcite, gesso e elevata quantità di quarzo
P.F.2: in questo caso, invece, domina il contenuto in ossalati di calcio, ma è molto basso il
tenore in Cl. Si ripresentano le miche di alluminio (vedi spettro EDS 9), in particolare un
incluso tra il substrato e la crosta.
La crosta nera che in microscopia ottica vede lo strato più esterno rosso, al SEM si perde la sua
colorazione, ma ne possiamo giustificare la cromia per la presenza di ossidi di ferro.
60
La caratteristica di questo campione è la presenza di minio Pb, elemento probabilmente usato per
produrre la cromia ocra che caratterizza l’intonaco presente. (vedi spettro EDS 11).
Foto 25 particolare che mostra una mica di alluminio
Spettro EDS 9 Spettro EDS 11
61
Foto 26 (4680x) Particolare della composizione della crosta in cui sono visibili cristalli luminescenti di solfato di bario e ossidi di ferro, invece i cristalli squadrati non sono cristalli di sale quanto Qz la cui forma non è tipica quindi solo l’analisi a spot ha permesso di riconoscerlo come composto da sola silice. (vedi spettro EDS 10)
Spettro EDS 10
4.5 – Osservazioni conclusive Le varie indagini hanno fornito diverse informazioni sui campioni e il loro relativo stato di
degrado. L’indagine microscopica ha chiarito la natura del supporto lapideo identificandolo
come una roccia carbonatica ricca in bioclasti, e sulla composizione dell’intonaco usato per
ricoprire i conci che costituiscono la facciata, come formato da calce e sabbia. L’osservazione
62
con microscopio ottico ha permesso di notare come interagisce la crosta nera sulla superficie sia
dell’intonaco (vedi P.F.5) che sul supporto lapideo (vedi P.F.4.1 e P.F.6). In entrambi i casi la
crosta nera non ha alterato molto la superficie scendendo in profondità, ma “riveste” entrambi i
supporti con un compatto strato di calcite e gesso. L’idratazione del gesso diventa una superficie
dal marcato comportamento elettrostatico nei confronti delle polveri che costituiscono
l’ambiente esterno e comporta un accumulo di polveri carboniose e Sali.
L’analisi diffrattometrica conferma la composizione della crosta nera come formata da calcite di
ricristallizzazione, gesso e polveri carboniose, ma i sali che si pensava di individuare in maniera
più marcata, come Na, Cl, li si ritrova solo in traccia. Ciò a portato a considerare la facciata poco
soggetta all’azione aggressiva dello spray marino, ma principalmente vittima dell’aggressione
dell’acqua piovana ricca in anidride carbonica che solubilizza il supporto producendo una
ricristallizzazione di calcite spatica.
La reazione fondamentale è la seguente:
CaCO3 + CO2 + H2O Ca(HCO3)2
calcite (carbonato di calcio) poco solubile (bicarbonato di calcio molto solubile)
Dalle indagini mediante diffrattometria RX è risultato presente il quarzo, di origine eolica o
residuale (è frequentemente presente come minerale accessorio nei calcari, dove non viene
attaccato dagli acidi corrosivi formatisi dagli inquinanti, concentrandosi così superficialmente).
Abbastanza frequenti sono gli ossalati di calcio la “weddellite” CaC2O4*2H2O, il termine
biidrato, è più comune della whewellite, la fase monoidrato , che possono derivare dall'attività
metabolica di varie specie di licheni, soprattutto di tipo incrostante, o da trattamenti antichi di
lucidatura o di protezione di marmi e calcari di natura proteica.
L’elevata concentrazione di gesso ha origine dall'inquinamento atmosferico, da composti dello
zolfo, divenuto oramai comunissimo in aree industrializzate e urbane, ove si adoperano
combustibili contenenti questo elemento, per lo più combinato in composti organici, per la
produzione di energia elettrica o termica (per impianti industriali o di riscaldamento domestico).
Lo zolfo prodotto ricade attraverso le acque piovane sotto forma di acido solforico che reagendo
con il carbonato di calcio produce gesso.
CaCO3+ H2SO4+H2O CaSO4.2H2O + CO2
Infine, l’indagine al SEM ha permesso di compiere indagini ancora più mirate dal punto di vista
composizionale confermando i risultati provenienti dalle altre forme di indagine, come la forte
ricristallizzazione della calcite spatica per lo più nei pori raggiungendo in alcuni casi anche un
aspetto euedrale ed individuando, in più, elementi che non avevano rivelato come il solfato di
bario e la presenza di piombo, il quale probabilmente è presente con funzione di pigmento per la
realizzazione del colore ocra dell’intonaco.
63
CONCLUSIONI Questo lavoro di tesi ha riguardato l’analisi dello stato di conservazione della facciata del
Palazzo Fizzarotti, un palazzo dei primi del’900 sito a Bari, con l’obiettivo di individuare i
processi di alterazione a carico dell’opera in esame e le cause del degrado.
Lo studio visivo dell’opera ha rivelato che i processi di alterazione e degrado hanno procurato
danni estetici riconducibili a fattori fisici, chimici, biologici ed antropici. Le azioni fisico-
chimiche hanno lasciato il materiale lapideo esposto a vari processi di degrado diverse, ma anche
facilmente riconoscibili.
Sono state prodotte poco dall’azione erosiva del vento, ma questi è il responsabile del trasporto
di materiale che per attrito e/o per attrazione magnetica di deposita sulle superfici lapidee ed
infine questo deposito può abradere e/o dissolvere la roccia carbonatica reagendo con le piogge
acide rese aggressive dall’inquinamento atmosferico e dalle croste nere.
Le azioni dell’uomo hanno concorso al degrado del monumento attraverso l’apposizione di
elementi in ferro che tendono a perdere per dilavamento materiale modificando il colore dei
supporti, e per applicazione di un intonaco a fini estetici il quale avendo un comportamento
differente al quello del supporto lapideo tende a creparsi e a scagliarsi.
Con l’ausilio delle analisi in laboratorio si è cercato di caratterizzare sia il materiale lapideo
utilizzato per la costruzione del monumento che l’intonaco applicato, ma soprattutto il materiale
che costituisce le croste nere per comprendere quale ruolo ricopre l’ambiente urbano nell’azione
del degrado.
La diffrazione a raggi X su polveri ha messo in evidenza le fasi cristalline dei materiali presi in
esame. I campioni sono risultati formati prevalentemente da calcite, gesso ed ossidi di ferro. Sia
l’intonaco che la roccia carbonatica sono costituite da bioclasti, che la microscopia ottica ha
permesso di notare.
L’attenzione del lavoro di tesi si è voluto concentrare sulle croste nere, sia dal punto di vista
composizionale che strutturale per comprendere con l’ambiente urbano interagisce con il
monumento. La crosta diventa un protettivo della superficie perché con la ricristallizzazione
della calcite blocca il degrado fisico del materiale, ma ne modifica fortemente l’aspetto estetico.
L’analisi al microscopio ottico della crosta nera ha messo in evidenza lo stato di gesso e di
calcite che la compone. L’analisi al SEM ha permesso di ottenere maggiore dettaglio e di notare
una forte presenza di materiale di elevato peso atomico come Piombo e Zolfo nel deposito,
rendendolo carico elettricamente all’accumulo di polveri carboniose provenienti dagli scarichi
delle auto.
La non presenza di muschi e licheni conferma l’elevata presenza di solfati che si sono depositati
sulla superficie per reazione dell’anidride solforosa con il carbonato di calcio.
64
BIBLIOGRAFIA AA. VV. “Metodologie Analitiche Mineralogiche e Petrografiche. Dispense di studio per la Diagnostica e Conservazione dei Beni Culturali”, Dipartimento Geomineralogico, Università di Bari, 2002. Amoroso G.G., “Trattato di Scienza della Conservazione dei monumenti”, Alinea Editrice, 2002. Amoroso G.G., Fassina V., “Stone decay and Conservation atmospheric pollution – clearing – consolidation and protection”, Elsevier, Amsterdam, 1983. Amoroso G.G., Felix C., “Processi di degrado della pietra e protezione con prodotti di trattamento”, L’Ingeniere, Nr 1, 2 GEN – FEB 1978. Archivio di Stato di Bari (ASba), Archivio Storico del Comune di Bari, Busta 20, Fasc. 6. Bernardi A. “Conservare opere d’arte: Il microclima negli ambienti museali”, Ed. Le Pleiadi, 2004. Berrino A. “Ettore Bernich 1850/1914. Storia progetto restauro”, Ed. Prospettive, 2006. Brandi C. “Teoria del restauro”, Roma, Piccola Biblioteca Einaudi, 1977. Camaiti M. Amoroso G.G. “Scienza dei materiali e restauro”, Alinea Editrice, 1997. Camuffo D. “Physical weathering of stoner the science of the total enivironment”, Elsevier vol.167, 1995. Camuffo D., Del Monte M., Sabbioni C. “Influenza delle precipitazioni e della condensazione sul degado superficiale dei monumenti in marmo e calcare”, Bolletino d’Arte, Supplemento al Nr. 41, Materiali Lapidei, 1987. Carra F. “La conservazione delle facciate materiali e tecniche per il recupero”, Ed. Tecniche Nuove, 2004.
Carunchio T. “Dal restauro alla conservazione. Introduzione ai temi della conservazione del patrimonio architettonico”,1997. Chiari G., Fiora L., Compagnoni R. “Studio dell’alterazione della pietra dell’Arco di Augusto a Susa (Piamonte, Italia), Le piete dell’architettura, struttura e superfici”, Bressanone, 1991. Clean Air Act, 1956, 4&5 Eliz.2, Ch.52 Codello R. “Gli intonaci: conoscenza e conservazione”, Alinea Editrice, 1996. E. Fizzarotti, “Bari nel presente e nel suo avvenire”, Bari, stab. Avellino & C., 1913
Fassina V., Lazzarini L., Biscontin G. “Effect of atmospheric pollutants on the composition of block clusts deposited on venezian marbles and stones”, Athens, Sept. 27 – Oct. 1, 1976. Feiffer C. “La Conservazione delle superfici intonacate il metodo e le tecniche” ed. Skira, 1997. Frattini F., Manganelli Del Fà C., Pecchioni E., “Le pietre nel patrimonio monumentale italiano: processi e cause d’alterazione”, L’Edilizia e l’Iindustrializzazione, Nr 9, Dicembre 1987.
65
Guarnieri A. “Pietre di Puglia: Il restauro del patrimonio architettonico in terra di Bari tra Ottocento e Novecento”, Gangemi Editore, 2007.
Guidoni E. “Bari moderna: 1790 – 1990: rivista internazionale di storia urbana e territoriale”, Elmond, Milano, 1990.
Lorusso S., Troili M., Biondi F., Marabelli M., Santamaria U. “Caratterizzazione delle qualità dell’aria in siti storici con differente tasso di metanizzazione”, 1st International Congress on Science and Tecnology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Bacin, Catania, 1995. Martinet G., Guedon J.S., Leroux A. “L’altération d’un calcaire lutetién dans un milieu urbain”, Conservation of stone and other materials, UNESCO – RILEM, Paris, 1993.
Melchiorre V.A. “Bari”, Mario Edda Editore, 2001. North F.J., “Limestone their origin, distribution and uses”, London, 1930 Odén S. “The Acidification of Air and its consequences in the natural environment”, Ecology Committee Bullettin, n°1, Stockholm, 1968 Patruno L., “Bari Vecchia”, Mario Adda Editore, 2000 Sharma R.K., Gupta H.O., “Dust pollution at the Taj Mahal. A Case study. Conservation of Stone and other materials”, UNESCO – Rilem, Paris, 1993. Signorile N., Gismondi F.P., “Atlante’900”, Editrice Laterza, 2009. Sorlini C. “Effetti ambientali delle Piogge Acide, Carbone e Ambiente”, Quaderni Le Scienze, 11, Dic. 1983. BIBLIO SITO GRAFIA
http://rilievo.stereofot.it/studenti/aa01/caserta/tema/tesina/murattiano.HTML
http://pugliaweb.net/scheda/palazzo-fizzarotti-bari/