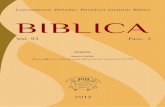ναυᾱγ-/ναυηγ-, una iscrizione e alcune forme di ἄγνυμι
-
Upload
mondodomani -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of ναυᾱγ-/ναυηγ-, una iscrizione e alcune forme di ἄγνυμι
A.I.O.N.
ANNALI DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI
DIPARTIMENTO DI STUDI DEL MONDO CLASSICO E DEL MEDITERRANEO ANTICO SEZIONE FILOLOGICO-LETTERARIA
XIX (1997)
KATÀ DIALEKTON Atti del III Colloquio Internazionale
di Dialettologia Greca
a cura di A.C. Cassio
[ESTRATTO]
Napoli - Fiaiano d'Ischia, 25-28 settembre 1996
NAYAr-/NAYHr-, UNA ISCRIZIONE E ALCUNE FORME DI • ArNYMI~<
Notoriamente la famiglia di ayvu1.u presenta qualche problema, sia in formazioni nominali sia in alcune verbali. Una iscrizione recentemente pubblicata consente il riesame più puntuale di un composto nominale e offre l'occasione di riprendere globalmente le questioni recate dalle suddette formazioni. V erranno tentativamente proposte alcune soluzioni, che, almeno riguardo alle forme verbali, non hanno certo carattere definitivo.
Converrà iniziare recensendo la situazione di vauay-/ vau11r-, il gruppo di composti interessati dall'iscrizione:
A) L'attico ha una famiglia di composti a base vauay(vaùç + ayvuiJ.t), le cui più antiche attestazioni sono in Aesch. Pers. 420, fr. 180, 4 R., Soph. El. 730, 1444, Eur. Tro. 438, Hel. 408, 410, 449, 507, 539, 1070 (cf. anche trag. adesp. 546a 2 K.Sn.), Aristoph. Th. 873 (paratragico), Thuc. I 50, 3; 51, 4; 54, 1; 54, 2; II 92, 4; IV 14, 5; VII 23, 4; 34, 6; 72, 1; 72, 2; VIII 106, 4; Xenoph. Hell. I 7, 4; 7, 5; 7, 18; 7, 29 (bis); Cyrop. III 1, 24. La prosodia lunga dell'a del secondo membro è assicurata da tutti i passi tragici, tranne il frammento eschileo e quello adespoto, ove è impossibile da determinare, nonché da Aristofane, ed in effetti in ionico corrisponde vaUlw-: Herodot. IV 103, 1; VII
,,. Questo lavoro deve molto alle discussioni con Albio Cesare Cassio, Emilio Crespo Giiemes e Anna Morpurgo, che ringrazio caldamente. Lo stesso vale per Martin Peters che mi ha fornito con grande generosità un dossier epistolare della consistenza di un vero e proprio contributo.
280 Emanuele Dettori
190; 191, l (vauay- aP); 192, l; 236, 2; VIII 8, 1; 8, 3; 12, 1 (vauay- V1Bc [I]); 12, 2; 18; 76, 2; 96, l; 96, 2 (bis) 1 .
Questa 'base' vamn- ha 56 occorrenze, distribuite in pochissimi testi: 14 in Erodoto, 39 nell'epigramma 2, 2 in Gregorio di Nazianzo (oltre che quella nell'epigramma dell'Antologia)3, 1 nella Batracomiomachia (v. 94), 1 negli Oracula Sibyllina (II 85). Ovvero, nel prosatore ionico per eccellenza, in un
1 vaucty-, come si indurrà anche dalla successiva recensione di vaum-, è la forma «normale», come dire di xotvfJ. L'unica altra sua occorrenza che potrebbe essere di un qualche interesse per quanto ci riguarda è in un epitafio di un caunio, ritrovato ad Anfipoli: CEG II 722 Hans. (IV a.C. ?) :E~puJ.wvoç tv cr~ÒJ.l!l'tt vaoctyf!craç ~t1tov <péiiç. Ma il luogo di ritrovamento (colonia attica) e la data ne impediscono una sicura valutazione.
2 Grosso modo in ordine cronologico: AG V 161, 4 (Hedyl. vel Asclep.); VII 266, 1 (Leonid. Tar.); 267, 2 (Posidipp., anche nel 'nuovo' Posidippo: cf. Posidippo. Epigrammi, a cura di G. Bastianini e C. Gallazzi, Milano 1993, XIII 1); 277, 1 (Callim.); 276, 5 (Hegesipp. ?); 76, 6; IX 568, 4 (ambedue Dioscor.); VII :.C:82, 1 (Theodorid.: vauar- Pl•b·'); 291, 2 (Xenocrit. Rh.); 265, l; 268, 1; 269, 2 (tutti e tre [Plat.]); 278, 1 (Archias); 290, 2 (Stat. Flacc.); 287, 7; 289, 1 (ambedue Antip. Thess.); 631, 3 (Apollonid.); IX 36, 5 (Secund.); 292, 2 (Honest.); VII 392, 5 (Heracl. Sinop.); 382, 3 (Philipp. Thess.); 550, 1; 675, 1 (ambedue Leonid. Alex.); IX 84, 5 (Antiphan.); 218, 6 (Aemil. Nic.); VIII 210, 1 (Greg. Naz.); X 65, 2 (Pallad.); V 235, 5 (Maced. con.); VII 582, 1; 584, 1; 587, 3 (Iulian. Aeg.); IX 30, 2 (Zelot. vel Bass.); VII 279, 3 (vauar- P/E); IX 105, 2; 115, 3; 133, 2; XII 156, 5; XIV 109, 3 (tutti adespoti). La forma vaucty- negli epigrammi dell'Antologia è in V 11, 2 (adesp., Asclep. Sternbach, Asclep. vel Posidipp. Stadtmiiller: vaum- Pl.), ove si trova sia yQ. che <p!ÀiT); 209, 5 (Posidipp. Pl., Asclep. Jacobs, Stadtmiiller, Schott), ove sono molte forme ioniche; IX 52, 2 (Carpyll.: vaum- Pl.EMarc.) ove al v. 6 è B\Ìcref3i11ç. Nonostante le coloriture ioniche che le accompagnano, è forse preferibile mantenere queste forme con et, che, considerata la situazione nell'Antologia, finiscono per costituire lectiones difficiliores.
3 Carm. I 2, 1, 685 (PG XXXVII 574, 8); II 2, 5, 213 (PG XXXVII 1537, 2). Si tratta, non a caso, di componimenti esametrici. Gregorio ha invece vaudyin una poesia in trimetri giambici (Il 1, 29, 78; PG XXXVII 1335, 3), e in una in prosa ritmica (l 2, 3, 43; PG XXXVII 636, 6). Su quest'ultima, cf. Meyer 1885, 312ss. (ediz. alle pp. 400ss.); sull'autenticità (dubbia), cf. Werhahn 1966, 343s. Curiosamente, anche un commentatore del Nazianzeno utilizza la forma con vocalismo T]. In Cosma di Gerusalemme (VII sec.) troviamo tre volte vaoT]yòç, due volte commentando la medesima forma in Gregorio (PG XXXVIII 449, ad II l, 44, 71; XXXVIII 482, ad II 2, 5, 213), ma non sta ripetendo il testo commentato, e una liberamente, senza che ci sia un riferimento nel testo di Gregorio in questione, cf. Crimi-Kertsch 1995, 400, 19. È come se Cosma conoscesse il vocabolo solo dalle opere del Nazianzeno (o, per lo meno, considerasse corretto il vocalismo ivi reperito ).
vuuay-/vuul]y-, una iscrizione e alcune forme di iiyvu)lt 281
genere, l'epigramma, considerato stretto parente dell'elegia ionica, e, ma tardi, in quattro componimenti esametrici.
Il vocalismo vauuy- in attico (per molti ìnatteso nel timbro) ha dato luogo a diversi tentativi di spiegazione (a volte combinati): l) allungamento in composizione 4 ; 2) «volksetymologisch» per la lunga di ~ul;a (sic), Mya (Hatzidakis) con in più l'influenza analogica di xatdyVUJ..l.t (da >:·xatapUyYUJ.tt)S; 3) semplice scelta lessicale 6; 4) per non confondere il vocabolo con un composto con -11y6ç = «guida», e rendere evidente il rapporto con ÈUY11, iiyvuJ..u 7; 5) effetto di u sul mantenimento di u (o meglio sul suo ripristino) analogo a quello di e, t e p 8•
4 Weir Smyth 1894, 179 n. 1, Frisk, GEW II 291, Chantraine, DELG 736 (per questi ultimi in combinazione con l'ipotesi 2). Cf. Brugmann 1906, 86, per cui l'a è «Kontraktionslange ... analogisch iibertragen».
5 Hatzidakis 1900, 591 (Hatzidakis non introduce, almeno esplicitamente, xu~dyvu)lt nel discorso: «es war leicht, nach vaiiç xa~Edyuta auch vauayòç vauayÉffi ... zu sagen »), Bjiirck 1950, 42, 147, Frisk, GEW II 291, Biersche 1970, 151. Non ci è chiaro Schwyzer 1939, 439 («vau!iyòç ... eher urspriingliches -pdy- », sempre che stia parlando del vocalismo). Una variante di questa ipotesi è in Ruijgh 1978a, 94, che accetta l'influenza di xa~éLyVU)lt per a, ma fa risalire la lunga ad una radice •·weh2g- , parallela a *peh2g- m'Jyvu)lt.
6 Mahlow 1927, 179, 216 (cf. anche 20). È noto che Mahlow non crede ad un « lautgesetzliches » a purum, ma imputa la fluttuazione tra a ed TJ a differenze sociolinguistiche. La forma vauay- dipenderebbe da un non altrimenti spiegabile amore degli ateniesi per -ayoç, che utilizzerebbero anche dove non ha rapporto con iiyro, come in ~ayòç e, appunto, in vaudyòç. Su ~!iyòç in attico, vd. ora Helly 1995, 38.
7 Hoffmann 1898, 354 ( « doch lassen sich auch andere Erklarungen geben » ), Hatzidakis 1900, 591. Non capisco se Schwyzer 1939, 190, accetti tale spiegazione o semplicemente ne riferisca, attribuendola, erroneamente, a Mahlow.
8 È probabile che tale atteggiamento sia da attribuire a Meyer 1896, 92 ( « das Attische hat dies TJ bei vorangehendem t, u, E und p in !i zuriickverwandelt, sonst erhalten » ), Brugmann 1900, 32 ( « im Attischen erscheint das urionischattische e; hinter p, t, E, u in !i zuriickverwandelt » ), Pisani 1973, 123 («in attico troviamo !i, e non T], dopo E t u p»), benché non menzionino esplicitamente vauayòç. Così anche Hoffmann 1898, 341, che però, abbiamo visto, fa di vaudyun caso particolare. Brandenstein 1954, 55: « zum Teil auch nach u un d po » (es. a p. 56, vf.a e cnxlia). Perplessità in Thumb 38, nella rielaborazione di Brugmann 1900 (Miinchen 1913: era uscito l'articolo di Hatzidakis), e Lejeune 1972, 235s. (<des traitements attiques de a. ancien après u, diphthongue en u, et o sont peu clairs » ), che menzionano il nostro vocabolo in questo contesto. Cf. anche Kiihner-Blass 1890, che a p. 385 affermano «nach u hat TJ zu stehen», ma non men-
282 Emanuele Dettori
La spiegazione di Mahlow (no. 3) è conseguente ad una impostazione generale difficilmente accettabile: si vedano le accurate controdeduzioni di Bjorck 1950, 21ss. L'ipotesi no. 5 non regge da tempo: l'irreperibilità di una regola per la fluttuazione u11/uu ha consigliato un atteggiamento puramente descrittivo e un «atomismo» pressoché completo nelle proposte di spiegazione dei singoli vocaboli che presentino ua 9• Proporre l'allungamento in composizione (no. l) è insufficiente: la Kompositionsdehnung avrebbe dovuto dare comunque -11-. Riguardo al no. 4, l'ipotesi appare insostenibile: non solo in quanto «non si chiarirebbe la forma ionica, né perché una coppia va.umòç-a'tpa.tT]yòç sarebbe più inaccettabile, in attico, che va.uayòç-A.oxuyòç» 10, ma anche perché un va.UllYÒç «comandante di nave» appare, per lo meno in greco, semanticamente improponibile. È vero che abbiamo lat. navigare e a.ind. navajd-11, ma in greco sembra che una cosa sia à.ystv, un'altra governare una nave, per cui, non a caso, esiste il termine tecnico va.t'la.PXoç 12• La possibilita della confusione tra va.umòç «naufrago» e va.u,yòç «comandante di nave» non si dava, quindi, a priori. Un va.ua.yòç «comandante di nave» non a p-
zionano ivi vauiiy-, ricordato invece a p. 126, descrittivamente, come isolato («vereinzelt») caso di dissenso con lo ionico. Un atteggiamento fenomenologico è mantenuto anche da Schwyzer 1939, 189, per cui, a parte il tipo eùcpufr, «die iibrigen Falle mit uii lassen sich aus besondern Bedingungen der betreffenden Worter erklaren » (per vauiiy- cf. ibid., nn. 2 e 4 ).
9 Un criterio per la Ruckverwandlung ad ii dopo u e o, in determinati contesti, è escogitata da Miller 1976, 150ss. Ma forse ci sarebbe bisogno di una giustificazione fonetica. Comunque, una eventuale forma vau111òç non sarebbe soggetta a « reversion » anche secondo le regole di Miller.
10 Bjorck 1950, 42. 11 I termini mi sono stati ricordati da Michael Meier-Briigger. Su niiviijd-,
cf. Mayrhofer 1992, 38 (anche av. nauiiza-). Sulla possibilità di intendere av. nauiiza- come nau-viiza-, "schiffbriichig », del tutto affine al greco vauiiyòç, cf. Thieme 1975, 348s. Vd. anche Benedetti 1988, 52s. (su niiviijd-, nauiiza- e un possibile latino *niivex).
12 Uno schema mentale che ci sembra rispecchiato nella diffusa metafora della «nave dello stato''· L~ composizione con -mòç, in riferimento alla navigazione, può invece valere per «strumenti»: cf. le denominazioni di battelli bt1tT]yòç e m•ll'Yòç. Cf., per questo, Wackernagel1889, 60, Bjorck 1950, 293.
vauuy-/vau1)y-, una iscrizione e alcune forme di li.yvwn 283
pare, in effetti, che in Euforione (fr. 158 Pow.), poeta notoriamente artefatto 13 •
L'ipotesi no. 2, finora rimasta tale benché in sé immune da contestazioni, ha ricevuto recentemente una conferma che direi definitiva, almeno per quanto riguarda il carattere secondario dell'a. A.S. Rusjaeva e J.G. Vinogradov hanno pubblicato 14 una iscrizione graffita su un coccio di vaso del tipo Fikellura, datato al 550-530 a.C., ritrovato ad Olbia e proveniente da Hylaia (basso corso dell'attuale Dnepr): una scrittura, dunque, di ambito ionico ts.
13 Lo stesso testimone, Hellad. ap. Phot. Bibl. 532b18, dichiara vauay6ç di Euforione una ì..él;tç xax6sT]ì..oç. Quanto si trova in Sud. v 54 vaumòç· 6 rijç veooç UPXTJY6ç· wii~o M xotv&ç, 1Ì lìÈ ltOiT]mç xaì ~òv vauay1'taav~a ou~ro ypa<pet è contraddetto dai testi, anche, parzialmente, a livello stilistico. Herodian. 1t. xaBoì... 7rpoa. I 234, 4s. L. attesta un vaumòç, ma il carattere esclusivamente formale della menzione impedisce di stabilire se si tratti di «naufrago» o di «guida della nave», come in Suda. Converrà una digressione sull'ultimo commentatore di E ufo rione. Groningen 1977, 219, afferma che, poiché «la lingua di Euforione è chiaramente ionizzante », il poeta avrebbe dovuto avere vauT]yòç e non vauuy6ç: ne conseguirebbe che avrà scandito vaul1yòç, e l'arbitrio (semantico) che gli viene imputato diminuirebbe di molto. Il ragionamento non sembra impeccabile, e, in ogni caso, per vauuyòç «guida di nave», per quanto discutibile, Euforione aveva da una parte di fronte il modello dei composti in -uy6ç, la cui coloritura dorica non penso fosse svanita dalla coscienza linguistica degli alessandrini e doveva essere condizionante anche per questa Neubildung semantica, dall'altra l'assoluta mancanza di qualsiasi appiglio formale per una scansione breve dell'a. Sul vauay6ç di Euforione, v d. anche Euler 1979, 63.
14 1991, 201s. (SEG XLII 710; Dubois 1996, 55ss., no. 24: da vedere per letture diverse e l'interpretazione). Per un'analisi di carattere storico, vd. Rusjaeva 1994, 95-99.
15 I due editori sembrano datare l'inscrizione più o meno contemporaneamente al manufatto. Dubois 1996, 55 e 56s., la fissa attorno al 400 a.C., per la presenza del «digrafo» OY (cf. la grafia w1touç 8e01tOtT]~ouç L 3, e lìouì..ot L 9). Ma Maria Letizia Lazzarini mi fa notare almeno due elementi grafici che rendono molto difficile una collocazione sotto il 500 a.C.: il theta «a croce» e l'epsilon con tratti paralleli molto obliqui e l'asta verticale che si prolunga oltre l'ultimo di questi tratti. V d. anche J.G. Vinogradov, ree. a Dubois 1996, « Gnomo n» LXX (1998), in corso di stampa. Per la mancanza di iota ascritto (L 5), che può apparire strana a questa data, basti rimandare alla "lettera di Berezan" (Dubois 1996, 50ss., no. 23) IL 9 e 11. È evidente che questi due interessantissimi documenti privati spingono ad un riesame, non pregiudiziale, della cronologia di alcuni fenomeni grafici. Direi che si possa comunque partire dal noto presupposto che la scrittura ufficiale è più conservatrice di quella privata.
284 Emanuele Dettori
[ - - - ]vo9ETIJ f..li>Àt xat xpto[ v - - - - - - J [xat va]uv roç smn;Ustç 7tEf..l7t[stv- -] [ - - o1t]roç 't07touç 9E07tOtTJ'touç 7tEpto[pnfJ.TJ'tnt - ] [xat 1ta]p axpTJV at TJ xaf..lE tpo q>roç VTJcr[ - - xat] [eu rom v J otxatroç EV 'tTj Xa.À.XTJVTJ at yuv[ atxsç, - J [o os sx1t ]A.TJ svesuesv sç TIJV YA.at[ TJV - - ] [ - - - ] aunç Ot l3rof.l.Ol l3el3AaJ..lJ..lEVO[t Etm· - - ] [ - - M]TJ'tpoç esrov xat Bopucres(vsro) vel ( -vtoç) xat HpaxA.[ TJOç] [-- J..l]E'ta 'to vauaytov ot oouA.ot xa'taopa[J..Letv] [ - - x]stpOUpytT]t MT]'tpoq>aveoç tpoç EÀt7te't[ o - - J [-- 't]rov m'tU(J)V xaxat, 't(J)V osvoprov OlTJXOm[a-- J [ - - o ]t BT]psu'tat 'trov t7t7trov TJUpTJxncrt J..lE'ta xtvouvrov Tupa[ - -
J
Ebbene, la l. 9 del graffito reca la seguente frase: J..L]E'ta 'tO vauaytov ot oouA.ot xa'taopçt[J..Lstv.
È necessaria qui una precisazione. Anche qualora si accettasse la datazione bassa dell'iscrizione, ciò non deve frettolosamente indurre al sospetto che vuuuytov sia elemento dialettalmente estraneo. Il contesto linguistico è del tutto privo di atticismi e i tratti ionici sono evidenti; inoltre non abbiamo elementi per dire che i composti con base vuuaysiano termini tecnici propri dell'Attica 16• Infine, da un punto di vista più generale, se, come anticipiamo, tutto lascia pensare che l'a sia secondario in attico, non dovrà suscitare perplessità il ritrovarlo in ambito ionico.
Si dovrà concludere che anche in ionico tali composti presentavano un a, che è da ritenere lungo, come ricaviamo non solo dal vauTJy- erodoteo, ma anche dal materiale che abbiamo elencato, e da quello che esamineremo in séguito 17• È
16 Comprensibilmente sorpreso dalla forma, Dubois 1996, 6ls., pensa, dubitativamente, a un atticismo, confrontando lìévlìprov (l. 11). Un'altra particolarità, non notata da Dubois, è che qui vauaytov è probabile significhi << naufragio» e non «relitto di naufragio»: il ché non si ritrova, a stare ai repertori, almeno fino a Strab. IV l, 7.
17 Martin Peters (per litt.) è incline alla presenza di un'a breve in vauaytov, rifacendosi a xa~al;-, attestato tre volte epigraficamente in Ionia orientale (vd. infra) e a forme ioniche come ÀU\IIE~at. :\.UI;tç, a fronte di '-fJlilemt, Uil;tç. Si tratte-
vauil.y-/vauT)y-, una iscrizione e alcune forme di ayvu~t 285
evidente che la presenza di un fi comune a ionico ed attico si spiega solo con una sua formazione secondaria, come, ad esempio, &:t'T] < ::-a,cn'tals.
Questo nuovo ritrovamento, che induce a ritenere « panellenico >> l' fi in questo composto, consente di considerare sotto nuova luce il (presunto) ionico vamn-: evidentemente un . . . 1penomsmo.
Sull'origine di tale iperionismo sembra difficile fare ipotesi sicure: una forma come vauay6ç poteva apparire in un qualunque momento come radicalmente non ionica, ed essere assoggettata ad ipercaratterizzazione, forse già dallo stesso Erodoto. Ma abbiamo qualche indizio per una localizzazione temporale: da una parte, in poesia, Callimaco nei Giambi usa la crasi di forma x1'J- anzi che xa- 19, nonché la forma BiT]ç, per Biaç (fr. 191, 73 Pf-)2°. E Callimaco è uno degli epigrammatisti più antichi ad usare vamn- (AG VII 277, l = Epigr. 58, l Pf.). D'altra parte, sul versante grammaticale, sono rilevanti due interventi di Zenodoto. È noto che in Omero troviamo almeno due forme collegate ad àyvuj.tt sicuramente con a radicale: èd'YT]
rebbe di arcaismi (anche à.yvu~eve<; in Herodot. I 185, 6), che rimandano ad un'originario *wag-, contro il normale comportamento della radice, con vocalismo lungo per influenza di rrflyw~t (cf. n. 123). Come anche l'a breve potrebbe scaturire da un'innovazione, che partirebbe da xa~(n) composto con ay- già privo di digamma iniziale. Non posso, qui, riferire nel dettaglio le argomentazioni di Peters, che, comunque, parte da un'analisi degli aoristi sigmatici di (xa~)nyvu~t piuttosto divergente dalla nostra (vd. infra). In generale, come si vedrà poi, non riteniamo sia necessario spiegare le forme collegate ad ayvu~t attraverso il parallelismo con (o l'influenza di) rrflyvu~t, quale postulata da Peters e da Ruijgh.
18 Per il momento lasciamo impregiudicata l'origine di questo a. secondario, su cui torneremo infra.
19 Lo nota Schmidt 1968, 21 (i passi ibid. n. 7). Per il caso differente di ionismi "non omerici" (tipo Sei), 'Ep~EiT]ç, "Ii)oveç), che potrebbero essere anche ionizzazioni artificiali di termini della lingua epica, cf. Schmidt 1968, 34s. n. 61.
20 Schmidt 1968, 34s. Schmidt afferma « soweit wir sehen, hat er (se. Callimaco) sich Hyperionismen sonst nicht erlaubt», ed è d'accordo con Hunt nel correggere in Biaç. Ma a p. 133 riconosce che la crasi x'IJ- è iperionismo; tenta però di mitigarlo rispetto a Binç, che sarebbe « eine rein kiinstliche Schopfung »,
mentre quel tipo di crasi perlomeno si conoscerebbe da altri dialetti. Callimaco presenta anche almeno un iperdorismo, se non due, cf. Cassio 1993, 903ss.
286 Emanuele Dettori
(A 559) e ò.dyÉç (ì~. 575)21, e che anche altrove forme del verbo, di suoi composti e di suoi affini nominali presentano il medesimo vocalismo (particolarmente in attico). Su tutto ciò torneremo in séguito, ma conviene intanto vedere cosa Zenodoto sembra aver ricavato da questa situazione: schol. Horn. N 166d1 (çuvÉa.ça:) ZT]vòOo,;oc; «çuvÉT]çe», schol. Horn. N 257c (xa.,;aaça.J.LeV:) ZT]vòOo,;oc; M « XO.'tei]ça.J.LeV)) otà 'tÒ xa.i ÉV ,;oic; ÈJ.17tpocr9av (se. N 166) «o çuvÉT]çs» Myatv. Evidentemente Zenodoto, sulla base dell'd caratterizzante molte forme della famiglia di àyvuJ.Lt, di cui almeno due sicuramente anche in Omero, ha iperionizzato, o, più verosimilmente, attinto da copie ioniche ipercaratterizzate22, probabilmente in maniera molto più estesa di quanto ci fanno intravvedere i nostri due scolii 23 •
L'operazione riguardante -a:y- ~ -m- in termini della famiglia di àyvuJ.Lt (quindi anche va.uay- ~ va.um-) potrebbe dunque datarsi almeno al primo III secolo 24• Anzi, c'è da ri-
21 Prescindiamo, al momento, da quale possa essere la sua origine. Su iil;ov (Z 306 ), &!;nt (<l> 178, 'l' 467), v d. infra.
22 Ritengo questo preferibile all~analisi di Diintzer 1848, 61, «duo augmenta habuit Zenodotus », seguito da J anko 1992, 66, « Zenodotus ... unaware that llyvuJ.u once began with F, read !;uvÉT]I;&; he introduced this double augment everywhere, perhaps thinking i t a kind of diectasis for -fil; E». van Thiel 1992, 4s., ritiene che quelle in -ÉTJI;E non siano interventi di Zenodoto sul testo, ma forme da lui solamente portate a confronto e in seguito fraintese come suoi emendamenti.
23 È quanto ritiene Diintzer 1848, 61 (naturalmente non in riferimento ad iperionismi, ma al «doppio aumento»). In Horn. t 539, ove i codd. recano miXÉvnç ni;E, Herodian. :rt. JlOV • .:t&ç. n 921, 32 L. ha ntJx.i:v" ~/;E, altra traccia di intervento ionizzante, forse dovuto allo stesso Zenodoto (sempre attraverso copie con iperdialettismi). Weir Smyth 1894, 469 e n. 2, discutendo di ni;E in Horn. 'l' 392 e t 539, afferma «Zenodotos read b]i;e, cf. E 316». Non so da dove lo abbia ricavato: in E 316 abbiamo énl;e, e né gli scolii,.né altra tradizione indiretta comunicano lezioni alternative (forse c'è alla base Diintzer 1848, 61 n. 41 [su 'l' 392]: « Zenodotus scripsit fortasse t:rt:rtEtov o· ol ~/;E»). Analoghe preferenze di Zenodoto per gli iperionismi sono testimoniate dagli scholl. Horn. A 56c, 198b1-1 òpfi~o per òpiho (la prima poteva facilmente esistere come forma di ÒPTJJ.Lt: in una scrittura priva di segni diacritici Zenodoto non l'avrà riconosciuta come tale), 530a XPTJ~òç per xpiltòç: in entrambi i casi viene sottolineato che Zenodoto credeva (falsamente) di porre una forma ionica. Cf. anche N 824b1 13ouya1E· ZT]vòOowç «13ouyf11E» lità wù fi, 824b2 ZT]vòliowç 1it «13ouyf11E>> ypaq>Et (sulla forma, cf. Frisk, GEW l 257).
24 Collegati ad essa sono, verosimilmente, forme come flyuì..i:T]v (Cali. fr.
vauuy-/vaum-, una iscrizione e alcune forme di ilyvu;n 287
tenere, alla luce dei dati in nostro possesso, che attualmente sia questa la quota cronologica attorno a cui collocarla, pur dubitativamente. Per quanto autorevolmente sostenuta, ha avuto comunque portata limitata, interessando, in sostanza, letteratura intesa come ionica per eccellenza: Erodoto, l'epigramma e, come si vedrà, Ippocrate.
Tale iniziativa, ovunque si situi temporalmente, potrebbe aver avuto conforto da forme come ~l;e Horn. o/ 392, t 539, xa.ti;l;a.ç Anacr. fr. 346, 10 P., xati;l;e Hippocr. Epid. V 26, xa.tTJ"(UtTJç Phoen. Col. fr. 5, 1 Pow. e più volte nel Corpus Hippocraticum, che riflettono una contrazione (di (ea) [ed (ee) ?] dopo iato dovuto alla caduta di digamma) 25, o, negli aoristi, un aumento "temporale" dovuto a perdita della coscienza che il verbo non iniziava per vocale. Naturalmente, questa eventuale pressione varrebbe anche per gli ippocratici x6.tTJ"(JlO. e x6.tTJI;tç, e per l'isolato 6crq>uf]l;, non 'localizzabile', di cui infra.
Dubbi su di un genuino vuum6ç potevano già sollevarsi sulla base di vuuci:ywv in Choer. fr. 9, 2 Bern., dyf] in Arat. 668 (729 v.l.); Apoll. Rh. I 554, IV 941; Numen. SH fr~ 584, 5 Ll.-
inc. auct. 749 Pf.; cf. Hesych. T\ 27 La. 'JÌyaÀi:ov· xoì.oj36v. xa~eayòç. xoilov. ei\9:\.amov) ed 'JÌYÒV (Hesych. T\ 84 La. = xa~eayòç). La seconda forma potrebbe essere un secondo elemento di composto poi reso si 'indipendente'. È probabile che la formulazione della seconda parte di Suda v 54 vaumòç ... 1Ì lìè 7tOtT\crtç xaì ~òv vauay'JÌcrav~a o(hro ypacpet sia riflesso della suddetta operazione. Sulla «manipolazione,. del testo di Erodoto, già in età ellenistica, cf. Cassio 1996, 148s. e n. 10 (con bibl.). Interessante quanto emerge in una lex sacra di Chio, pubblicata da Koumanidis-Mattheou 1985, 105-12 (SEG XXXV 923), e databile attorno al 400 a.C. Alle IL 10s. si legge etvq.! [lìe] ~au~a ~au~la xq.! o~av tpov xa8mperocrtv (il séguito è alquanto lacunoso). Sull'ultima forma verbale gli edd. notano «éxet i'Jiìll xa~axropT\8&1 cr~à :\.el;txà à1tò cptì.o:\.oytxèç ltT\Yèç, 7t.x. :EocpOXÀÉouç "FUxrpa, crnx. 1141 >>. Ma in Soph. El. 1140 (non 1141) è una forma di livatpi:ro, ovvero livelÀ.Òf!T\V (in Eur. El. 1143 è, invece, xaerue ~aiipov). Poiché è probabile che la procedura prevista nell'iscrizione sia di purificazione, ci si aspetterebbe un cong. di xaeaipro: se non si voglia pensare ad una confusione tra i due verbi, è perfettamente adeguata l'annotazione di Peters 1985, 365 (G 482) «wohl hyperion(isch) ».
25 Cf. Peters 1980,271, 275 n. 227,283 n. 236, 331 add. ad pp. 256 e 268, 332 add. ad p. 302. L'(ea) che troviamo nelle iscrizioni ioniche sarebbe «historische Schreibung», che nasconde un'avvenuta contrazione. Dati anche in Hoffmann 1898, 461-63 (cf. 459) e 471-74, Solmsen 1893, 520. Questa possibilità mi viene suggerita da Emilio Crespo Giiemes.
288 Emanuele Dettori
J.IP.; AG VII 699, 6 (adesp.)26; ncptfiyf]v Arat. 688 27, ncptfiyÉ~>ç Meleag. AP VI 163, 3: tutti autori in cui ci aspetteremmo una coloritura ionica 28.
Appare ragionevole, a questo punto, considerare iperionici anche xéttrmw. e xéttr]l;lç del corpus Hippocraticum 29• Data la stratificazione cronologica e altra del corpus sarebbe azzardato avventurarsi in illazioni se gli iperionismi dipendano dall'autore o dalla tradizione. Che di ciò si tratti, è comunque pressoché assicurato dal vocalismo a dei termini finora elencati, da quello delle poche occorrenze di xéttayJ..La, che si presenta sempre in questa forma fuori dal corpus Hippocraticum (cf. LSJ 887a), insieme al dettato di Ammon. diff voc. 255 Nickau xéttatJ..I.tJ..I.a xaì xéttayJ..La otacpf:pct. xéttayJ..La J..LÈV { tò} f:xtstUJ..LÉVroç tò xatsayòç xai cruvtf:tplJ..LJ..LÉvov, xéttUYJ..I.U oÈ !3paxtroç tò toù èpiou EA.xucrJ..La 30• Con l'allungamento in composizione noi ci attenderemmo comunque XU'tTJYJ..LU: poiché non lo ritroviamo, se non nel corpus Hippocraticum, è evidente che ha prevalso, anche per questo vocabolo, la generalizzazione di fi,
caratteristica della famiglia. A confronto di xét'tT]/;tç si consideri, d'altra parte, il vocalismo di cbwxéttal;tv in Aristoph. fr.
26 Anche a Chio, nel IV a.C., troviamo la forma àyi]: SEG XXII 508 A I 17, II 50. In tragedia, in posizione metrica indifferente o indecidibile, ma dobbiamo supporre con vocalismo lungo, àyiJ è in Aesch. Pers. 425; Soph. fr. 969 R.; Eur. Suppl. 693; adesp. trag. fr. 583a K.-Sn. Cf. anche xu,.mwayeìç in Soph. OC 1243, non significativo per il timbro vocalico, perché in sezione lirica.
27 Ricondotto ad nyro da Frisk, GEW I 13, ma cf. Herodot. I 185, 6 1repì MJ.màç 1toì..Aàç àyvui!Evoç (se. 7tO~nl!òç) e Arat. 46.
28 Di grande rilevanza è àdytç in Horn. ì.. 575 (ripreso da Theocr. XXIV 123 ùdyeìç ed Apoll. Rh. III 1251 àdytç), che conviene però introdurre più tardi nella discussione.
29 xli'tlJYI!n: Aphor. V 22; Liqu. I 2; VI 6; Morb. II 23, 2; 24, l; Morb. I 6, 10; Fract. 1; 4 (ter); 5 (quater); 6 (ter); 7 (bis); 8; 9 (ter); 13; 16 (ter); 17; 21; 23; 25 (bis); 30; 31; 45; 47 (bis); Mochl. 17; 35; VC 4; Off 12 (bis); Art. 14 (bis); 27; 33; 37 (bis); 69. xan]!;tç: Alim. 43; Fract. 24; Art. 14 (ter); 33; 35 (bis); 39; 49. La forma xn~ny-, a stare agli apparati, è in Loc. hom. 32, 1 (Cornarius: vv. Il. xn'tlJyupln A, xn~ay1n V; ma si tratta di una sorta di titolo del capitoletto, forse non originale); Aphor. cit. (v.!. in Y); in una delle occorrenze di Fract. 4 (v.!. in B); xa'tlJI;tç è sempre tràdito con TJ.
30 Per quest'ultimo, da xn~ayw, cf. Soph. Trach. 695, Aristoph. Lys. 583, 584, Philyll. fr. 21 K.-A., Plat. Pol. 282e5.
vauay-/vaul)y-, una iscrizione e alcune forme di llyvwu 289
100 K.-A. (e le testimonianze lessicografiche addotte dagli editori, PCG III 2, Berlin-N ew Y ork 1984, 77), che conferma il quadro finora delineato.
Ciò, converrà specificare, non significa rifiutare l'esistenza di vauT)y- e x6:rrmw a un certo punto, forse anche abbastanza alto, della storia della lingua greca: si tratta solo di identificarli come iperionismi 31 .
Una qualche attenzione merita il solitamente trascurato òcrq>ufjl;, attestato solo in una pericope del Lexicon de spiritu, p. 209 Valckenaer (ed. Li p s. 1822 = 234 ed. Lugd. Ba t. 1739): òcrq>ufjl;, ò xooacr~évoç xnì àcr6Bvi]ç 't'IÌV òcrq>uv. EX toii uyro, ul;ro, o ÒT)ÀOÌ tò XÀ.iii. cbç tò
yepovtoç òcrq>ufiyoç. La struttura del termine, la cui etimologia tràdita del secondo elemento non pare da mettere in dubbio 32, è quella di un composto con Wurzelnomen deverbale 33: il suo T), in altre condizioni atteso allungamento in composizione (cf. ~1tT)Àuç, xroÀTJ'Jf), potrebbe determinare qualche perplessità, rispetto al quadro che si è sopra delineato. Tuttavia la costruzione non sembra avere molte chanche di essere antica, appare anzi ad hoc34• Il contesto che riteniamo evocato dall'emistichio, si badi giambico, riportato dal Lexicon de spiritu, è di erotismo comico o, appunto, giambico, forse più precisamente relativo a prestazioni sessuali 35. Non ci stupiremmo se questo nome di tale struttura, il cui tipo era sentito come arcaico, sia stato "creato" per il nostro caso, a scopi comici o parodici. E che abbia subito, nel vocalismo finale, la pressione di analoghi composti, peraltro semanticamente i più vicini, come l'attivo ~OU1tÀfjl;, e soprattutto i passivi oicrtpo1tÀfjl; e 1ta.pa.1tÀfjl; 36 • A meno che non rifletta anch'esso un iperionismo (giambo ellenistico? 37). In ogni caso, òcrq>uf]l;,
31 Cf. Cassio 1993, 905: «ci si è resi conto da parecchio tempo che gli iperdialettismi possono benissimo essere non fenomeni creati a tavolino ma realtà linguistiche autentiche».
32 Cf. Chantraine, DELG 834. 33 Su cui vd., e.g., Chantraine 1933, 4s., Risch 1974, 194s. 34 Cf. e1tfjì..uç in Eur. Cycl. 680 e Chantraine 1933, 5. 35 Anche per questo non saremmo inclini ad approvare il riferimento del
nostro frammento ad Aesch. fr. 361 R. eç òcnpuaì..yoùç xcbouvoc:mét&oç ì..uypoii l ytpovtoç (Iolao ?), visto benevolmente da Radt 1985, 424. òcrcpufJI; ci sembra designare qualcosa di diverso e più proprio ad una impietosa descrizione comica, rispetto ad òcrcpuaì..yflç: non so se i due termini siano intercambiabili. Inoltre, dovremmo ritenere casuale, perché in realtà non continua, l'impeccabile sequenza giambica tràdita dal Lexicon de spiritu.
36 Cf. lo strano metaplasmo di xroÀ'liJI in xroì..11l; ( -xoç). 37 Knox 1929, 40, attribuiva il frammento ad Ipponatte, combinandolo
290 Emanuele Dettori
qualunque fosse il sentimento del suo legame con uyvwn, per la sua struttura facilmente poteva risultare estraneo al sistema degli altri suoi derivati nominali, e seguire, quindi, strade indipendenti.
Fino a qui ci si è mantenuti su di un piano il più possibile "fenomenologico", e su di esso sono state tirate le conseguenze. Ma è possibile avanzare ipotesi sull'origine ultima dell'a secondario che abbiamo visto caratterizzare i derivati nominali della famiglia di a:yvwn.
Per ciò è necessario introdurre le forme verbali, alcune delle quali presentano peculiarità dello stesso tipo 38:
A) aoristo intrans. in -'11-: hanno la lunga Horn. A 559 è<hlli Aristoph. Ach. 928 xatuyij 39; 944 xatuyeill; fr. 620 K.-A. xatuyij 40; Apoll. Rh. IV 1686 èl;uydcra (G). Inoltre, in una serie di variae lectiones in Ippocrate. lvi troviamo, per questo tema, normalmente le forme xatay- e xan:ay-, ma xatelly- 41 è tràdito, mai unanimemente (se non in artic. 86), in fract. 17, 18 (ter), artic. 14, 18, 50, 69, 86 (xa't'lly- infract. 7, 17, 18, artic. 14, 37, 40, 50 [bis]). Interessante anche la variante registrata nello schol. ET Horn. e 385 nvtç !!Staypacpoucrt Èayev: per Èa/;ev a chiusura del verso. Per la breve, attesa in questo tema verbale, cf. àyll in Horn. r 367, n 801, àyev in Horn. il 214, èayll in Horn. N 162, P 607, x 560, À 65, Theocr. XXII 190, Apoll. Rh. III 954 (se la lezione tràdita è corretta), AG XV 10, 3, Èayllcrav in adesp. epic. fr. 4, 7 Pow., xamyÈvtoç in AG XVI 187, 342 .
con il frammento eschileo, tramandato da Plutarco (cui imputava un errore di memoria nella menzione dell'autore), e con l'attuale Hippon. fr. 11 Deg. wùç l't.vlipaç 101houç òlii>v11 tma.Utpemaet. Il risultato, che diremmo aberrante, è i] li' òcrcpufiya xaì òouvocrmili' alpei1at l yépov1a (vooliòv ...... xchepòcpOa.A~ov).
38 Ci limitiamo alla recensione dei dati utili per la discussione. 39 Sulla costituzione testuale del verso cf. Dover 1977, 139. 40 In Aristoph. Vesp. 1428 xawiy11 il metro consente anche la breve, ma i
paralleli garantiscono la lunga. 41 Su xa1eay- e xa1B11Y· in forme non dell'indicativo, vd. infra. Si rammenti
che non per tutte le opere del corpus abbiamo edizioni che abbiano sostituito quella di Littré.
42 Ci si è limitati ai luoghi ove la prosodia sia garantita metricamente.
vuuay-/vaul)y-, una iscrizione e alcune forme di ilyvujlt 291
B) perfetto: Hes. Op. 534 e Sapph. fr. 31, 9 V. ~ay~::; Herodot. VII 224, l xat&Tt'Yòta; Aristoph. Pl. 545 xat&ayòtoç 43; Choer. Sam. fr. 9, 1 Bern. Myòç; Arat. 46 Myroç44• Nel corpus Hippocraticum, su 43 occorrenze relative al tema del perfetto, anche solo quale v.l., si trovano napÉay~:: e èmèay~:: in mochl. 40 (unanimemente tràditi), e varianti in -~::ay- in Epid. II 2, 9; artic. 35, 68; fract. l, 3, 4, 7 (Galeno), 15, 26. La forma -~>mricorre 36 volte (escludendo quelle restituite per congettura). Quella in -m- si ritrova, senza la concorrenza di -~>m-, in art. 35, fract. 1, 3, 15, se no in fract. 36.
C) presente: Hippocr. fract. 26 xatT]yYU).I.&va; 45 xati]yvutat (MV); XU'tTJ'YVU).I.&Va ( codd. praeter V); artic. 49 xati]yvutat (MV); 67 XU'tT]yY\l).I.ÉVOtcrt (B);
D) aoristo sigmatico: la lunga è reperibile nelle lezioni çuvèT]ç~::v (Horn. N 166) e xat~::i]çuf..L&V (Horn. N 257) di Zenodoto (vd. supra, p. 286s.), nonché ~T]ç& in t 539, riportata da Erodiano (cf. n. 23). Inoltre, l'accentazione di alcuni di questi aoristi indicherebbe la prosodia lunga: Horn. Z 306 &çov 45; <I> 178 &çat (ma solo 0 20 8U 4) 46; Eur. Suppl. 508 xatclçat; Aristoph. Lys. 357 n~::ptxatiiçat (Dindorf: -!lçat Rr); Phryn. fr. 73,
Nella prosa attica le forme sono sempre con -a-: cf., ad es., Lys. III 14, 40, Andoc. I 61, Plat. Crat. 398bl, Gorg. 469d6, /G lP 1673, 31, 33, 39 (tutte di xu~ayvuilt).
43 In Eur. Cycl. 684 xa~éaya, Aristoph. Ach. 1180 xa~taye, Thesm. 403 xa~éayev, Mnesim. fr. 7, 7 K.-A. xa~eayò~a la lunga non è metricamente obbligatoria, ma tutte le altre forme di perfetto citate la rendono certa.
44 Sono gli unici luoghi valutabili prosodicamente, almeno fino all'ellenismo compreso. Niente si può decidere a riguardo di Phoen. Col. fr. 5, l Pow. xa'tT]yuiTJç, anche se è probabile che, considerato l'autore, 1J di XU'tl']- sia contrazione « neoionica » di -eTJ-. La prosa attica ha sempre -eay-: cf., ad es., P lat. Crat. 389b2, Gorg. 469d6, 515e8, 524c8, /G P 422, 34, 37; 425, 11 (ca. 414 a.C.).
45 Cf. Herodian. n:epi &xpovwv II 14,20 L. ~ò Iii; «iìçov lil'J frxoç Ll.toiliJiieoç», xaì ~ò xpiiçov èx~Etajlévov txoum ~ò a. Cf. anche schol. Horn. :E 521. La tradizione manoscritta sia diretta che indiretta è divisa [v d. addenda].
46 La scelta di scrivere &l;at per ill;at 1h 'l' 467 è degli editori, contrariamente alla testimonianza concorde della tradizione manoscritta [ma vd. addenda]. In molte trattazioni del verbo si ritrovano, come avremo anche occasione di vedere, grafie di forme sigmatiche, come M.l;a, che danno per scontata la prosedia lunga. Essa, in realtà, non è in nessun modo assicurata.
292 Emanuele Dettori
4 K.-A. xa'tiil;ut; Apoll. Rh. III 96 &i;ut (ove la tradizione manoscritta sembra concorde).
La attuale valutazione delle forme sentite come problematiche tra quelle appena menzionate si può riassumere nei modi seguenti:
Le occorrenze ippocratiche di presente (sez. C) sono da tempo riconosciute come iperionismi47.
La lunga del tema del perfetto (sez. B) è sempre stata considerata non problematica, come se fosse « lautgesetzlich »,
per cui lo ionico avrebbe regolarmente -ETJY-1-TJY- (Erodoto, Corpus Hippocraticum, e, probabilmente, Fenice di Colofone). Ma sorgono diversi problemi riguardo all'aspetto di più di una forma. Se quelle attiche di Eur. Cycl. 684 xa'tÉfiyu, Aristoph. Pl. 545 xa'tECiy6'toç (e, con tutta probabilità, Aristoph. Ach. 1180 xa'tÉCiyE, Thesm. 403 xa'tÉfiyEv, Mnesim. fr. 7, 7 K.-A. xa'tEfiy6'ta), potrebbero eventualmente spiegarsi con la Ruckverwandlung48 (cf. vEfiviaç), più complicate sono le cose con Hes. Op. 534 MyE, Choer. Sam. fr. 9, l Bern. f:fiy6ç, Arat. 46 èayroç, tanto più in presenza dell'attestazione, in letteratura ionica, di -ETJy-. Le ultime due occorrenze non hanno ricevuto, che io sappia, attenzione, la forma esiodea, invece, è stata considerata attica o eolica 49•
La questione è più problematica di quanto possa apparire, essendo in gioco, oltre che il vocalismo, la quantità della sillaba. Tutt'altro che trasparente è, infatti, la Stammbildung dei perfetti da radici in a. Un rompicapo con cui si è cimen-
47 Cf. Weir Smyth 1894, 470. 48 Vd. infra, p. 296 e n. 65. Ovviamente, concedendo, per il momento,
che la lunghezza radicale sia attesa. 49 Cf. Wackernagel 1885, 274 (attico: correggere in ì\lJys), Schulze 1892,
264 n. 5 (attico), Weir Smyth 1894, 470 (attico [o eolico ?]), Chantraine 1958, 18 (attico), West 1966, 82 (sulla cui peculiare posizione vd. n. 69), Hiersche 1966, 4s. (eolico), Edwards 1971, 113 (che menziona West, ma anche Hiersche), Palmer 1980, 104 (eolico), Janko 1982, 168 (eolico). Per un tentativo di spiegazione come allungamento metrico, a partire da una clausola esametrica ''(MEA.s) pnypoç, con pnypoç (cf. ai. vajra~) etimologicamente collegato ad liyvuJ.n, cf. Watkins 1986, 325 (varrebbe anche per l'aggettivo atiyéç, di cui infra). Il raccordo etimologico, ma non l'interpretazione del nome MEA.éaypoç, trova l'accordo di Pinauh 1993, 177-79.
vuuay-/vuum-, una iscrizione e alcune forme di llyvu~u 293
tato già Saussure 50, costituendo un difficile banco di prova per il suo celebre « coefficient sonantique » (poco più tardi noto come « laringale » ). Di una serie di perfetti (ad es., come li elenca lui, Ài:Àà.9u, XÉXfiÒU, 'tÉ'tà.XIl, EuOU, crÉcrll1tll, ).!E)lllXcOc;,
E7t't11XU, Ea.ya., 7tÉ1tll"fU, AÉAllxu, EÌÀll<pu, xÉXll<pE), si aspetterebbero forme del tipo ''A.Uroeu (*le-loH-, in trascrizione più moderna 51 ), in ragione dell'originario grado o del perfetto. Si trova quindi costretto alla formulazione di tre ipotesi di spiegazione, di cui due di natura analogica 52.
La laringale nella struttura della radice di iiyvu)lt è data per scontata, con una qualche cursorietà, da Rosén53• Ancora a proposito del nostro verbo, Ruijgh 54 ricostruisce forme di partenza ''weH2g- e >:-woH2g- > r=Uy- rispettivamente per il futuro da lui trascritto (w)ak-so e il perfetto (w)é-(w)ag- 55• Esse avrebbero condotto, combinandosi con il modello di pag-: pag-, a un presente (F)Iiy-vu-)lt quando ci si attenderebbe, a suo parere, *uyvu)lt ( < '~w H zg-), evidentemente per l'esito di digamma + laringale 56• A parte tutte le questioni di carattere teorico (ad es. la supposizione e l'esito di oH2), l'asserita presenza della laringale non viene in alcun modo motivata. Anche Beekes 1988,
50 1879, 154s_ In generale sull'Ablaut afro, vd. Peters 1980, 1s. e n. l (con bibl.).
51 Non specifichiamo la laringale, in quanto vi sono opinioni diversificate sulla natura delle laringali in caso di esito di timbro o.
52 l) «est-ce que, avant la contraction, ea s'est substitué à oa? »; 2) azione del presente sul perfetto ?; 3) alternanza di una I sg. ;\.IWi9a con una III sg. *ì..Mro9e, con generalizzazione dell'o.?
53 1962, 146 (non vi è alcuna argomentazione). Cf. anche Schmitt-Brandt 1967, 14, 91 (liyvuJ.Lt da un grado zero *wH-,g-; radice con «g-Erweiterung » ),
Lubotsky 1981, 135, Hamp 1988, 90s., Ringe 1988-90, 85s., Darden 1990, 65, Vine 1998, 692 (quest'ultima è cortese segnalazione di Martin Peters). Sui dati ittiti e tocarii (wak), cf., rispettivamente, H.C. Melchert 1994, 68s., 80s., 147s., e Ringe 1996, 120 (quest'ultimo decisamente favorevole ad un'ipotesi laringalistica).
5< 1988, 459. Cf. già Ruijgh 1976, 345 n. 36; Ruijgh 1978a, 94. 55 Ruijgh aderisce all'ipotesi che -oHr dia esito -d-. La prosodia da lui
indicata per il futuro non ha alcun riscontro. 56 D'accordo è Hackstein 1995, 131s. Ma cf. Beekes 1988, 22s., Darden
1990, 61ss., e Schrijver 1991, 161-72, per la vocalizzazione della laringale in caso di sonante in Anlaut.
294 Emanuele Dettori
31s., nuene che ea:yt: rimandi ad una radice con laringale: ':·weh2g-/''wh2g-, che spiegherebbe regolarmente la prosodia.
Molto più organico e impegnato risulta il tentativo di spiegazione della Kimball 57, riguardante tutta la serie di perfetti con vocalismo -a.- (ion.-att. -TJ-) alternante, in altri temi, con -11-. Dopo aver osservato che questi perfetti fanno parte di una classe morfologicamente produttiva (costituiscono, insomma, un piccolo sistema), elenca quelli reperibili nell'epica e nella lirica arcaica (pp. 242s.; alla I sg. dell'incl.): 'tÉEh]Àa, ÀÉÀT)9a, ÀÉÀTJXU, JlÉJlTJXU, 1tÉ1tTJYU, <JÉ<J'T)1tU, tÉtT)XU, tÉEh]1ta, XÉXTJV<l, e, a parte, Mya, Moa, OÉOTJa. Saggiamente la Kimball non impone un'origine laringalistica a tutte le radici in questione. La argomenta, però, per il nostro verbo: riscontrando un'alternanza a : ro : a (MI; a : iroyf], Èmroyf], XUJ.Latroyf] : llyvUJlt, UYTJV ), ricostruisce, rispettivamente, >:·weH2g-: ''woH2g-: ':·wH2g- 58•
Ma il XUJ.Latofiyt:iç di Soph. OC 1243 avrebbe forse dovuto indurre a maggiore riflessione. Se non si tratta di una «distrazione» artificiale, del tipo xÉap f- xfip (e non v'è ragione cogente di crederlo), il composto può anche suggerire che ro in XUJlU'troyf] 59 sia esito di contrazione, riverbera tosi sulla formazione di iroyi] ed Èmroyi], con il primo frutto di cattiva divisione del secondo (È7t-troyi])6D.
57 1988, 241-56. 58 Analogo ragionamento è in Hackstein 1995, 130 n. 77 (cf. anche DGE
I, Madrid 1980, 29c). La prosodia lunga asserita per il tema di aoristo sigmatico, se esiste, appare secondaria (vd. infra, pp. 299s-). Non ha ragione d'essere una ricostruzione *weH2g-.
59 Herodot. IV 196, 1; IX 100, l; Democr. fr. 164 D.-K. 60 M. Peters (per litt.) ipotizza, a questo proposito, l'influenza di iroxfj.
Del resto, il rapporto di formazioni nominali di li-yvu1-n con le onde (o con il mare in generale) è ben più frequente che l'isolato caso di iro-yfj in Horn. l'; 533, ove si tratta di «frantumare" l'impeto di Borea: si può ipotizzare una sequenza cronologica con iro-yfj alla fine. Per iro-yfj originario (* FtFtwyij), contro tmro-yfj, è Wackernagel 1878, 292. Più prudente della Kimball era stato Saussure 1879, 155. Estrema cautela sulla correlazione etimologica di a-yvu1-n e !ro-yfj è in Beekes 1988, 31s. (ma, mi sembra, solo perché lo costringerebbe ad ammettere un esito •·ah2 > o). Da ultimo, per !w-yfj da una falsa segmentazione di émro-yfj, cf. Vine 1998, 692s. (influenza, forse, di irofj: cf. 6. 276, A 308). Per il vocalismo radicale, come si è visto (n. 53), Vine accetta la ricostruzione con laringale (con -o- oppure -a-), ma non discute, nemmeno lui, il sofocleo xujlawuye"iç. È da tener pre-
vuuay-/vaum-, una iscrizione e alcune forme di O.yvu~J.t 295
Sembra, in generale, non si possa raggiungere sufficiente determinazione nel ricostruire la struttura delle radici di questo tipo in direzione laringalistica 61 . Ma il più interessante risultato nell'articolo della Kimball sta nel fatto che, al di là della struttura originaria della radice di questi verbi, il loro tema del perfetto viene giustificato mediante un livellamento analogico. Per l'atteso grado o, di una regolare alternanza qualitativa, avremmo l'introduzione di un «secondary quantitative ablaut» (o./a.), la cui formazione analogica è acutamente e doviziosamente argomentata dalla Kimball. Non ripercorreremo qui la sua strada: essa è tortuosa, ma appare sostanzialmente plausibile62 •
Anche ammettendo tutto ciò, saremmo arrivati a spiegare
sente che l'astratto semplice ha sempre la forma ayiJ. Non so se possano entrare in gioco anche Hesych. 1t 1962 Schm. Jteptr.ilyuva· tmcrcrrotpa· o! òè taç XVT]~J.\aç, ut JtEptltfJyvuvtm tai:ç li~J.~mç e ro 18 Schm. royuvov· XVTJ~J.Ìç li~J.~T]ç: ovviamente « fratti» in quanto non rettilinei (cf. ayvu~J.Evoç in H ero do t. I 185, e Jtept!iyfJv in Ara t. 688). Ma tali termini sono ricondotti ad ayro (f- ay-royiJ) da Frisk 1938, 17s., con l'assenso di Chantraine, DELG 1297.
61 Non la considerano, per quella di ayvu~J.t, Jasanoff 1978, 41, e Melchert 1984, 12 («o ne could also assume ''weh2g-, but evidence for "·a in this root is weak»; più possibilista in 1994, pp. 68s., 147s.). M. Peters (per litt.) mi fa notare: « die hethitische Evidenz ist einem Ansatz *wag- vielleicht sogar giinstiger als einem Rekonstrukt ''wah2g-: hier hat ... das etymologisch zugehorige waa-ki 'beisst (ab)' mit einfachem -k- ein anderes Aussehen als sa-a-ak-ki 'weiss' mit doppelt geschriebenem -k-, das man in der Regel auf *soh2g- zuriickfiihrt». Nel nostro caso, si osservi a margine, la presenza di una laringale nella radice metterebbe in crisi il rapporto etimologico tra ayvu~J.t e ai. vajra~ (av. vazra-), che viene normalmente accolto (cf. Mayrhofer 1995, 492). Ci si attenderebbe allora ''·vijra~ (l'accento, come in vajra~, sarebbe ritratto probabilmente per sostantivizzazione), soprattutto se, come ritiene Watkins 1986, 327s., si tratta in origine di aggettivo con suffissazione « Caland ». Infatti, questa etimologia è decisamente rifiutata da Hackstein 1995, 130 n. 77. Ma un esito ai. vajra~ (av. vazra-) di *wahd,ro- potrebbe essere difeso dalla "Lex Lubotsky", cf. Lubotsky 1981, 135 (per i termini arii) e 136 (per la formulazione della regola), tenuto presente da V in e 1998, 692 n. 27. Alla possibilità di una forma originaria *wahd,ro- mi accenna Martin Peters (per litt.), rimandando a Weiss 1993, 76 n. 3, e a de Lamberterie 1996, 135-52.
62 Genericamente per una origine analogica dell'a di &aya è Sihler 1995, 573s. Un cursorio accenno alla secondarietà della lunga nel perfetto è in Watkins 1986, 325 (che legge edy1J, perfetto, in Horn. A 559). Cf. anche Wyatt 1969, 79.
296 Emanuele Dettori
la lunghezza, ma non il timbro del vocalismo 63 : che è un problema non solo in Esiodo, ma, direi, anche in Cherilo ed Arato64.
Ovviamente, sono da prendere in considerazione i tentativi di soluzione avanzati in relazione ad Esiodo, ovvero eolismo o atticismo. Quest'ultimo secondo la seguente trafila: •:·FEFllYU e quindi, in seguito alla scomparsa di digamma, Ruckverwandlung Mya 65. Ma non si può non tener conto di Choer. Sam. fr. 9, 1 Bern. suyòç, Arat. 46 suyroç. Avrebbero essi questo vocalismo se veramente in ambito ionico fossero stabilmente esistite forme in -ET]-? Le possibile spiegazioni potrebbero essere: 1) si tratta di ulteriori eolismi o atticismi, il che sembra francamente improbabile, 2) la forma esiodea (ammettendo, pel momento, che sia eolica o attica), per una qualche ragione, si è imposta come modello ineludibile all'epica successiva (rarità delle attestazioni del verbo semplice, per lo meno al perfetto ?), 3) data l'evidente dipendenza delle due clausole in questione da Horn. A 559 ÙJ.L<pìç sdYT] (Choer. Sam. fr. 9, 1 Bern. UJ.L<pìç suyòç, Arat. 46 ùJ.L<pi -r' suyroç), i due poeti potrebbero aver modellato il vocalismo del perfetto sull'aoristo di Omero (di cui infra)66,
Naturalmente i problemi sono minori se si accede all'interpretazione di Peters, che la Ruckverwandlung nota come attica abbia coinvolto anche la Ionia occidentale (almeno in determinati contesti: -ptiv-, -pCJF-, r _ tr, e_ (X) bisill., # e _) 67. Egli ricorda (1995, 196 n. 35), oltre all'esiodeo My&, eti06'ta. di Horn. I 173, cr 422, e le varie forme eucr- di i:él.oo, che confronta con Hesych. e 618 La. é11crov· éa.crov. L'ipotesi presuppone, però, notevoli complicazioni: bisogna in qualche modo aderire alle conclusioni di Peters, di una redazione di Iliade ed Odissea ad opera di un
63 Significativo Beekes 1988, 31, << the vocalism of the perfect is secondary ... , but the length will be old ».
64 Non altrettanto, ovviamente, sarebbe per il luogo erodoteo e le occorrenze ippocratiche. Riguardo a quelle attiche, cf. supra, p. 292.
65 Per questo passaggio, proprio in relazione al perfetto di à.yvu~u, cf. Solmsen 1893, 519, Hoffmann 1898,343, Brugmann 1900,32, Pisani 1971,58, Ruijgh 1976, 345 n. 36, Peters 1980, 302.
66 Un'altra possibilità è che abbiano letto in A 559 un perfetto (quale, del resto, è stato congetturato).
67 Peters 1987, 229; Peters 1993, 93 n. 27; Peters 1995, 194-96 e nn.
vaufiy-/vau7JY-, una iscrizione e alcune forme di O.yvwn 297
Omero di madrelingua ionico-occidentale 68 , ritenere che tale patina linguistica abbia indirettamente influenzato Esiodo (il perfetto di ll:yvwn non è attestato in Omero), o ricorrere a tradizione epica perduta in dialetto euboico, e, infine, concludere che tale tratto linguistico si sia conservato determinando, attraverso Esiodo o altro, le forme epiche fino almeno a Cherilo e Arato 69 • Senza dire, per quanto riguarda uno degli altri esempi riportati da Peters, che l'é11crov di Esichio è del tutto isolato, e per esso sembra valere quanto nota Latte in apparato: «videtur hyperionice dictum, 7o.
Egualmente complessa appare la questione delle forme di aoristo intransitivo (sez~ A): tutte, infatti, testimoniano indiscutibilmente una breve per questo tema, tranne Horn. A 559, la variante Mysv in s 385, le occorrenze aristofanee e Apoll. Rh. IV 1686 (f:l;iiysi:cra, v.l. in G )71. Si vedano, per la breve, llyT] in Horn. r 367, I1 801, àysv in Horn. ~ 214, M.yTJ in Horn. N 162, P 607, x 560, 'A 65, Theocr. XXII 190, Apoll. Rh. III 954 (se la lezione tràdita è corretta), AG XV 10, 3, Éét.'YT]crav in adesp. epic. fr. 4, 7 Pow., xa'tayÉv'toç; in AG XVI 187, 3.
L'a. delle forme aristofanee viene chiarito con la pressoché completa sostituzione, in attico, del semplice O:yvwn con xa'td'YVU!-lt (< >=·xa'ta-,F(iyvwn) 72•
68 Cf. Peters 1989. 69 Non comprendo appieno l'argomentazione di W est 1966, 82, che sem
bra considerare la forma come possibile in ionico non orientale: « East Ionic has ÉTJYU ... ; but Homer has the alpha-form in the subjunctive Mru [A 559, ove, ricordiamo, è congetturale] ... , an d i t has a parallel in èaliò~a ... the regular change (F)fi > 11 was probably inhibited by the l1 of the other parts of the verb; in Attica, but perhaps also further East» (a West rimanda Kimball 1988, 243 n. 6).
70 Inoltre, le forme wcr- hanno altre possibilità di interpretazione: cf. Chantraine, DELG 309.
71 Anche qualche v.l. nel Corpus Hippocraticum: cf. xa~&TJY- tràdito, mai unanimemente (se non in artic. 86), infract. 17, 18 (ter), artic. 14, 18, 50, 69, 86 (xa~y- infract. 7, 17, 18, artic. 14, 37, 40, 50 [bis]). Ma !'11 dimostra che si tratta, in questi casi, di ipercaratterizzazioni dialettali analoghe a quelle di alcuni presenti (vd. infra).
72 Cf. Wackernagel 1914, 126, Schwyzer 1939, 248, Ruijgh 1976, 345 n. 36, Ruijgh 1978b, 306. Negli stessi termini, per estensione analogica, potrebbero spiegarsi, almeno per il vocalismo, le forme attiche di perfetto, se non per Riickverwandlung. Wackernagel, comunque, applica le sue conclusioni solo a forme prive di aumento (purtroppo, l'unica forma ad aumento, xamiYTJ di Vesp. 1428, non è in posizione tale da chiarire senza residui quale sia la quantità dell'a).
298 Emanuele Dettori
L'gfiyT] di Horn. A 559 è stato o corretto 73 , o variamente spiegato. L'unica correzione che ha avuto un certo appeal è gfiyu (perf. cong.), che sembra risalire ad Ahrens 74: ma essa, oltre a fornire un aspetto stativo all'azione del tutto inadeguato al contesto 75 , non risolve il problema del vocalismo 76.
Altrimenti la forma è stata interpretata a) come atticismo, b) come allungamento metrico al sesto piede, c) come risultato di meta tesi da ':·rv=ayT) (con aumento in TJ-), d) come confusione con il tema del perfetto 77•
A parte merita una particolare discussione Apoll. Rh. IV 1686. La tradizione reca èçiiyeìcru G ed èçeClyeìcra LASPE: la seconda forma è difesa da Boesch, Giangrande e Livrea 78 e accolta nel testo da F. Vian. Le ragioni sono elencate da Livrea: a) la v .l. « antiqua » èl; ... èétl;et in E 161 79, «una ghiotta novità di cui forse Ap. volle appropriarsi» (da Giangrande 1967); b) <<il rapporto paraetimologico sentito dagli antichi fra uyvuJ..Lt e uyro» (da Giangrande 1967); c) «il carattere ionico di èl;eayeìcru >> (da Giangrande 1969) so. In realtà, la grafia -eu- delle forme
73 Rassegna delle proposte in Leaf 1900, 504s. Sull'occorrenza apollo-niana tiçayeicra vd. infra.
74 Ahrens 1852, 247. Cf. anche Bekker 1863, 134 (lo scritto è del 1857). 75 Cf. Monro 1891, 44n. 76 Cf. Weir Smyth 1894,470. Leumann 1955,257 n. 6, non è chiaro: sem
bra favorire il perfetto per il nostro luogo, trova élin ~ ganz undenkbar », alla luce delle altre occorrenze di aoristo in -Tl, ma si trova a concludere che àaytç (ì.. 575), da lui ritenuto, per uso e posizione, del tutto dipendente da A 559, presupponga la lettura di un aoristo in questo verso: « die ecr-Adjektive gehen in der Stammgestalt weithin mit dem 1']-Aorist zusammen».
n Cf., e.g., Wackernagel1885, 274, Monro 1891, 61, Wackernagel1916, 141, Schwyzer 1939, 653, Chantraine 1958, 18, Hiersche 1966, 4 n. l, Shipp 1972, 16, Rix 1976, 227, Bertheau 1979, 80. 47ss., Hainsworth 1993, 284.
78 Rispettivamente Boesch 1908, 23, Giangrande 1967, 97 n. 2 (cf. anche n. 3 ), Giangrande 1969, 184 n. 5, Livrea 1973, 463. La difesa da parte di Boesch, sostanzialmente priva di argomentazioni, si può tralasciare. Possibilista sulla forma come genuinamente apolloniana è Duquesnoy 1891, 108.
79 Testimoni ne sono l' Ambrosianus 450 (a. 1276) e il Parisinus 2767 (XIV sec.): sfuggono le ragioni per cui la lezione possa definirsi << antiqua ». La desinenza -et si direbbe la notoria forma tarda sostitutiva di -u.
80 Già Giangrande consigliava: «cf. Hippocrates' tiçeayelç, quoted in KB II 346 », Livrea fa l'identico rimando aggiungendo, oltre allo stesso Giangrande, Boesch 1908, 23. A parte che l'attribuzione della forma all'ambito ionico è del tutto infondata, né tiçenyelç né alcuna forma di tiç6.yvuJ.n compaiono nel corpus Hippocraticum, e Kiihner-Blass, infatti, non ne hanno traccia (quan-
vaua:y-/vauT]y-, una iscrizione e alcune forme di ll:yvtJilt 299
non ad aumento dell'aoristo intransitivo costituisce un'innovazione reperibile in più tradizioni manoscritte 81 : cf. xcrc&a:yfjvut BTWF a Plat. Gorg. 469d6, xu1:' wyEi:ç M ad Aristoph. fr. 620 K.-A., e, nel corpus Hippocraticum, 29 volte su 56 occorrenze di aoristi intransitivi non all'indicativo82. Un fenomeno che, partito presumibilmente dalla confusione di perfetto e aoristo in -11 83, ha coinvolto anche forme del presente, XU'tcUYVUJ.l.ÉVotcn MV ad Hippocr. artic. 67, dell'aoristo sigmatico, XU'tcclçctc S ad Aristoph. Ach. 1166, XU'tcil!;uv'toç a Lys. III 42 (cf. Hesych. u 5612 La. li!;uv'tcç· xu'tca!;uv'tcç), nonché forme nominali, XU'tcilyJ.l.U'toç MV a Hippocr. fract. 4, che ha paralleli in due papiri del II d.C. (xu'tÉUYJ.l.U) 84. Niente di diverso sarà 1'-roy- della tradizione apolloniana. Quando si sia introdotta questa grafia spuria è difficile stabilire, [Aristot.] Mech. 852b22 ha una forma xu'tcilcrcrc't:Ut, Aesop. 4 e 86 Chambry XU't:Éucrcrc e XU'tcacrcrctv, in un verbo rifatto su aoristo sigmatico e futuro d~ xu'tay~UJ.l.t. ~ comur:q~e d~fficile imputare tale volgarismo _ad Apollomc Rodw 85: e prefenb1le c1tare Wackernagel, « è!;dycicru m1t langem ù nach xu'tùyEi:cru ware sehr verstandlich» 86. Aggiungiamo che sarebbe, in Apollonia, unico poeta a compierla, una ripresa dell'unico, e pertanto prezioso, aoristo intransitivo di liYVUJ.l.l a vocalismo lungo presente in Omero 87.
Per le forme di aoristo sigmatico (sez. D), non sussiste alcun dubbio, considerate in particolare le occorrenze di aoristo intransitivo, che l'accentazione degli esempi attici (Eur. Suppl. 508 xa1:iiçat; Aristoph. Lys. 357 7tEptxa1:à.l;at; Phryn. fr. 73, 4 K.-A. xa1:à.l;at) 88 rifletta un reale vocalismo lungo 89.
to all'opinione degli stessi su questo tipo di forme, vd. n. 85). Lo stesso vale per Boesch.
81 Una dettagliata rassegna delle vicende di tale 'eccezione' nelle grammatiche (a partire da quelle rinascimentali) e il suo trattamento critico testuale negli autori del periodo classico è reperibile in Duquesnoy 1891, 88-108.
82 Sulle scelte di Littré al proposito, cf. Littré 1841, 429 n. 19. 83 Cf. Duquesnoy 1891, 91s., Kiihner-Blass 1892, 346, Weir Smyth 1894,
470, Solmsen 1901, 255s., Schwyzer 1939, 656. 84 Cf. LSJ 922b. Cf. anche Sud. at 3 atay11a· 8pfjvoç. xaì mJV't:Ptllllll (se. WYilll),
[Zonar.] 86 atayjla ò 8pfivoç. ÈllYilll lìÈ 1:ò cruv'tptllllll, ljf!Àòv. 85 C'è da concordare con Kiihner-Blass 1892, 346: «falsche Formen
Konj. xa1:eayfj, etc.», « die Formen xa'trol;av'teç ... èç-eayeicra ... sind falsche und missbrauchliche Dbertragungen aus dem Indikativ, und nur bei Spateren zu dulden ». Mayser 1938, 112, e Mandilaras 1973, 113, che trattano in generale dell'aumento 'spurio', non citano alcun caso anteriore al118 a.C.
86 Wackernagel 1914, 127. 87 Ma ÈdYTJ è v.!., estremamente suggestiva (e direi da eleggere), di circa
metà dei codici nella clausola di Batrachom. 241, per l:xJ,.éJ.crS,. 88 Inappuntabile risulta l'intervento di Dindorf sul neptxa'téJ.I;at tràdito in
300 Emanuele Dettorz
Su Horn. Z 306 &;ov, <l> 178 &;ut vi sono differenti opinioni (per &;m in 'l' 467, cf. n. 46): un atticismo della tradizione 90,
estensione dell'esito di una metatesi di quantità da '~ilal;a (> Éaça -7 &;ov) 91, influenza di xa-riÌyvuJ..tt92.
Viene giustamente rilevato da Kiihner-Blass e Wackernagel93, che Erodiano vuole il vocalismo lungo in Omero basandosi sui tardi rifacimenti analogici iicrcrw e xa-riicrcrw, per cui esso risulterebbe anacronistico. Va osservato, oltre quanto già in Kiihner-Blass e Wackernagel, che in <l> 178 l'accentazione properispomena è del tutto minoritaria rispetto ad à.l;at del resto della tradizione, che l'&<;at di 'l' 467 è opera degli editori, contro à.l;at della tradizione94, e che anche in Apoll. Rh. I 1168 l'abituale scrittura &<;sv contrasta con l'à.<;sv di L e G, a stare all'apparato di Merkel 95. Se si considera che da un determinato momento della tradizione questa forme erano a forte rischio di essere 'naturalmente' lette con l'a, che si era generalizzato, l'accentazione parossitona assume caratteristiche di difficilior 96 •
Aristoph. Lys. 357. Su x6:~11Sov di Aristoph. fr. 605, 2 K.-A., cf. Wackernagel 1914, 126s.
89 Cf. Wackernagel 1914, 126. 90 Jacobsohn 1908, 351, Wackernagel 1914, 127 (o un <<Koinismus»),
Chantraine 1958, 18, 190, Hiersche 1966, 4 n. l. 91 Schulze 1888, 237, ancora Chantraine 1958, 190. 92 Bjiirck 1950, 42, Wyatt 1969, 79, DGE I, Madrid 1980, 29c. Quest'ul
tima ipotesi è normalmente complementare alla prima, considerando la prosadia attica appunto analogica da xcnay- (ma cf. Wyatt 1969, 79).
93 Rispettivamente 1892, 345, e 1914, 127. 94 Weir Smyth 1894, 469, afferma: «&l;at with a taken from the indicative
édé;a». Ancora una volta l'asserzione di un indimostrato vocalismo lungo in forme sigmatiche di aoristo. È opportuno richiamare, qui, Hesych. !} 201 La. ~O:çov· x6:~11Sov (xa~6:E;tov cod.). A6:xroveç: se non la si voglia interpretare come caso di accentazione dorica, ai sensi di Vendryes 1904, 260s., è una testimonianza che, se pure si è data, comunque la lunghezza delle forme di aoristo sigmatico è secondaria, non si presta, quindi, all'uso in discussioni etimologiche e va comunque usata con prudenza in trattazioni di carattere generale.
95 Contro la prosodia iiE;ev si esprime Wackernagel 1914, 126 n. 3. 96 Diversamente Martin Peters (per litt. ): « das tié;at, tié;ev der Hss. in <l>
178, 'l' 467, A.R. l, 1168 besagt wohl wenig, bieten Hss. bei anderen Autoren doch sogar xa~6:E;at (se. ad Aristoph. Lys. 357) ... ; verfeh!t Wackernagels ... ablehnende Haltung gegeniiber einem iiE;ev bei A.R .... ; der Akut mag hier da-rauf beruhen, dass man tiyvu~n in der Antike mit tiyro in Zusammenhang ge-
v!wdy-/vau7JY-, una iscrizione e alcune forme di àyVUflL 301
La prima impressione è che non si possano scindere le questioni di timbro vocalico e di prosodia di queste forme da quanto abbiamo riscontrato nella parte nominale. Riportiamo quindi, alla lettera, le parole di chi aveva argomentato per l'origine secondaria dell'a. in vauayòç (cf. p. 2 e n. 5 ):
Hatzidakis 1900, 591: « das lange d war zu hause bei Mya Ml;a., und es war leicht, nach vaùç xa't&dyuia auch vauayòç vauayÉro volksetymologisch zu sagen» 97;
Bjorck 1950, 41s.: «att. vaua.yòç gegen ion. vamnòç, um den Zusammenhang mit ÈU'YTJ (se. con a.) eaya zu behaupten (vgl. Hatzidakis ... nach Hoffmann ... ) ... xa'tO:rvUJ..n hat durchgehend dasa< a-pa, was auf das Simplex hini.ibergriff, s. Wackernagel, GGN 1914, 126f., Schwyzer 248 »;
Frisk, GEW II 291: «mit Verlangerung cles a-Vokals, teils infolge kompositioneller Dehnung bzw. Analogie (so sicher in io n. -m-), teils auch nach xa'tdyvu,..n, enya » (con rimando a Bjorck) 98;
Hiersche 1970, 151: «a ist normales Kontraktionsprodukt aus a;=a ... in tÌyft ... , vaua.yòç ... (nach att. xa'td'YVUJ.H < xa'ta;=uy-) » (in relazione alle occorrenze tragiche);
Ruijgh 1978a, 94: «P.C. explique de façon convaincante l'a long de vau-a.yòç ... par l'influence du ... xa'td'YVUJ..Ll ... En revanche, nous ne croyons pas que la voyelle longue soit issue d'un allongement. Il vaut mieux partir de '~vau-F(iyòç, forme
bracht hat» (per queste due ultime affermazioni, Peters rimanda a Giangrande 1967, e Giangrande 1970, 265s., di cui forse si fida troppo). Non è inutile segnalare che Hippocr. Mochl. 39 ha xa~al;av~oç, senza traccia di -11- (in un trattato, per altro, privo di forme in -em- o -m- per questo verbo). Riguardo la forma fJI;e in Horn. 'I' 392 (ài;e Vat. gr. 26 e POxy. 15, 1818), ~ 539, vd. le prese di posizione per correggere restituendo i\al;e in Hoffmann 1848, 77 (cf. p. 93), Monro 1891, 363, Weir Smyth 1894, 469, Schwyzer 1939, 654 e n. 2, Bertheau 1979, 80, 45 (cf. Diintzer 1848, 61 n. 41). Probabilmente non sussiste la necessità. Contro tale restituzione, per lo meno in 'l' 392, è Bechtel 1908, 236. Un aoristo xa"tfjl;- è reperibile, proprio in ambito ionico, in Anacr. fr. 346, 10 P. (xa"tfjl;aç) e Hippocr. Epid. V 26 (xa"tfil;e).
97 Cf. Hoffmann 1898, 354: «Um ... den Zusammenhang mit ilyvuflt éliyllv fiihlbar zu machen ». Così espresso non è chiaro se si intenda chiarire solo il timbro vocalico di vaudy- o anche la lunga.
98 Ripetuto fedelmente da Chantraine, DELG 736.
302 Emanuele Dettori
parallele à '1·vau-mxy6ç ... En effet, la racine pfiy- < '~weh2g- était originellement tout à fai t parallele à nay- < ~-peh2g- ».
A queste vanno aggiunte le considerazioni di Wackernagel 1914, 126, sull'origine dalla composizione con xa-ru dell'a nelle forme attiche non ad aumento.
Le asserzioni sopra riportate hanno bisogno di qualche correzione e precisazione, in base a quanto si è potuto osservare in precedenza.
l) Non sembra esistere, originariamente, un ionico -rncontro un -ay- degli altri dialetti, specie dell'attico: ciò vale senz'altro per vauay-, e comunque invita a coinvolgere anche il ionico nella discussione di questo a;
2) La presenza di a in forme dell'aoristo sigmatico di iiyvwn diverse da quelle in composizione con xa-ru non è assicurata in nessun modo, anzi vi sono indizi per escluderla, per lo meno in Omero;
3) Dubitiamo che la lunga del perfetto, qualunque sia la sua origine, possa aver influenzato l'intera famiglia di iiyVUJ.I.t. È, piuttosto, verosimile che tale lunga fosse sentita normale in questo tema e, allo stesso tempo, distintiva: cf. gli aoristi, radicali tematici o intransitivi, tutti a vocalismo breve, paralleli ai perfetti -ré9r]A.a, AÉAT]xa, J..LÉJ..LTJXU, ntnma, crécrT]na, 'tÉ'tT]xa, -ré9rjna, M.Oò-ra, òéòTta, XÉXTJVa;
4) In generale, queste ipotesi, così come formulate, non risolvono il problema della presenza del timbro vocalico a in molte delle forme in questione;
5) Di aoristo in -T]- con la lunga abbiamo pochissimi esempi: Horn. A 559, la variante Mysv in E 385, Aristoph. Ach. 928 xa-rayij; 944 xa-raysiT]; fr. 620 K.-A. xa-rayij. Un'eventuale sua influenza sull'intera famiglia andrebbe perlomeno argomentata99;
6) Infine, riteniamo necessario temperare una argomentazione di Wackernagel1°0 . Egli sostiene che in ambito ionico il
99 Apoll. Rh. IV 1686 è ovviamente insignificante in una discussione di questo tipo. È meglio lasciare fuori le variae lectiones ippocratee.
100 1914, 126s.
vuuuy-/vau!]y-, una iscrizione e alcune forme di llyvwu 303
semplice àyvuvat doveva essere di uso comune, ed abituale, quindi, l'a breve: lo testimonierebbe l'occorrenza, in prosa, di Herodot. I 185 7tepi xaj.l.7tàç; 1toUàç; àyvuj.l.evoç; (se. 7tO'tUj.l.òç;). Da parte sua, l'attico avrebbe il semplice solo in tragedia, e raramente (cita «Euripides», ovviamente Hel. 410 e 1598, e Achae. fr. 26, l K.-Sn.): verrebbe sostituito da xa-rdyvuj.l.t. Conseguirebbe da qui che la trasposizione, nella tradizione di Omero, della lunga all'aoristo sigmatico, di cui Wackernagel sta trattando, sarebbe un atticismo o un « Koinismus ». Questo, nella fattispecie dell'aoristo sigmatico, è senz'altro più che probabile, come abbiamo visto. Ma bisogna notare che Erodoto, in quel passo usa il verbo in un significato particolare, molto raro, «fratto» nel senso di «piegato» (in molte anse) 101, per il quale non si sarebbe in alcun modo potuto usare, tra l'altro, il composto, intensivo, xu-ràyvuj.l.t. Quindi l'occorrenza erodotea, per essere sia singola che semanticamente peculiare, non può, a nostro parere, significare una consuetudine del semplice iiyvuj.l.t in ambito ionico. Sono invece da rilevare xa-ràçet nelle Dirae Teiae (Teo, DGE 710 B 38 Schwyz.) e due occorrenze che W ackernagel non poteva conoscere, xa'tfjl;aç; in Anacr. fr. 346, 10 P. e xa-ral;aç; in un graffito da Kepoi datato fine VI-inizio V a.C. 102• Tali occorrenze, in mancanza, tra l'altro, di contemporanee occorrenze del semplice, farebbero supporre una diffusione di xu-réiyvuj.l.t in ambito ionico maggiore di quanto ritenuto da Wackernagel.
La situazione che abbiamo davanti richiede tentativi di spiegazione forse un po' articolati e pm comprenstvt, pur senza abbandonare spunti presenti nelle ipotesi sopra trascritte.
Una possibilità di spiegazione può partire da un tenue indizio. Sappiamo che le radici in digamma iniziale potevano es-
101 Cf. Arat. 46. 102 Edito da Sokol'skij 1973, 88-92. Cf. anche Johnston 1989-90, 312s.,
che ritiene (p. 314) vi sia una forma di xu~6.yvu~.u anche nel xu16./;avmç su una band-cup di Gravisca edita da Torelli 1982, 311 no. 50. L'interpretazione di Johnston è accettata da Dubois 1995, 173.
304 Emanuele Dettori
sere caratterizzate da un aumento 11- 103 . Assumendo che l'omerico à1Ìy11 di A 559 sia frutto di una metatesi di una forma con tale aumento 104, da tale tarda forma potrebbe essere derivato il nominale àfiyiJç 105, che spiegherebbe benissimo prima di tutto l'ùayéç di A. 575 106 e quindi l'a di tutte le formazioni nominali.
Dei presenti, futuri e aoristi sigmatici è presso che impossibile giudicare, salvo pochi casi (cf. p. 29ls.), stante la posizione dell'a in sillaba chiusa. Potremmo però dedurne l'assoggettamento allo stesso fenomeno, per lo meno in epoca postomenca.
Per i perfetti lo scenario delineato è nettamente improbabile, per ragioni che conviene vedere più tardi, dopo aver
IOJ Cf. Chantraine 1958, 479-81. 104 Come è stato supposto: cf. supra, p. 298. Da rilevare, a margine, che
proprio i verbi inizianti in *FU- in Omero sembrano i più riluttanti ad ammettere l'aumento in TJ- (cf. i dati in Chantraine 1958, 480). Rarissima è, in generale, in O mero, la metatesi TJCl > ed: cf. Wyatt 1969, 144s. Contro l'aumento in TJ-(F-), cf. ora Ruijgh 1997, 618. Molto interessante è la proposta di Martin Peters (per litt. ), che le sequenze del tipo ero-, ed- non si debbano a meta tesi di *TJo-, ""TJa-, ma a fenomeni di sinizesi, da l eo- l, l ea- l, con dieresi secondaria (cf. Peters ap. Méndez Dosuna 1993, 111 n. 29). Tra gli esempi Peters porrebbe l'omerico MyT] (nonché Mv, édì..mv).
105 Sul rapporto tra aoristi in -TJ ed aggettivi composti in -i]ç cf., ad es., Fawcett Tucker 1990, 59-61. La forma àyi]ç è in realtà attestata in Etym. Gen. a 17 L.-L. àayéç· li9paucr~ov· à1tò ~oii liym, tò xM.vm, ci.yi]ç, xaì JJ.età wii é.mtanxoii d àayi]ç x~., ma potrebbe essere creazione grammaticale. Molto più concreta è la possibilità che a base di ci.dyi]ç (ma non per la prosodia dell'a) sia il neutro llyoç, testimoniato da Hesych. a 738 La. (cf.~ 26 La. ~ayoç = Fétroç) ed Etym. M. 418, 2 (per il genere, vd. quest'ultimo: 1tllPIÌ tò liyoç, o O"TJJJ.Clivet x~.).
106 Non si tratterebbe più di considerarlo un allungamento metrico, favorito dal modello, peraltro altrettanto problematico, di é.dyT] in A 559 (benché in ambedue i casi si tratti di p61taì..a), come è sostenuto da Leumann 1955, 257 n. 6; Chantraine 1958, 18; Shipp 1972, 16 (cf. anche Watkins 1986, 325). Leggermente diverso Wyatt 1969, 78s. Fragile ci appare l'argomentazione di Hamp 1988, 90s. Egli parte dal ricostruito *wagr6s (cf. n. 49) e dalla sua parentela etimologica con ai. vdjra~ (Watkins), notando, però, la difficoltà morfofonetica sopra segnalata (cf. n. 61). Ricostruisce, allora, una forma ''wH.g-r6- e, sul confronto con JJ.Clxpòç, oùpavoJJ.TJXT]ç, ritiene àdyéç la prosodia attesa (Hamp non si sofferma sul timbro vocalico). Il presupposto etimologico è problematico, e i dati di confronto sono troppo esigui perché l'ipotesi di Hamp possa riuscire convincente.
vaudy-/vau']y-, una iscrizione e alcune forme di uyvqn 305
esposto la seconda possibilità di origine dell'a, e dopo aver isolato la trattazione di questo tema verbale.
Comunque, anche a prescindere dalle forme di perfetto, la ricostruzione a partire da un aumento 11- degli aoristi intransitivi incontra l'evidente difficoltà dell'essere unica l'attestazione di tfiyTJ in Horn. A 559, a fronte di quasi tutte le altre occorrenze di aoristo intransitivo in -T]-, sia americhe che successive, con l'atteso vocalismo breve.
L'altra possibilità parte dalle forme verbali composte con xa1:éL, soluzione sia pur concisamente già proposta, a raggio limitato.
Per poterla sviluppare bisogna, però, rendere espliciti tre presupposti:
a) la precoce caduta del digamma in ionico-attico; b) che la cc tmesi" già in O mero è un arcaismo o una sorta
di manierismo letterario 107;
c) che l'aumento non era obbligatorio. A partire da questi punti, nonostante prima del V secolo
su 45 occorrenze del verbo, xa'tUYVUJ.tt ricorra solo 6 forse 7 volte, di cui due nella forma eolica xaual;atç 108, più 6 volte in cc tmesi" 109, si può forse supporre la progressiva e vincente influenza del vocalismo dovuto alla contrazione di xa'ta-ay(xa'ta-al;- ), dato che, per lo meno dalle attestazioni dal VI secolo in giù possiamo affermare che questo composto è la forma cc normale" in cui il verbo si presenta 110• Su 54 occorrenze (calcolando anche il graffito di Gravisca e l'iscrizione cretese di cui a n. 111) dal VI secolo a Platone, 44 sono di xa'tliyvUJ.tt, più una in cctmesi" (Sapph. fr. 31,9 V.) 111 .
107 Cf. Morpurgo Davies 1985, 86ss. 108 Horn. N 257, t 283, Anacr. fr. 346, 10 P., le due iscrizioni di Kepoi e
Gravisca citate sopra (l'ultima dubbia); xaua~atç: Hes. Op. 666, 693 109 Horn. e 403, 417, 'l' 341, t 539, Hes. Op. 439s., Sapph. fr. 31, 9 V. 110 Giusta, del resto, il suo significato di «spezzare». Per xata in compo
sizione con questo significato, cf. Lindblad 1922, lllss. Un accenno in questo senso è in Ruijgh 1976, 345 n. 36. Tuttavia in una prospettiva in cui Ci sostituisce un atteso TJ ( < *weh2g-) in iiyVUJ.lt, u~ro e ì'ta~a, non coincidente con quella qui proposta. Cf. anche Ruijgh 1978b, 306.
11 1 Ovviamente la composizione in Saffo avrebbe dato risultati partico-
306 Emanuele Dettori
La situazione di Omero sembra fornire il fenomeno in statu nascendi. Così si può spiegare l'unico f:dYTJ di A 559, a fronte degli altri aoristi in -T)- con l'atteso vocalismo breve, e del fatto che gli aoristi sigmatici sembrano anch'essi preservare l'atteso O.. È da notare che tale situazione ha condizionato la tradizione poetica: tutte le occorrenze di aoristo in -T)- di cui possiamo valutare la prosodia (ovvero quelli attestati in poesia) riflettono, se non sono di ambito attico, lo stato di cose presente nel testo omerico, ovvero hanno tutte il vocalismo breve, anche il xatay&vtoç di AG XVI 187, 3 112•
L'omerico f:dyT) merita ancora qualche considerazione. Essa è l'unica forma di aoristo in -T)- a trovarsi in clausola, al contrario di quanto avviene per le forme di aoristo sigmatico, che chiudono il verso in E 161, N 166, 'P 341, 467, y 298, E 316, 385 (e precedono cesura femminile in H 270, A 114, 175, P 63, t 283, t 539, quest'ultimo con la lezione erodianea), in particolare con la III pers. sing. (~al;~>), la stessa di f:dyT). È molto verosimile che la chiusura di A 559 sia un adattamento di quella più comune con l'aoristo sigmatico, ma non è necessario che tale adattamento comprenda anche l'allungamento metrico. Da quanto si è potuto osservare finora, non è peregrino ipotizzare per la stratificata lingua america la compresenza, ad un certo punto, di due alternative prosodiche: una che prevedeva il vocalismo breve, originario per un aoristo in -T)-, un'al-
lari: cf. l'esiodeo xa.unl;cnç (e vd. infra, p. 308). Non abbiamo incluso il Corpus Hippocraticum, che comunque, per ragioni di lessico tecnico, avrebbe sbilanciato molto di più a favore di xa.tér.yvu1-u la distribuzione delle forme. Le alternative a xatay- sono in [Hes.) Scut. 279, 348 ayvuw, Eur. Hel. 410 ayvutm, 1598 lll;aç, Herodot. I 185, 6 à.yvò~J.&voç (di cui supra), Achae. fr. 26, l K.-Sn. ayvuvteç, Timoth. fr. 791, 12 P. lll;et&v, Choer. Sam. fr. 9, l Bern. tayòç. In !C IV 46 B ls. (Gortyn. in. V) compare la forma òtaF(IXcrat, probabilmente forma di ayvui-H (cf. Guarducci 1950, 105). L'occorrenza, apparentemente unico esempio di *òtér.yvu~J.t, è assente in LSJ.
112 Anche l'eccezione, àçuyeicra di Apoll. Rh. IV 1686, come abbiamo visto, dipende in ultima analisi dalla situazione del testo omerico. Non è forse senza significato che le clausole di Choer. Sam. fr. 9, l Bern. Ò.~J.cpiç Myòç e Arat. 46 Ò.IJ.cp( t' èfiyroç, dipendenti, si direbbe, dal nostro A 559 Ò.~J.cpiç tiÌyTJ, prevedano però il perfetto, la cui prosodia lunga era accreditata, mentre il contrario avveniva per l'aoristo in -TJ.
vauCìy-/vaUJJY-, una iscrizione e alcune forme di ayvu~J.t 307
tra con quello lungo 113 • In definitiva, riteniamo, l'aedo aveva "a disposizione" forme di aoristo intransitivo di llyvul-t.t a vocalismo allungato (o la possibilità di costruirne), e nel nostro caso ne è stato fatto uso 114•
Un parallelo, per certi versi, può essere costituito da dJ..òvte in E 487, tra l'altro non passibile del sospetto di allungamento metrico. Se è vero che non può derivare che da giÌJ..rov 115, e che tale prosodia non appartiene al "sistema" omerico, che conosce solo ilJ..ro (eventualmente *tdJ..ro) e dJ .. oiicra, potremmo essere di fronte, con dì..6vte, ad una scelta fra varie possibilità conosciute dall'aedo. Scelta, anche in questo caso, «extra-sistema», o, per meglio dire, possibile in un momento, cronologicamente basso, in cui esistevano le due alternative prosodiche (il verso è indubitabilmente tardo) 116•
Con questa interpretazione, per presente, futuro ed aoristo sigmatico valgono estensioni e procedimenti analogici affini a quelli supposti discutendo della prima ipotesi.
Per quanto riguarda il perfetto, il ragionamento non può essere in questi termini. Questo tema verbale, per FO-Y-, è certamente antico: è difficile ipotizzare per esso il vocalismo di un risultativo come, ad esempio, ytypdcpa. E quale che sia la sua origine, il sistema dell'alternanza 11 l a (> 11) nel vocalismo
113 Una influenza analogica del vocalismo di =~liyvUJ.it su tdy11 è presa in considerazione da Wyatt 1969, 79 e, forse, in DGE I 29c, ma il dettato non è chiaro.
114 Sulla variante royev di e 385 è difficile concludere alcunché, se non che tale prosodia per l'aoristo intransitivo era sentita possibile in Omero. La variante può semplicemente dipendere dal nostro èdy'll di A 559 (si noti l'identica posizione in fine di verso).
115 Cf. Schulze 1888, 237, Shipp 1972, 15. Si usa costantemente presentare la forma come « att. &dì..rov »: ciò ha aspetto di verità, ma solo in quanto essa compare esclusivamente in Aristoph. Vesp. 355. Si parte abitualmente da *11· FIXÀ.WV, ma non si può escludere, a mio parere, l'influenza di à.vQ/..òro/à.vCìì..(crxro. Sulla possibilità che questi due ultimi verbi si siano formati ben più anticamente delle loro prime attestazioni, cf. Chantraine, DELG 62.
116 Che liì..òv~e non sia ionico (così Shipp 1972, 15) può essere messo in dubbio da dì..oovm in Hippon. fr. 41, l Deg. (cf. Schulze 1888, 237). Certo questo può a sua volta derivare dal duale omerico, ma limitare all'attico tdì..rov perché compare solo una volta e in Aristofane appare corretto esclusivamente in termini descrittivi.
308 Emanuele Dettori
radicale di presente/aoristo vs. perfetto appare piuttosto saldo, per lo meno sincronicamente a data alta. Per cui non ci sentiremmo di proporre, almeno in prima istanza, la partenza da una forma Mya e l'estensione successiva dell' a secondario al tema del perfetto, con timbro vocalico 'bloccato' su l a/, anche nei casi dove ci aspetteremmo 11, appunto per la secondarietà del fenomeno.
Conviene invece notare, prima di tutto, come Esiodo, che reca, appunto, un problematico M.ys, per le altre occorrenze, composte, del verbo utilizzi la forma eolica xauaçmç (Op. 666, 693) 117, oppure, per quanto, forse, meno significativo, una 'tmesi' con apocope (metricamente necessaria) della preposizione (Op. 439s. XCÌJ.l JJ.ÈV apo-cpov l a.çstav) 118• La possibilità di Mys quale eolismo in Esiodo sembra ottenere conforto su versanti altri dal semplice vocalismo. D'altra parte, si consideri che perché lo scenario che prevede l'influenza determinante di xa-cdyvUJJ.t funzioni anche per il perfetto, bisognerebbe ritenere che l'Mys di Sapph. fr. 31, 9 V. non sia forma epicorica, e provenga da tradizione letteraria non eolica. Infatti, come si può vedere dalle forme esiodee appena citate, in eolico d'Asia non avremmo avuto i fenomeni fonetici che ci hanno permesso di tentare una spiegazione dell'a in altri temi verbali e nei sostantivi di questa famiglia 119• A questo punto lo scenario più probabile è che Eiiys in Saffo costituisca semplicemente la forma attesa nel suo dialetto 120, m Esiodo una di tradizione eolica. Da cui consegue:
117 L'osservano Hiersche 1966, 4, e Palmer 1980, 104. Janko 1982, 168, da parte sua, ricorda gli altri eolismi che caratterizzano la descrizione dell'inverno: !tiÀvn (v. 510) e,liclxvu (v. 526).
118 In ciò distinguendosi da Omero, che in tmesi ha sempre la forma 'piena' xa~a: cf. e 403, 417, 'l' 341, ~ 539.
119 Oltre all'antico *xnuny- (< xa~-FUy-), la poetessa poteva conoscere, dal suo dialetto, una eventuale "ricomposizione" recente m~-ay-, con apocope. Dal che, comunque, non si potrebbe spiegare alcun passaggio di a da xn~dyvuj.n al tema del perfetto.
120 In ogni caso, lo iato yA.iiicrcrn MyE indica che la poetessa deve aver assunto il verbo (difficilmente il sintagma, che costituisce immagine inedita e, pare, presso che senza seguito: cf. Bonanno 1993, 61ss.), da tradizione prece-
vauay-/vaum-, una iscrizione e alcune forme di èlyvu~-tt 309
a) ovviamente, che il XU'!Ell'YÒ'!U di Herodot. VII 224, l e i perfetti ippocratici in -Ell'Y- sono attesi;
b) che il XU'!Efiy6'!o<; di Aristoph. P!. 545 è effetto della Riickverwandlung;
c) che l'tuy6ç; di Choer. Sam. fr. 9, l Bern. e l'Myroç; di Arat. 46, inattesi in poesia che si presume ionizzante, si dovranno al fatto che la forma esiodea (eolica), per una qualche ragione, si è imposta come modello ineludibile all'epica successiva (rarità delle attestazioni del verbo semplice, per lo meno al perfetto ?).
Lascerei, comunque, uno spiraglio per la possibilità alternativa che il perfetto di uyvwn potesse prevedere anch'esso un Il secondario (da cui vocalismo e prosodia in Esiodo, Cherilo e Arato e nelle occorrenze attiche). Gli esempi di fluttuazione tra à ed TJ di Il secondari (o presenti in termini non greci di acquisizione non antica) non sono pochi, e, in linea di principio, il xa'tETJYÒ'ta di Herodot. VII 224, 1 e i perfetti ippocratici in -ETJY- non garantiscono di nulla. Proprio per questo tema verbale credo sia opportuno portare all'osservazione una glossa esichiana: E 614 La. Èf]À.axgv· ÈÀ.TJql9TJ. Latte scrive in apparato: «h. e. TJÀ.COXEV - EÀ.T]ql8TJV H: S ». Nonostante l'interpretamentum sia all'aoristo passivo, la cosa più probabile è che il lemma sia una forma di perfetto l:f)J..coxE. Da una parte esso potrebbe semplicemente riflettere la conflazione di due varianti, a partire da una situazione come Herodot. I 191, 6, ove a l:aÀ.coxò'tcov R 1 soprascrive f)J..coxò'tcov 121 . Ma alternativamente, a fronte del normale l:aA.cox- (Herodot. I 191, 6 [bis]; 209, 3) e, comunque, dell'd che sembra proprio di questo perfetto (cf. Pind. Pyth. III 57), Èf]À.COXE potrebbe spiegarsi a partire dai casi sopra menzionati di aoristo di aA.icrxoJ.Lat con o., e quindi ipercaratterizzazione dialettale. La glossa, non del tutto limpida e non 'collocabile', non permette ulteriori, e ulteriormente rischiose, suggestioni.
Rimane da dire che si è consci che le soluzioni qui proposte sono problematiche. Tuttavia, ci sembrano prevedere un atteggiamento meno «atomistico» del solito rispetto alle que-
dente, in cui il digamma era "operante" (cf. la discussione in Hiersche 1966, 2ss.). Per Hiersche 1966, 4s., tale tradizione era eolica, accomunando il perfetto di Saffo sotto questo segno con quello esiodeo (egualmente in iato).
121 Cf. Rosén 1962, 209, per liaÀroxacrav di V a Herodot. I 84, 5.
310 Emanuele Dettori
stioni poste dall'insieme delle forme 'singolari' di questo verbo e dai sui derivati nominali 122 •
EMANUELE DETIORI
[addenda: p. 291 e n. 46, pp. 299-300: per la situazione testuale in Z 306 vd. ora
M.L. W est, Homerus. Ilias, I, Stutgardiae-Lipsiae, ad l.; i dati della tradizione in <l> 178 e 'P 467 potrebbero essere diversi da quelli ricavati dalle correnti edizioni omeriche e qui esposti: cf. West, cit. XX: «Z 306 ... <l> 178, 'P 467 testibus Herodiano librisque melioribus ii longum habent». Ciò non inficia, comunque, il ragionamento.
p. 298 n. 74: W est cit., ad l., attribuisce la correzione a K.H.F. Grashof, i cui lavori omerici mi sono risultati inaccessibili. A giudicare dai titoli, è probabile che l'intervento si trovasse in Zur Kritik des homerischen Textes etc., Gymn.-Progr. Diisseldorf 1852: fosse, quindi, contemporaneo a quello di Ahrens].
122 Martin Peters (per litt.) attribuirebbe il vocalismo lungo dei derivati di *wag- all'influenza, totalizzante, di 7tfJyvu1.1t: molti a lunghi (xa~ayv- e xa~o.ç-) sarebbero esiti regolari di kataw7ifg-; ove ricorre a, lungo o breve, per l'atteso -T]·,
esso si dovrebbe ad arcaismo (cf. n. 17), o a peculiarità fonetiche dello ionico occidentale (cf. pp. 296s.), o ancora, nel corpus Hippocraticum, ad atticismi della tradizione; l'aoristo intransitivo potrebbe avere la lunga da -a1;-. Si osservi che una serie di forme «difficili » caratterizzano radici inizianti in di gamma: oltre ai nostri casi (da *wag-, in notazione tradizionale), cf. i citati d:ì..òv~e, Mì..rov, d:ì..éiivm (da *wal-), èa.Oò~a in Horn. I 173 = cr 422 (da *swad-: sul timbro vocalico di èdliò~a, v d. Schwyzer 1939, 770 n. 5, Chantraine 1958, 20s. [un' eolismo ], e, contra, le due diverse ipotesi di Peters 1989, 107s. [cf. anche 1980,261, 270], e 1995, 196 n. 35, nonché Crespo 1977, 47, Di Giovine 1990, 229 n. 562). Ma non si riesce a trovare una spiegazione comprensiva (non tutto, ad esempio, è risolvibile introducendo un aumento TJ- ).
vauay-/vavT)y-, una iscrizione e alcune forme di t'tyvu~u 311
Bibliografia
H.L. Ahrens, Griechische Formenlehre des Homerischen und Attischen Dialektes, Gottingen 1852
A. Bammesberger (Hrsg.), Die Laryngaltheorie und die Rekonstruktion des indogermanischen Laut- und Formensystems, Heidelberg 1988
F. Bechtel, Die Vocalcontraction bei Homer, Halle/Saale 1908 R.S.P. Beekes, PIE. RHC- in Greek and other languages,
« IF » XCIII {1988) L Bekker, Homerische Blatter, I, Bonn 1863 M. Benedetti, Lat. auriga, aurigari (-are), aureax, «SSL»
XXVIII {1988) M. Bertheau, in Lexikon des fruhgriechischen Epos, l, Gottin
gen 1979 G. Bjorck, Das Alpha impurum und die tragische Kunstspra
che, Uppsala 1950 G. Boesch, De Apollonii Rhodii elocutione, Diss. Berolini
1908 M.G. Bonanno, Saffo 31, 9 V.: y.A..rocn:m ilare, «QUCC» 43 n. l
{1993) W. Brandenstein, Griechische Sprachwissenschaft, I, Berlin
1954 K. Brugmann, Griechische Grammatik, Miinchen 19003
K. Brugmann, Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, II l, Strassburg 19062
A.C. Cassio, Iperdorismi callimachei e testo antico dei lirici (Call. Hy. 5, 109; 6, 136), in R. Pretagostini (ed.), Tradizione e innovazione nella cultura greca da Omero all'età ellenistica, III, Roma 1993
A.C. Cassio, La prose ionienne post-classique et la culture de l'Asie Mineure a l'époque hellenistique, in CL Brixhe (dir.), La koiné grecque antique. II La concurrence, Nancy-Paris 1996
P. Chantraine, La formation des noms en grec ancien, Paris 1933
P. Chantraine, Grammaire homérique, I, Paris 1958
312 Emanuele Dettori
E. Crespo, Elementos antiguos y modernos en la prosodia homerica, Salamanca 1977
C. Crimi-M. Kertsch, Gregorio Nazianzeno. Sulla virtù. Carme giambico [I 2, l 0], Pisa 1995
B.J. Darden, Laryngeals and syllabicity in Ba!to-Slavic and Indo-European, « CLS » XXVI.2 (1990)
P. Di Giovine, Studio sul perfetto indoeuropeo, I, Roma 1990 K.J. Dover, Ancient interpolation in Aristophanes, «ICS» II
(1977) L. Dubois, Inscriptiones grecques dialectales de Grande Grèce,
I, Genève 1995 L. Dubois, Inscriptions grecques dialectales d'Olbia du Pont,
Genève 1996 H. Diintzer, De Zenodoti studiis Homericis, Gottingae 1848 Duquesnoy, L 'augment aux aoristes du verbe arvv,ut, « Comp
te rendu du Congrès scientifique international cles catholiques ». VI sect. Philologie, Paris 1891
G.P. Edwards, The language of Hesiod in his traditional context, Oxford 1971
W. Euler, Indoiranisch-griechische Gemeinsamkeiten der Nominalbildung und deren indogermanische Grundlage, Innsbruck 1979
E. Fawcett Tucker, The creation of morphological regularity: Early Greek verbs in -éo, -do, -6o, -uo and -io, Gottingen 1990
H. Frisk, Indogermanica, «GHÀ>> XLIV (1938) G. Giangrande, 'Arte allusiva' and Alexandrian epic poetry,
« CQ » LXI (1967) G. Giangrande, On Moschus' Megara, «CQ» LXIII (1969) G. Giangrande, Der stylistische Gebrauch der Dorismen zm
Epos, «H ermes» XCVIII (1970) B.A. van Groningen, Euphorion, Amsterdam 1977 M. Guarducci, lnscriptiones Creticae, IV, Roma 1950 O. Hackstein, Untersuchungen zu den sigmatischen Prasens
stammbildungen des Tocharischen, Gottingen 1995 B. Hainsworth, The Iliad: A commentary. Vol. III: books
9-12, Cambridge 1993
vo.udy-/vaul]y-, una iscrizione e alcune forme di ayvu~t 313
E. Hamp, The spread of -uno factitives in Greek, «TPhS» LXXXVI (1988)
G.N. Hatzidakis, Uber die Lautgruppe 071 im Attischen, «KZ» XXXVI (1900)
B. Helly, L'état thessalien, Lyon 1995 R. Hiersche, Zu Sappho 2, 9 D. 2 xàJ.l J.lèv yJ..còcrcra tays « die
Zunge ist gebrochen», «Glotta» XLIV (1966) R. Hiersche, Grundziige der griechischen Sprachgeschichte bis
zur klassischen Zeit, Wiesbaden 1970 C.A.]. Hoffmann, Quaestiones Homericae, II, Clausthaliae
1848 O. Hoffmann, Die griechischen Dialekte, III, Gottingen 1898 H. Jacobsohn, Der Aoristtypus iù:ro und die Aspiration bei
Homer, « Philologus » LXVII (1908) R. Janko, Homer, Hesiod and the Hymns, Cambridge 1982 R. Janko, The Iliad: A commentary. Vol. IV: books 13-16,
Cambridge 1992 J.H. Jasanoff, Stative and middle in Indo-European, Inns
bruck 1978 A. J ohnston, Anotherathema, «Scienze dell'antichità» III-IV
(1989-90) S.E. Kimball, Analogy, secondary Ablaut and ~·OH2 in com
mon Greek, in Bammesberger 1988 A.D. Knox, Herodes, Cercidas and the Greek choliambic
poets, London-Cambridge (Mass.) 1929 S.N. Koumanidis-A.P. Mattheou, Aòo iepoi VÒJlOt Xirov, «Ho
ros » III (1985) R. Kiihner-F. Blass, Ausfiihrliche Grammatik der griechischen
Sprache, I-II, Hannover 1890-923
Ch. de Lamberterie, Lat. pignus et la théorie glottalique, in H. Rosén (Ed.), Aspects of Latin, Innsbruck 1996
W. Leaf, The Iliad, I, London 19002
M. Lejeune, Phonétique historique du mycénien et du grec ancien, Paris l 972
M. Leumann, Griech. horn. ei&oç i8uìa und èotxroç €i:xuia,
àpTJpffiç àpapuia, «Celtica» III (1955) = Ausgewahlte kleine Schriften, Ziirich-Stuttgart 1959 (da cui si cita)
314 Emanuele Dettori
W. Lindblad, Die Bedeutungsentwicklung des Prafixes KATA in Kompositis, Helsingfors 1922
É. Littré, Oeuvres complètes d'Hippocrate, III, Paris 1841 E. Livrea, Apollonii Rhodii Argonauticon liber quartus, Fi
renze 1973 A. Lubotsky, Gr. p~gnumi : Skt. pajra- and loss of laryngeals
before mediae in Indo-Iranian, «MSS» XL (1981) G.H. Mahlow, Neue Wege durch die griechische Sprache und
Dichtung, Berlin-Leipzig 1927 V.G. Mandilaras, The verb in the Greek non-literary papyri,
Athens 1973 M. Mayrhofer, Etymologisches Worterbuch des Altindoari
schen, II, Lief. 11, Heidelberg 1992 M. Mayrhofer, Etymologisches Worterbuch des Altindoari
schen, II, Lief. 17, Heidelberg 1995 E. Mayser, Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptole
maerzeit, I 2, Berlin-Leipzig 19382
H. C. Melchert, Studies in Hittite historical phonology, Gottingen 1984
H.C. Melchert, Anatolian historical phonology, AmsterdamAtlanta (GA) 1994
J. Méndez Dosuna, Metdtesis de cantidad en j6nico-dtico y heracleota, «Emerita>> LXI (1993)
G. Meyer, Griechische Grammatik, Leipzig 18963
W. Meyer, Anfang und Ursprung der lateinischen und griechischen rythmischen Dichtung, « Abh.Miinch.Akad. >> XVII (1885)
D.G. Miller, Glide deletion, contraction, Attic reversion, and related problems of ancient Greek phonology, « Die Sprache>> XXII (1976)
D.B. Monro, A grammar of the Homeric dialect, Oxford 18912
A. Morpurgo Davies, Mycenaean and Greek language, in A. Morpurgo Davies-Y. Duhoux (Edd.), Linear B: A survey, Cabay/Louvain-La-Neuve 1985
L.R. Palmer, The Greek language, London 1980 M. Peters, Untersuchungen zur Vertretung der indogermani
schen Laryngale im Griechischen, Wien 1980
vauil:y-/vaurJY-, una iscrizione e alcune forme di ilyvu~n 315
M. Peters, Indogermanische Chronik 31b, «Die Sprache» XXXI.2 (1985)
M. Peters, Indogermanische Chronik 33, «Die Sprache» XXXIII. 1-2 (1987)
M. Peters, Sprachliche Studien zum Fruhgriechischen, Wien 1989
M. Peters, Beitrage zur griechischen Etymologie, in L. Isebaert (Ed.), Miscellanea linguistica Graeco-Latina, Namur 1993
M. Peters, 'Ap_qn{xpaoç und die attische Ruckverwandlung, in M. Ofitsch-Chr. Zinko [Hrsgg.], Studia Onomastica et Indogermanica. Festschrift fur Fritz Lochner von Hiittenbach zum 65. Geburtstag, Graz 1995
G.-J. Pinault, Tokharien A malkartem et autres mots, «TIES» VI (1993)
V. Pisani, Glottologia indoeuropea, Torino 1971 4
V. Pisani, Manuale storico della lingua greca, Brescia 19732
S. Radt, Tragicorum Graecorum fragmenta. Vol. 3 Aeschylus, Gottingen 1985
D.A. Ringe, Jr., Evidence for the position of Tocharian in the Indo-European family?, «Die Sprache» XXXIV (1988-90)
D.A. Ringe, Jr., On the chronology of sound-changes in Tocharian. Vol. l, New Haven (CT) 1996
E. Risch, Wortbildung der homerischen Sprache, Berlin-New York 19742
H. Rix, Historische Grammatik des Griechischen, Darmstadt 1976
H.B. Rosén, Eine Laut- und Formenlehre der herodotischen Sprachform, Heidelberg 1962
C.J. Ruijgh, Observations sur la flexion des verbes du type rpif3w, cppvyw: l'origine des alternances r/I et r/iJ, in «Studi es in Greek, Italic and Indo-European linguistics offered to Leonard R. Palmer», Innsbruck 1976
C.J. Ruijgh, Ree. P. Chantraine, DELG III, «Lingua» XLIV (1978a)
C.J. Ruijgh, Ree. Rix 1976, «Mnem.» IV S. XXXI (1978b) C.J. Ruijgh, Observations sur !es traitements des laryngales en
grec préhistorique, in Bammesberger 1988
316 Emanuele Dettori
C.J. Ruijgh, Ree. L. Threatte, The grammar of Attic inscriptions II, « Mnem. » IV s. L (1997)
A.S. Rusjaeva, Ol'bija i Gileja (k probleme vladenii v archaiceskoe vremja), « Drevnee Pricernomor' e», Od essa 1994
A. S. Rusjaeva-J.G. Vinogradov, Der « Brief des Priesters » aus Hylaia, in R. Rolle/M. Miiller-Wille/K. Schietzel (Hrsgg.), Gold der Steppe. Archaologie der Ukraine, Neumiinster 1991
F. de Saussure, Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes, Lipsia 1879 [1878]
V. Schmidt, Sprachliche Untersuchungen zu Herondas, Berlin 1968
R. Schmitt-Brandt, Die Entwicklung des indogermanischen Vokalsystems, Heidelberg 1967
P. Schrijver, The reflexes of the Proto-Indo-European laryn-geals in Latin, Amsterdam-Atlanta (GA) 1991
W. Schulze, Zwei verkannte Aoriste, «KZ» XXIX (1888) W. Schulze, Quaestiones epicae, Giitersloh 1892 E. Schwyzer, Griechische Grammatik, I, Miinchen 1939 G.P. Shipp, Studies in the language of Homer, Cambridge
19722
A.L. Sihler, New comparative grammar of Greek and Latin, Oxford 1995
N.I. Sokol'skij, Kul't Afrodity v Kepach kontsa VI- V v. do n. e., « VDI» 1973. 4
F. Solmsen, Der Obergang von sin t vor Vocalen in den griechischen Mundarten, «KZ» XXXII (1893)
F. Solmsen, Untersuchungen zur griechischen Laut- und Verslehre, Strassburg 1901
H. van Thiel, Zenodot, Aristarch und andere, «ZPE» 90 (1992)
P. Thieme, Wurzel YAT im Veda und Avesta, «Monumentum H.S. Nyberg», III, Leiden-Téhéran-Liège 1975
M. T orelli, Per la definizione del commercio greco-orientale: il caso di Gravisca, « PP >> XXXVII (1982)
J. Vendryes, Traité d'accentuation grecque, Paris 1904 B. Vine, The etymology of Greek XWJ11J and related problems,
vauay-lvauiJy-, una iscrizione e alcune forme di iiyvu~n 317
in J. Jasanoff-H.C. Melchert-L. Oliver (Edd.), Mir curad. Studies in honor of Calvert Watkins, Innsbruck 1998
J. Wackernagel, Die epische Zerdehnung, « BB » IV (1878) J. Wackernagel, Miszellen zur griechischen Grammatik, «KZ»
XXVII (1885) J. Wackernagel, Das Dehnungsgesetz der griechischen Kompo
sita, Progr. zur Rektoratsfeier der Universitat Basel 1889 J. Wackernagel, Akzentstudien III. Zum homerischen Akzent,
« GGN >> 1914 J. Wackernagel, Sprachliche Untersuchungen zu Homer, Got
tingen 1916 C. Watkins, The name of Meleager, in A. Etter (Hrsg.), o-o
pe-ro-si. Festschrift fiir Ernst Risch zum 75. Geburtstag, Berlin-New York 1986
M.L. Weiss, Studies in Italic nominai morphology, Ph. D. Diss. Cornell Univ. 1993
H.M. W erhahn, Dubia et spuria unter den Gedichten Gregors von Nazianz, in Studia patristica, VII. 1, Berlin 1966 («TU>> 92)
H. W eir Smyth, The sounds and inflections of the Greek dialects. I onic, Oxford 1894
M.L. W est, H esiod. Theogony, Oxford 1966 W.F. Wyatt, Jr., Metricallengthening in Homer, Roma 1969