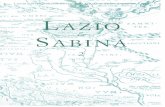Una nuova iscrizione latina arcaica del Foro Romano (area del cd. Equus Domitini)
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Una nuova iscrizione latina arcaica del Foro Romano (area del cd. Equus Domitini)
Tra il 1903 ed il 1904 Giacomo Bo-ni(1) condusse importanti indagininel Foro Romano rimettendo in luceun basamento in opus caementiciumda lui ritenuto il podio del monu-mento equestre eretto in onore diDomiziano(2). In quell’occasione l’ar-cheologo rinvenne, all’interno dellastruttura muraria, quattro teche lapi-dee formate da blocchi di travertino,originariamente chiuse da un coper-chio; nell’unica conservatasi integrarecuperò un servizio per libagionicostituito da cinque vasi databili alsecondo quarto del VII a.C. (fase la-ziale IV A ), in nessun modo ricon-ducibili ad un corredo funebre(3).
Secondo gli studi di Filippo Coa-relli(4), il basamento apparterrebbe ad
un sacello inserito in un complessosacro, documentato da quattro fasicostruttive comprese fra l’età di Ce-sare e quella di Costantino. Nel sitosi dovrebbero riconoscere i Doliola,l’area sacra così denominata da alcu-ni vasi ivi sepolti, che sappiamo es-sere in rapporto con la palude delForo, il tempio di Vesta (presso la do-mus del flamen Quirinalis) e la CloacaMaxima; secondo Varrone il culto deiDoliola fu istituito da Numa; di con-tro Festo e Livio lo pongono in rela-zione con l’incendio gallico del 390a.C. quando le Vestali, non potendoportare via tutti i sacra populi romani,furono costrette a nasconderne unaparte(5).
Che il culto legato ai Doliola avesse
PATRIZIA FORTINI
UNA NUOVA ISCRIZIONE LATINA ARCAICA DAL FORO ROMANO(AREA DEL cd. EQUUS DOMITIANI)
267
1 - Sulla vita e l’attività di questo insigne archeologo al Foro Romano ed al Palatino oltre al fondamentalevolume di E. Tea, Giacomo Boni nella vita del suo tempo, I-II, Milano 1932, vd. da ultimo I. Iacopi, “GiacomoBoni”, in Gli scavi di Giacomo Boni al Foro Romano. Documenti dall’Archivio disegni della Soprintendenza Ar-cheologica di Roma, I.1, a cura di P. Fortini - A. Capodiferro, Roma 2003, con bibliografia.2 - Lexicon Topographicum Urbis Romae, II, a cura di E.M. Steinby, [Roma 1995], pp. 228-229, sv. Equus domi-tianus (C.F. Giuliani), con bibliografia.3 - La documentazione manoscritta dello scavo si conserva presso la Soprintendenza Archeologica di Ro-ma; una breve notizia in G. Gatti, “Scoperte recentissime al Foro Romano”, in Bullettino della CommissioneArcheologica Comunale di Roma, 1904, pp. 174-179; A. Mosso, “Crani preistorici trovati nel Foro Romano”,in Notizie degli Scavi, 1906, pp. 46-54, in particolare pp. 49-54 pubblica lo studio sui resti umani rinvenuti;lo scavo e la documentazione furono poi ripresi da E. Gjerstad, Early Rome, I. Stratigraphical Researches inthe Forum Romanum and along the Sacra Via, Lund 1953, pp. 21-85.4 - F. Coarelli, Il Foro Romano. Età arcaica, Roma 1983, pp. 282-298; Lexicon Topographicum Urbis Romae, II, acura di E.M. Steinby, [Roma 1995], pp. 20-21, sv. Doliola (F. Coarelli). La struttura rimessa in luce dal Boni ècontrassegnata con il n. 19 nella fig. 79 a p. 287. Il vasellame recuperato nella teca lapidea entro il basa-mento consta di una grande olla costolata d’impasto, un’anforetta a doppia spirale, due tazze d’impastocarenate con ansa e decorazione incisa, un boccale monoansato d’argilla decorato con fasce sopraddipin-te; al loro interno furono rinvenute una pepita d’oro e frammenti di scaglie di tartaruga.5 - Varro, l.L. V 157; Serv., ad Aen. VI 238; Fest. (Paul), p. 60; Liv. V 40, 7-8.
un carattere ctonio traspare dal di-vieto di sputare in loco ricordato daVarrone(6) unitamente alla presenzadi ossa cadaverum.
A questo proposito è interessanterilevare che nel saggio stratigraficocondotto in corrispondenza del ba-samento, Giacomo Boni effettiva-mente rinvenne i resti “antichissimi”di un uomo adulto, una giovanedonna ed un neonato, deposti diret-tamente sul terreno vergine senzacorredo e con segni di morte violen-ta almeno per i due adulti(7). (fig. 1).
Il recente riesame di queste depo-sizioni(8) ha confermato le intuizionidel Boni. L’uomo, di 24-25 anni, e laragazza, di 12-14 anni, vissero, aquanto sembra, nella parte finaledell’Età del Bronzo(9); al momentodella morte erano stati legati; un col-po in testa inferto con un’arma da ta-glio avrebbe ucciso la giovanetta, tral’altro affetta dalla sindrome diDawn(10).
Ripercorrendo la genesi di questaimportantissima scoperta, ho avutomodo di riprendere in mano le cas-
268
6 - Varro, l.L. V 157.7 - G. Gatti, “Scoperte antichissime cit.”; A. Mosso, “Crani preistorici cit.”, pp. 49-54; negli Anni Quarantalo scavo del Boni fu ripreso da E. Gierstad, Early Rome, I cit.; P. Carafa “I contesti archeologici dell’età ro-mulea e della prima età regia”, in Roma. Romolo, Remo e la fondazione della città, Catalogo della Mostra, Roma,Museo Nazionale Romano Terme di Diocleziano, 28 giugno-29 ottobre 2000, a cura di A. Carandini e R. Cappelli,Roma 2000, pp. 68-73, in particolare p. 71.8 - Ringrazio la dr.ssa Irene Iacopi, direttore del Foro Romano-Palatino, per aver consentito l’esame di tut-ta documentazione relativa allo scavo, comprese le carte manoscritte del Boni. Lo studio completo del ri-trovamento condotto con la collaborazione della dr.ssa Paola Catalano, direttore del Servizio di Antropo-logia della Soprintendenza Archeologica di Roma, è in corso di pubblicazione. Le riproduzioni fotografi-che si devono a Luciano Mandato e Gianfranco Gentile, della Soprintendenza Archeologica di Roma; i di-segni a Gianni Mulas.9 - I campioni ossei dell’uomo e della donna sono stati sottoposti all’analisi del C 14 calibrato al doppiosigma: 1250/900 a.C. la donna; 1190/930 a.C. l’uomo.10 - L’anomala posizione del capo della giovane e delle braccia, riscontrabile quest’ultima anche nell’uo-mo, fanno pensare che avesse la parte superiore del corpo stretta da corde; è probabile che anche gli artiinferiori fossero legati.
I resti umani ritrovati presso il cd. equus Domitianidurante lo scavo di G. Boni. Foto SAR.
sette con il materiale archeologico re-cuperato in quella occasione dal Bo-ni ed attualmente conservato pressol’Antiquarium Palatino. In un sac-chetto dove erano stati raccolti mate-riali vari (ceramica, ferro, vetro, ossadi animali, etc.) corredato da un car-tellino con la dicitura “privi di indi-cazione stratigrafica”(11) ho notato, tratutti, un frammento vascolare conuna iscrizione in lingua latina incisadopo la cottura.
Si tratta di parte del fondo di unvaso di forma aperta, probabilmen-te una ciotola, di bucchero nero pe-sante, prodotto da una fabbrica pre-sumibilmente romana; la superficieesterna ha mantenuto solo pochetracce della lucidatura originaria edin alcuni punti è di colore rossastroper la cattiva cottura; l’impasto èmal cotto, di colore grigio scuro,duro e con piccolissimi granuli emica. Rimangono, solo in parte, lavasca con pareti concave ed il basso
piede ad anello (larghezza massimacm 12,6; altezza massima cm 2,5;diametro del piede cm 7).
Tipologicamente la ciotola ricordaquelle di tipo 4 della classificazionedel Rasmussen, datate fine VI a.C.-Va.C.(12); le caratteristiche morfologi-che del bucchero, richiamano il tipoD della tipologia di Pianu, in uso pertutto il VI a.C. e sino agli inizi del Va.C.(13).
Sul fondo interno, la ciotola reca,incisa dopo la cottura, la nota X. Delsegno a croce resta poco più dellametà del braccio di sinistra ed unbreve tratto di quello di destra nelpunto di intersezione dei due segni(altezza massima mm 38).
Una seconda iscrizione è presenteal di sotto del piede, tracciata entrol’anello dopo la cottura, profonda-mente e con ductus destrorso; vi silegge la parola trepios (altezza dellelettere mm 3-9).
L’analisi dei singoli grafemi dal
269
11 - Il materiale del cd. equus Domitiani è stato successivamente studiato dal Gerstad (vd. supra) ed è pro-babile che il cartellino in questione sia stato compilato in quella occasione; la grafia infatti non corrispon-de a quella presente su analoghi cartellini che possiamo riferire con sicurezza all’operato del Boni.12 - T.B. Rasmussen, Bucchero Pottery from Southern Etruria, Cambridge 1979, pp. 123, 125. 13 - G. Pianu, Il buchero, Bari 2000, pp. 13-14.
Prospetto e sezione del frammento vascolare.
punto di vista grafico ha rilevato leseguenti caratteristiche:
- la lettera T ha il tratto superioreperfettamente orizzontale (altezzamm 8);
- il grafema R ha la forma di rho;l’occhiello abbastanza grande ed ar-rotondato è chiuso in basso; in alto siinnesta sull’asta verticale poco al disotto della parte iniziale, in bassoverso la metà della stessa; il trattoterminale dell’asta è stato tracciatodallo scriba dopo aver chiuso l’oc-chiello continuando il segno dellostesso (altezza mm 9);
- la lettera E presenta i tratti tra-sversali lunghi e moderatamente di-scendenti; quello superiore, più cor-to degli altri due, si innesta sull’astaverticale lasciando superiormenteuna sorta di piccola appendice; l’ul-
timo tratto ha inizio pressoché allabase dell’asta ed è inoltre molto al-lungato così da terminare al di sottodell’asta verticale della lettera P se-guente (altezza mm 7);
- il grafema P è reso con l’uncinoarrotondato nella parte inferiore chesi innesta sul tratto verticale poco aldi sotto dell’inizio (altezza mm 6);
- la lettera I è esente da particola-rità grafiche (altezza mm 4,5);
- la lettera O, arrotondata, ha di-mensioni ridotte ed è posta a circametà della riga di scrittura (altezzamm 3);
- il grafema S è formato da tre trat-ti angolosi e segue una direzione in-versa rispetto alle rimanenti lettere(altezza mm 8).
Raffronti paleografici istituiti conle iscrizioni di età arcaica già note(14)
270
14 - In particolare vd. R. Wachter, Altlateinische Inschriften. Sprachliche und epigraphische Untersuchungen zuden Dokumenten bis etwa 150 v. Ch., Bern-Frankfurt-New York 1987; B. Vine, Studies in Archaic Inscriptions,
a. Segno a croce inciso sul fondo interno; b. iscrizione incisa al di sotto del piede.
hanno evidenziato come anche neltesto del Cippo del Foro, tracciatocon andamento bustrofedico (secon-da metà VI a.C.)(15), siano presenti lelettere T con la traversa orizzontale,la R con occhiello chiuso, la S a tretratti retrograda e la E con i tratti po-co discendenti e breve appendice in-feriore. Quest’ultimo grafema, chediviene usuale nelle iscrizioni latinerecenti, si ritrova inoltre nel testodell’altrettanto noto vaso di Duenos,datato tra il 575 ed il 550 a.C.(16), e nel-la base da Tivoli (seconda VI a.C. /fine VI a.C.) dove è presente anche il
segno P con valore di /r/(17) che soloa partire dal IV a.C. sarà sostituitodal grafema R(18). Nella stele di Satri-cum (fine VI a.C.) ritornano simil-mente le lettere E, P, O)(19). Alla dedi-ca a Castore e Polluce da Lanuvium(seconda metà VI a.C.) riporta il se-gno P con uncino arrotondato e la Odi dimensioni ridotte posta a metàrigo, tipica della scrittura latina ar-caica(20).
Esaminando poi i testi tracciatisull’instrumentum domesticum prove-niente dall’area romana e dai centrivicini(21), si nota come nell’iscrizione
271
Innsbruck 1993; G. Colonna, “L’aspetto epigrafico”, in Lapis Satricanus. Archaeological, Epigraphical, Lingui-stic and Historical Aspects of the New Inscription from Satricum, (Archeologische Studien van het NederlandsInstituut te Rome, Scripta Minora, V), s-Gravenhage 1980, pp. 41-52; G. Colonna, “Appendice. Le iscrizio-ni strumentali latine del VI e V secolo a.C.”, in Lapis Satricanus. Archaeological, Epigraphical, Linguistic andHistorical Aspects of the New Inscription from Satricum, (Archeologische Studien van het Nederlands Insti-tuut te Rome, Scripta Minora, V), s-Gravenhage 1980, pp. 53-69 per le iscrizioni latine su instrumentum do-mesticum di area romana e centri viciniori; D. Urbanová, “La paleografia delle iscrizioni latine arcaiche”,in XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina, Roma, 18-24 settembre 1997, Atti I, Roma 1999, pp.477-490; O. Colazingari, S. Falzone, P. Pensabene F.M. Rossi, S. Valerio, “Ceramica graffita di età arcaica erepubblicana dall’area sud ovest del Palatino”, in Scienze dell’Antichità. Storia, archeologia, antropologia, 10(2000), pp. 163-247, in particolare pp.183-247. Fondamentale la raccolta di iscrizioni latine arcaiche espo-sta nel Museo Nazionale Romano – Sezione Epigrafica, cfr. R. Friggeri, La collezione epigrafica del Museo Na-zionale Romano alle Terme di Diocleziano, [Milano 2001], pp. 16-46.15 - CIL I2, 4, 1; vd. tra l’altro, G. Colonna, “I Latini e gli altri popoli del Lazio”, in Italia. Omnium terrarumalumna, Milano 1989, p. 514; M. Cristofani, “Il cippo del Foro”, in La grande Roma dei Tarquini, Catalogo del-la Mostra, Roma, Palazzo delle Esposizioni, 12 giugno-30 settembre 1990, a cura di M. Cristofani, Roma 1990, pp.58-59, n. 3. 39; P. Carafa, Il Comizio dalle origini all’età di Augusto, Roma 1998, pp. 128- 130; R. Friggeri, Lacollezione epigrafica del Museo Nazionale Romano cit., p. 25.16 - C.I.L., I2, 4, 4; M. Cristofani, “Vaso di Duenos”, in La grande Roma dei Tarquini cit, pp. 20-21, n. 1.4 ; U.Kaestner, “Vaso triplo, detto «vaso di Duenos»”, in Principi Etruschi tra Mediterraneo ed Europa, Catalogo del-la Mostra, Bologna, Museo Civico Archeologico, 1 ottobre 2000-1 aprile 2001, [Venezia 2000], p. 326, n. 441 conbibliografia.17 - C.I.L., I2, 2658; G. Colonna, “L’aspetto epigrafico cit.”, p. 47; L. Gregori, “La base inscritta di Tivoli”, inLa grande Roma dei Tarquini cit, p. 24, n. 1.11; R. Friggeri, La collezione epigrafica del Museo Nazionale Romanocit., p. 23 fig. 7.18 - G. Colonna, “L’aspetto epigrafico cit.”, pp. 46, 48.19 - C.I.L., I2, 4, 2823a; G. Colonna “L’aspetto epigrafico cit.”, pp. 41-45; M. Cristofani, “Blocco iscritto daSatricum, in La grande Roma dei Tarquini cit., pp. 23-24, n. 1.10 con bibliografia; A.L. Prosdocimi, “Rivista diepigrafia italica”, in Studi Etruschi, LIX (1993), pp. 324-327; G. Colonna, “Ancora sul lapis Satricanus”, inStudi Etruschi, LXI (1995), pp. 350-351; R. Friggeri, La collezione epigrafica cit., p. 23 fig. 8.20 - C.I.L., I2, 4, 2833; G. Colonna “L’aspetto epigrafico cit.”, p. 46; G. Tagliamone, “Laminetta bronzea condedica ai Dioscuri”, in La grande Roma dei Tarquini cit., pp. 190-191, n. 29; R. Friggeri, La collezione epigrafi-ca cit., p. 27.
saluetod tita incisa sull’olla prove-niente da Gabii (loc. Osteria dell’O-sa), ritorni il grafema T con traversaorizzontale ed il grafema E con i trat-ti leggermente inclinati ed asta conbreve apice superiore(22); lettere conle stesse caratteristiche compaionoanche nel testo eco urna tita uendiasmamarc[---]d fh[---] su un’olla da Cae-re datata come la precedente nel 630-620 a.C.(23).
Ritroviamo la lettera O piccola etondeggiante nell’iscrizione post(umos)(la t è di incerta lettura) incisa sotto ilpiede di un frammento di ciotola dibucchero nero della prima metà delV a.C.(24), e nell’iscrizione [---]biospresente su un frammento di piat-tello in bucchero grigio subarcaico(V a.C., forse seconda metà)(25) en-trambe dal Palatino. Nell’iscrizioneeqo kanaios (la n è di incerta lettura)
incisa su un frammento di vaso diforma chiusa in bucchero pesantedatabile nella seconda metà del VIa.C., ritrovata ad Ardea, il grafema Oè sì piccolo ma la forma è più rom-boidale(26). Nel testo [---]etartispo[---],impresso prima della cottura conductus sinistrorso, su una tegola pro-veniente dall’abitato sulla Laurenti-na, databile nella prima metà VI sec.a.C.(27), le lettere T, R, S, P, O sono si-mili a quelle della nostra iscrizio-ne(28), il grafema R poi ha in comuneanche il modo in cui è stato realizza-to: lo scriba ha tracciato la parte ter-minale dell’asta proseguendo il trat-to dell’occhiello. Ancora la lettera Rcon occhiello chiuso ritorna nell’i-scrizione [---?]uar[---] incisa su unframmento di vaso in bucchero pe-sante della seconda metà del VI a.C.,che fa parte del materiale della stipe
272
21 - C.I.L., I2, 4; G. Colonna (a cura di), “Appendice. Le iscrizioni strumentali latine del VI e V secolo a.C.”,in Lapis Satricanus cit.; P. Broccato, “Rivista di epigrafia italica”, in Studi Etruschi, LX (1994), pp. 301-302; G.Colonna, “Rivista di epigrafia italica”, in Studi Etruschi, LX (1994), pp. 298-300; S. Falzone, “Il contributodell’epigrafia: graffiti su ceramica”, in Roma. Romolo, Remo e la fondazione della città, Catalogo della Mostra,cit., pp. 82-83.22 - A. De Santis, “Il servizio simposiaco dalla tomba 115 della necropoli di Osteria dell’Osa”, in La gran-de Roma dei Tarquini cit., p. 100, n. 4.3.1 con bibliografia; G. Colonna, “Greco more bibere: l’iscrizione dellatomba 115 dell’Osteria dell’Osa”, in Archeologia Laziale 3, 1980 (Quaderni di Etruscologia Etrusco Italica, 4),pp. 51-55, ritiene che Tita sia un prenome femminile arcaico caduto in disuso; R. Friggeri, La collezione epi-grafica del Museo Nazionale Romano cit., p. 21 fig. 4.23 - M. Cristofani, “Olla iscritta da Caere”, in La grande Roma dei Tarquini cit., p. 101, n. 4.4.4 con bibliografia. 24 - G. Colonna (a cura di), “Appendice. Le iscrizioni strumentali latine del VI e V secolo a.C.”, in Lapis Sa-tricanus cit., p. 58, IB.16, dalla zona delle Scale Caci.25 - G. Colonna (a cura di), “Appendice. Le iscrizioni strumentali latine del VI e V secolo a.C.”, in Lapis Sa-tricanus cit., pp. 61-62, IB.22, dalla Casa dei Grifi, area del cd. Lararium della Domus Flavia scavata dal Bo-ni nel 1912. Nell’iscrizione è presente anche la S a tre tratti retrograda, ma più curveggiante. 26 - G. Colonna (a cura di), “Appendice. Le iscrizioni strumentali latine del VI e V secolo a.C.”, in Lapis Sa-tricanus cit., p. 66, IV.36.27 - CIL, I2, 4, 2902d; G. Colonna (a cura di), “Appendice. Le iscrizioni strumentali latine del VI e V secoloa.C.”, in Lapis Satricanus cit., p. 64, II.31, legge [---]etartispo[---] con la e di incerta lettura; A. Bedini, “Fram-mento di tegola con iscrizione”, in La grande Roma dei Tarquini cit., pp. 177, n. 45.28 - T con traversa orizzontale; R come rho; P con uncino arrotondato anche se più ampio; S a tre tratti maserpentiforme, retrograda rispetto al verso della scrittura; O di piccole dimensioni.
votiva scoperta dal Boni nel 1899 nelniger Lapis(29). La S a tre tratti retro-grada, tipica delle iscrizioni etruschearcaiche, ricorre tra l’altro nel testoououios (la prima O di incerta lettura)inciso su un frammento di ciotola dibucchero pesante databile intorno560-530 a.C. trovato nell’area delsantuario di S. Omobono(30).
Sulla base dei raffronti e conside-rando che l’andamento verso destradella scrittura appare di norma apartire dall’ultimo quarto del VIa.C.(31), è probabile pensare di datarel’iscrizione recuperata nell’area delcd. equus Domitiani tra la fine del VIa.C. e gli inizi del V a.C.
Trepios rappresenta la forma onoma-stica di età arcaica, espressa in caso ze-ro, del più tardo trebius, presente neidocumenti epigrafici latini sia in fun-
zione di prenomen che di gentilizio(32).Il nome trepios ha la sua origine in
ambito italico(33). Alle lingue italico-orientali riconducono la suffissazio-ne - io e la radice *treb> che racchiu-de in se il valore semantico di “casa”(trebos = casa; tr b- = abitare)(34), lastessa del teonimo umbro *Trebos Io-vios (o *Treba Iovia) menzionato nelleTabulae Iguvinae(35).
L’onomastica delle genti italico-orientali riporta Trebis quale prenomeosco. Con questa funzione lo ritrovia-mo inciso tra l’altro all’interno di unakylix attica di V a.C. recuperata a Frat-te di Salerno(36), su un elmo in bronzooggetto di dono, ora nel Museo di Pa-lermo(37), nonché su tre tegole bollateprovenienti da Tricarico (Matera) da-tabili al IV a.C.; in quest’ultimo caso ilfigulo italico Trebius Arruntius appar-
273
29 - G. Colonna (a cura di), “Appendice. Le iscrizioni strumentali latine del VI e V secolo a.C.”, in Lapis Sa-tricanus cit., p. 53, IA.4.30 - G. Colonna (a cura di), “Appendice. Le iscrizioni strumentali latine del VI e V secolo a.C.”, in Lapis Sa-tricanus cit., p. 57, n. 13; M. Torelli, “Il donario di M. Fulvio Flacco nell’area di S. Omobono”,in Quadernidell’Istituto di Topografia antica dell’Università di Roma, V, Roma 1968, pp. 75-76 legge ouduios (incerta la let-tura della prima o e della d); stessa lettura anche in P. Virgili, “Le iscrizioni. Materiali dagli scavi del tem-pio Arcaico nell’area sacra di S. Omobono”, in Vivere quotidiano in Roma arcaica, Catalogo della Mostra, Ro-ma, Area sacra di S. Omobono, 24 maggio-2 giugno 1989, [Roma 1989], p. 58, fig. 36.31 - Cfr. G. Colonna “L’aspetto epigrafico cit.”, p. 47, anche se sporadicamente il ducuts destrorso si ritro-va anche nel VII a.C.32 - P. Castrén, Ordo Popolusque Pompeianus. Polity and Society in Roman Pompeii (Acta Instituti Romani Fin-landiae, 8), Roma 1975, pp. 230-231; W. Schulze, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, Zuerich 1991 [ri-stampa anstatica dell’edizione Weidemann 1909), pp. 246 s, 468 s, precisa che il gentilizio deriva dal pre-nomen; H. Solin - O. Salomies, Repertorium nominum gentium et cognomina Latinorum. Editio nova addendiscorrigendisque augmentata (Alpha-Omega, 80), Hildesheim-Zuerich-New York, 1994, pp. 183, 190.33 - Cfr. nota precedente.34 - G. Devoto,”Rapporti onomastici etrusco-italici”, in Studi Etruschi, III (1949), pp. 277, 280-281.35 - E. Vetter, Handbuch der italischen Dialekte, I, Heidelberg 1953, p. 440; V. Pisani, Le lingue dell’Italia anticaoltre il Latino, Torino [1964], pp. 154 - 155: Tavole Iguvine I a 8 (trebe iuvie), VI a 58 (trebo iouie).36 - G. Colonna, “Nuovi dati epigrafici sulla protostoria della Campania”, in Istituto Italiano di Preistoria eProtostoria, Atti della XVII riunione scientifica in Campania, 13-16 ottobre 1974, Firenze 1975, pp. 162 ss, fig.7;P. Pocetti, Nuovi documenti italici a completamento del manuale di E. Vetter, Pisa [1979], p. 193, n. 263; R. An-tonimi, “Rivista di epigrafia italica”, in Studi Etruschi, XLIX (1994), p. 338.37 - V. Pisani, Le lingue dell’Italia antica cit, p. 48, n. 4 A, Trebius S. f. Festius dedit, indica la provenienza dalBrutium.
tiene ad una gens che rimanda ad unaorigine etrusca(38).
La radice *treb> costituisce poi labase dei gentilizi latini Trebellenus,Trebellienus, Trebellius, Trebenna, Trebi-cius, Trebienus, Trebonius, Trebucenna,Trebulanus, Trebulanius, Trebanius,Trebatius, Trebicius, Trebularius, Triba-tius, Tribetius, Tribellius, Tribius, e delgià menzionato Trebius(39).
In ambiente etrusco, dato che le for-me onomastiche di origine italicacambiano la suffissazione –io in -i/-ie e-u/-unia (area settentrionale) trebis di-viene trepi/trepu(40). Chiusi ed il suoterritorio sembrano essere l’area dimaggiore diffusione. A Montalto diCastro, ager volcentanus, è documen-tata la forma trepe quale prenome diun membro della gens dei tetnie(41).
Grazie alle iscrizioni bilingui sap-piamo che l’etrusco trepi/trepu corri-sponde al latino trebius/trebonius. In-teressante notare la concentrazionedei documenti epigrafici in un perio-
do relativamente recente della storiaetrusca(42).
Concludiamo ricordando che laformula monomia trepios va ad ag-giungersi al novero di quelle presen-ti sulle iscrizioni strumentali arcai-che elencate da G. Colonna che sonoda riferire ad individui di probabileo sicura origine italica, comeOuouios, Pacua, Kanaios, Fulfios, PalpsBlaisios(43).
La presenza del segno a croce graf-fito all’interno della ciotola di cuiTrepios dichiara di essere il proprieta-rio, avvalora l’ipotesi che ad un cer-to momento il vaso abbia perso lasua originaria funzione di instrumen-tum domesticum per divenire oggettodi dono: è il vaso stesso che comuni-ca di essere stato donato dall’uomodi cui porta inciso il nome: trepios(44).
A chi Trepios volesse offrirlo non losappiamo; considerando il luogo delrinvenimento(45), si potrebbe, in via
275
38 - P. Pocetti, Nuovi documenti italici cit., p. 108, n. 146; R. Antonimi, “Rivista di epigrafia italica”, in StudiEtruschi, XLIX (1994), p. 341.39 - H. Solin – O. Salomies, Repertorium nominum cit, p. 190.40 - T.L.E., I, pp. 334-335; G. Devoto “Rapporti onomastici etrusco-italici cit., p. 277; H. Rix, Das Etruski-scher Cognomen, Wiesenbaden 1963, pp. 188, 345 e nota 104; W. Schulze, Zuer Geschichte cit., p. 326; H. Rix,Etruskische Texte. Editio minor, I-II, Tuebingen 1991, in particolare a p. 178 elenco delle attestazioni.41 - M. Martelli, “Rivista di Epigrafia Etrusca”, in Studi Etruschi, XLVII (1979), pp. 339-341, nn. 52-53, dueciotole a vernice nera (III-II a.C.).42 - H. Rix, Etruskische Texte cit.43 - G. Colonna (a cura di), “Appendice. Le iscrizioni strumentali latine del VI e V secolo a.C.”, in Lapis Sa-tricanus cit., p. 69.44 - Sull’importante funzione della pratica dello scambio di doni, anche riferita ad oggetti di scarso pre-stigio, che recano incisi il solo nome del proprietario, vd. tra l’altro L. Agostiniani, Le «iscrizioni parlanti»dell’Italia antica, Firenze 1982; G. Colonna, “Identità come appartenenza nelle iscrizioni di possesso dell’I-talia Preromana”, in Epigraphica, 45 (1983), pp. 55-57; S. Panciera, “Le iscrizioni votive latine”, in Scienzedell’Antichità. Storia, archeologia, antropologia, 3-4 (1989-1990), pp. 229-231; G. Sassatelli, “Il Principe e lascrittura”, in Principi Etruschi tra Mediterraneo ed Europa cit., pp. 309-317.45 - Ricordiamo che deve essere escluso ogni riferimento ad un contesto funebre e la probabile identifica-zione del sito con l’area sacra dei Doliola.46 - Cfr. O. Colazingari, S. Falzone, P. Pensabene, F.M. Rossi, S. Valerio, “Ceramica graffita di età arcaicacit.”, p. 193 e nota 106;
del tutto ipotetica, pensare che lo ab-bia offerto ad una divinità(46). Allasfera religiosa sembrano riconnet-tersi molti dei reperti vascolariiscritti ritrovati, ad esempio sulPalatino nell’area del tempio dellaMagna Mater dove, accanto a no-mi di uomini comuni, è presenteanche quello di Iuno Sospita(47). Ladea Vesta è ricordata su una cioto-la in bucchero (metà VI a.C.) rin-venuta presso il tempio nel Foro(48),Anna Perenna sulla coppa (secondametà VI a.C.) recuperata nellaCloaca Massima(49), Iuno Sororia sulframmento di ciotola (V a.C.) pro-veniente dalla Meta Sudans(50). Enon possiamo dimenticare che lacoppa con l’iscrizione rex (ultimoquarto VI a.C.) probabilmentemenziona il rex sacrorum che risie-deva là dove il Boni la rinvenne,nella Regia(51).
276
47 - G. Colonna (a cura di), “Appendice. Le iscrizioni strumentali latine del VI e V secolo a.C.”, in Lapis Sa-tricanus cit., p. 61 ritiene che la divinità possa essere identificata anche con Vesta; S. Falzone, “Il contribu-to dell’epigrafia: graffiti su ceramica cit.”, p. 83; O. Colazingari, S. Falzone, P. Pensabene F.M. Rossi, S. Va-lerio, “Ceramica graffita di età arcaica cit.”, p. 194; R. Friggeri, La collezione epigrafica del Museo NazionaleRomano cit., p. 22, fig. 5.48 - G. Colonna (a cura di), “Appendice. Le iscrizioni strumentali latine del VI e V secolo a.C.”, in Lapis Sa-tricanus cit., pp. 55-56, I A10: uis(ta).49 - G. Colonna (a cura di), “Appendice. Le iscrizioni strumentali latine del VI e V secolo a.C.”, in Lapis Sa-tricanus cit., pp. 55-56, I A12: ana.50 - G. Colonna, “Iscrizione latina arcaica dai pressi della Meta Sudans (valle del Colosseo)”, in Studi Etru-schi, LXI (1995), pp. 347-350: ianaias (S di incerta lettura); R. Friggeri, La collezione epigrafica del Museo Na-zionale Romano cit., pp. 22-23, fig. 6.51 - G. Colonna (a cura di), “Appendice. Le iscrizioni strumentali latine del VI e V secolo a.C.”, in Lapis Sa-tricanus cit., p. 56, I A1.11; M. Cristofani, “Coppa iscritta dalla Regia”, in La grande Roma dei Tarquini cit.,pp. 22-23, n. 1.9; R. Friggeri, La collezione epigrafica del Museo Nazionale Romano cit., p. 26.
Roma: il foro.