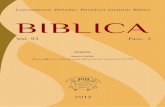Caratterizzazione cronologica mediante termoluminescenza di alcune ceramiche
Transcript of Caratterizzazione cronologica mediante termoluminescenza di alcune ceramiche
R I V I S TA
D I S T U D I L I G U R I
ANNI LXXVII – LXXIX
GENNAIO – DICEMBRE 2011-2013
ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURIMUSEO BICKNELL – BORDIGHERA
Atti del Convegno
IL PIENO SVILUPPO DEL NEOLITICOIN ITALIA
Museo Archeologico del Finale – Finale Ligure Borgo8–10 giugno 2009
a cura diMaria Bernabò Brea – Roberto Maggi – Alessandra Manfredini
Bordighera 2014
Con il patrocinio diIstituto Italiano di Preistoria e ProtostoriaUniversità di Roma – La SapienzaDirezione regionale per i beni culturali e paesaggistici della LiguriaSoprintendenza per i beni archeologici dell’Emilia e RomagnaSoprintendenza per i beni archeologici della LiguriaIstituto Internazionale di Studi LiguriCivico Museo del Finale
Con il contributo diComune di Finale Ligure, Cava Arene Candide s.r.l., Freddy S.p.A.
Comitato scientificoMaria BernaBò Brea, roBerto Maggi, alessandra Manfredini
Comitato organizzatoredaniele aroBBa, andrea de Pascale, angiolo del lucchese, roBerto Maggi
Organizzazione e gestione del sito web dedicatostefano rossi
Redazione dei pre-attistefano rossi, anna sMaldone
Segreteria del Convegnostefano rossi, anna sMaldone
con la collaborazione disiMona Mordeglia, Manuela saccone, carlo Vinotti
Segreteria di redazione degli AttiMaria BernaBò Brea, roBerto Maggi, chiara Panelli, stefano rossi
Studio grafico e impaginazioneOLTRE s.r.l., via Torino 1, Sestri Levante, Genova
Programma del Convegno
8 giugno 09.30 Saluti delle Autorità10.15 M.Bernabò Brea, R. Maggi, A. Manfredini - Introduzione11.00 D. Binder - VBQ-Chassey tra Provenza e Liguria12.00 pausa11.30 A. Beeching - Rapporti Francia-Italia attraverso le Alpi12.30 A. Pedrotti, E. Bannfy - Le culture dell’area nord-orientale nella prima metà
del V millennio a. C. La cultura di Lengyel e la cultura dei Vasi a Bocca Quadrata: rituali funerari a confronto
13.00 pranzo14.30 Tavola Rotonda: Ambiente, economia, uso del territorio – chairman: R. Maggi16.30 pausa17.00-19.30 Tavola Rotonda: Ambiente, economia, uso del territorio – chairman: R. Maggi21.00 apertura staordinaria e visita al Museo Archeologico del Finale
9 giugno
09.00 Tavola rotonda: Le produzioni quali indicatori di identità e di contatti – chairman A. Del Lucchese10.45 pausa11.15 Tavola rotonda: Le produzioni quali indicatori di identità e di contatti – chairman A. Del Lucchese13.00 pranzo14.00 Tavola Rotonda: Il mondo rituale e funerario – chairman M. Bernabò Brea16.45 pausa17.15-19.30 Tavola Rotonda: Antropologia – chairman L. Salvadei
Presentazione del volume, Il riparo di Pian del Ciliegio. Un sito Neolitico sull’altopiano delle Manie a cura di A. Del Lucchese
10 giugno09.00 Tavola Rotonda: Definizione degli aspetti culturali – chairman L. Sarti11.00 pausa11.30 Tavola rotonda: Quale società? - chairman A. Manfredini14.30-16.30 Escursione alla Caverna delle Arene Candide
INDICE
Maria BernaBò Brea, roBerto Maggi, alessandra Manfredini
Introduzione 17
i. Uno sgUardo da occidente
didier Binder, cedric lepère
From Impresso-Cardial to SMP and Chassey in Provence 21
ii. aMBiente, econoMia, Uso del territorio
MaUro creMaschi
L’uso del suolo nel Neolitico in ambito padano: lo stato dell’arte 33
daria giUseppina Banchieri, lanfredo castelletti, BarBara cerMesoni, elisa Martinelli, paolo oppizzi
Modalità di occupazione e sfruttamento del territorio nel corso del V millennio a.C. nella Lombardia occidentale e nel Canton Ticino 41
girolaMo fiorentino, cosiMo d’oronzo, Milena priMavera, MassiMo caldara, italo Maria MUntoni, francesca radina
Variazioni ambientali e dinamiche antropiche in Puglia (5 600 – 4 000 BC) 47
MaUro rottoli, elena regola
L’agricoltura in Italia settentrionale nel V millennio a.C.: nuovi dati dal sito di via Guidorossi a Parma 55
Marco Marchesini, ilaria goBBo, silvia Marvelli
La ricostruzione del paesaggio vegetale nel Neolitico medio in Emilia Romagna attraverso le indagini palinologiche 63
Marialetizia carra
I macroresti vegetali dal sito di Ponte Ghiara (PR). Considerazioni paleo-ecologiche e paleo-economiche 71
cynthianne spiteri, oliver edward craig, italo Maria MUntoni, francesca radina
The transition to agriculture in the Western Mediterranean. Evidence from pots 79
Jacopo de grossi Mazzorin
L’analisi archeozoologica di alcuni siti della cultura neolitica dei vasi a bocca quadrata del Parmense 87
BarBara voytek
Plus ça change, plus c’est la même chose. Change and Continuity in the Neolithic 95
Jacopo de grossi Mazzorin, alBerto c. potenza
Lo sfruttamento delle risorse animali nel sito neolitico di Serra Cicora (Nardò, Lecce) 101
leonardo salari, Maria cristina de angelis, antonio tagliacozzo
La fauna neolitica della Grotta dei Cocci (Narni, Umbria) 105
cecilia conati BarBaro
Forme di aggregazione sociale e uso del territorio nel Tavoliere di Puglia 111
arMando gravina
La Daunia nel V millennio: note di topografia 119
lorenza Bronzoni, paolo ferrari
Elementi per una riflessione sulle strutture infossate della fase VBQ in Emilia occidentale 127
daniele aroBBa, angiolo del lUcchese, piera Melli, rosanna caraMiello
Evidenze di scalvatura in rami di frassino del Neolitico medio a Genova 137
antonio cUrci, Maria cristina de angelis, adriana Moroni lanfredini, siMona padoanello, antonio tagliacozzo
Grotta Bella (Umbria). Dati per un’analisi economica e paleo ambientale 143
alessandra facciolo, antonio tagliacozzo, vincenzo tiné
Le fosse di combustione con resti di animali dai livelli del Neolitico medio (facies Serra d’Alto) di Grotta San Michele di Saracena (CS) 151
daniele aroBBa, rosanna caraMiello
Indagine archeobotanica sui livelli del Riparo di Rocca Due Teste presso Alpicella (Varazze, Savona) 157
iii. le prodUzioni qUali indicatori di identità e di contatti
italo Maria MUntoni
La ceramica Serra d’Alto in Italia meridionale. Circolazione di materie prime, di prodotti finiti, di tecnologie? 169
Marta coloMBo
La standardizzazione delle misure e delle decorazioni nelle forme vascolari della Cultura di Catignano 179
BiancaMaria arangUren, annaMaria de francesco, Marco Bocci, gino crisci, pasqUino pallecchi
Ceramiche di imitazione Serra d’Alto a Grotta della Spinosa, Massa Marittima (GR) 185
valentina cannavò, Maria BernaBò Brea, sara t. levi, paola Mazzieri
Dati archeologici e analisi archeometrica di vasetti tipo “San Martino” rinvenuti in Emilia 191
andrea de pascale
Le pintadere neolitiche nelle collezioni del Museo Archeologico del Finale 203
valentina cannavò, sara t. levi, siMone Mantini, Maria BernaBò Brea
Analisi esplorativa della statuina neolitica di Vicofertile 211
siMone occhi
Le asce in pietra levigata della collezione storica del Museo Archeologico Nazionale di Parma 215
patrizia gariBaldi, eUgenia isetti, irene Molinari, gUido rossi
Le asce in pietra levigata del Neolitico della Penisola italiana: collezioni e nuove ricerche 225
roBerto Micheli
Ornamenti personali e gruppi neolitici: elementi di differenziazione culturale nell’ambito della cultura dei Vasi a Bocca Quadrata 235
siMona scarcella
La produzione della ceramica stentinelliana a Perriere Sottano (CT). Rottura nelle decorazioni e continuità nell’utilizzo delle materie prime 243
Maria grazia BUlgarelli, laUra d’erMe
Poggio Olivastro (Canino, VT): la fase del pieno Neolitico 249
claUdio capelli, angiolo del lUcchese, elisaBetta starnini
La produzione ceramica neolitica: analisi archeometriche su materiali del Riparo di Pian del Ciliegio (Finale Ligure - SV) 255
alessia colaianni, alfredo geniola, doMenico loiacono, antonio Minafra, rosa ModUgno, rocco sanseverino, lUigi schiavUlli
Caratterizzazione cronologica mediante termoluminescenza di alcune ceramiche di tipo Serra d’Alto dal sito di Santa Barbara (Polignano a Mare – BA). Risultati preliminari 257
iv. il Mondo ritUale e fUnerario
renata grifoni creMonesi
Aspetti ideologici e funerari nella cultura di Ripoli e nell’Italia centro meridionale 265
alessandra Manfredini
Animali: non solo cibo 275
alfredo geniola, rocco sanseverino
Elementi funerari nell’area centro-meridionale del sito di Santa Barbara (Polignano a Mare - BA) 283
andrea ciaMpalini, Marco firpo, eUgenia isetti, ivano rellini, antonella traverso
Il culto del sacro nel complesso di Grotta Scaloria (FG) 289
donato coppola, antonio cUrci, francesco genchi
La frequentazione cultuale della Grotta di San Biagio (Ostuni – Brindisi) 295
Maria BernaBò Brea, Maria Maffi, paola Mazzieri, loretana salvadei, iaMes tiraBassi
Le necropoli VBQ in Emilia 303
Maria BernaBò Brea, paola Mazzieri
Osservazioni sulla sfera rituale del mondo VBQ in base ai dati forniti dagli insediamenti dell’Emilia occidentale 315
paola Mazzieri, roBerto Micheli
Tradizioni funerarie e ornamenti personali. Alcune osservazioni dalla sfera VBQ emiliana alla luce delle ultime scoperte 323
paola Mazzieri, siMone occhi
Le asce nei corredi sepolcrali dell’Emilia occidentale 331
daniela castagna, valentina gazzoni, gaBriele lUigi francesco BerrUti, Martina de March
Studio preliminare sulle sepolture neolitiche del territorio mantovano: i casi di Mantova, Bagnolo San Vito e San Giorgio 339
ida tiBeri, sara dell’anna
Usi funerari nel Salento del V millennio a.C. Le tombe di Carpignano Salentino (Lecce) 353
v. antropologia
paola iacUMin, antonietta di Matteo, lUciana Mantovani
Gli isotopi stabili nelle popolazioni del Neolitico Medio dell’Emilia occidentale 361
daMiano Marchi, vitale s. sparacello
Un approccio biomeccanico alla ricostruzione delle strategie di sussistenza delle popolazioni neolitiche della Liguria occidentale 365
gwenaëlle goUde, didier Binder, angiolo del lUcchese
Alimentation et modes de vie néolithiques en Ligurie 371
elsa pacciani, giUseppe d’aMore, sylvia di Marco, andrea Messina, lUca sineo
Il reperto cranico umano del Riparo della Rossa, Serra San Quirico (Ancona), nel contesto della variabilità morfometrica delle popolazioni neolitiche italiane ed europee 383
loretana salvadei
Antropologia dentaria delle popolazioni padane del Neolitico medio. Dati metrici e morfologici 389
loretana salvadei, alessandra spina
Antropologia dentaria delle popolazioni padane del Neolitico medio. Dati patologici 399
vi. definizione degli aspetti cUltUrali
angiolo del lUcchese
Nuovi dati sul pieno Neolitico nel Finalese dal Riparo di Pian del Ciliegio 405
gian piero Martino, giUliva odetti
Il Riparo di Rocca Due Teste all’Alpicella di Varazze (SV) nel contesto del Neolitico medio e superiore della Liguria 413
nicola dal santo, paola Mazzieri
Connotazione e sviluppo diacronico del VBQ in Emilia occidentale in base alle industrie ceramiche e litiche. Gli esempi dei siti di Ponte Ghiara, Benefizio e via Guidorossi 419
iaMes tiraBassi
La fase iniziale della Cultura VBQ documentata a Rivaltella – Ca’ Romensini (RE) 429
chiara panelli
Il sito neolitico di Vicofertile (Parma) 439
paola Mazzieri
Il Sito VBQ di stile “meandro-spiralico” di via Guidorossi a Parma 447
paola Mazzieri, Marco grignano
L’insediamento di VBQ I di Benefizio (Parma) 457
Maria Maffi, anna frasca
Nuovi dati relativi alla frequentazione dei Vasi a Bocca Quadrata in territorio piacentino 465
paola Mazzieri
Il sito VBQ di Pontetaro (PR) 477
MaUrizio liBelli
Il sito neolitico di Gaione “Parco del Cinghio” 485
lUcia sarti, nicoletta volante
Il pieno Neolitico in Toscana: variabilità delle produzioni ceramiche e litiche nel contesto dell’Italia centrale 497
alfredo geniola, rocco sanseverino
Considerazioni culturali sull’aspetto Chiantinelle nel territorio di Serracapriola (FG) 505
elettra ingravallo
Serra Cicora e le facies neolitiche meridionali: un’occasione per parlarne 511
vincenzo tiné, elena natali
Il Neolitico medio nella Calabria settentrionale. Nuovi dati da Grotta San Michele di Saracena e Grotta della Madonna di Praia e Mare (CS) 515
IndIce deI PrePrInt 521
Rivista di Studi Liguri, LXXVII – LXXIX (2011–2013)
Caratterizzazione cronologica mediante termoluminescenza di alcune ceramiche di tipo Serra d’Alto dal sito di Santa Barbara (Polignano a Mare – BA).
Risultati preliminari
Alessia Colaianni* - Alfredo Geniola** - Domenico Loiacono*** - Antonio Minafra***
- Rosa Modugno*** - Rocco Sanseverino**** - Luigi Schiavulli*****
1. IntroduzIone: Il sIto dI santa BarBara
L’insediamento neolitico in contrada Santa Barbara1 nel territorio di Polignano a Mare insiste sul secondo ri-alzo sub-costiero (circa 60 m sul livello del mare) a 1,5 Km. dalla costa.
Il sito archeologico, indagato dalla metà degli anni settanta, è stato interessato da due periodi di frequentazio-ne: nel periodo più antico nell’area fu impiantato un vil-laggio che era perimetrato, sia pure a tratti, da un fossato che lo rende eccezionale nella Puglia centrale ed era ca-ratterizzato da capanne delle quali restano buche di pali; nel secondo periodo di frequentazione, corrispondente al Neolitico maturo, troviamo insediata una nuova gene-razione di coltivatori con una forte propensione questa volta per la caccia selettiva e per l’artigianato ceramico. Essa introdusse l’usanza di modellare ipogei artificiali, dalla complessa strutturazione, generalmente con ingres-si alla base dei fossati2. Un tratto di fossato denominato La Trappola ricade lungo quello che sembra attualmente essere il margine sud-ovest dell’insediamento: la parti-colare morfologia della struttura appare immediatamente delinearsi con il suo andamento sinuoso caratterizzato, al tetto della stratificazione interna, dalla presenza di una necropoli a piccolo tumulo realizzata all’interno del de-posito caratterizzato dalla cultura di Serra d’Alto3.
Le dinamiche relative alla neolitizzazione della peni-sola italiana necessitano di agganci quanto mai assoluti, in termini di cronologia, essenzialmente per fissare eventi, non certo di carattere assoluto e generale, ma indispensa-bili a legare tra loro singoli momenti di una realtà troppo grande e apparentemente priva di contatto quale quella che può sembrare ad esempio, la paleostoria delle culture neo-litiche affermatesi nel contesto geografico qui considerato.
Accanto ai metodi di datazione isotopica come il C14, applicabile solo su elementi di natura organica, da cir-ca un trentennio la tecnica applicata al principio fisico della termoluminescenza (TL) può affiancare i sistemi di datazione assoluta tradizionali puntando a definire, in termini di cronologia assoluta, gli elementi della cultura
materiale (come la ceramica) che perentoriamente ven-gono datati attraverso il sistema relativo ai confronti. Il principio fisico, esaustivamente descritto in seguito, è stato applicato ad un contesto i cui riferimenti culturali si collocano in ambito della facies Serra d’Alto per la quale già si possiedono termini cronologici validi (BM-2257R) 5920±170 BP e (BM-2256) 6129±170 BP4. Negli ultimi anni di ricerca si è reso necessario incrociare i dati stra-tigrafici con quelli cronologici non legati esclusivamente alla tipologia. In un sito ampio e pluristratificato come Santa Barbara non manca il riferimento alle stratigrafie “orizzontali” dovuto all’articolata antropizzazione del paesaggio, la quale si manifesta attraverso la monumen-talizzazione dell’area con architetture ricavate in negati-vo scavando la roccia calcarenitica: le strutture sino ad ora individuate coprono un arco temporale compreso tra fine VI e IV millennio come appena indicato.
2. Il materIale analIzzato
L’area dalla quale provengono i materiali ceramici sottoposti ad analisi (TL) è quella all’interno di uno dei tratti di fossato denominato La Trappola (fig. 1) entro il quale si definiscono stratigrafie di fasi in cui paiono al-ternarsi momenti post-frequentativi a momenti di attività.
Tra questi ultimi, dopo la perdita delle sue funziona-lità, nella struttura è stata allestita una piccola necropoli caratterizzata da inumazioni in piccolo tumulo.
I materiali restituiti dall’analisi stratigrafica sono co-stituiti da ceramiche di impasto non depurato, depurato, fine e figulino di tipo Serra d’Alto.
La stratigrafia analizzata dal punto di vista tipologico sembra riservare non pochi interessanti risvolti soprattut-to se si considera che, almeno i due terzi della potenza stratigrafica del deposito (circa tre metri), sono carat-terizzati da materiali della stessa cultura. Il campiona-mento del materiale ceramico è stato effettuato tenendo rigorosamente presenti le necessità del procedimento a garanzia dell’assoluta integrità dei risultati. Si è così pro-
*Scuola di Dottorato in Geomorfologia e Dinamica Ambientale, Università di Bari INFN Sezione di Bari; **Preistoria e Protostoria europea, Univer-sità degli Studi di Bari; ***Laboratorio di Ricerca per la diagnostica dei Beni Culturali dell’Università di Bari; ****Dipartimento di Beni Culturali e Scienze del Linguaggio, Università degli Studi di Bari; *****Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Bari, INFN Sezione di Bari, Laboratorio di Ricerca per la diagnostica dei Beni Culturali dell’Università di Bari.
alessIa ColaIannI, alfredo GenIola, domenICo loIaCono
antonIo mInafra, rosa moduGno, roCCo sanseverIno, luIGI sChIavullI
258
ceduti al prelievo in strati antropici di buona affidabilità in più punti all’interno del deposito non meno di 0.3 – 0.4 m di profondità. La selezione del materiale è avvenuta con il criterio di conservazione, di tenacità e di grandezza del frammento; inoltre, è stato campionato il sedimento a contatto diretto con i reperti al fine di misurarne la radio-attività contenuta.
I materiali (fig. 1) sono stati cosi determinati innan-zitutto in base alla loro appartenenza culturale ovvero ai tipi di Serra d’Alto e tecnologico (impasto poco depura-to, impasto fine e figulino).
3. datazIone tramIte la termolumInesCenza. rIsultatI sperImentalI
Il fenomeno della termoluminescenza (TL) viene uti-lizzato per la datazione di reperti archeologici di tipo ce-ramico sin dagli anni 70 del secolo scorso e il protocollo di analisi5 è ormai ben collaudato e di normale utilizzo in campo archeologico.
Il reperto da datare si comporta come un dosimetro naturale che assorbe e accumula nel tempo energia scatu-rita dal decadimento dei radionuclidi presenti nel terreno circostante e nel reperto stesso6. Occorre, ovviamente, che in un dato momento del passato questa energia im-magazzinata dal materiale che costituisce il reperto da analizzare venga totalmente rilasciata: da quel momento in poi la radioattività alfa, beta e gamma assorbita tornerà ad accumularsi fino al rilascio “artificiale” dovuto alla misura di termoluminescenza. Nel caso della ceramica, l’azzeramento iniziale coincide con la cottura in forno del nostro reperto che, raggiungendo temperature di almeno 800 – 1000 oC, permette di svuotare il reperto dell’energia accumulata precedentemente.
L’età del reperto potrà essere ottenuta da:
]1[ AnnuaDose
PaleodoseEtà = [1]
dove la Paleodose corrisponde alla dose di radioattività
Fig. 1. Fossato La Trappola: planimetria e ubicazione del saggio i; a sinistra i reperti in analisi.
termolumInesCenza CeramIChe tIpo serra d’alto 259
assorbita dal reperto a partire dalla cottura in forno fino al momento della misura di TL, mentre la dose annua corri-sponde alla quantità di energia assorbita dal materiale in un anno. La dose annua dipenderà dai vari tipi di radio-attività assorbita e potrà essere espressa dalla relazione
Dose Annua = a Dα + Dβ + D γ+ Dc [2]
dove Dα, Dβ, Dγ e Dc indicano, rispettivamente, la dose assorbita dalle particelle alfa, beta, gamma e quella dovu-ta ai raggi cosmici. Il parametro a indica, invece, l’effi-cienza della radiazione alfa che varia da reperto a reperto e tiene conto del fatto che a parità di dose assorbita la TL è minore per le alfa rispetto alla radiazione beta e gamma7.
I campioni da analizzare con la TL sono stati prepa-rati utilizzando il metodo ”fine grain”8. Per ogni reperto analizzato sono state effettuati da due a tre prelievi in zone differenti e ciascuno di questi è stato sottoposto a misura di TL.
Per l’analisi è stato utilizzato il sistema TL/OSL-DA-15 prodotto dalla Risø National Laboratory9. Le mi-sure di TL sono state eseguite utilizzando come rampa di riscaldamento una velocità di 5 oC/s. Durante la misura il campione è stato tenuto sotto un flusso di azoto pari a 2 l/m. Il calcolo della paleodose è stato ottenuto adope-rando il metodo delle multi aliquote: da quattro a otto ali-quote di quelle ottenute per ogni prelievo è stata misurata la TL archeologica. Altre aliquote sono state irraggiate con dosi crescenti di radioattività beta che si aggiungono a quelle naturali; le rimanenti sono state irraggiate con dosi crescenti di radioattività alfa. Per ogni valore di dose aggiuntiva sono stati irraggiati dai tre ai quattro campio-ni e per ogni prelievo sono state utilizzate da quattro a cinque dosi crescenti. La sorgente beta utilizzata è una di Stronzio-90 calibrata (0.1333 ± 0.0085 Gy/s), mentre la sorgente alfa è un Americio 241 anch’essa calibrato (0.0416 ± 0.0016 Gy/s). A titolo di esempio in figura 2 sono evidenziate le curve di TL relative al campione L.T. 7; nella figura, a sinistra sono evidenziate le aliquote con dosi crescenti beta, mentre a destra quelle con dosi crescenti alfa. Per poter ottenere il valore della paleodo-se occorre individuare l’intervallo di temperature dello spettro di TL dove l’energia assorbita è rimasta stabile nel tempo senza apprezzabile rilascio dal momento della cottura del reperto: tale valore è dato dal Plateau Test10. L’intervallo di temperatura da noi prescelto è risultato 300-380 °C.
I punti rappresentano l’integrale delle curve di TL nell’intervallo di temperatura ottenuto dal Plateau Test per le varie aliquote con le sole dosi archeologiche e per quelle con dosi crescenti beta aggiuntive. L’intercetta della migliore retta passante per i vari punti, ottenuta con il metodo dei minimi quadrati, con la parte negativa dell’ascissa, permette di ottenere la paleodose.
In Tabella I sono mostrate le dosi archeologiche ed il fattore a che descrive l’efficienza della radiazione alfa per i vari campioni analizzati.
TABELLA ICampione Dosi archeologiche (Gy) Fattore aL. T. 2 27,8 ± 2,7 0,253 ± 0,033L. T. 6 21,3 ± 1,6 0,176 ± 0,017L. T. 7 27,2 ± 2,1 0,135 ± 0,018L. T. 8 23,3 ± 1,8 0,110 ± 0,014
Le componenti a e b relative alla dose annua dipen-dono dal contenuto dei radionuclidi presenti (K-40, U, Th), dal contenuto di umidità naturale presente durante l’interramento. Tali valori possono essere calcolati uti-lizzando le tavole di corrispondenza contenuto/dose11. Il contenuto di U e Th è stato ottenuto tramite conteggi delle particelle a12, quello di K è stato acquisito mediante misure di fotometria a fiamma. La componente ambien-tale della dose annua (dovuta soltanto alla radiazione g) è data sia dall’analisi di alcuni grammi di terreno circo-stante i vari campioni prelevati, sia lasciando per quattro mesi in vari punti del sito dei TLD al LiF opportunamen-te schermati da un cilindro di rame avente pareti di 3 mm di spessore, in modo tale che tali dosimetri possano as-sorbire solo la radiazione g e i raggi cosmici13. Entrambi i metodi hanno portato a valori simili della dose annua, entro gli errori sperimentali.
Per il calcolo della dose annua si è tenuto conto del contenuto di umidità presente sia nel terreno che nelle ceramiche. I dati relativi alle dosi annue sono mostrati in Tabella II.
TABELLA IICampione Dose annua totale (mGy/anno)L. T. 2 4,74 ± 0,16L. T. 6 4,44 ± 0,06L. T. 7 4,81 ± 0,32L. T. 8 5,41 ± 0,15
Le datazioni dei reperti analizzati sono riportati in Tabella III.
TABELLA IIICampione Età (anni BP)L. T. 2 5860 ± 550L. T. 6 4810 ± 380L. T. 7 4330 ± 370L. T. 8 5660 ± 570
alessIa ColaIannI, alfredo GenIola, domenICo loIaCono
antonIo mInafra, rosa moduGno, roCCo sanseverIno, luIGI sChIavullI
260
I dati ottenuti, per quanto credibili, sono da ritenere preliminari: nel calcolo non si è tenuto conto della pre-senza di un fenomeno detto fading anomalo, il quale può essere corretto analizzando i campioni dopo alcuni mesi dalla prima misura e sarà necessario effettuare stime dell’eventuale disequilibrio secolare delle catene radio-attive degli isotopi presi in considerazione.
4. ConClusIonI
I valori ottenuti per le datazioni dei campioni analiz-zati, come già detto in precedenza, necessitano di ulterio-ri indagini prima di poter essere considerati certi. Molto importante sarà verificare l’eventuale presenza di dise-quilibrio secolare all’interno della catena di decadimento dell’U-238 che potrebbe portare a sensibili variazioni del-le date proposte. In letteratura sono stati mostrati effetti di disequilibrio in ceramiche del Neolitico14 e, quindi, questo tipo di verifica è sicuramente estremamente importante al fine di una maggiore significatività dei risultati.
Per quanto riguarda gli aspetti culturali, il dato, ot-tenuto attraverso la misurazione della dose radioattiva, appare allinearsi a quel gruppo di datazioni al C-14 (più recenti) che tenderebbero a rialzare la cronologia della facies di Serra d’Alto attestandola alla metà del V mil-lennio in cronologia calibrata. Dei campioni sottoposti a misurazione sono stati presi in considerazione perchè attinenti al contesto culturale in esame, il campione L.T.2 ed L.T.8. Per L.T.2 la misura rilevata corrisponderebbe al 3851+550 a.C. trova conferma in datazioni recenti effet-tuate in contesti di aspetti culturali ben distinti ma rien-tranti tutti nell’ambito del gruppo culturale di tipo Serra d’Alto15 diffuso ampiamente nella Puglia centro-meridio-
nale e materano ma con proprie caratterizzazioni nella Sicilia (comprese le Eolie), l’alto Tavoliere con il primo Subappennino, le Marche e infine l’area padano-triden-tina16. Un’areale sicuramente molto ampio che giustifi-cherebbe una manifestazione così lunga e variegata con complesse articolazioni interne alla cultura meandro-spi-ralica costituita da contatti, influenze che diventano reci-proche, raccolte nella sfera di altri ambiti culturali (Dia-na, Ripoli, VBQ, ecc.).
Il dato proveniente dalla misurazione di L.T.8 di 3651+570 sembra confermare quello ottenuto dalla data-zione isotopica all’ipogeo Manfredi. E’ tuttavia doveroso tenere presente che l’ambito di variazione risulta molto ampio per entrambi i campioni qui considerati: la con-seguente applicazione di variabilità estesa ad arretrare o attardare il risultato non conforta ed invaliderebbe la tradizione ormai consolidata per la facies di Serra d’Alto. Il dato esposto costituisce dunque un valore preliminare che trova applicabilità nella misura in cui lo si accetti come valore puro, non decisivo ai fini di una corretta at-tribuzione cronologica allo stato attuale della ricerca. La risoluzione di problematiche metodologiche unitamente a considerazioni più raffinate dell’errore percentuale17 contribuiranno ad una valutazione più precisa dei conte-sti stratigrafici pre-proto e storici, integrando altri sistemi di datazione assoluta più consolidati.
RingRaziamenti
Si ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia per il finanziamento del progetto di ricerca ARCHEO che ha permesso di acquisire la strumentazione necessaria per il completamento del Laboratorio di datazione del Dipartimento di Fisica dell’Università di Bari.
Fig. 2. Curve di TL relative al campione L.T. 7 ; a sinistra sono evidenziate le aliquote con dosi crescenti BETA, mentre a destra quelle con dosi crescenti ALFA.
termolumInesCenza CeramIChe tIpo serra d’alto 261
note
1 GenIola 1987a, 1997.2 GenIola 1998.3 GenIola 1987b.4 GenIola 1997.5 aItken 1985.6 mCkeever 1997.7 adamIeC 1998.8 zImmerman 1971.9 Botter-Jensen 1988, 2000; thomsen 2007.
10 aItken 1985.11 namBI 1986.12 aItken 1985.13 Bos 2011.14 vartanIan 2001.15 tunzI 2008.16 GenIola 2002.17 eGe 2007.
BIBlIoGrafIa
adamIeC G., aItken M. 1998, Dose-rate conversion factors: update, in “Ancient TL”, 16, 2, pp.37-49.
aItken, M.J. 1985, Thermoluminescence dating, Academic Press, Londra.
Botter-Jensen L. 1988, The automated Riso TL dating reader system, in “Nuclear Tracks and Radiation Measurements”, 14, pp. 177-188.
Botter, Jensen L. 2000, Development of Optically Stimulated Lumines-cence Techniques using Natural Minerals and ceramics and their Application to Retrospective Dosimetry (Risoe National Labora-tory), Roskilde.
Bos A. J. J. 2001, High sensitivity thermoluminescence dosimetry, in “Nuclear Instruments and Methods in Physics Research”, B, 184, pp. 3-28.
eGe A., WanG Y., toWsend P. D. 2007, Systematic errors in thermolu-minescence, in “Nuclear Instruments and Methods in Physics Re-search”, A, 576, pp. 411–416.
mCkeever S.W.S., Chen R. 1997, Luminescence models, in “Radiation Measurements”, 27, 5/6, pp. 625-661.
GenIola A. 1987a, Il neolitico della Puglia centrale, in Il Neolitico in Italia (Atti della XXVI Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze, 7-10 novembre 1985), Firenze 1985, pp. 55-82.
GenIola A. 1987b, La cultura di Serra D’Alto nella Puglia centrale, in Il Neolitico in Italia (Atti della XXVI Riunione Scientifica dell’Isti-tuto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze, 7-10 novembre 1985), Firenze 1985, pp. 771-782.
GenIola A. 1997, L’Insediamento neolitico di Santa Barbara (Quader-no di Paletnologia, I), Bari.
GenIola A. 1998, The hypogea of Central Apulia,in Atti del XIII Con-gresso delle Scienze Preistoriche e Protostoriche, Forlì, 8-14 set-tembre 1996, Forlì, pp. 251-258.
GenIola A. 2002, Nuovi elementi decorativi incisi della cultura di Serra d’Alto nel quadro dei rapporti tra area balcanica, padano-triden-tina ed apula, in Preistoria e Protostoria del Trentino Alto Adige /Südtirol, in ricordo di Bernardino Bagolini (Atti della XXXIII Ri-unione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria Trento, 21-24 ottobre 1997), Trento, pp. 305-311.
namBI, K.S.V., aItken, M.J. 1986, Annual dose conversion factors for TL and ESR dating, in “Archaeometry”, 28, pp. 202-205.
thomsen K.J. 2007, Temperature calibration and MiniSys temperature upgrade for the Risø TL/OSL-DA-15 reader, in “Ancient TL”, 25,.1.
tunzI A. M., sanseverIno R. 2008, Nota preliminare sull’insediamento neolitico di C.no S. Matteo – Chiantinelle (Serracapriola – FG), in Atti del 28° Convegno sulla Preistoria – Protostoria – Storia della Daunia, Foggia, pp. 87-97.
vartanIan E., GuIlBert P., BeChtel F., sChvoerer M., alBore-lIvadIe C. 2001, Contribution de la thermoluminescence à la chronolo-gie de la culture du Gaudo: datation de céramiques du site de La Trinità, Piano di Sorrento, Italie, in “L’Anthropologie”, 105, pp. 421-434.
zImmerman, D.W. 1971, Thermoluminescence dating using fine grains from pottery, in “Archaeometry”, 13, pp. 29-52.