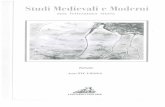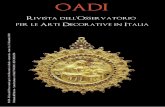Impresari del marmo ticinesi e lombardi. Carriere e dinastie
Au rebours. Nota su alcune sculture in marmo dell’acropoli di Cuma
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Au rebours. Nota su alcune sculture in marmo dell’acropoli di Cuma
INDICE
7 Premessa, Teresa Elena Cinquantaquattro11 1090 Introduzione, Carlo Rescigno
CUMA, IL TEMPIO DI GIOVE E LA TERRAZZA SUPERIORE DELL’ACROPOLI
13 CARLO RESCIGNO
Il Tempio di Giove sulla rocca cumana. Motivazioni di una ricerca
35 ROSARIA SIRLETO, ELIANA VOLLAROGli scavi storici dell’acropoli di Cuma. Contesti e materiali
63 RUGGERO MORICHI, ROSARIO PAONERiflessioni su una rilettura del rilievo del Tempio di Giove sull’acropolidi Cuma
67 GIUSEPPE CAMODECALa documentazione epigrafica e i templi dell’acropoli di Cuma romana
85 ELSA NUZZOAu rebours. Nota su alcune sculture in marmo dell’acropoli di Cuma
103 PAOLO CAPUTO, GENNARO CARANDENTE, MARZIA DEL VILLANO,CESARE GIORDANONote sulla terrazza superiore dell’acropoli di Cuma
119 GIANFRANCO DE ROSSILa chiesa di San Massimo: fonti storiche, evidenze archeologiche, ipotesiricostruttive
6
127 CRISTINA REGISRecenti interventi di scavo nell’area della Cripta Romana a Cuma.Analisi della stratigrafia dal saggio del vestibolo
135 MARIO PAGANOAlcune nuove osservazioni su Cuma
Materiali e documenti (a cura di CARLO RESCIGNO, ROSARIASIRLETO, ELIANA VOLLARO)
I. Cartografie e immagini storiche II. Materiali dell’acropoli nei disegni di Raffaele OlivaIII. Documenti di archivio
217 Sintesi dei materiali rinvenuti
219 Abbreviazioni bibliografiche (a cura di ROSARIA SIRLETO, ELIANAVOLLARO)
150170196
84 GIUSEPPE CAMODECA
43 Dennison 1898, p. 398, n. 64: [- - -]imi aedem.44 Dennison 1898, p. 374 n. 2 = AE 1899, 33 = Not. Sc., 1901, p. 19 = AE 1901, 169; cfr.
Tran Tam Tinh 1972, p. 147: [Ex] iussu I(ovis) O(ptimi) M(aximi) Heliopolitan[i] / [aede]mdilapsam M(arcus) Ulpius Sabinus aeditus i[—]; alt.: 24 x +117,50 x 15; ora esposta al MuseoArcheologico dei Campi Flegrei; si vd. con foto la mia scheda in rete sul sito edr-edr-it:EDR071689.
85LA DOCUMENTAZIONE EPIGRAFICA E I TEMPLI DELL’ACROPOLI DI CUMA ROMANA
ELSA NUZZO*
Au rebours. Nota su alcune sculture in marmo dell’acropolidi Cuma
Il presente lavoro si prefigge l’obiettivo di comporre una valutazione preliminare sul Bildprogramm delle sculture in marmo che animavanol’Acropoli di Cuma. Il compimento di una campagna di scavo presso il cd.
“Tempio di Giove”, con l’ausilio di metodologie d’indagine rigorose da partedella Seconda Università di Napoli, consente di riflettere in maniera dialetticasui risultati degli studi cumani, vivificati dalle recenti ricerche del “Progetto Kyme”e dall’apertura al pubblico del Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel castel-lo di Baia. In accordo con i principi del seminario, ho riesaminato la documenta-zione d’archivio (giornali di scavo e librette d’inventario), al fine di potere accer-tare le notizie concernenti i contesti di rinvenimento, procedendo all’analisistilistica dei marmi scolpiti e alla formulazione di ipotesi sulle tradizioni decorativee sui livelli della committenza che tale produzione investe. Per agevolare il ri-scontro nella documentazione, il lettore potrà consultare l’elenco trascritto inappendice e i testi della sezione documentaria del presente volume.
1. La decorazione architettonica attraverso i rinvenimenti sull’Acropoli
La difficoltà di identificare l’originario contesto di provenienza anche per gli
* Dottore di Ricerca in Archeologia della Magna Grecia – Università degli Studi di NapoliFederico II: [email protected]. Sono grata al Prof. Carlo Rescigno per avermi invitato a parte-cipare a questo incontro di studi sull’acropoli di Cuma, offrendomi la possibilità di discutere dialcune sculture in marmo ivi rinvenute nel corso del Novecento. Ad eccezione delle figure 3 e 4,che sono dell’autrice, le immagini sono tratte da Museo Archeologico dei Campi Flegrei 1.
ELSA NUZZO86
elementi in situ o quelli emersi dalle recenti campagne di scavo è intrinseca-mente connessa alle vicende storiche di Cuma, che è stata interessata in epocatardoantica da una sistematica spoliazione degli edifici pubblici del Foro e dallatrasformazione dei templi dell’acropoli in basiliche cristiane1: ladefunzionalizzazione dello spazio pubblico, accompagnata dall’impianto dicalcare, il progressivo impaludamento dell’area forense e l’installazione in epo-ca moderna di numerose masserie che hanno inglobato le strutture antiche,pur costituendo interessanti testimonianze della vitalità di Cuma in epoca post-classica, hanno modificato radicalmente il paesaggio urbano, ostacolando, inalcuni casi, anche la localizzazione delle aree indagate nei secoli scorsi. Le ri-cerche archeologiche del ’900 condotte con spirito pionieristico da EttoreGabrici, da Vittorio Spinazzola e da Amedeo Maiuri hanno contribuito a valo-rizzare le vestigia della città antica, dando avvio, con annose pratiche diesproprio, alla creazione del parco archeologico. Tuttavia la documentazionedegli scavi, redatta dai “sovrastanti”, risulta esigua e spesso non sufficiente aidentificare i materiali, che sono stati collocati nei depositi locali, trasferiti inparte nell’Antiquarium Flegreo a Pozzuoli ed infine al Museo ArcheologicoNazionale di Napoli.
In assenza di precisi dati epigrafici e di documentazione stratigrafica deicontesti di scavo, la distinzione tra i vari tipi di committenza si evince non solodal livello qualitativo degli ornamenta, ma anche dalla scelta dei materiali, lo-cali e d’importazione. L’adozione di specifiche tradizioni artigianali da partedei marmorarii mette in risalto i meccanismi di formazione delle maestranze ele fasi di trasmissione del repertorio decorativo all’interno di un atelier, lascian-do intravedere forme di cooperazione tra scalpellini di diversa origine. Pur secome disiecta membra, i marmi architettonici recuperati sulla rocca nel corsodel novecento consentono di illustrare il processo di elaborazione delle tradi-zioni decorative a partire dagli ultimi decenni del I secolo a.C., quando ilmunicipium assume un ruolo centrale nell’azione politica e militare svolta daOttaviano e Agrippa, fino alla compiuta definizione del processo di adegua-mento all’Imago Urbis nel corso della età augustea.
In proprietà Poerio nel 1911, sull’Acropoli, è scoperta “una cornice doppiae lunga ca 1 m”, che ho individuato nella casa colonica di un erede del Poerio -ubicata ad ovest del Capitolium, alle pendici del Monte di Cuma2 (fig. 1). Puòessere ascritta a una fase sperimentale del linguaggio architettonico con i fioria girandola di tradizione ellenistica e una sintassi delle modanature non ancoraarticolata secondo le formule espresse negli ordini del Foro di Augusto a Roma3.Alla fase augustea può essere attribuito un blocco di mensola4, recuperato ildue marzo del 1917: il toro, raffigurato come una vittima sacrificale, èaccovacciato sulle zampe anteriori, nell’atto di chinare il capo, cinto da una
AU REBOURS. NOTA SU ALCUNE SCULTURE IN MARMO 87
tenia. La resa naturalistica del corpo an-cora vigoroso, segnato dalle pieghe vo-luminose, contrasta con l’aspetto stiliz-zato, a chiocciola, del vello. Alla mede-sima fase cronologica appartiene ancheun capitello ionico figurato con protomed’ariete il cui movimento si accorda conla spirale della voluta5. Il luogo di rinve-nimento, la Crypta Romana, lascia sup-porre, pur con le debite cautele, una pro-venienza dalle terrazze dell’acropoli6
(fig. 2).È stata scoperta sulla rocca nel 1917
una cornice marcapiano frammentariaa meandro, formata da una successio-ne di svastiche e quadrati con bugnacentrale, con un kyma lesbio continuosemplice in corrispondenza dei margi-ni superiore e inferiore. Il pezzo, con-servato nella Villetta Vergiliana, va con-frontato con numerosi frammentirecuperati nelle Terme del Foro, nel1952, caratterizzati da un diverso kymalesbio7. Questi ultimi riproducono fe-delmente le cornici delle nicchie cheaccoglievano le immagini dei summiviri e della gens Iulia nel Foro di Augu-sto8; trovano precisi confronti anche inalcuni frammenti del Palatino e delMuseo del Bardo, adespoti, riferibili aun modulo dimensionale standard (dialtezza pari circa a 1 piede romano).En passant, vorrei ricordare che le la-stre forensi sono state recuperate assie-me con la bella immagine di Psiche ed Eros, il donum ad Apollo cumano daparte di un Cn. Lucceius9. Sono sempre stata incuriosita dalla foggia dell’acanthusspinosa e dell’ornato floreale, che parrebbe indicare l’adozione di modelli invoga tra l’età triumvirale - prima età augustea, di tradizione greco-orientale10.La dedica al nume della città potrebbe suggerire anche l’ipotesi che la statua siastata esposta in un sacello consacrato ad Apollo nell’area forense e non sull’acropoli.
Fig. 1. Baia, Museo Archeologico dei CampiFlegrei. Cornice di coronamento.
Fig. 2. Baia, Museo Archeologico dei CampiFlegrei. Capitello ionico con protome di ariete.
ELSA NUZZO88
Nello sterro della Crypta Romanaè stato recuperato un architrave fregiomonumentale11, che reca l’iscrizionedi dedica da parte di Lucceia Maximasacetis, membro dell’insigne genscumana cui era riservato, come è noto,il sacerdozio di Cerere. Il pezzo,attribuibile ad un edificio del Foro in-dagato dal conte di Siracusa, Leopoldodi Borbone12, presenta sul retro delblocco, semilavorato, visibili tre incassiper l’alloggio delle travi del tetto e unacroce incisa sul marmo in epocapostclassica, quando il blocco, ridot-
to nello spessore in corrispondenza del fregio, fu forse reimpiegato come spoliumnelle basiliche cristiane dell’acropoli o in luogo di preghiera non identificabilecon certezza. L’epistilio, coronato da un listello e da una gola rovescia, è artico-lato in tre fasce di altezza decrescente; tra la I e la II è disposto un astragalo. Lagola rovescia è decorata da un Bügelkymation, formato da archetti dalla super-ficie scanalata che racchiudono una punta di dardo e si alternano a plasticitulipani. L’astragalo è costituito da perline ovali distese e fusarole a calotta.Entrambi gli ornati possono essere attribuiti all’età augustea: il Bügelkymatione l’astragalo corrispondono rispettivamente ai tipi B nella classificazione delLeon13. L’uso dell’astragalo con fusarole a calotta come elemento di separazio-ne tra le fasce è documentato soprattutto in età medio-augustea, quando s’im-pone come modello l’apparato decorativo del Tempio di Marte Ultore; in par-ticolare compare solo tra la summa e media fascia in un architrave di Cherchel14,in quello del tempio di Roma ed Augusto a Ostia15, in una lastra d’architrave diPompei16, secondo una sintassi che costituisce una versione semplificata delloschema tipo A del Foro d’Augusto17. Per la resa naturalistica dell’ornato pro-pongo una datazione tra la media e tarda età augustea, attribuendo l’esecuzio-ne del pezzo all’attività di una bottega che rielabora le formule decorative delForo di Augusto, semplificando il profilo dell’architrave, all’interno del lin-guaggio architettonico diffuso nella Regio I e in Mauretania (Cherchel).
Un frammento di architrave-fregio a tralci d’acanto, recuperato nella CryptaRomana, segna, invece, il compimento del processo di adeguamento all’Imagourbis18. Il progressivo aggiornamento del repertorio decorativo, probabilmenteavvenuto nel corso dell’età tiberiana, è documentato da alcune cornici19 (fig.3), forse provenienti dall’acropoli. Il kyma lesbio trilobato, che costituisce lamodanatura di transizione tra sima e corona, trova confronto in alcune cornici
Fig. 3. Cuma, cornice di coronamento.
AU REBOURS. NOTA SU ALCUNE SCULTURE IN MARMO 89
di coronamento di Cherchel20, analogamente alle mensole seguite direttamen-te da una fila di dentelli21, mentre il kyma ionico al di sotto di questi ultimi èattestato nell’ordine superiore interno della Basilica Aemilia22 ed in una corni-ce di Ostia23. Una sintassi simile si riscontra in un frammento collocato nelMuseo Archeologico Nazionale di Napoli, presso il “Cortile della Vanella”24.Accanto a soluzioni che ancora rivelano la dipendenza da schemi protoaugustei- l’uso dei dentelli come prima modanatura della sottocornice - appaiono ilprofilo a voluta delle mensole e il ridimensionamento dei dentelli, unacommistione formale che significativamente caratterizza le cornici del tempiodi Roma ed Augusto ad Ostia25. La formazione del linguaggio architettonico inetà tardo-augustea e tiberiana parrebbe segnata da un graduale aggiornamentodel repertorio decorativo con una marcata influenza delle formule proto-augustee. Inoltre le affinità ri-scontrate nelle cornici del Mu-seo di Napoli e in quelle diOstia lasciano supporre un ana-logo sviluppo nei centri flegreie laziali, rendendo anche vero-simile l’attribuzione alle stessemaestranze. Le cornici marmo-ree recuperate nel 1914 nei ter-reni di Poerio26 offrono lo spun-to per analizzare la fase di tran-sizione tra la tarda età giulio-claudia e quella flavia, rivelan-do il progressivo aggiornamen-to del repertorio decorativo, purnei limiti di una ricerca ostaco-lata dal carattere sporadico deirinvenimenti27 (fig. 4ab). In que-sta prospettiva d’indagine la do-cumentazione archeologica del-la Campania risalente al perio-do compreso tra il terremoto del62-63 e l’eruzione del 79 d.C.assume un ruolo centrale nellostudio della Bauornamentik, co-stituendo- drammaticamente-un contesto sigillato, nel qualeil processo di trasformazione del Fig. 4a-b. Cuma. Cornici di coronamento.
ELSA NUZZO90
repertorio decorativo appare fissato in un’immagine istantanea. Il motivo dellagola dritta di coronamento, uno Scherenkymation tipo E del Leon28, èstilisticamente affine a quello che compare, esempi tra altri, in una cornicecollocata nel Lararium di Pompei29, in alcuni esemplari del Museo Archeologi-co Nazionale di Napoli etc.30. Il kyma lesbio trilobato è assimilabile al tipo Adel Leon31. Il kyma ionico sottostante presenta ovuli tronchi superiormente eappuntiti alla base, che appaiono piuttosto isolati all’interno degli sgusci, diforma ovale, definiti da nastri piatti; le lancette presentano una cuspide ingros-sata, che annuncia la progressiva trasformazione in freccetta. I dentelli di formaquadrangolare, posti ad una distanza pari alla metà della loro larghezza e prividi elementi intermedi, rientrano in una tendenza decorativa di età giulio-claudia.Lo Scherenkymation di chiusa è composto di forbici tronche in alto e congiuntealle estremità inferiori, che inquadrano una spora centrale lanceolata, parzial-mente nascosta; lo spazio di risulta assume la forma di un triangolo ribassato.L’ornamento sembra abbastanza vicino alle versioni giulio-claudie del tipo Cdel Leon32, anche se è minore l’ondulazione del profilo. Nelle cornici menzio-nate è possibile, infatti, rilevare l’incipiente vegetalizzazione dei kymatia lesbi-ci, la graduale metamorfosi della lancetta in freccetta all’interno del kyma ionicoe il ridimensionamento dei dentelli. L’adeguamento all’Imago Urbis avviene aCuma con il restauro del Capitolium33 e la costruzione della cd. “Masseria delGigante” in età domizianea34. L’esecuzione dei marmi architettonici della “Mas-seria del Gigante” mi pare sia stata affidata a maestranze locali, aduse alla lavo-razione di ornamenta di piccolo modulo, come mostra, ad esempio, la mancatacorrispondenza assiale delle modanature; essa rivela tipologie decorativeascrivibili all’epoca flavia e la persistenza di formule di ascendenza giulio-claudia,rappresentate dalla corona e dal soffitto lisci, nonché dalla moderatavegetalizzazione degli ornati35. In Campania la persistenza della tradizione giulio-claudia in epoca vespasianea è documentata nei capitelli del sacello B dell’areasuburbana di Ercolano, un’aedes Veneris, restaurata da Vibidia Saturnina e dalfiglio A. Furius Saturninus intorno al 70 d.C.36. All’età vespasianea, come mo-stra l’iscrizione incisa sul fregio-architrave, risalgono alcuni frammentiarchitettonici del Perirrhanterion, ricostruito in una sala della CentraleMontemartini a Roma37. Nell’Urbs la tradizione tardo-augustea tiberiana so-pravvive in forme semplificate nella tarda età giulio-claudia, come rivela ladecorazione dei portici in Sacra Via, di poco successiva all’incendio del 64d.C.38. Questo fenomeno, coerente al sistema di trasmissione del repertoriodecorativo basato sulla consuetudine e sulla prassi, documenta una continuitàartigianale durante la seconda metà del I secolo d.C., quando a Cuma la realiz-zazione di elementi architettonici sembra essere affidata a maestranze locali,verosimilmente dipendenti da commesse municipali. La decorazione
AU REBOURS. NOTA SU ALCUNE SCULTURE IN MARMO 91
architettonica in marmo della cella del Capitolium a Cuma mostra una mise àjour del repertorio decorativo da correlare ai cantieri dell’Arco di Tito a Romae a quelli dell’Arco di Traiano a Benevento39. La ristrutturazione sembra accor-darsi con l’impegno urbanistico di Domiziano che investe, nell’insieme, im-portanti centri della Campania40 e Cuma, in particolare, con costruzione delTempio del Divo Vespasiano (CIL X 3698), della Via Domiziana e dell’ArcoFelice, in concomitanza, forse, con l’istituzione della colonia, come suggerisceCamodeca in riferimento alla seconda redazione della Lex libitinaria41.
2. I ritratti
Rilevando in alcuni casi influssi delle botteghe insulari, anche per la qualità delmarmo (fig. 5)42, i ritratti sostanziano il desiderio di autorappresentazione espres-so dalle élites locali, che paiono scegliere l’acropoli come luogo di esposizionedelle imagines gentilizie, già negli anni centrali del I a.C. Già le testimonianzeepigrafiche documentano atti di evergetismo nella tarda età repubblicana an-che se ad essi non possiamo far corrispondere ritratti. Tra l’80 e il 60 a.C., èattribuita l’iscrizione musiva rinvenuta nel 191043 nel pavimento del cd. Sacello
B sulla terrazza inferiore, con la più antica men-zione dei praetores cumani: un Cn. Carisius eun M. Papirius, già scriba quaestorius (G.Camodeca). All’età sillana Stefania AdamoMuscettola ha attribuito la realizzazione dellafronte orientale del foro, di forte impattoscenografico, il “Portico delle maschere”44.L’aristocrazia municipale, che Cesare percepi-sce nel 49 a.C. come fazione a lui ostile, pareschierarsi con Pompeo. Un’epigrafe scopertanel Foro (1952) celebra come patronus delmunicipium cumano un L. Gellio L. f., identi-ficato da Giuseppe Camodeca con il L. GellioPoplicola, che ottiene il comando da Pompeonel 67 a C. nella guerra contro i pirati. Il figlio,tra i sodales di Antonio, cons. nel 36 a.C., gui-da l’ala destra della flotta ad Azio, cadendo vit-tima nella battaglia navale (Camodeca 2010a).A conclusione delle guerre civili contro SestoPompeo e Antonio sono eretti i portici cheinquadrano il Capitolium, nel settore occiden-
Fig. 5. Baia, Museo Archeologicodei Campi Flegrei. Ritratto virile.
ELSA NUZZO92
tale del foro, con fregi d’armi e capitelli corinzidi “secondo triumvirato”45. Il tema delle armicompare ad ornare un fregio di un mausoleo46,manifestando il carattere uniforme del linguag-gio architettonico adottato da maestranze adusea scolpire materiali diversi, il tufo grigio e il mar-mo lunense. Tra i ritratti scoperti nella CryptaRomana vorrei ricordare l’immagine giovaniledi Tiberio47 (fig. 6). Il tipo Copenhagen 624, notoda 25 repliche, figura nel ciclo dinastico di LeptisMagna agli inizi degli anni venti del I secolo d.C.Come in numerose sculture flegree, è da notarela tecnica di esecuzione del pezzo, che sul latosinistro, dalle tempie all’occipite, era completa-to con tasselli di riporto, congiunti senza l’ausiliodi perni metallici. A Cuma i sacrifici compiuticon hostiae maiores dinanzi alle statue di Tiberioe della madre, Livia, sonoricordati in un decre-to dei decurioni in
onore di Gaius Cupiennus Satrius Marcianus48,mentre a Pozzuoli la munificenza dell’impera-tore verso le città d’Asia, colpite da devastantiterremoti tra il 17 e il 29 d.C., è celebrata nellacosiddetta “Base di Tiberio”49, replica in scalaridotta di un celebre monumento urbano.Alla età tiberiana è attribuibile anche unritratto di Caligola (?), oggi esposto, assie-me alle altre sculture recuperate nella CryptaRomana, nel Museo dei Campi Flegrei a Baia(fig. 7).
Le modalità di rinvenimento di alcunesculture di II secolo, tra materiali di spoglio,non consentono di accertare il contesto pre-ciso di provenienza dei ritratti50, anche se ladedica di due statue di Marco Aurelio e LucioVero da parte di C. Pomponius Xystus, tra il161 e il 169 d.C., lascia ipotizzare la presen-za sull’acropoli delle statue raffiguranti i divifratres51. Il rinvenimento di un ritratto di epo-
Fig. 6. Baia, Museo Archeologico deiCampi Flegrei. Ritratto di Tiberio.
Fig. 7. Baia, Museo Archeologico deiCampi Flegrei. Ritratto di Caligola (?).
AU REBOURS. NOTA SU ALCUNE SCULTURE IN MARMO 93
ca tetrarchica (fig. 8)52 nel 1935 potrebbe suggerire, secondo Fausto Zevi, l’espo-sizione, sulla rocca di Cuma, di un gruppo di tetrarchi, da cui potrebbe prove-nire anche il ritratto recuperato nello sterro della Crypta Romana53 (fig. 9). Nelpieno IV secolo sono dedicate due statue di Virius Turbo, cons. Campaniae54 e al350 d.C. risale la dedica di Fabius Titianus, cos. nel 337 e XVvir sacris faciundis, chescioglie un voto ad Apollo cumano.
Fig. 8. Baia, Museo Archeologico deiCampi Flegrei. Ritratto virile barbato.
Fig. 9. Baia, Museo Archeologico deiCampi Flegrei. Ritratto virile barbato.
3. Sculture e opera nobilia dell’acropoli nel II secolo d.C.
Possediamo un elenco di materiali trasferiti al Museo Archeologico Nazionaledi Napoli nel 1937, dunque un anno prima dell’avvio ufficiale delle indagininell’area del Foro; in esso è menzionata, al primo numero, una “testa virile didivinità barbata e con chioma a riccioli spioventi sulla nuca e diversi sulla
ELSA NUZZO94
fronte. Copia romana? Frammentata al-l’estremità del naso e alla punta dei ric-cioli. H. max. m 0,315; largh. m 0,225 em 0,250” (Appendice) che propongo diidentificare con la replica del tipo Milles-Barberini55 (fig.10). L’ipotesi, se fosse cor-retta, fornirebbe un terminus ante quemper il rinvenimento e individuerebbel’acropoli come contesto originario di pro-venienza del pezzo. L’originale, attribui-to alla cerchia fidiaca, è stato riferito al mo-numento degli eroi eponimi nell’agorà diAtene, i dieci eroi prescelti dalla Pizia perdare il nome alle tribù di Atene al tempodella riforma di Clistene. Il monumento,già restaurato in epoca ellenistica, esibì trale immagini patrie l’effigie di Adriano,l’imperatore filoelleno (Pausania, I, 1-5)56.Le caratteristiche formali hanno consen-tito a Carlo Gasparri di attribuire la repli-ca di Cuma al repertorio della bottega diBaia, rinnovato nel corso dell’età adrianea
attraverso l’adozione di modelli attici dello stile tardo-severo, come l’AspasiaSosandra 57 e la Peplophoros Candia-Ludovisi58 (fig. 11).
Mi pare interessante riflettere sulla selezione delle immagini compiuta inepoca adrianea attraverso le opere della “bottega di Baia” e sui fenomeni cheessa innesca su un segmento della produzione scultorea destinato soddisfare lerichieste dei committenti, in cui è possibile riconoscere l’imperatore e il suoentourage. A Cuma verosimilmente l’eroe attico contribuisce ad animare i luo-ghi della pietas apollinea, in accordo con gli atti munifici di Q. Tineius Rufus,un personaggio eminente dell’età adrianea, su cui si è soffermato G. Camodeca.Consul suffectus nel 127, egli fu legato in Giudea dal 130 al 133, al tempo dellagrande rivolta giudaica di Bar Kokhba59 . Se la ricostruzione cogliesse nel se-gno, la città di Cuma parrebbe sostanziare nell’esibizione dell’opus nobile un’im-magine archetipica dell’Atene classica, in accordo con gli ideali del Panhellenion60.Attraverso un ambizioso programma urbanistico compiuto da Adriano, è dise-gnata un’“immagine mitica” di Atene, dell’antica Grecia in generale, che per leélites romane, come per Adriano, ha costituito sin dai tempi di Cicerone unparadigma culturale ed artistico61. In epoca adrianea il classicismo si manifestanello studio e nella ripresa fedele dei modelli architettonici di epoca classica ed
Fig. 10. Baia, Museo Archeologico dei Cam-pi Flegrei. Testa virile barbata del tipoMilles-Barberini.
AU REBOURS. NOTA SU ALCUNE SCULTURE IN MARMO 95
ellenistica (ad esempio ad Atene nelcompletamento dell’Olympieion, nel-l’esecuzione di statue di culto in avorio eoro, secondo una tradizione scultorea le-gata a Fidia; etc.), finanche nei singolidettagli dei profili delle modanature e neisistemi di assemblaggio dei blocchimarmorei. In epoca antonina, verosimil-mente in seguito all’invasione dei Costo-boci nel 170 d.C., il fenomeno si ripetead Eleusi nella copia dell’arco di Adrianoad Atene, che diventa esso stesso un mo-dello della cultura classicistica62. La con-sapevole ripresa di prototipi attici investeanche Neapolis, come mostra un capitel-lo del Foro63, ascrivibile a una bottega cheadotta come precipuo stilema le formedell’acanto ellenistico, elaborate dall’archi-tetto Cossutius per l’Olympieion diAntioco IV Epiphanes, negli anni centra-li del II a.C. La città partenopea esibiscecultura e lingua greca anche in epoca im-periale, costruendo un’immagine di sé for-temente connotata dalla cultura classica,tràdita in epoca medioevale e umanistica64.Significativamente la città è una tappa delviaggio di C. Iulius Arion, uno deiPanhellenes, di origine spartana, impegna-to nel compimento di un sacrificio, in etàantonina65. A Pozzuoli è stato trovato unimportante documento epigrafico, relati-vo all’ammissione della città di Kibyra nelsinedrio del Panhellenion: Paola Lombardiipotizza che a Puteoli, in quell’occasio-ne, sia stato consacrato un monumento,forse un’ara, per il culto di Adriano de-funto, presso la tomba posta in una delleville di Cicerone o nello stadio66.
All’età adrianea può essere attribuitauna testa ideale femminile maggiore del
Fig. 11. Baia, Museo Archeologico deiCampi Flegrei. Testa di Peplophoros tipoCandia-Ludovisi.
Fig. 12. Baia, Museo Archeologico dei CampiFlegrei. Testa di divinità femminile.
ELSA NUZZO96
vero, in marmo greco, che Giuliana Tocco ha recuperato nella rampa di ac-cesso nord-occidentale al santuario di Apollo, presso la prima cisterna67 (fig.12). Pur nella difficoltà di identificarne l’originale, mi pare che la presenza diun erote sulla spalla possa avvicinare la scultura cumana alle immagini diVenus Genetrix,68 alla cui variante è assimilata l’Antonia Minore del Ninfeodi Punta Epitaffio69. In una preliminare prospettiva di analisi, annovero unastatuetta di Afrodite in marmo da Thasos tra le elaborazioni del tipoiconografico durante il II d.C.70. Nei recenti scavi del Foro di Cuma è statariconosciuta in una statua ritratto una variante della Afrodite Louvre-Napo-li, interpretata come Umbildung flavia della Venus Genetrix augustea71. Leaffinità formali della testa in esame con l’Apollo di Punta Pennata72 suggeri-scono l’attribuzione a una bottega comune di gusto eclettico attiva tra l’etàadrianeo-antonina nei Campi Flegrei. A Cuma la supplicatio in onore di VenusGenetrix e di Mars Ultor sembra essere già prescritta nel Feriale cumano,datato tra il 4 e il 14 d.C.73
4. Conclusione
Questo breve excursus mira a contestualizzare gli ornamenta marmorei di Cumain un più ampio circuito di produzione che investe nell’insieme la Regio I,mettendo in evidenza la pluralità dei fenomeni che hanno determinato la for-mazione e la diffusione del nuovo linguaggio architettonico a partire dall’etàaugustea, seppur attraverso la persistenza di formule decorative diffuse in epo-ca tardo-repubblicana. I materiali architettonici recuperati nella Crypta Roma-na, cui si è fatto riferimento in questo contributo, seppure adespoti, rappresen-tano i semata di una sintassi compositiva coerente, da riferire ad architetture dietà tiberiana. A questo periodo risalgono alcuni ritratti, un Tiberio e un Cali-gola (?), che potrebbero appartenere a una galleria di icone dinastiche, forseesposte sull’Acropoli. Le immagini ideali dell’eroe eponimo attico e dellaPeplophoros Candia-Ludovisi, opere attribuite alla cd. Bottega di Baia, manife-stano la munificentia di Adriano e del suo più ristretto entourage sulla roccaconsacrata ad Apollo.
Appendice documentaria
Un documento d’archivio attesta che nel 1937 alcuni materiali recuperati nellecampagne di scavo precedenti furono trasferiti al Museo Archeologico Nazio-nale di Napoli74.
AU REBOURS. NOTA SU ALCUNE SCULTURE IN MARMO 97
1) Marmo. Testa virile di divinità barbata e con chioma a riccioli spioventisulla nuca e diversi sulla fronte. Copia romana? Frammentata all’estremità delnaso e alla punta dei riccioli. H. max. m 0,315; largh. m 0,225 e m 0,250.
2) Marmo. Testa virile imberbe di uomo maturo mancante del naso. Ri-tratto romano. Lavoro in grossa parte abbozzato. Qualche scheggiatura. H. m0,29; largh. m 0,19 e 0,225.
3) Marmo. Testa virile di giovinetto. Ritratto romano di età augustea. Man-cante di parte del naso. Forse L. Cesare o C. Cesare o Augusto giovinetto. H. m0,29; largh. m 0,185 e 0,220.
4) Marmo. Ritratto virile imberbe di uomo maturo, lavorato a gradina aldisotto del collo per l’incastro di un torso. Manca del naso e del padiglione del-l’orecchio destro. Ritratto romano di età augustea. H. m 0,36; largh. 0,175 e 0,190.
5) Marmo. Testa virile imberbe di uomo giovane. Tagliata dallo zigomosinistro fino all’occipite: lavorata per essere connesso ad un altro pezzo. Lavo-ro in alcune parti abbozzato. La superficie della guancia destra e del padiglionedell’orecchio destro. Ritratto romano di età augustea. Misure h. m 0,265; largh.della parte conservata m 0,22.
6) Marmo. Testa virile imberbe e calva di uomo maturo. Mancante di partedel naso e di quasi tutta la metà posteriore, le orecchie sono abrase. Ritrattoromano. Il mento, la gola, il labbro inferiore sono scagliati. H. m 0,27.
7) Marmo. Testa virile barbata di uomo maturo. Con la punta del nasocorrosa e totale abrasione della superficie di tutta la metà destra. Ritratto roma-no di età traianea. H. m 0,265; largh. m 0,205 e 0,205.
8) Marmo. Testa virile imberbe di uomo maturo. Mancante di tutto il mentoe parte delle guance e della punta del naso, che era lavorato a parte, inserita;corrotto nella parte superiore, manca inoltre tutta la calotta cranica superiore etutto il lato sinistro. Ritratto romano. Misura dalla parte conservata h. m 0,20;largh. m 0,205.
9) Marmo. Testa di divinità femminile lavorata solo nella metà anteriore,con parte del collo scagliato e con il viso completamente corroso. Ha i capellistretti intorno alla testa da una benda che passa dietro le orecchie, rigonfi sullafronte con ciocche sporgenti sulle tempie e sulle guance e due lunghi boccolisul collo. H. m 0,26; largh. m 0,175.
10) Marmo. Testina femminile di Afrodite scheggiata e corrosa nella parteinferiore del viso, nella fronte e nell’orecchio destro. La testa ha i capelli spar-titi sulla fronte e stretti da una benda intorno alla testa, rigonfi sui lati e raccoltiin un nodo sulla nuca. H. m 0,18; largh. m 0,13 e 0,13. (v. ritratto antiquriamflegreo.
11) Marmo. Testa virile barbata. Terzina di divinità (Poseidon) con capellistretti da una benda e spioventi sulla nuca. Mancante del naso e di parte della
7
ELSA NUZZO98
barba a sinistra. H. m 0,225; largh. m 0,150 e 0,120.12) Marmo. Erma bicipite mancante di una faccia di divinità virile (Apollo)
di tipo arcaicistico con triplice serie di riccioli chiccioliforme sulla fronte ediadema, ornato sui lati, dio nudo, boccoli spiraliformi sul lato destro del viso,sul mento e sulle labbra.
13) Marmo. Ermetta bicipite di satirello e sileno barbato. Quasi integra,salvo qualche scheggiatura.
14) Marmo. Ermetta bicipite di Sileno e satirello ridente, alquanto logora-ta e scheggiata.
15) Marmo. Frammento di rilievo romano di arte augustea. Sono conser-vate due teste di littori con fascio e di sacerdote? Forse rappresenta una pompa.Misura della parte conservata h. m 0,20; largh. m 0,26. (150209)
16) Marmo. Frammento di rilievo con testa femminile di divinità con dia-dema e velata. Misura della parte conservata h. m 0,165; largh. m 0,155 e h.max del rilievo m 0,085 (150208).
17) Marmo. Statua di divinità femminile seduta sul plinto, coperto da cu-scino e sostenuto da pilastro di dimensioni 1 al vero. La dea (Anfitrite) indossaun sottile chitone cinto molto in alto sulla vita e al disopra di questo mantelloche le copre anche la testa con i capelli adorni di un diadema. Il viso e buonaparte della superficie della statua sono corrosi. Mancano il braccio destro finoal gomito e il sinistro fino al disotto della piegatura, il piede destro per unametà e parte della base. Sotto i piedi è uno sgabello. Lavoro ellenistico di artedecorativa. H. m 1,18; largh. max m 0,50.
18) Marmo. Statua terzina di divinità maschile seduta (Poseidon), nellostessa posizione e stesso schema della precedente con cui formava una coppia.Il dio è coperto dal mantello che è raccolto sulla spalla sinistra, tiene nelladestra un piccolo delfino poggiato sulla gamba destra. Parte della superficie èlievemente corrosa. Manca il naso, il braccio sinistro, la punta del piede destro,parte della base (lo spigolo e la zampa dello sgabello). Misure: h. m 1,70; largh.m 0,48.
19) Marmo greco. Torso mutilo di divinità femminile con chitone cintoalla vita e ampiamente rimboccato. È una replica dell’Eirene di Cefisodoto.Misura della parte conservata H. m 1,48; largh. m 0,60.
AU REBOURS. NOTA SU ALCUNE SCULTURE IN MARMO 99
1 Di recente: De Rossi 2006; Caputo, De Rossi 2006, pp. 68-70; Malpede 2005; P. Caputoin Museo Archeologico dei Campi Flegrei 1, pp. 419-422; Guardascione 2009, pp. 152-153, fig.6 (calcara).
2 Museo Archeologico dei Campi Flegrei 1, p. 375, n. inv. 313869 (Cuma, sala 21); Nuzzo2010, pp. 377-398, in particolare p. 379, fig. 1.
3 La sequenza di kyma ionico, dentelli, gola rovescia nella sottocornice diventa canonicanell’architettura imperiale: De Angeli 1992, nota 554.
4 Museo Archeologico dei Campi Flegrei 1, p. 391, n. inv. 241545 (Cuma, sala 22). È segna-lato al numero 127 nell’inventario del materiale archeologico rinvenuto nello sterro della“Grotta della Sibilla” (da intendere come Crypta Romana) e nel “Tempio di Giove” (C 18/8,fasc. 2) (cfr. all. III.29).
5 Museo Archeologico dei Campi Flegrei 1, p. 376 (Cuma, sala 21).6 È forse il caso di ricordare che nel 1911 a poca distanza da un “rudere di forma
ottogonale”, a sud del Tempio di Apollo, è stato rinvenuto “un capitello di ordine ionicoper ornamento di pilastro. Di esso avanza la parte anteriore ornata da motivi di mezzi ovolie da una voluta. Lungh. 0,40x0,18”, in marmo bianco. La notizia va correlata a un docu-mento che menziona il recupero, nel 1911, di un frammento di capitello ionico rivestito distucco pertinente alla decorazione del Tempio d’Apollo (h. m 0,65, largh. m 1) in proprietàPoerio (ACN C 18/28: documento n. di protocollo 4130 datato 7/10/1911; nell’anno suc-cessivo si denuncia l’avvenuta scomparsa del rivestimento in stucco: ACN, C 20/2, n. diprotocollo 3034 del 22/8/1912) e nel 1913 di un capitello in marmo bianco di ordine ionico(?), che misura m 0,19 x 0,70 x 0,33 (ACN, C 15/1, n. di protocollo 3447, datato 14/11/1913). Sarebbe opportuno compiere una verifica nei depositi locali, un lavoro arduo, ma chepotrebbe essere agevolato dai numeri di inventario apposti sui singoli pezzi, da confrontarecon quelli riportati nelle librette.
7 Museo Archeologico dei Campi Flegrei 1, p. 339, inv. n. 151082 a-d (Cuma, sala 19). Nellostesso contesto furono recuperate anche cornici marcapiano a tralci d’acanto: Museo Archeo-logico dei Campi Flegrei 1, p. 338, inv. n. 151081 a-g (Cuma, sala 19); Nuzzo 2010, pp. 385-386, figg. 12-13.
8 Nuzzo 2007, pp. 350, 359; per gli esemplari urbani: Ungaro 2007, p. 159, fig. 217;Polito 2002, pp. 91-112.
9 Museo Archeologico dei Campi Flegrei 1, n. inv. 151072 (Cuma, sala 18).10 Cohon 2004, pp. 83-106.11 Museo Archeologico dei Campi Flegrei 1, n. inv. 230793, p. 319 (Cuma, sala 17).12 Cfr. Camodeca 2005, pp. 175-177, fig. 5; Di Re, Pollio 2009, pp. 271-282; cfr. anche M.
Pagano in questo volume.13 Leon 1971, p. 246 (Bügelkymation), p. 271 (astragalo).14 Pensabene 1982, n. 169.15 Leon 1971, pp. 171, 254, 271, fig. 70,1; Hänlein-Schäfer 1985, p.132, tav. 4; Calandra
2000, p. 433, fig. 22.16 Mau 1892, p. 141, fig. 1.17 Leon 1971, p. 169, tav. 68,1.18 Museo Archeologico dei Campi Flegrei 1, p. 95 (Cuma, sala d’ingresso 4).19 Cuma, Cripta Romana. Presentano nella sopracornice la sima, solo parzialmente con-
servata, con il profilo di una gola dritta decorata da baccellature, un listello, una gola rove-
NOTE
ELSA NUZZO100
scia ornata da Bügelkymation, che segna la transizione alla corona liscia e al soffitto amodiglioni; nella sottocornice i dentelli che si collocano sotto il piano d’imposta delle men-sole, un kyma ionico, un astragalo ed infine una gola rovescia decorata da Bügelkymation.Un frammento, pertinente alla medesima serie, è conservato a Cuma, nel deposito dellaVilletta Vergiliana, n. inv. 67 (scaffale D, scomp. 1, rip. B, cassetta n. 357: la provenienzadalla Cripta Romana o dal Tempio di Apollo è riportata sulla cassetta).
20 Pensabene 1982, nn. 69-107, 133, 134.21 Pensabene 1982, nn. 8-28, tipi II-III, tavv. 31-33.22 Pensabene 1982, p. 172, 269, 278, tav. 69.3.23 Pensabene 1982, p. 193, tav. 111.3.24 Il pezzo, adespota, differisce solo per la presenza di uno Scherenkymation come
modanatura terminale della sottocornice25 Leon 1971, p. 184, tav. 79.4; von Hesberg 1980, p. 210, tavv. 32.3, 35.1; Pensabene
1995, pp. 356 e 360, fig. 369; Pensabene 1996, pp. 190-191, fig. 3; Calandra 2000, pp. 434-436, nn. cat. 12 a-b, figg. 25-26. Nella sottocornice si susseguono dentelli e kyma lesbio.
26 Nel febbraio del 1914 è recuperata una cornice di coronamento in marmo bianco,leggermente arcuata, intagliata con modanature decorate (dimensioni indicate: m 0,29x 1,73x0,75) e alla distanza di m 1,50 un frammento pertinente allo stesso tipo (ACN, C 15/11).
27 Proprietà Giacomo Poerio, via Cuma 1, s.n. Le cornici, in marmo lunense, presenta-no il profilo leggermente curvilineo e sono profilate con le seguenti modanature (dall’altoverso il basso): una gola dritta, delimitata da listelli marginali, decorata da uno Schrenkymationvegetalizzato; una gola rovescia ornata da un kyma lesbio trilobato; un ovolo con un kymaionico; un listello; una fila di dentelli e una gola rovescia con uno Scherenkymation.
28 Pensabene 1972, pp. 31-33, nota 52.29 Iacobelli, Pensabene 1995-1996, pp. 45-75, p. 51, fig. 8.30 MANN Box 15: nn. inv. 242736, 244718.31 Leon 1971, pp. 245-246 (età augustea).32 Leon 1971, p. 263.33 Gasparri 2007, pp. 17, 21; Petacco, Rescigno 2007; Rescigno 2009b; Foresta 2009.34 Sull’edificio: Coraggio 2007, p. 147.35 Cuma, Foro, s.n. Le cornici di coronamento orizzontale pertinenti all’ordine dei por-
tici presentano le seguenti modanature (dall’alto verso il basso): una gola dritta di corona-mento definita superiormente da un listello e decorata da uno Scherenkymation fitomorfo,un tondino ed un listello che segnano la transizione alla corona e al soffitto lisci; nellasottocornice un listello, una gola rovescia ornata da un Bügelkymation; un ovolo intagliatocon kyma ionico, un listello ed una gola rovescia liscia.
36 Guidobaldi, Balasco, Camodeca 2008.37 Al monopteros sono stati attribuiti dallo studioso alcuni elementi architettonici di
ordine corinzio recuperati nei depositi del Portico d’Ottavia: due capitelli corinzi, unarchitrave a tre fasce con iscrizione dedicatoria, un fregio decorato all’interno da tralci d’acantoe all’esterno da un serto d’alloro sorretto da corna di bucrani, una cornice di coronamentoa modiglioni. La Rocca 1993, p. 22; Bertoletti 2008, pp. 210-211; Vitti 2010, pp. 529-584.
38 Pensabene, Caprioli 2009, p. 110.39 Cfr. Demma 2007, p. 204 ss.40 Miseno: Camodeca 2000; Camodeca 2011c, pp. 374-391; Napoli: von Hesberg 2010,
pp. 44-48; Longobardo, Zeli 2010, pp. 43-44, fig. 20 (capitelli di tradizione tardoflavia-traianea,attribuiti al terzo ordine della scena); Pozzuoli, arco del Quadrivio dell’Annunziata, cuisono riferiti i noti rilievi Berlino-Philadelphia: rilievo con Germano, n. inv. 264910: MuseoArcheologico dei Campi Flegrei 2, p. 83 (Pozzuoli, sala 32).
41 Camodeca 2004, pp. 89-92 (con bibl.); Castagnetti 2004, pp. 133-146. La tabula èesposta nel castello di Baia: Museo Archeologico dei Campi Flegrei 1, pp. 354-355 (Cuma, sala20). Cfr. Gasparri 2009, pp. 131-147, in particolare p. 141.
42 Museo Archeologico dei Campi Flegrei 1, p. 380.
AU REBOURS. NOTA SU ALCUNE SCULTURE IN MARMO 101
43 Il ritrovamento è registrato nel Giornale di Scavo 1910 il giorno 25 maggio: ACNC21/2, fasc. 2.
44 Adamo Muscettola 2007, pp. 209-228; Di Re, Pollio 2007, pp. 229-234.45 Museo Archeologico dei Campi Flegrei 1, pp. 94-95 (Cuma, sala 3).46 Il pezzo, recuperato durante le ricerche del Centre J. Bérard, è conservato a Cuma, nei
depositi del Foro.47 Museo Archeologico dei Campi Flegrei 1, p. 382, n. inv. 150197, 155748 (Cuma, sala 22).48 AE 1927, p. 158. L’iscrizione di età tiberiana, riferita all’acropoli da G. Camodeca, è
stata datata tra il 14 e il 29, anno della morte di Livia.49 L’originale, rinvenuto a Pozzuoli nel 1693, è esposto al MANN, inv. 6780. Museo
Archeologico dei Campi Flegrei 2, p. 33 (Pozzuoli, sala 28, calco in gesso).50 Il 7 dicembre del 1916, a nord del Tempio di Apollo, reimpiegata in un muro tardo, è
stata recuperata una statua femminile del tipo Orante, risalente all’età adrianea: Museo Ar-cheologico dei Campi Flegrei 1, p. 374 (Cuma, sala 21). Il 26 giugno del 1935 presso la cd.Torre Bizantina è rinvenuta una testa virile in marmo, identificata con un ritratto degli inizidel II d.C. Le lunghe ciocche di capelli sulla fronte formano un motivo a tenaglia sul latosinistro, secondo le formule iconografiche del ritratto di Traiano, creato per celebrare idecennalia del regno. Sul ritratto dei Musei Capitolini, inv. 276: Ritratti 2011, p. 272 (G.Colugnati).
51 C. Pomponius Xystus, uno dei membri della plebs degli Augustales di Liternum, consa-cra assieme a C. Pomponius Agon, probabilmente il figlio, un’arula in marmo proconnesio aIuppiter Flazus: Museo Archeologico dei Campi Flegrei 1, p. 303 (Cuma, sala 16). In relazionea CIL X, 3695 e 3695a: Camodeca 2001b, p. 166.
52 Museo Archeologico dei Campi Flegrei 1, p. 386, n. inv. 150195 (Cuma, sala 22). ACN, C24/12 (26 giugno 1935): Rinvenimento testa barbuta pertinente ad una statua virile in mar-mo presso lo scavo della torre. Alt. 0,27 x 0,40 m. Lo scavo è stato sospeso, perché il muro dirinforzo alla parete est della torre, fatto in epoca posteriore, poggia su un terrapienopreesistente e che potrebbe essere l’antico piano di calpestio. Attraverso diversi saggi pareche il piano della torre fosse ricavato con lo spianamento della roccia tufacea sottostante econ la colmata si siano superati gli inconvenienti di dislivelli aventi la roccia. La colmata è caottanta cm e su questa, uniformemente, è nato uno strato di calce, di spessore 10 cm, ricava-to probabilmente con marmi, come rilevasi dai diversi pezzi raccolti e di non perfetta cottu-ra. Dal riesame dei documenti non appare accertato il rinvenimento durante lo scavo dellaTorre del ritratto, inv. n. 150193: Museo Archeologico dei Campi Flegrei 1, p. 383 (Cuma, sala22).
53 Museo Archeologico dei Campi Flegrei 1, p. 387 (Cuma, sala 22).54 Tra il 5 e 11 giugno del 1911 durante lo scavo, iniziato sul lato occidentale del Tempio
di Apollo, si scoprono le due basi in travertino.55 Museo Archeologico dei Campi Flegrei 1, p. 388, n. inv. 150240 (Cuma, sala 22).56 Vatin 1995, pp. 33-41.57 MANN, inv. 153654. Il tipo della c.d. Aspasia, noto da più di 20 repliche, riproduce
un originale datato concordemente tra il 470-460 a.C., ma l’identificazione dell’artista restacontroversa: di recente Gasparri 1995, p. 176, nota 19; Ferrara 1999; Saletti 1999, pp. 68-73,figg. 1-8.
58 Museo Archeologico dei Campi Flegrei 1, p. 387, n. inv. 153655 (Cuma, sala 22). È possi-bile ipotizzare che la scultura sia stata rinvenuta nel 1952 nella Crypta Romana assieme alritratto, inv. n. 315392: Museo Archeologico dei Campi Flegrei 1, p. 380 (sala 22).
59 Eck 1999, pp. 76-89.60 Graindor 1934; Oliver 1965, pp. 123-133; Benjamin 1963, pp. 57-86; Spawforth, Walker
1985; Willers 1990; Marotta 1995, pp. 157-167; Jones 1996, pp. 29-56; Romeo 2002; Galli2008.
61 A. Henrichs, in HSCP, 97, 1995, 258-61.62 Kienast 1959-1960, pp. 61-69; Clinton 1989, pp. 56-68; Giraud 1989, pp. 69-78; Antonetti
ELSA NUZZO102
1995, pp. 149-156; Baldassarri 2007.63 Capitelli corinzieggianti di lesena (n. inv. 312251): San Lorenzo Maggiore. Guida al
Museo e al complesso, Napoli 2005, a cura di D. Giampaola, n. 4, p. 18 (E. Nuzzo). Laricerca sull’attività di questa bottega di marmorarii tra l’età adrianea e antonina, di prossimapubblicazione, è stata da me condotta ad Atene, presso la Scuola Archeologica Italiana nel2010.
64 Adamo Muscettola 1994.65 Oliver 1965; Caldelli 2005.66 Dalla collezione del vescovo Rosini nel seminario di San Francesco: Lombardi 2003.
Cfr. Camodeca 2000-2001, pp. 147-175.67 Museo Archeologico dei Campi Flegrei 1, p. 378, n. inv. 241462 (Cuma, sala 22).68 Bieber 1933; Guerrini 1959-1960; Denti 1982, pp. 158-174.69 Museo Archeologico dei Campi Flegrei 3, p. 159.70 Musée Archeologique di Thasos, s.n. Recuperata nel Quartier de la porte d’Hermes a
Thasos, presenta un erote sulla spalla sinistra.71 Gasparri 2010, p. 34; Museo Archeologico dei Campi Flegrei 1, p. 357 (Cuma, sala 20);
Foresta 2009, pp. 221-223, figg. 10-11.72 Scatozza 1976, pp. 31-33, tav. VIII, 11.73 ILS 108=Degrassi n. 44 “[...]i, Marti Ultori, Veneri [Genetrici]”. Rives 1994, p. 304.
L’iscrizione è esposta nel castello di Baia: Museo Archeologico dei Campi Flegrei 1, p. 313, n.inv. 3015 (Cuma, sala 17). Significativo il rinvenimento nel Foro di una statua di MarteUltore datata in epoca flavia: F.M. Guardascione, in Studi Cumani 2, pp. 160-163.
74 ACN, C18/8, I fascicolo.
DOCUMENTI D’ARCHIVIO 219
AASS Acta Sanctorum, ed. Padri Bollandisti, Bruxelles.Acerenza 1995 AA.VV., Acerenza, Venosa 1995.ACN Archivio Corrente della Soprintendenza Archeologica
di Napoli e Pompei.Adamo Muscettola 1994 S. Adamo Muscettola, ‘Napoli e le belle antechetate’,
in F. Zevi (a cura di), Neapolis, Napoli 1994, pp. 95-109.Adamo Muscettola 2007 S. Adamo Muscettola, ‘Maschere a Cuma. Il teatro in-
stabile di Cuma’, in C. Gasparri e G. Greco (a cura di),Cuma, indagini archeologiche e nuove scoperte, StudiCumani 2, 2009, pp. 209-228.
ADN Archivio Disegni della Soprintendenza Archeologicadi Napoli e Pompei.
AFN Archivio Fotografico della SoprintendenzaArcheologica di Napoli e Pompei.
Ambrasi, D’Ambrosio 1990 D. Ambrasi, A. D’Ambrosio, La diocesi e i vescovi diPozzuoli, Napoli 1990.
Annecchino 1930 R. Annecchino, Torregaveta, Pozzuoli 1930.Antonetti 1995 C. Antonetti, ‘La centralità di Eleusi nell’ideologia
panellenica adrianea’, in Ostraka 4, 1995, pp. 149-156.Annecchino 1908 R. Annecchino, ‘Pel Museo Civico Flegreo’, in Bolletti-
no Flegreo, Napoli 1928, pp. 5-10.Arena 1994 R. Arena, Iscrizioni greche arcaiche di Magna Grecia e
Sicilia III. Iscrizioni delle colonie euboiche, Pisa 1994.Arthur 1996 P. Arthur, ‘Ceramica comune tardo-antica e alto-medie-
vale’, in P. Arthur (a cura di), Il complesso archeologico diCarminiello ai Mannesi. Napoli (scavi 1983-1984),Galatina 1996, pp. 181-220.
ASN Archivio Storico Soprintendenza Archeologica di Na-poli e Pompei.
Baiae-Misenum 1979 M.R. Borriello, A. D’Ambrosio, Baiae-Misenum. For-ma Italiae, Regio I, vol. XIV, Firenze 1979.
Baldassarri 2007 P. Baldassarri, ‘Copia architettonica come memoria delpassato. I Grandi Propilei di Eleusi e il santuario di etàantonina’, in O.D. Cordovana, M. Galli (a cura di), Artee memoria culturale nell’età della seconda sofistica, Cata-nia 2007, pp. 211-232.
Barrett 1989 A.A. Barrett, Caligula. The Corruption of Power, London1989.
Barsanti 2008 C. Barsanti et alii (a cura di), Rex Theodoricus. Il meda-
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE220
glione d’oro di Morro d’Alba, Roma 2008.Bartonek, Buchner 1995 A. Bartonek, G. Buchner, ‘Die ältesten griechischen
Inschriften von Pithekoussai (2. Hälfte des VIII. bis I.Hälfte des VI. Jh.)’, in Die Sprache 37.2, 1995, pp. 129-231.
Bejaoui 1994 F. Bejaoui, Sbeitla, l’antique Sufetula, Tunis 1994.Bejarano Ossorio 2002 A. M. Bejarano Ossorio, ‘Una ampulla de vidrio con la
planta topografica de la ciudad de Puteoli’, in Mérida 8,2002, pp. 513-532.
Benjamin 1963 A. S. Benjamin, ‘The altars of Hadrian in Athens andHadrian’s Panhellenic program’, in Hesperia 32, 1963,pp. 57-86.
Beloch 1890 = 1989 (tr. it.) K. J. Beloch, Campanien. Geschichte und Topographie desantiken Neapel und seiner Umgebung, Zweite vermehrteAusgabe, Breslau 1890. Traduzione italiana: Campania.Storia e topografia della Napoli antica e dei suoi dintor-ni (a cura di Cl. Ferone e F. Pugliese Carratelli), Napoli1989.
Bertoletti 2008 M. Bertoletti, ‘Monopteros’, in E. La Rocca, S. Tortorella(a cura di), I Trionfi romani, Milano 2008, pp. 210-211.
BHL Bibliotheca Hagiographica Latina antiquae et mediaeaetatis, Bruxelles 1898-1901.
Bieber 1933 M. Bieber, ‘Die Venus Genetrix des Archilaos’, in RM48, 1933, pp. 261-276.
Boccini, Ciccozzi 2007 F. Boccini, E. Ciccozzi (a cura di), Opera nazionale per iCombattenti. Progetti, Roma 2007.
Boethius. His life 1981 M. Gibson (a cura di), Boethius. His life, thought andinfluence, Oxford 1981.
Boezio 1979 L. Orbetello (a cura di), Severino Boezio. La consolazio-ne della filosofia. Gli opuscoli teologici, Milano 1979.
Boschung 1993 D. Boschung, ‘Die Bildnistypen der iulisch-claudischenKaiserfamilie: ein kritischer Forschungsbericht’, in JRA6, 1993, pp. 39-79.
Boschung 2002 D. Boschung, Gens Augusta. Untersuchungen zuAufstellung, Wirkung und Bedeutung der Statuengruppendes julisch-claudischen Kaiserhauses, Mainz am Rhein2002.
Breglia 2009 L. Breglia, ‘I culti di Cuma opicia’, in Cuma, ACIStMGrXLVIII, 2008 (2009), pp. 229-270.
Brown 1984 T.S. Brown, Gentlemen and Officers. Imperialadministration and Aristocratic Power in Byzantine ItalyA. D. 554-800, Rome 1984.
Brun, Munzi 2001 J.P. Brun, P. Munzi, ‘Cumes’, in MEFRA 113, 2001, pp.484-487.
Buonarroti 1716 F. Buonarroti, Osservazioni sopra alcuni frammenti divasi antichi di vetro ornati di figure trovati ne’ cimiteri diRoma, Firenze 1716.
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE 221
Burkert 1987 W. Burkert, Mito e rituale in Grecia. Struttura e storia,trad. it., Roma-Bari 1987.
Burkert 1988 W. Burkert, ‘Katagogia-Anagogia and the Goddess ofKnossos’, in R. Högg, N. Marinatos, G.G. Nordquist(a cura di), Early Greek Cult Practice (Proceedings ofthe International Symposium at the Swedish Instituteat Athens 1986), Stokholm 1988, pp. 81-88.
Calandra 2000 E. Calandra, ‘Documenti inediti sul Tempio di Roma edi Augusto a Ostia’, in RM 107, 2000, pp. 417-450.
Caldelli 2005 M.L. Caldelli, ‘Eusebeia e dintorni: su alcune nuove iscri-zioni puteolane’, in Epigraphica LXVII, 2005, pp. 63-85.
Calvino 1960 R. Calvino, ‘Una inedita iscrizione cristiana rinvenutaa Cuma’, in Asprenas 7, 1960, pp. 235-236.
Calvino 1969 R. Calvino, Diocesi scomparse in Campania, Napoli 1969.Calvino 1976 R. Calvino, ‘Documenti e testimonianze monumentali
sul culto del martire Sossio, diacono della chiesa diMiseno’, in Campania sacra 7, 1976, pp. 279-285.
Calvino 1982 R. Calvino, ‘Testimonianze monumentali della chiesadi Misenum nel Museo Archeologico Nazionale diNapoli e nel Museo Nazionale di San Martino’, in RACLVIII, 1982, pp. 47-57.
Cameron 1996 A. Cameron, ‘Orfitus and Constantius: a note onRoman gold glasses’, in JRA 9, 1996, pp. 295-301.
Camodeca 1980-1981 G. Camodeca, ‘Ricerche su Puteoli tardoromana’, inPuteoli IV-V, 1980-1981, pp. 59-128.
Camodeca 2000 G. Camodeca, ‘Domiziano e il collegio degli Augustalidi Miseno’, in G. Paci (a cura di) Epigraphai. Miscellaneaepigrafica in onore di Lidio Gasperini, Tivoli 2000, pp.171-187.
Camodeca 2001a G. Camodeca, ‘Iscrizioni pubbliche nuove o riedite emonumenti di Cumae I – Foro e tempio di Apollo’, inAIONArchStAnt, n. s. 8, 2001, pp. 149-162.
Camodeca 2001b G. Camodeca, ‘Albi degli Augustales di Liternum dellaseconda metà del II d.C.’, in AIONArchStAnt, n. s. 8,2001, pp. 163-182.
Camodeca 2000-2001 G. Camodeca, ‘Lo stadium di Puteoli, il sepulchrum diAdriano in Villa Ciceroniana e l’Historia Augusta’, inRendPontAcc 73, 2000-2001, pp. 147-175.
Camodeca 2004 G. Camodeca, ‘Per la riedizione delle leges libitinariaeflegree’, in Libitina e dintorni. Libitina e i luci sepolcrali,le leges libitinariae campane iura sepulcrorum: vecchie enuove iscrizioni, Roma 2004, pp. 83-104.
Camodeca 2005 G. Camodeca, ‘Sulle proprietà senatorie in Campaniacon particolare riguardo al periodo da Augusto al IIIsecolo’, in Cahiers Glotz XVI, 2005, pp. 121-137.
Camodeca 2007 G. Camodeca, ‘Il giurista L. Neratius Priscus cos suff
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE222
97. Nuovi dati su carriera e famiglia’, in Studia et Docu-menta Historiae et Iuris LXXIII, 2007, pp. 291-311.
Camodeca 2010a G. Camodeca, ‘Il patrimonio epigrafico latino e l’élitemunicipale di Cumae’, in L. Chioffi (a cura di), Il Medi-terraneo e la storia. Incontro internazionale di studio.Epigrafia e archeologia in Campania: letture storiche (Na-poli, 4-5 dicembre 2008), Napoli 2010, pp. 47-72.
Camodeca 2010b G. Camodeca, ‘Sull’élite e l’amministrazione cittadinadi Cuma romana’, in M. Cébeillac Gervasoni (a curadi), La Praxis municipale dans l’Occident romain (AttiConv. EMIRE, Paris ott. 2009), Clermont-Ferrand 2010,pp. 215-239.
Camodeca 2011a G. Camodeca, ‘La base con iscrizione osca posta daMaius Calovius Of(felli filius) e le istituzioni di Cumanel II secolo a.C.’, in B. D’Agostino – M. Giglio (a curadi), Cuma. Le Fortificazioni 3. Lo scavo 2004-2006, Na-poli 2011, pp. 48-55.
Camodeca 2011b G. Camodeca, ‘Puteoli e Cumae in epoca romana nelCampanien di Beloch’, in F. Senatore (a cura di), KarlJulius Beloch da Sorrento nell’Antichità alla Campania(Atti del Convegno storiografico in memoria di Clau-dio Ferone, Piano di Sorrento 28 marzo 2009), I Qua-derni di Oebalus 3, Roma 2011, pp. 201-221.
Camodeca 2011c G. Camodeca, ‘Nuove dediche imperiali dal collegiodegli Augustales di Miseno per Domiziano e perElagabalo’, in Corolla Epigraphica: hommages Y.Burnand, Bruxelles, Latomus 2011, pp. 374-391.
Campi Flegrei 1990 AA.VV, I Campi Flegrei, Napoli 1990.Capaccio 1607 G.C. Capaccio, La vera antichità di Pozzuolo, Napoli
1607.Capaccio 1630 G.C. Capaccio, Il forastiero. Dialoghi, Napoli 1630.Capaccio 1652 G.C. Capaccio, La vera antichità di Pozzuolo, Napoli
1652.Capaldi 2009 C. Capaldi, ‘Dediche a membri della famiglia imperiale
ed attestazioni di munificentia nel Foro’, in C. Gasparrie G. Greco (a cura di), Cuma. Indagini archeologiche enuove scoperte, Studi Cumani 2, Pozzuoli 2009, pp. 197-212.
Capasso 1882-1892 B. Capasso, Monumenta ad Neapolitani Ducatushistoriam pertinentia, voll. I-II, Napoli 1882-1892.
Caputo 1991 P. Caputo, ‘Pozzuoli (Napoli). Cuma. Terme del Foro.Saggi di scavo’, in BA 11-12, 1991, pp. 173-175.
Caputo 1993a P. Caputo, ‘Cuma. Crypta Romana. Saggi di scavo’, inBA 22, 1993, pp. 121-124.
Caputo 1993b P. Caputo, ‘Cuma. Indagini archeologiche all’anfitea-tro’, in BA 22, 1993, pp. 130-132.
Caputo 1997 P. Caputo, ‘Vicende e conseguenze della II guerra mon-
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE 223
diale nell’area archeologica di Cuma’, in R. Giamminelli(a cura di), Gli studiosi dei Campi Flegrei rendono omag-gio a Raimondo Annecchino (Atti del Convegno 17, 31gennaio e 14 febbraio 1997), Napoli 1997.
Caputo 1998 P. Caputo, ‘Saggi di scavo nella Crypta Romana di Cuma:proposta di rilettura del monumento’, in C. AlboreLivadie, F. Ortolani (a cura di), Il sistema uomo-ambien-te tra passato e presente, CUEBC Ravello, Bari 1998, pp.49-55.
Caputo 2001 P. Caputo, ‘Il lago Fusaro: storia e archeologia di unterritorio’, in Centro Ittico Campano. Le grotte dell’Ac-qua. Intervento di salvaguardia e di valorizzazione, Bacoli2001, pp. 26-38.
Caputo 2003a P. Caputo, ‘Il tempio di Iside a Cuma: nuovi documen-ti sul culto isiaco in Campania’, in ATTA 12, 2003, pp.209-220.
Caputo 2003b P. Caputo, ‘Nuovi rinvenimenti vitrei dall’areaarcheologica di Cuma. Prospettive di ricerca’, in C.Piccioli, F. Sogliani (a cura di), Il vetro in Italia Meridio-nale ed insulare (Atti del Secondo ConvegnoMultidisciplinare, Napoli, 5-7 dicembre 2001), Napoli2003, pp. 45-51.
Caputo 2004 P. Caputo, ‘La Grotta di Cocceio a Cuma. Nuovi datida ricerche e saggi di scavo’, in ATTA 13, 2004, pp. 309-330.
Caputo 2005 P. Caputo, ‘Una domus-villa urbana a Cuma, in Campa-nia, e il suo rapporto con la città’, in Otium. Festschriftfür Volker Michael Strocka, Remshalden 2005, pp. 39-46.
Caputo 2006 P. Caputo, ‘Ricerche sul suburbio meridionale di Cuma’,in ATTA 15, 2006, pp. 107-134.
Caputo, Cavassa 2009 P. Caputo, L. Cavassa, ‘La fabrication du bleu égiptienà Cumes’, in J.P. Brun (a cura di), Artisanats antiquesd’Italie et de Gaule. Mélanges offerts à Maria FrancescaBuonaiuto, Naples 2009, pp. 169-179.
Caputo, De Rossi 2006 P. Caputo, G. De Rossi, ‘Cuma bizantina: il castrum.Stato delle ricerche e indagini recenti’, in G. Coppola,E. D’Angelo, R. Paone (a cura di), Mezzogiorno e Medi-terraneo. Territorio, strutture, relazioni tra Antichità eMedioevo (Atti del Convegno internazionale, Napoli 9-11 giugno 2005), Napoli 2006, pp. 65-75.
Caputo, De Rossi 2007 P. Caputo, G. De Rossi, ‘“Rioccupazione cristiana” diedifici pubblici e infrastrutture a Cuma: lo scavo dellaCrypta Romana’, in R.M. Bonacasa Carra, E. Vitale (acura di), La cristianizzazione in Italia fra Tardoantico eAltomedioevo (Atti dell’IX Congresso Nazionale diArcheologia Cristiana, Agrigento 20-25 novembre 2004),Palermo 2007, pp. 979-990.
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE224
Caputo, Pugliese 1997 P. Caputo, M.R. Pugliese, La via delle Terme. Proposte diitinerari nell’area flegrea dall’antichità ad oggi, Napoli1997.
Caputo, Regis 2009a P. Caputo, C. Regis, ‘L’anfiteatro cumano e le cavitàartificiali di Cuma’, in Cuma, ACIStMGr XLVIII, 2008(2009), pp. 729-733.
Caputo, Regis 2009b P. Caputo, C. Regis, ‘L’area della Cava Greca a Cuma.Rinvenimento di una fornace d’età bizantina a Cuma’,in Les céramiques communes, de Marseille à Genes (et enLanguedoc, Campanie et Sicile), Ie s. av. J. - C. – IIIe s. apr.J.-C. Structures de production, typologies et contextes inédits(Atti della Tavola Rotonda, Napoli 2-3 novembre 2006),Napoli 2009, pp. 109-117.
Caputo, Rescigno 2006 T. Caputo, C. Rescigno, ‘Cuma, Foro: le terrecottearchitettoniche arcaiche e classiche dai riempimenti delpodio del Capitolium’, in Deliciae Fictiles III,Architectural Terracottas in Ancient Italy: new discoveriesand interpretations, Oxford 2006, pp. 280-293.
Carafa 1999 P. Carafa, ‘Il tempio grande dell’acropoli di Cuma. Ana-lisi metrologica e proposte di ricostruzione’, in R.E.Docter, E.M. Moormann (a cura di), Proceedings of theXVth International Congress of Classical Archaeology,Amsterdam, July 12-17,1998, Amsterdam 1999, pp. 104-106.
Carafa 2008 P. Carafa, Culti e santuari della Campania antica, Roma2008.
Cartaro 1584 M. Cartaro, Ager Puteolanus, Roma 1584.Castagnetti 2004 S. Castagnetti, La lex cumana libitinaria nelle due reda-
zioni, in Libitina e dintorni. Libitina e i luci sepolcrali, leleges libitinariae campane iura sepulcrorum: vecchie e nuo-ve iscrizioni, Roma 2004, pp. 133-146.
Cattedrale in Italia P. Testini, G. Cantino Wataghin, L. Ermini Pani (a curadi), La cattedrale in Italia. Atti XI Congresso Interna-zionale di Archeologia Cristiana (Lione 1986), Città delVaticano 1989.
Cecchelli 1951 C. Cecchelli, Vita di Roma nel Medio Evo 1: arti minorie costume. 3: vetri e ceramiche, Roma 1951.
Chaniotis 2002 A. Chaniotis, ‘Ritual dynamics: the boiotian festival ofthe Daidala’, in H.S. Versnel, H.F.J. Horstmanshoff (acura di), Kykeon: studies in honour of H.S. Versnel, Leiden2002, pp. 23-48.
Chausson 2007 Fr. Chausson, Stemmata aurea, Roma 2007Christern 1966-1967 J. Christern, ‘Jupitertempel in Cumae und seine
Umwandlung in eine Kirche’, in RM 73-74, 1966-1967,pp. 232-241.
Christern 1977 J. Christern, ‘Il Cristianesimo nella zona dei CampiFlegrei’, in I Campi Flegrei nell’archeologia e nella storia
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE 225
(Atti del Convegno Internazionale, Roma 4-7 maggio1976), Roma 1977, pp. 213-225.
Cinque, Russo, Pagano 1991 A. Cinque, F. Russo, M. Pagano, ‘La successione deiterreni di età post-romana delle Terme di Miseno (Na-poli): nuovi dati per la storia e la stratigrafia delbradisismo puteolano’, in Bollettino della Società Geolo-gica Italiana 110, 1991, pp. 231-244.
Ciprotti 1957-1958 P. Ciprotti, ‘Pitture pompeiane inedite’, in RendPontAccXXX-XXXI, 1957-1958, pp. 153-160.
Clinton 1989 K. Clinton, ‘Hadrian’s contribution to the renaissanceof Eleusis’, in S. Walker, A. Cameron (a cura di), TheGreek Renaissance in the Roman Empire, London 1989,pp. 56-68.
Cogitore 1992 I. Cogitore, ‘Séries de dédicaces italiennes à la dynastiejulio-claudienne’, in MEFRA 104, 1992, pp. 817-864.
Cohon 2004 R. Cohon, ‘Forerunners of the scroll work on the AraPacis Augustae made by a Western Asiatic workshop’,in JRA 17, 2004, pp. 83-106.
Coraggio 2007 F. Coraggio, ‘La Masseria del Gigante’, in C. Gasparri,G. Greco (a cura di), Cuma. Il Foro. Scavi dell’Universi-tà di Napoli Federico II, 2000-2001, Studi Cumani 1, 2007,pp. 235-260.
Costa 1860 O.G. Costa, Del Fusaro. Descrizione e proposte, Napoli1860.
Colonna 1984 G. Colonna, ‘I templi del Lazio fino al V secolo com-preso’, in ArchLaz VI, 1984, pp. 396-411.
Comstock-Vermeule 1971 M. Comstock, C. Vermeule, Greek, Etruscan and RomanBronzes in the Museum of Fine Arts Boston, Greenwich1971.
Cracco Rugini 1998 L. Cracco Rugini, ‘Il senato fra due crisi (III-VI secolo)’,in Il Senato nella Storia I. Il Senato nell’età romana, Roma1998, pp. 223-375.
Criscuolo 2001 U. Criscuolo, ‘Su alcune tarde interpretazioni del mitodi Icaro’, in RAAN , n.s. LXX, 2001, pp. 307-328.
Cristofani 1987 M. Cristofani, ‘I santuari: tradizioni decorative’, inEtruria e Lazio arcaico, QuadCSEI 15, 1987, pp. 95-120.
Cristofani 1998 M. Cristofani, ‘Luoghi di culto dell’ager Campanus’, inI Culti della Campania antica (Atti del Convegno Inter-nazionale di Studi in ricordo di Nazarena Valenza Mele,Napoli 15-17 maggio 1995), Roma 1998, pp. 169-173.
Crocco 1970 A. Crocco, Introduzione a Boezio, Napoli 1970Cuma e il suo parco 1996 P. Caputo, R. Morichi, R. Paone, P. Rispoli, Cuma e il
suo parco archeologico. Un territorio e le sue testimonian-ze, Roma 1996.
D’Ambrosio 1980-1981 D’Ambrosio, in G. Camodeca (a cura di), ‘Schedeepigrafiche’, in Puteoli 4-5, 1980-81, pp. 265-287.
D’Andrea et alii 1991 G. D’Andrea, U. Del Vecchio, C. Tufano, F. Iovino, ‘I
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE226
bunkers di Cuma’, in R. Paone e C. Piciocchi (a cura di),3rd International Symposium on Underground quarries(Castel dell’Ovo, 10-14 July 1991), Napoli 1991, pp. 64-99.
DAGL 1991 W. Buchwald, A. Hohlweg, O. Prinz, Dictionnaire desauteurs grecs et latins de l’Antiquité et du Moyen Age, Bru-xelles 1991.
Dally 2006 O. Dally, Die Architekturfragmente aus Terrakotta undKalkstein. Katalog der Sammlung antiker Kleinkunst desarchäologischen Instituts der Universität Heidelberg,Siebter Band, Mainz am Rhein 2006.
De Angeli 1992 S. De Angeli, Templum Divi Vespasiani, Roma 1992.De Caro 1999 S. De Caro, ‘Dati recenti sul Tardoantico nella Campania
settentrionale’, in L’Italia meridionale in età tardo anti-ca, ACIStMGr XXXVIII, 1998 (1999), pp. 223-242.
de Jorio 1817 A. de Jorio, Guida di Pozzuoli e contorno, Napoli 1817.de Jorio 1822 A. de Jorio, Guida di Pozzuoli e contorni, 2a ed., Napoli
1822.de Jorio 1823 A. de Jorio, Viaggio di Enea all’Inferno, ed agli Elisii se-
condo Virgilio, Napoli 1823.de Jorio 1839 A. de Jorio, Guida per le catacombe di S. Gennaro de’
Poveri, Napoli 1839.De Lellis 1950 C. De Lellis, Storia di Avellino, Avellino 1950.Degrassi 1926 (=1962) A. Degrassi, ‘Iscrizione municipale di Cuma’, in RFIC
54, 1926, pp. 371-379 = Scritti vari di antichità, 1, Roma1962, pp. 473-481.
Del Verme, Sacco 2002-2003 L. Del Verme, G. Sacco, ‘Cuma: frammenti ceramiciiscritti dagli scavi dell’Orientale’, in AIONArchStAnt9-10, 2002-2003, pp. 251-270.
Delpino 1998 F. Delpino, ‘Vittorio Spinazzola. Tra Napoli e Pompei,fra scandali e scavi’, in P. G. Guzzo (a cura di), Pompei,scienza e società. 250 anniversario degli Scavi di Pompei(Atti del Convegno Internazionale, Napoli 25-27 no-vembre 1998), Napoli 1998, pp. 51-61.
Demma 2007 F. Demma, Monumenti pubblici di Puteoli. Per un’Arche-ologia dell’Architettura, Roma 2007.
Dennison 1898 W. Dennison, ‘Some new Inscriptions from Puteoli,Baiae, Misenum and Cumae’, in AJA 2, 1898, pp. 373-398.
Denti 1982 M. Denti, ‘Un’Afrodite della collezione Torno e alcu-ne osservazioni in margine al problema della VenusGenetrix di Arkesilaos’, in ArchCl 34, 1982, pp. 158-174.
Deposito votivo 2002 M. Catucci, L. Jannelli, L. Sanesi Mastrocinque, Il depo-sito votivo dall’acropoli di Cuma, Roma 2002.
De Rossi 1998 G. De Rossi, ‘Gli Acta translationi Sancti Sosii e la per-duta cattedrale di Miseno’, in Domum tuam dilexit. Mi-scellanea in onore di Aldo Nestori, Città del Vaticano
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE 227
1998, pp. 251-264.De Rossi 2000a G. De Rossi, ‘Sulla topografia cristiana di Misenum: con-
siderazioni e ipotesi di ricerca. Il sito della Ecclesia SanctiSosii’, in Proculus LXXV, n.s. 4, 2000, pp. 579-591.
De Rossi 2000b G. De Rossi, ‘Il porto di Miseno tra Costantino eGregorio Magno: nuova luce dalle recenti acquisizioni’,in L’Africa Romana (Atti del XIV Convegno di Studio,Sassari 7-10 dicembre 2000), Roma 2002, pp. 835-845.
De Rossi 2004 G. De Rossi, ‘La fornace di Misenum (Napoli) ed i suoiprodotti ceramici: caratteri e diffusione’, in S. PatitucciUggeri (a cura di), La ceramica altomedievale in Italia,Firenze 2004, pp. 253-264.
De Rossi 2005 G. De Rossi, ‘Indicatori archeologici della produzionee diffusione del vino della Baia di Napoli in età altome-dievale’, in G. Volpe, M. Turchiano (a cura di), Paesaggie insediamenti rurali in Italia meridionale fra Tardoanticoe Altomedioevo, Bari 2005, pp. 541-549.
De Rossi 2006 G. De Rossi, ‘Ridisegnando la topografia urbana dellecittà dei Campi Flegrei’, in M. Ghilardi et alii (a curadi), Les Cités de l’Italie tardo-antique (IVe-Vie siècle):institutions, économie, société, culture et religion, Rome2006, pp. 235-250.
Deichmann 1993 Fr. W. Deichmann, Archeologia cristiana, Roma 1993.Dewailly, Munzi Santoriello 2011 M. Dewailly, P. Munzi Santoriello,‘‘Cuma, un acroterio
a disco con maschera di Gorgo. Dal ritrovamento allaipotetica collocazione’, in P. Lulof, C. Rescigno (a curadi), Deliciae Fictiles IV. Images of Gods, Monsters andHeroes, Oxford 2011, pp. 322-330.
Di Re, Pollio 2007 R. Di Re, A. Pollio, ‘Cuma: il Portico delle Maschere’,in C. Gasparri, G. Greco (a cura di), Cuma, Il Foro. Sca-vi dell’Università di Napoli Federico II, 2000-2001, StudiCumani 1, 2007, pp. 229-234.
Di Re, Pollio 2009 R. Di Re, A. Pollio, ‘Primi scavi del 1853 eseguiti perordine di Sua Altezza Reale il Conte di Siracusa’, in G.Gasparri, G. Greco (a cura di), Cuma. Indagini archeolo-giche e nuove scoperte, Studi Cumani 2, 2009, pp. 271-282.
Duval 1982 N. Duval, L’urbanisme de Sufetula = Sbeitla en Tunisie’,in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, Principat10, II, 1982, pp. 596-631.
Eck 1999 W. Eck, The Bar Kokeba Revolt: the Roman Point ofView’, in JRS 89, 1999, pp. 76-89.
Engelmann 1968-1969 J. Engelmann, ‘Bermerkungen zu spätrömischenGläsern mit Goldfoliendekor’, in JbAC 11-12, 1968-1969,pp. 7-25.
Enjuto Sanchez 2006 B. Enjuto Sanchez, ‘I Neratii: legami tra Roma e le cittàdel Sannio nel IV secolo d.C.’, in Les cités de l’Italie tar-
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE228
do-antique (IVe-VIe siècle), Rome 2006, pp. 113-121.Ermini Pani 1985 L. Ermini Pani, ‘Note sull’architettura monastica del
Lazio Meridionale nell’Alto Medioevo’, in L. Gulia, A.Quacquarelli (a cura di), Antichità paleocristiane ealtomedioevali del Sorano (Atti del Convegno di Studi,Sora 1-2 dicembre 1984), Sora 1985, pp. 19-40.
Faedo 1978 L. Faedo, ‘Per una classificazione preliminare dei vetridorati tardo romani’, in AnnPisa 8, 1978, pp. 1025-1070.
Ferrara 1999 A. Ferrara, ‘La Sosandra “da Stabiae”: testimonianza pre79 d.C. dal centro urbano di Castellamare’, in RStPompX, 1999, pp. 167-175.
Ferro 1606 A. Ferro, Apparato delle statue nuovamente trovate nelladistrutta Cuma, Napoli 1606.
Foresta 2009 S. Foresta, “L’area antistante al Tempio di Giove Otti-mo Massimo Capitolino e il settore nord-occidentaledel Foro”, in C. Gasparri e G. Greco (a cura di), Cuma.Indagini archeologiche e nuove scoperte, Studi Cumani 2,2009, pp. 213-227.
Fraschetti 1982 A. Fraschetti, ‘Un nuovo senatore da Giffoni Valle Pia-na’, in Epigrafia e ordine senatorio 1, Tituli 4, Roma 1982,pp. 553-558.
Fratta 2002 F. Fratta, ‘Per una rilettura del sistema di fortificazionidi Cuma’, in Cuma. Nuove forme di intervento per lostudio del sito antico (Atti della giornata di studio, Na-poli 12 febbraio 2001), Napoli 2002, pp. 21-73.
Frontisi Ducroux 1975 F. Frontisi Ducroux, Dédale. Mythologie de l’artisan enGrèce ancienne, Paris 1975.
Gabrici 1910 E. Gabrici, ‘Cuma. Sua importanza nell’antichità, laGrotta della Sibilla e la religione dei morti, gli scavida farsi’, in BA 3, 1910, pp. 105-122.
Gabrici 1913 E. Gabrici, Cuma, in MAL XXII, 1913.Galli 2008 M. Galli, ‘Theos Hadrianos: le élites delle città greche e
il culto dell’imperatore filolleno’, in A.D. Rizakis, F.Camia (a cura di), Pathways to Power.‘Civic elites in theEastern Part of the Roman Empire, Atene 2008, pp. 73-105.
Gallo 1985-1986 A. Gallo, ‘Il santuario di Apollo sull’acropoli di Cuma’,in Puteoli IX-X, 1985-1986, pp. 121-210.
Galonier 2004 A. Galonier, ‘Cassiodore entre politique et science:l’exemple du portrait de Boèce’, in Schola salernitanaIX, 2004, pp. 61-87.
Garcia Y Garcia 1998 L. Garcia Y Garcia, Nova Biblioteca Pompeiana. 250 annidi bibliografia archeologica, I, Roma 1998.
Garrucci 1858 R. Garrucci, Vetri ornati di figure in oro trovati nei cimi-teri dei cristiani primitivi di Roma, Roma 1858.
Gasparri 1995 C. Gasparri, ‘L’officina dei calchi di Baia’, in RM 102,1995, pp. 173-187.
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE 229
Gasparri 2007 C. Gasparri, ‘Il foro di Cuma: le campagne 2000-2001’,in C. Gasparri, G. Greco (a cura di), Cuma. Il Foro. Sca-vi dell’Università di Napoli Federico II, 2000-2001, StudiCumani 1, 2007, pp. 15-26.
Gasparri 2009 C. Gasparri, ‘Il Foro di Cumae: un bilancio prelimina-re’, in C. Gasparri e G. Greco (a cura di), Cuma. Indagi-ni archeologiche e nuove scoperte, Studi Cumani 2, 2009,pp. 131-147.
Gasparri 2010 C. Gasparri, ‘Cuma romana’, in L. Chioffi (a cura di),Incontro internazionale di studio. Epigrafia e archeologiain Campania: letture storiche (Napoli 4-5 dicembre 2008),Napoli 2010, pp. 23-46.
Gialanella 1998 C. Gialanella, ‘Una fornace per il vetro a Puteoli’, in C.Piccioli, F. Sogliani (a cura di), Il vetro in Italia meridio-nale e insulare (Atti del Primo ConvegnoMultidisciplinare, Napoli 5-6-7-marzo 1998), Napoli1998, pp. 151-160.
Gigante 1995 M. Gigante, ‘Un Iseo a Cuma?’, in RM 102, 1995, pp.317-319.
Giraud 1989 D. Giraud, ‘The Greater Propyleia at Eleusis, a copy ofMenesikles Propylaia’, in S. Walker, A. Cameron (a curadi), The Greek Renaissance in the Roman Empire, London1989, pp. 69-78.
Glass 1987 D.B. Harden (a cura di), Glass of the Caesar, Milano 1987.Gold-glass 1959 C.R. Morey, G. Ferrari (a cura di), The gold-glass collection
of the Vatican Library, Città del Vaticano 1959.Graindor 1934 P. Graindor, Athènes sous Hadrien, Le Caire 1934.Gray 1948 N. Gray, ‘The Paleography of Latin Inscriptions in the
Eighth, Ninth and Tenth Centuries’, in PBSR XVI,1948, pp. 38-171.
Grella 1989 C. Grella, Il pothos della dogana di Avellino nel MuseoIrpino, Avellino 1989.
Gualtieri 2003 M. Gualtieri, La Lucania romana. Cultura e società nelladocumentazione archeologica, Napoli 2003.
Gualtieri 2008 M. Gualtieri, ‘La Lucania centro-settentrionale in etàromana: la nuova documentazione archeologica’, in A.Russo, H. Di Giuseppe (a cura di), Felicitas temporum.Dalla terra alle genti: la Basilicata settentrionale tra ar-cheologia e storia, Potenza 2008, pp. 205-221.
Gualtieri 2010 M. Gualtieri, ‘Acerenza tardo-antica e il territorio alto-bradanico’, in G. Volpe, R. Giuliani (a cura di), Paesaggie insediamenti urbani in Italia meridionale fra tardoanticoe alto medioevo (Foggia 27-28 maggio 2006), Bari 2010,pp. 193-199.
Guardascione 2009 F. M. Guardascione, ‘Lo scavo della cd. Aula sillana’, in C.Gasparri e G. Greco (a cura di), Cuma. Indagini archeolo-giche e nuove scoperte, Studi Cumani 2, 2009, pp. 149-166.
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE230
Guarducci 1971-1972 M. Guarducci, ‘Gli avori erculei della cattedra di SanPietro’, in MemAccLincei, Scienze morali VIII, XVI, 5,1971-1972, pp. 263-350.
Guerrini 1959-1960 L. Guerrini, ‘Ricerche stilistiche intorno a un motivoiconografico’, in ASAAtene 37, 1959-1960, pp. 403-419.
Guidobaldi, Balasco, M.P. Guidobaldi, A. Balasco, G. Camodeca, ‘Il tempioCamodeca 2008 di Venere di Ercolano nell’area sacra di Ercolano:
anastilosi e ricostruzione dell’epigrafe dedicatoria’, inP.G. Guzzo, M.P. Guidobaldi (a cura di), Nuove ricerchearcheologiche nell’area vesuviana (scavi 2003-2006), Roma2008, pp. 560-564.
Hänlein-Schäfer 1985 H. Hänlein-Schäfer, Veneratio Augusti. Eine Studie zuden Tempeln des ersten römischen Kaisers, Archeologica39, Roma 1985.
Hayes 1972 J.W. Hayes, Late roman pottery, London 1972.Hurlet 1997 F. Hurlet, Les collègues du prince sous Auguste et Tibère. De
la légalité républicaine à la légitimité dynastique, Rome 1997.Iacobelli, Pensabene 1995-1996 L. Iacobelli, P. Pensabene, ‘La decorazione architettonica
del tempio di Venere a Pompei. Contributo allo studioe alla ricostruzione del santuario’, in RStPomp 7, 1995-1996, pp. 45-75.
Iasiello 2003 I. Iasiello, Il collezionismo di antichità nella Napoli deiVicerè, Napoli 2003.
Itinerario Flegreo 1984 A. Maiuri, Itinerario Flegreo, Napoli 1984.Iversen 2007 P.A. Iversen, ‘The Small and the Great Daidala in
Boiotian History’, in Historia 56, 2007, pp. 381-418.Jannelli 1999 L. Jannelli, ‘La frequentazione dell’acropoli di Cuma
in età pre-protostorica: i dati dello scavo Buchner’, inAIONArchStAnt 6, 1999, pp. 73-90.
Jeffery 1960 L.H. Jeffery, The Local Scripts of Archaic Greece, London1960.
Johannowsky 1973 W. Johannowsky, ‘Note sui criptoportici pubblici inCampania’, in Les cryptoportiques dans l’architectureromaine (Actes du Colloque de Rome, 19-23 avril 1972),Publications de l’École française de Rome 14, 1973, pp.143-165.
Jones 1996 C.P. Jones, ‘The Panhellenion’, in Chiron 26, 1996, pp.29-56.
Jost 1997 M. Jost, ‘Le théme des disputes entre Héra et Zeus enArcadia et en Béotie’, in J. de La Genière (a cura di),Héra. Images, espaces, cultes (Actes du colloqueInternational, Lille 29-30 novembre 1993), Naples 1997,pp. 87-92.
Kerschner, Schlotzhauer 2005 M. Kerschner, U. Schlotzhauer, ‘A new classificationsystem for east greek pottery’, in Ancient West & East4.1, 2005, pp. 1-56.
Kienast 1959-1960 D. Kienast, ‘Hadrian, Augustus und die eleusinischen
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE 231
Misteren’, in JNG 10, 1959-1960, pp. 61-69.Knoepfler 2001 D. Knoepfler, ‘La fête des Daidala des Platées chez
Pausanias: une clef pour l’histoire de la Béotiehellénistique’, in D. Knoepfler, M. Piérart (a cura di),Éditer, traduire, commenter Pausanias en l’an 2000,Neuchâtel 2001, pp. 343-374.
Koch 1912 H. Koch, Dachterrakotten aus Kampanien mit Ausschlussvon Pompeji, Berlin 1912.
Heer 1910 J.M. Heer, Evangelium Gratianum, Fribourg 1910.La Rocca 1993 E. La Rocca, ‘Due monumenti a pianta circolare: il
perirrhanterion e la columna bellica’, in R. T. Scott, A.Reynolds Scott (a cura di), Eius virtutis studiosi,Washington 1993, pp. 17-29.
Lambert 2008 C. Lambert, Studi di epigrafia tardo antica e medievalein Campania, I. Secoli IV-VII, Firenze 2008.
Lazzarini 1976 M.L. Lazzarini, “Le formule delle dediche votive nellaGrecia arcaica”, in MAL XIX, Roma 1976.
Lentini 2006 M.C. Lentini (a cura di), Vasi del Wild Goat Style dallaSicilia e dai musei europei, Gela 2006.
Leon 1971 C.F. Leon, Die Bauornamentik des Trajansforums und ihreStellung in der früh-und mittelkaiserzeitlichenArchitekturdekoration, Wien 1971.
Le sculture Farnese I C. Gasparri (a cura di), Le sculture Farnese I. Le scultureideali, Milano 2009
Lewit 2003 T. Lewit, ‘Vanishing villas: what happened to élite ruralhabitation in the West in the 5th-6th c.?’, in JRA 16,2003, pp. 260-274.
Lissi Caronna 1980 E. Lissi Caronna, ‘Oppido Lucano (Potenza). Rappor-to preliminare sulla seconda campagna di scavo (1968)’,in NSA 34, 1980, pp. 119-297.
Lluch-Baixauli 1997 M. Lluch-Baixauli, Boezio. La ragione teologica, Milano1997
Locri II M. Barra Bagnasco (a cura di), Locri Epizefiri II. Gli iso-lati I2 e I3 dell’area di Centocamere, Firenze 1989.
Loffredo 1580 F. Loffredo, L’antichità di Pozzuolo et luoghi convicini,Napoli 1580.
Lombardi 2003 P. Lombardi, ‘L’ellenismo di Puteoli nel II d.C., Kibyrae il Panhellenion: considerazioni sull’iscrizione IG, XIV829’, in M.L. Lazzarini, P. Lombardi (a cura di), L’Italiacentro meridionale tra Repubblica e Primo Impero. Alcu-ni aspetti culturali e istituzionali, Opuscola epigraphica11, 2003, pp. 11-31.
Longobardo, Zeli 2010 F. Longobardo, F. Zeli, ‘Considerazioni sulla tipologiaarchitettonica del monumento’, in Il teatro di Neapolis.Scavo e recupero urbano, Napoli 2010, pp. 35-46.
Lugli 1957 G. Lugli, La tecnica edilizia romana, Roma 1957.Machina 2009 M. Galli, G. Pisani Sartorio (a cura di), Machina. Tecno-
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE232
logia dell’antica Roma, Roma 2009.Magna Grecia 1996 La Magna Grecia nelle collezioni del Museo Archeologico
Nazionale, Napoli 1996.Maiuri 1927 A. Maiuri, ‘Gli ultimi scavi di Cuma e l’epopea
virgiliana’, in Nuova Antologia 16, 1927, pp. 489-499.Maiuri 1932 A. Maiuri, ‘Lavori di robustamento del muro di
fortificazione’, in BA 26, 1932, pp. 240-241.Maiuri 1934 A. Maiuri, ‘Monumenti cristiani di Cuma’, in Atti del III
Congresso Internazionale Archeologia Cristiana (Ravenna25-30 settembre 1932), Roma 1934, pp. 217-231.
Maiuri 1956 A. Maiuri, Taccuino Napoletano, Napoli 1956.Maiuri 1958 A. Maiuri, I Campi Flegrei. Dal sepolcro di Virgilio al-
l’antro di Cuma, Napoli 1958.Mallardo 1940 D. Mallardo, San Gennaro e compagni nei più antichi
testi e monumenti, Napoli 1940.Malpede 2003 V. Malpede, ‘Cuma: reperti vitrei dalle recenti indagini
dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli nell’areadelle fortificazioni settentrionali’, in Il Vetro in Italiameridionale e insulare (Atti del Secondo ConvegnoMultidisciplinare, Napoli, 5-7 dicembre 2001), Napoli2003, pp. 33-43.
Malpede 2005 V. Malpede, ‘Cuma: continuità e trasformazioni in etàtardoantica’, in G. Vitolo (a cura di), Le città campanefra tarda antichità e alto medioevo, Salerno 2005, pp. 193-218.
Maraglino 1906 V. Maraglino, ‘Cuma e gli ultimi scavi’, in RAAN XXV,Napoli 1906, pp. 5-39.
Marotta 1995 V. Marotta, ‘Il Senato e il Panhellenion’, in Ostraka 4,1995, pp. 157-167.
Mataccota 2010 D. Mataccota, Simmaco, Forlì 2010.Mathews 1975 J. Mathews, Western Aristocraties and Imperial Court,
A.D. 364-425, Oxford 1975.Mau 1892 A. Mau, ‘Osservazioni sull’edifizio di Eumachia in
Pompei’, in RM 7, 1892, pp. 113-142.Mazzella 1591 S. Mazzella, Sito et antichità della città di Pozzuolo e del
suo amenissimo distretto, Napoli 1591.Mazzella 1606 S. Mazzella, Sito e antichità della città di Pozzuolo, 2a
ed., Napoli 1606.Mele 2009 A. Mele, ‘Cuma in Opicia tra Greci e Romani’, in Cuma,
ACIStMGr XLVIII, 2008 (2009), pp. 75-167.Micunco 2002 G. Micunco, ‘Claudiano e la lode di Ercole’, in Invigilata
lucernis 24, 2002, p. 151-166.Mlasowsky 1996 A. Mlasowsky, ‘Nomini ac fortunae Caesarum proximi.
Die Sukzessionpropaganda der römischen Kaiser vonAugustus bis Nero im Spiegel der Reichsprägung undder archäologischen Quellen’, in JdAI 111, 1996, pp.249-388.
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE 233
Moggi, Osanna 2010 M. Moggi, M. Osanna (a cura di), Pausania. Guida dellaGrecia. Libro IX. La Beozia, Torino 2010.
Morghen 1769 F. Morghen, Le antichità di Pozzuoli, Baja e Cuma incisein rame e pubbl. da F. M., Napoli 1769.
Mormile 1670 G. Mormile, Descrittione della città di Napoli e del suoamenissimo distretto e dell’antichità della città di Pozzuolo,Napoli 1670.
Morris 1992 S.P. Morris, Daidalos and the Origins of Greek Art,Princeton 1992.
Museo Archeologico dei Campi Flegrei 1 F. Zevi, F. Demma, E. Nuzzo, C. Rescigno,C. Valeri (a cura di), Museo Archeologico dei Campi Flegrei.Catalogo generale. 1, Cuma, Napoli 2008.
Museo Archeologico dei Campi Flegrei 2 F. Zevi, F. Demma, E. Nuzzo, C. Rescigno,C. Valeri (a cura di), Museo Archeologico dei CampiFlegrei. Catalogo generale. 2, Pozzuoli, Napoli 2008.
Museo Archeologico dei Campi Flegrei 3 P. Miniero, F. Zevi (a cura di), Museo Archeo-logico dei Campi Flegrei. Catalogo generale. 3 Liternum,Baia, Miseno, Napoli 2008.
Naissance 2001 G. Guyon, M. Heijes (a cura di), D’un monde à l’autre.Naissance d’une Chrétienté en Provence IVe-VIe siècle,Arles 2001.
Niccolini 1846 A. Niccolini, Descrizione della Gran Terma puteolanavolgarmente detta Tempio di Serapide, Napoli 1846.
Nizzo 2007 V. Nizzo, ‘Nuove acquisizioni sulla fase preellenica diCuma e sugli scavi di E. Osta’, in MEFRA 119/2, 2007,pp. 483-502.
Nocella s.l.d. F. Nocella, Fusaro. Storia, cultura, arte, s.l.d.Nuzzo 2007 E. Nuzzo, ‘Memorie d’archivio: lo stato del Foro (1938-
1953) e le collezioni dell’Antiquarium Flegreo. Una notasulla ricerca archeologica a Cuma’, in C. Gasparri, G.Greco (a cura di), Cuma. Il Foro. Scavi dell’Università diNapoli Federico II, 2000-2001, Studi Cumani 1, 2007, pp.337-374.
Nuzzo 2010 E. Nuzzo, ‘Subtilitas Phlegraea. Nota sulla formazionedel linguaggio architettonico a Cuma in età augustea’,in MEFRA 122/2, 2010, pp. 377-398.
Oliver 1965 J. H. Oliver, ‘The Athens of Hadrian’, in A. Piganiol etH. Terrasse (a cura di), Les empereurs romains d’Espagne.Actes du colloque international sur les empereurs romainsd’Espagne, Paris 1965, pp. 123-133.
Orbetello 1974 L. Orbetello, Severino Boezio, Genova 1974.Orbetello 1991 L. Orbetello, ‘I trattati teologici di Boezio’, in Filosofia
42, 1991, pp. 439-451.Ordo generis 1992 L. Viscido (a cura di), Ordo generis Cassiodorum.Excer-
pta, Napoli 1992, pp. 23, 40-41, 48-50.Pagano 1985-1986 M. Pagano, ‘Considerazioni sull’antro della Sibilla a
Cuma’, in RAAN LX, 1985-1986, pp. 69-94.
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE234
Pagano 1987 M. Pagano, ‘Una proposta di identificazione per il san-tuario di Demetra sull’acropoli di Cuma’, in Puteoli XI,1987, pp. 79-91.
Pagano 1992 M. Pagano, ‘L’acropoli di Cuma e l’antro della Sibilla’,in M. Gigante (a cura di), Civiltà dei Campi Flegrei (Attidel Convegno Internazionale, Napoli 18-21 ottobre1990), Napoli 1992, pp. 261-330.
Pagano 1993 M. Pagano, ‘Ricerche sulla cinta muraria di Cuma’, inMEFRA 105, 1993, pp. 847-871.
Pagano 2003 M. Pagano, ‘Variazioni del livello del mare fra Miseno eBaia’, in C. Albore Livadie, F. Ortolani (a cura di), Va-riazioni climatico-ambientali e impatto sull’uomo nell’areacircum-mediterranea durante l’Olocene, Bari 2003, pp.71-85.
Pagano 2009 M. Pagano, ‘Continuità insediativa delle ville nellaCampania fra tarda antichità e Alto medioevo’, in C.Ebanista, M. Rotili (a cura di), La Campania fra tardaantichità e Alto Medioevo. Ricerche di archeologia del ter-ritorio (Atti della Giornata di studio, Cimitile 10 giu-gno 2008), Cimitile 2009, pp. 9-22.
Pagano 2010 M. Pagano, ‘Il primitivo cristianesimo a Stabiae: nuovescoperte’, in C. Ebanista, M. Rotili (a cura di), IpsamNolam barbari vastaverunt: l’Italia e il Mediterraneo oc-cidentale tra il V secolo e la metà del VI (Atti del Conve-gno Internazionale di Studi in occasione del premioCimitile, Cimitile-Nola-S. Maria Capua Vetere 18-19giugno 2009), Cimitile 2010, pp. 129-140.
Pagano, Prisciandaro 2006 M. Pagano, R. Prisciandaro, Studio sulle provenienze deglioggetti rinvenuti negli scavi borbonici del Regno di Napo-li. Una lettura integrata, coordinata e commentata delladocumentazione, I, Castellammare di Stabia, 2006
Paget 1968 R.F. Paget, ‘The ancient ports of Cumae’, in JRS LVIII,1968, pp. 152-169.
Panciera 1994 S. Panciera, ‘Il corredo epigrafico del Mausoleo diAugusto’, in H. von Hesberg – S. Panciera (a cura di),Das Mausoleum des Augustus. Der Bau und seineInschriften, München 1994, pp. 66-175.
Parma 1988-1989 A. Parma, ‘Schede epigrafiche’, in G. Camodeca (a curadi), Puteoli XII-XIII, 1988-1989, pp. 211-229.
Pasquale 1875 P. Pasquale, Il lago Fusaro in Pozzuoli, Napoli 1875.Pauly-Wissova 1893-1980 A.G. von Pauly, G. Wissowa (a cura di), Paulys
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft,Stuttgart 1893-1980.
Pavolini 2006 C. Pavolini, “Archeologia e topografia della regione II(Celio). Un aggiornamento sessant’anni dopo Colini”,in Lexicon topographicum urbis Romae. SupplementumIII, Roma 2006.
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE 235
Pellarano 1904 B. Pellarano, Guida di Napoli e dintorni, 1904.Pellino 2006 G. Pellino, Rilievi architettonici fittili d’età imperiale
dalla Campania, Roma 2006.Pensabene 1982 P. Pensabene, ‘La decorazione architettonica di Cherchel,
cornici, architravi, soffitti, basi e pilastri’, in 150-Jahr-Feier Deutsches Archäologisches Institut Rom. Ansprachenund Vorträge, Mainz 1982, pp. 116-169.
Pensabene 1995 P. Pensabene, Le vie del marmo, Roma 1995.Pensabene 1996 P. Pensabene, ‘Committenza pubblica e committenza
privata ad Ostia’, in A. Claridge, A. Gallina (a cura di),‘Roman Ostia’ Revisited. Archaeological and HistoricalPapers in Memory of Russell Meiggs, London 1996, pp.185-222.
Pensabene, Caprioli 2009 P. Pensabene, F. Caprioli, ‘La decorazione architettonicad’età flavia’, in F. Coarelli (a cura di), Divus Vespasianus.Il bimillenario dei Flavi, Milano 2009, pp. 110-115.
Pergola 2003 Ph. Pergola, ‘Dalla Civitas classica alla sede di diocesicristiana: teorie e metodi della topografia cristiana’, inV. Ruggieri, L. Pieralli (a cura di), Eukosmia. Studi mi-scellanei per il 75¡ di Vincenzo Poggi S.J., Soveria Mannelli2003, pp. 341-375.
Pesando 2000 F. Pesando, ‘Un tempio della Magna Mater sull’acropolidi Cuma’, in AIONArchStAnt 7, 2000, pp. 163-177.
Pescatori 1936 S. Pescatori, Avellino settecentesca, Avellino 1936.Pescatori 2005 G. Pescatori, ‘Città e centri demici dell’Hirpinia:
Abellinum, Aeclanum, Aequum Tuticum, Compsa’, inG. Vitolo (a cura di), Le città campane fra tarda antichitàe alto medioevo, Salerno 2005, pp. 283-312.
Petacco, Rescigno 2007 L. Petacco, C. Rescigno, ‘I saggi sul Capitolium e il set-tore occidentale della piazza forense’, in Cuma. Il foro.Scavi dell’Università di Napoli Federico II, 2000-2001,Studi Cumani 1, 2007, pp. 77-117.
Pettenati 1978 S. Pettenati, I vetri dorati e graffiti e i vetri dipinti, Tori-no 1978.
Pietri 1966 Ch. Pietri, ‘Le sénat, le peuple chrétien et les partis ducirque à Rome sous le pape Symmaque (498-514)’, inMélanges d’archéologie et d’histoire 78, 1966, pp. 123-139.
Pietri 2000 Ch. Pietri, Prosopographie chrétienne du Bas Empire,Rome 2000.
Pionato, Forgione 1989 G. Pionato, A. Forgione, Avellino. Memorie e immagi-ni, 2ª ed., Avellino 1989.
Pittura di un Impero 2009 E. La Rocca et alii (a cura di), Roma. La pittura di unImpero, Milano 2009.
Pirenne Delforge 2008 V. Pirenne Delforge, Retour à la source. Pausanias et lareligion grecque, Athènes, Liège 2008.
Polara 2001 G. Polara, ‘Simmaco e la Campania’, in G. Polara (acura di), Ricerche sulla tarda antichità, Napoli 2001, pp.
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE236
79-91.Polito 2002 E. Polito, ‘Il meandro dall’arte greca ai monumenti
augustei’, in RIASA 57, III, XXV, 2002, pp. 91-112.Pompei. Pitture e mosaici X Pompei. Pitture e mosaici X. La documentazione nell’ope-
ra di disegnatori e pittori dei secoli XVIII e XIX, Roma1995.
PPP I 1981 I. Bragantini, M. de Vos, F. Parise Badoni, V. Sampaolo,Pitture e pavimenti di Pompei, Roma 1981.
Prandi 1983 L. Prandi, ‘L’Heraion di Platea e la festa dei Daidala’,in M. Sordi (a cura di), Santuari e politica nel mondoantico, Milano 1983, pp. 82-94.
Quodvultdeus 1964 Quodvultdeus, Livres des promesses et des prédictions deDieu, Paris 1964
Rescigno 1998 C. Rescigno, Tetti Campani. Età arcaica. Cuma, Pitecusae gli altri contesti, Roma 1998.
Rescigno 2009a C. Rescigno, ‘Osservazioni sulle architetture templaridi Cuma preromana’, in Cuma, ACIStMGr XLVIII, 2008(2009), pp. 447-479.
Rescigno 2009b C. Rescigno, ‘Kyme 3, zona 2.1 Capitolium. Scavo nel-l’area del pronao. Risultati delle indagini compiute tragiugno e novembre 2005’, in C. Gasparri e G. Greco (acura di), Cuma. Indagini archeologiche e nuove scoperte,Studi Cumani 2, 2009, pp. 89-120.
Rescigno 2011 C. Rescigno, ‘Tufo, legno, terracotta. Osservazioni sul-le architetture arcaiche della Campania settentrionale’,in Atti del XXVI Convegno di Studi Etruschi e Italici,(Capua, S. Maria Capua Vetere, Teano, 11-15 novembre2007), Pisa - Roma 2011, pp. 283-303.
Ribezzo 1920 F. Ribezzo, ‘Le iscrizioni greco-arcaiche di Cuma’, inRivista Indo-greco-italica III, 1920, pp. 71-87.
Ritratti 2011 E. La Rocca, C. Parisi Presicce con A. Lo Monaco (acura di), Ritratti: le tante facce del potere, Loreto 2011.
Rives 1994 J. Rives, ‘Venus Genetrix outside Rome’, in Phoenix 48,1994, pp. 294-306.
Rocchi 1989 M. Rocchi, ‘Kithairon et les fêtes des Daidala’, in DHA15, 1989, pp. 309-324.
Roma 2001 M.St. Arena et al. (a cura di), Roma dall’Antichità alMedioevo. Archeologia e storia nel Museo Nazionale Ro-mano Cripta Balbi, Milano 2001.
Romeo 2002 I. Romeo, ‘The Panhellenion and ethnic identity inHadrianic Greece’, in ClPhil 97, 2002, pp. 21-37.
Rose 1997 Ch. B. Rose, Dynastic commemoration and imperialportraiture in the julio-claudian period, Cambridge Mass.1997.
Roscher Lexicon WH Roscher, Ausführliches Lexicon der Griechischen undRömischen Mytologie, Leipzig 1884-1937.
Rossolino 1995 T. Rossolino, Alvignano. Una proposta di recupero e
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE 237
valorizzazione, Alvignano 1995.Rotili 1977-1978 M. Rotili, ‘Alle origini di un centro rurale nel principa-
to longobardo di Benevento: dalla chiesa al castello aPonte’, in Campania Sacra 8-9, 1977-1978, pp. 5-37.
Ruesch 1911 A. Ruesch, Guida illustrata del Museo Nazionale di Na-poli. Parte prima: antichità, Napoli 1911.
Ruggiero 1888 M. Ruggiero, Degli Scavi di Antichità nelle Province diTerraferma dell’antico Regno di Napoli, Napoli 1888.
Rüpke 2005 J. Rüpke, Fasti sacerdotum 1-3, Stuttgart 2005.Saletti 1999 C. Saletti, ‘L’ “Afrodite Sosandra” di Calamide: la testa
di Pavia’, in ArtLomb 127/3, 1999, pp. 68-73.Salvatorelli 1936 L. Salvatorelli, Storia della letteratura Latina cristiana
dalle origini alla metà del VI secolo, Milano 1936.Sangermano 2003 G. Sangermano, ‘Momenti della politica degli Stati del-
la Campania medievale nel Libellus in defensioneStephani episcopi del prete Ausilio’, in M.C. De Matteis(a cura di), Ovidio Capitani: quaranta anni per la storiamedioevale, Bologna 2003, pp. 335-343.
San Simmaco 2000 G. Mele, N. Spaccapelo (a cura di), Il papato di SanSimmaco (Atti Convegno Internazionale, Oristano 19-21 novembre 1998), Cagliari, 2000.
Sardella 1996 T. Sardella, Società, chiesa e stato nell’età di Teodorico,papa Simmaco e lo scisma laurenziano, Messina 1996.
Sarnelli 1685 P. Sarnelli, La Guida de’ Forestieri curiosi di vedere e diriconoscere le cose più memorabili di Pozzuoli, Napoli1685.
Sarnelli 1697 P. Sarnelli, Guida de’ forestieri curiosi di vedere e d’inten-dere le cose più notabili di Pozzuoli, Baia, Miseno, Cumaed altri luoghi circonvicini, Napoli 1697.
Scatozza 1976 L.A. Scatozza, Le sculture del Vallone di Punta Pennata(Bacoli), Napoli 1976.
Scatozza 1987 L.A. Scatozza Höricht, Le terrecotte figurate di Cumanel Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Roma 1987.
Scatozza Höricht 1990 L.A. Scatozza Höricht, ‘Phlegräische Glasfunde und dieVerlagerung von Glashütten aus dem Mittelmeer nachCampanien’, in AA 1990, pp. 425-433.
Schachter 1981 A. Shachter, Cults of Boiotia I, London 1981.Settipani 2000 Chr. Settipani, Continuité gentilice et continuité
familiaire dans les familles sénatoriales romaines à l’Epoqueimpériale, Oxford 2000.
Sibari 1970 Sibari. Scavi al Parco del Cavallo (1960-1962 e 1969-1970)e agli Stombi (1969-1970), in NSA 24, suppl. 3, Roma1970.
Simon 1985 E. Simon, ‘Dedalo’, in Enciclopedia Virgiliana, II, Roma1985, s.v., pp. 12-14.
Silvagni 1943 A. Silvagni, Monumenta epigraphica christiana saeculoXIII antiquiora quae in Italiae finibus adhuc extant, vol.
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE238
IV, 1, Città del Vaticano 1943.Skinner 1995 P. Skinner, Family power in Southern Italy. The duchy of
Gaeta and its neighbours 850-1139, Cambridge Mass.,1995.
Spawforth, Walker 1985 A.J. Spawforth, S. Walker, ‘The world of thePanellenion. I. Athens and Eleusis’, in JRS 75, 1985, pp.78-104.
Strasser 2004 J.Y. Strasser, ‘La fête des Daidala des Platées et la “gran-de année” d’Oinopidès’, in Hermes 132, 2004, pp. 338-351.
Testa 1893 N. Testa, ‘Avellino’, in Le cento città d’Italia, Suppl. il-lustrato del Secolo, 25 agosto 1893.
ThesCRA Thesaurus Cultum et Rituum Antiquorum. LexiconIconographicum Mythologiae Classicae, Basel, Los Angeles2004-2006.
TLG Packard Humanities Institute, Thesaurus Linguae Grecaeproject, Irvine 1999.
Tran Tam Tinh 1972 V. Tran Tam Tinh, Le culte des divinités orientales enCampanie, Leiden 1972.
Tocco 1976 G. Tocco, ‘Saggi di scavo nella città e nella necropoli diCuma’, in La Magna Grecia nell’età romana, inACIStMGr XV, (1975) 1976, pp. 485-496.
Trillmich 1978 W. Trillmich, Familienpropaganda der Kaiser Caligulaund Claudius. Agrippina Maior und Antonia Augusta aufMünzen, Berlin 1978.
Ungaro 2007 L. Ungaro, ‘La memoria dell’antico’, in L. Ungaro (acura di), Il Museo dei Fori imperiali nei Mercati di Traiano,Milano 2007, pp. 130-169.
Utro 2001-2002 U. Utro, ‘Raffigurazioni agiografiche sui vetri doratipaleocristiani’, in RendPontAcc 74, 2001-2002, pp. 195-219.
Vaccai 1902 G. Vaccai, Le feste di Roma antica, Torino 1902.Vanni 2005 F.M. Vanni, ‘Un vetro dorato dal territorio aretino’, in
D. Ferrari (a cura di), Il Vetro nell’Alto Medioevo (Attidelle VIII Giornate Nazionali di Studio, Spoleto 20-21aprile 2002), Imola 2005, pp. 19-24.
Valenza Mele 1991-1992 N. Valenza Mele, ‘Hera ed Apollo a Cuma e la manticasibillina’, in RIA 14-15, 1991-1992, pp. 5-71.
Vatin 1995 C. Vatin, ‘La base des Héros Eponymes à Athèns autemps de Pausanias’, in Ostraka IV.1, 1995, pp. 33-41.
Vermeule 1988 C. Vermeule, Sculpture in stone and bronze. Additions tothe collections of Greek, Etruscan and Roman Art, 1971-1988, in the Museum of Fine Arts Boston, Boston 1988.
Vitti 2010 M. Vitti, ‘Note di topografia sull’area del Teatro diMarcello’, in MEFRA 112/2, 2010, pp. 529-584.
von Duhn 1912 F. von Duhn, ‘Sui recenti scavi sull’acropoli di Cuma’,in RAL, s. V, XXI, 1912, pp. 202-205.
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE 239
von Hesberg 1980 H. von Hesberg, Konsolengeisa des Hellenismus und derfrühen Kaiserzeit, Mainz 1980.
von Hesberg 2010 H. von Hesberg, I marmi dal fondaco Marramarra. Unarco di Domiziano, in Napoli: la città e il mare. PiazzaBovio: tra Romani e Bizantini, Verona 2010, pp. 44-48.
Vopel 1899 H. Vopel, Die Altchristlichen Goldgläser, Freiburg 1899.Vuolo 2006 A. Vuolo, ‘Rilettura del dossier agiografico di san
Gennaro e Compagni’, in G. Luongo (a cura di), SanGennaro nel XVII centenario del martirio (305-2005) I,Campania sacra 37, 2006, pp. 179-221.
Vuolo 2010 A. Vuolo, ‘I santi Massimo e Giuliana a Cuma e la loro“translatio” a Napoli’, in Hagiographica XVII, 2010, pp.175-187.
Wilmart 1931 A. Wilmart, ‘La tradition des grandes ouvrages de SaintAugustin’, in Miscellanea Agostiniana II, Roma 1931,pp. 257-316.
Willers 1990 D. Willers, Hadrians panhellenisches Programm:archäologische Beiträge zur Neugestaltung Athens durchHadrian, Basel 1990.
Zanchi Roppo 1969 F. Zanchi Roppo,Vetri paleocristiani a figure d’oro con-servati in Italia, Bologna 1969
Zevi 1987a F. Zevi, ‘Fra mito e storia’, in I Campi Flegrei, Napoli1987, pp. 11-72.
Zevi 1987b F. Zevi, ‘I santuari di Roma agli inizi della Repubblica’,in Etruria e Lazio arcaico, QuadCSEI 15, 1987, pp. 121-132.
Zevi 2006 F. Zevi, ‘Pozzuoli come Delo minore e i culti egizi neiCampi Flegrei’, in S. De Caro (a cura di), Egittomania.Iside e il mistero. Catalogo della Mostra (Napoli, MuseoArcheologico Nazionale, 12 ottobre 2006-26 febbraio2007), Napoli 2006, pp. 69-86.
FINITO DI STAMPARE DALLA
ALFAGRAFICA VOLONNINO LAVELLO
PER CONTO DI
O S A N N A E D I Z I O N I S. r . l .
G I U G N O 2 0 1 2