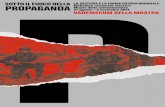CERAMICHE DA FUOCO DA CONTESTI DI ETA’ TARDOANTICA E BIZANTINA NELLA SICILIA CENTRO-MERIDIONALE:...
-
Upload
parcodeitempli -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of CERAMICHE DA FUOCO DA CONTESTI DI ETA’ TARDOANTICA E BIZANTINA NELLA SICILIA CENTRO-MERIDIONALE:...
LRCW 4 Late Roman Coarse Wares,
Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean Archaeology and archaeometry
The Mediterranean: a market without frontiers
Edited by
Natalia Poulou-Papadimitriou, Eleni Nodarou and Vassilis Kilikoglou
BAR International Series 2616 (I)2014
Volume I
Published by
ArchaeopressPublishers of British Archaeological ReportsGordon House276 Banbury RoadOxford OX2 [email protected]
BAR S2616 (I)
LRCW 4 Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and archaeometry. The Mediterranean: a market without frontiers. Volume I.
© Archaeopress and the individual authors 2014
Cover illustration: Early Byzantine amphora from Pseira, Crete (photo by C. Papanikolopoulos; graphic design by K. Peppas).
ISBN 978 1 4073 1251 4 (complete set of two volumes) 978 1 4073 1249 1 (this volume) 978 1 4073 1250 7 (volume II)
Printed in England by Information Press, Oxford
All BAR titles are available from:
Hadrian Books Ltd122 Banbury RoadOxfordOX2 7BPEnglandwww.hadrianbooks.co.uk
The current BAR catalogue with details of all titles in print, prices and means of payment is available free from Hadrian Books or may be downloaded from www.archaeopress.com
581
CERAMICHE DA FUOCO DA CONTESTI DI ETA’ TARDOANTICA E BIZANTINA NELLA SICILIA CENTRO-MERIDIONALE: IL CASO DI CIGNANA
MARIA SERENA RIZZO1, LUCA ZAMBITO2, FRANCESCO GIANNICI3, RENATO GIARRUSSO4,
ANGELO MULONE4
1 Parco Archeologico Valle dei Templi Agrigento; [email protected]
2 Dottore di Ricerca Università di Messina; [email protected] 3 Dipartimento di Fisica e Chimica, Università di Palermo; [email protected]
4 Geolab s.r.l. Palermo; [email protected]; [email protected]
Focus of this paper is the assemblage of Late Antique and Byzantine Cooking wares from the rural settlement of Cignana, near Agrigento. Macroscopic and archaeometric analysis gave us opportunity to identify seven fabric groups: one local and the other imported from various Mediterranean centers. Until the mid-seventh century Pantellerian ware dominated the pottery assemblage but from the mid 6th century other productions, e.g. the so called “Micaceous Ware”, arrived at Cignana. In late byzantine layers are encountered some pots and lids produced in a calcitic black fabric, whereas later assemblages, whose chronology is uncertain, are dominated by handmade cooking wares produced in Agrigento.
KEYWORDS: AGRIGENTO, SICILY, COOKING WARES, PANTELLERIAN WARE, MICACEOUS WARE, CALCITIC FABRICS.
Nel corso dell’ultimo decennio, grazie ai fondi europei del POR 2000-2006, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento ha potuto proseguire le indagini in alcuni siti di età romana e tardo romana, già noti e parzialmente esplorati nel corso del secolo scorso; si sono così ottenuti molti nuovi dati sulla circolazione e sulla produzione di ceramiche nel territorio agrigentino, già in parte editi (Rizzo 2010; Rizzo and Zambito 2007; 2010; Caminneci 2010; Caminneci et al. 2010; Parello, et al. 2010).
Tra i reperti recuperati si trova, naturalmente, molta ceramica da fuoco, che costituisce l’oggetto di questa discussione: in questa sede vengono presentati, in particolare, alcuni gruppi di manufatti provenienti dal villaggio di età tardoantica e bizantina di Cignana (Naro).
M.S.R.
Il vasellame da fuoco rinvenuto a Cignana
Dagli strati del villaggio tardo antico di Cignana provengono 345 frammenti diagnostici di ceramica da fuoco; su un piccolo gruppo di campioni è stata eseguita l’indagine archeometrica, che ha consentito di precisare e, in qualche caso, di modificare le ipotesi di provenienza che erano state fatte sulla base del solo esame macroscopico di forme e impasti (Rizzo and Zambito 2012).
192 individui sono riferibili a produzioni pantesche (tav. I, 1-4); solo tre individui sono riconducibili ad olle mentre sono documentati in ugual numero tegami e teglie, i primi a orlo indistinto e pareti leggermente
curvilinee e con due piccole anse ad orecchio impostate subito sotto l’orlo, le seconde con spesse pareti diritte e profondo incasso per il coperchio; in quantità notevole anche i piatti/coperchi.
Sembra, nelle attestazioni di questo tipo ceramico a Cignana, che ci sia una successione cronologica fra gli esemplari riconducibili alle forme M1 (per la classificazione delle forme della Pantellerian ware si fa riferimento a Guiducci 2003), documentate nelle stratigrafie a fine V-inizi VI, e quelli delle forme M2 che invece sono presenti a partire da metà VI e, probabilmente, fino alla metà del VII d.C. Le analisi petrografiche hanno indicato, inoltre, Pantelleria come luogo di produzione per un gruppo di 16 esemplari che potrebbero provenire da un atélier differente rispetto al resto dei materiali isolani da cui li distingue, forse, una diversa cava di approvvigionamento delle argille (due cave con argille di colore differente sono state individuate a Pantelleria, Alaimo and Montana 2003, 53-54) e che avevamo distinto in un precedente contributo dalla Pantellerian Ware (Rizzo and Zambito 2012) per il colore rosa della matrice dell’impasto, caratteristica che ci era sembrata peculiare. Si tratta essenzialmente di casseruole a orlo ingrossato e di coperchi a orlo ingrossato e ribattuto oppure a orlo indistinto.
Un piccolo numero di forme è caratterizzato da una importante presenza di pagliuzze di mica ed è riferibile anche tipologicamente alle produzioni con fabric 1.6 e 1.7 isolate a Cartagine. Fra di esse si segnalano: un’olla a bordo ingrossato e rientrante con pareti poco inclinate, impasto marrone parzialmente combusto e abbondanti inclusi di piccole dimensioni non arrotondati ma a spigoli
LRCW4
582
vivi (tipo Fulford 20.2); un coperchio ad orlo indistinto caratterizzato da impasto arancio, mica argentata e inclusi ferrici di medie dimensioni (tav. I, 6); una pentola ad orlo indistinto vicina alla forma 24 di Fulford (tav. I, 5) (sulla produzione cfr. Santoro 2007, 365-377).
Soltanto in un caso l’attestazione della forma è coerente cronologicamente con il contesto stratigrafico: si tratta di un’olla biansata con anse orizzontali confrontabile con la forma Fulford 20.2, datata a Cartagine tra gli inizi e fino al terzo quarto del VI d. C. In tutti gli altri casi, infatti, i frammenti rinvenuti sono residuali in strati più tardi.
Pertinente alla stessa fase cronologica è anche una forma difficilmente ricostruibile in tutte le sue componenti morfologiche (tav. I, 7): si tratta, forse, di una casseruola genericamente assimilabile al tipo Fulford 13.1, di cui si conserva il fondo e una piccola porzione di parete. E’ peculiare, in questo caso, la presenza sul fondo e in frattura di abbondantissimo tritume di quarzo e calcarenite bioclastica. Questo strato di frammenti litici è applicato in un momento sicuramente successivo alla foggiatura del vaso e prima della sua cottura. Per l’uso di questa tecnica e per la morfologia essa rimanda alle produzioni africane note come Calcitic ware (Bonifay 2004, 305-311). Sembra, dunque, che la forma palmese, pur facendo riferimento al patrimonio formale della produzione in Calcitic ware, non sia un prodotto di importazione e anzi la presenza di biocalcarenite quarzosa potrebbe essere dovuta ad una sua provenienza dal territorio di Agrigento.
Di produzione africana è invece, stando ai risultati dell’esame della sezione sottile, il campione CCu50, cui è riferibile una casseruola con orlo ingrossato, estroflesso e complanare, e corpo ceramico nero (tav. I, 8).
Non è stato sottoposto ad analisi petrografica ma si segnala comunque un frammento che richiama dal punto di vista morfologico i tipi prodotti nel fabric 3.7 di Cartagine ma con un impasto alquanto caratteristico, nero, duro, contenente molti grossi granuli di quarzo, visibili anche sulla superficie di colore chiaro, beige o arancio. Tra le forme prodotte con questo impasto si segnala il fr. di tav. I, 9, che trova confronto in particolare con un tipo presente nel sito di Carabollace, presso Sciacca (Caminneci 2010, Fig, 15, 14).
In un settore del villaggio (SAS 5), sono state scavate alcune unità stratigrafiche depositatesi al di sopra degli strati di VII secolo, difficili da datare, ma che contengono un tipo di ceramica da fuoco peculiare e caratteristico: si tratta di alcune pentole o olle con orlo estroflesso e corpo espanso (tav. I, 10, 12), due coperchi con grossa presa a bottone e segni lasciati dal filo al momento del distacco della forma dal tornio (tav. I, 11) e una pentola con orlo indistinto, pareti verticali e ansa a bastoncello; oltre che per la morfologia, queste ceramiche si distinguono per essere prodotte con impasti (impasti del gruppo 1, CCu47 e 52, e CCu46, con le stesse caratteristiche) ricchi di calcite presente in granuli di medie dimensioni e di colore scuro per cottura in atmosfera semiriducente. Le pareti esterne in molti casi assumono una tonalità beige. Le analisi archeometriche,
per la genericità degli impasti, non hanno consentito di formulare ipotesi circa l’area di produzione per queste forme.
Gli strati più tardi rinvenuti finora a Cignana sono forse rappresentati da un gruppo di UUSS (1044, 1045, 1046) depositatisi su un piano in acciottolato relativo a due strutture murarie purtroppo non indagate in estensione. Insieme a diversi vasi a listello, tra i quali un gruppo sembra da riferire alle produzioni più tarde in sigillata D4, per le quali è stata proposta una datazione che potrebbe arrivare fino alla fine del VII secolo/inizi dell’VIII (Bonifay 2004, 210), e ad un frammento di ansa con solcatura mediana, si rinviene un frammento di chafing dish a vetrina pesante, del tutto analogo, per morfologia, a un frammento rinvenuto a Xirumi, presso Augusta (Cacciaguerra 2009, Fig. 5.7), che potrebbe rappresentare il principale indicatore per una cronologia degli strati all’VIII-IX secolo (Cacciaguerra 2009). La ceramica da fuoco contenuta negli strati, abbondante, è costituita in grande maggioranza da coperchi e pentole con orlo indistinto e prese orizzontali (tav. I, 15-17), con impasti ricchi di calcarenite, pertinenti al gruppo 3, di produzione agrigentina. Sono inoltre presenti due frammenti di testelli con impasto CCu43, provenienti dall’area etnea (tav. I,13-14).
Inoltre è da segnalare la presenza in questi strati di due individui, un coperchio con bassa e tozza presa e una casseruola ad orlo indistinto, prodotti con impasto sicuramente alloctono e forse, se proveniente dall’isola, di origine peloritana, sabbioso e morbido al tatto, di colore camoscio e in cui sono presenti grandi quantità di mica e rari inclusi calcitici.
Nei livelli altomedievali di Cignana risultano invece assenti, finora, le casseruole ad orlo ingrossato ed introflesso e impasto caratterizzato da numerosissimi inclusi calcitici e fondo grigio delle paste, simili al tipo Rocchicella, identificati recentemente come un importante indicatore di questa fase cronologica, almeno nella Sicilia orientale (Arcifa 2004; 2010a; 2010b, 120-121) ma, data l’esiguità dell’area scavata nel settore in cui sono presenti depositi stratigrafici alto medievali, non ci sentiamo di dare molto peso a questo dato anche perché indagini di superficie hanno rinvenuto forme pertinenti a questa classe ceramica sulla costa e nell’immediato entroterra agrigentino a non grande distanza dal sito di cui ci stiamo occupando.
E’ difficile stabilire un nesso fra mutate esigenze alimentari testimoniate forse dalla comparsa di profonde olle da un lato e da forme basse dall’altro e l’arrivo di culture gastronomiche alloctone (come propone Arthur 2007); di certo induce ad indagare in tal senso la compresenza sulle mense palmesi anche degli oggetti rivestiti da vetrina pesante e l’esistenza di indizi relativi a possedimenti sotto il diretto controllo del basileus bizantino nel comprensorio.
La presenza, sia pure in piccole quantità, di ceramiche da fuoco provenienti dalla Sicilia orientale sembrano suggerire che ancora in epoca altomedievale il sito sia rimasto in qualche modo aperto ai contatti con quella
RIZZO-ZAMBITO-GIANNICI-GIARRUSSO-MULONE
583
parte dell’isola, fatto spiegabile con la vicinanza del sito tanto alla costa quanto al tracciato della grande viabilità est-ovest tuttora vitale e non sia del tutto ripiegato in consumi autarchici, come avviene invece in altri più piccoli siti dell’entroterra: si prenda per tutti un piccolo insediamento nel territorio di Campobello di Licata, in cui il complesso della ceramica è prodotta localmente.
L.Z.
Conclusioni
Il primo dato che appare chiaramente da quanto esposto sopra è la netta predominanza quantitativa delle produzioni di Pantelleria fino alla metà circa del VII secolo. Prodotte a partire dal II sec. a. C., e diffuse nel Mediterraneo occidentale dal I sec. a.C. in poi, soprattutto lungo una rotta che collega l’Africa con la Sicilia, la Sardegna e la Spagna (Santoro Bianchi et al. 2003, 66), le ceramiche da fuoco di Pantelleria sono ampiamente distribuite nel Mediterraneo occidentale soprattutto tra il III ed il V secolo (Sami 2005, 403), mentre le esportazioni sembrano diminuire in termini quantitativi nel corso del VI, anche se rimane ampia l’area di diffusione, soprattutto lungo le coste del Tirreno (Santoro Bianchi et al. 2003, 68). La Sicilia occidentale sembra, in tutto il periodo, rappresentare una meta privilegiata delle produzioni pantesche (Santoro Bianchi et al. 2003; Sami 2005, 403; Belvedere et al. 1993, 244-245; Parello et al. 2010; Caminneci et al.2010); ad Agrigento (Bonacasa Carra 1987, 209-210; Fiertler 2003) e nel suo hinterland, in particolare, tra IV e V secolo, la ceramica di Pantelleria sembra dominare il mercato, affiancandosi alle produzioni africane, la cui presenza appare però ridotta in questo periodo.
La minore incidenza percentuale della Pantellerian ware dal VI secolo in poi coincide probabilmente con una crisi produttiva e commerciale delle officine pantesche, le cui produzioni dal V secolo sembrano non essere più presenti nella Sicilia orientale (per l’area iblea Cacciaguerra 2009, 438), anche se ne rimane ampia l’area di diffusione, soprattutto lungo le coste del Tirreno (Santoro Bianchi 2003, 68). La crisi delle officine di Pantelleria, che potrebbe forse coincidere cronologicamente con la distruzione del villaggio di Scauri (Sami 2005, 403-404), permette forse l’emergere delle produzioni locali e la conquista di fette di mercato da parte di altre produzioni, come quella della micaceous ware (Fulford and Peacock 1984, 12-13 e 163-166; Reynolds 1995, 98; Santoro 2007, 368; Cau Ontiveros 2007, 221-222).
Per quanto riguarda le produzioni locali, a Cignana è stato in particolare identificato il gruppo 3, caratterizzato da inclusi biocalcarenitici grossolani e con ogni probabilità proveniente da officine agrigentine; nell’ambito di questo gruppo, particolarmente interessanti sono i piatti da fuoco e i coperchi con impasto CCu54, assai vicini morfologicamente alle calcitic wares africane, e che utilizzano un’analoga tecnica nell’uso di un tritume calcarenitico come degrassante e sul fondo dei vasi al posto della calcite presente sulle pentole africane
(Peacock 1984, fabric 1.3; Bonifay 2004, 75-77 e 305-309). Le calcitic wares, prodotte in Africa in diverse officine a carattere probabilmente non specializzato (Bonifay 2004, 75), potrebbero avere dei corrispettivi anche in Sicilia, come sembrerebbe documentare l’esempio di Canalicchio di Calamonaci (Parello and Amico in questo volume). Anche se in modo assolutamente ipotetico, si può forse pensare che pentole con analoga morfologia e che utilizzano tecniche simili siano state prodotte anche in altri siti, tra cui appunto Agrigento, utilizzando però il materiale disponibile localmente.
Una rottura evidente con la tradizione di matrice “mediterranea” è segnalata dalla comparsa delle pentole del gruppo 1 (Calcitic ware), fabbricate prevalentemente al tornio e caratterizzate dall’impasto scuro, derivato dalla cottura in atmosfera riducente, in alcuni casi con superficie irregolarmente beige, e dagli inclusi calcitici, ben evidenti in frattura; tra le forme, è presente l’olla, con orlo verticale o a tesa obliqua o orizzontale, e i coperchi con presa troncoconica. Le ceramiche di Cignana trovano confronto con tipi simili rinvenuti a Vito Soldano (Canicattì, Ag) (Rizzo and Zambito 2012), nell’entroterra agrigentino, in contesti difficilmente databili, ma che, per l’associazione di alcuni degli esemplari con un’anfora dipinta, potrebbero essere riportati all’VIII secolo. Una cronologia analoga sembra verosimile anche per i contesti di Cignana, nei quali le pentole calcitiche sono associate alle forme più tarde della sigillata africana e a due esemplari di lucerne di tipo siciliano, forma Provoost 10B: le lucerne di questo gruppo, fabbricate, a quanto sembra, nella Sicilia orientale e diffuse in ambito peninsulare a partire dal tardo VI secolo e per tutto il VII (Pavolini 1998, 133-134), sembrano avere nell’agrigentino una circolazione limitata e tardiva. Sul piano morfologico, le olle di questo gruppo appaiono genericamente simili a quelle rinvenute in strati di VIII secolo di Marettimo e Cefalù (Ardizzone 2004) che hanno però impasti con caratteristiche diverse. Le nostre ceramiche potrebbero avere comunque una cronologia analoga, anche in considerazione del fatto cheproprio la cottura riducente sembra caratterizzare diverse produzioni siciliane dall’VIII secolo (Arcifa 2004, 401; 2010b, 112).
Le caratteristiche mineralogiche delle nostre ceramiche, piuttosto generiche, non chiariscono se esse fossero prodotte localmente; si tratta d’altronde di un tipo di materiali finora non rilevato in altri siti siciliani, e di cui vanno ancora del tutto individuati centri di produzione, caratteri della circolazione ed ampiezza della diffusione, mentre ne deve essere ancora ulteriormente chiarita la cronologia.
Queste ceramiche rappresentano comunque certamente il più significativo elemento di novità nel quadro della cultura materiale dei nostri siti nei secoli altomedievali, con l’introduzione di nuovi tipi morfologici, le pentole o olle con orlo estroflesso, i coperchi con presa a bottone e i testelli, che rompono decisamente con la tradizione tardo antica: difficile dire, data anche la ristrettezza dei nostri contesti altomedievali e l’assenza di indagini sui resti zoologici rinvenuti, se questa introduzione fosse
LRCW4
584
legata a cambiamenti nelle abitudini alimentari; a noi sembra comunque che essa segnali un mutamento di orizzonte culturale, con l’affievolirsi del legame che ancora fino alla fine del VII secolo aveva in modo preferenziale collegato la Sicilia centromeridionale con la sponda sud del Mediterraneo, non solo dal punto di vista economico, ma anche della cultura materiale, determinando una koiné ceramica che accomunava le città e gli insediamenti rurali siciliani alle città e agli insediamenti rurali nordafricani, e in particolare a Cartagine. E’ probabilmente la caduta di Cartagine nelle mani degli Arabi a spezzare, seppure temporaneamente, questo legame: il “registro delle comunicazioni mediterranee” stilato da McCormick non segnala, per tutto l’VIII secolo, rapporti tra la Sicilia e l’Africa che non siano connessi con incursioni e scorrerie (McCormick 2008, 977-1007). L’introduzione delle olle a cottura riducente e dei testelli sembra invece marcare l’ingresso del nostro sito in un ambito culturale ormai altomedievale, che trova somiglianze piuttosto con l’ambiente “peninsulare”, e forse in particolare con le aree italiane di cultura bizantina. Pentole e olle a cottura riducente sono attestate in ambito adriatico (Staffa 1998; 2004); la transizione, nel corso del VII secolo, dalla prevalenza delle casseruole con prese ad orecchio a quella delle casseruole e delle olle con orlo estroflesso è evidente a Napoli (Carsana et al.2007, 427); olle e pentole con orlo estroflesso dominano il panorama delle ceramiche da fuoco negli strati della fine del VII secolo alla Crypta Balbi (Ricci 1998, Figs. 2-4).
Infine, le produzioni agrigentine con impasti ricchi di biocalcarenite (CCu9,10 e 45a), che caratterizzano gli strati più tardi di Cignana, potrebbero rappresentare una significativa novità nel panorama delle produzioni altomedievali del nostro territorio: se davvero, infatti, gli strati potessero essere datati all’VIII-IX secolo, avremmo un’attestazione precoce della produzione di pentole a cottura ossidante, plasmate a mano, con orlo indistinto e impasti chiari che, se da una parte riprendono morfologie ampiamente diffuse nelle ceramiche da fuoco tardo antiche, tra cui la Pantellerian ware, dall’altra presentano somiglianze, nei caratteri generali, con produzioni di età islamica, ben note dall’XI secolo (Ardizzone 2004, 201-204) e prodotte, in età normanna, anche dalle officine agrigentine (Bonacasa Carra and Ardizzone 2007, Figs. 27-28). La cronologia dei nostri contesti, tuttavia, è affidata, come si è visto, a pochi elementi certi, tra i quali il più significativo potrebbe essere il frammento di chafing dish a vetrina pesante, perché se ne possano trarre conclusioni.
M.S.R.
Indagini petrografiche su ceramiche da fuoco di Cignana
Premessa
Le indagini petrografiche sono stati effettuate su 12 campioni di materiale ceramico da contesto tardo antico e bizantino provenienti da Cignana (contrassegnati da sigla
CGN-CCu), in provincia di Agrigento.Le indagini, condotte mediante osservazione di sezioni sottili al microscopio polarizzatore (Tav. II), hanno consentito di suddividere i reperti ceramici indagati nelle seguenti categorie:
1. Calcitic Ware
2. Pantellerian Ware
3. Ceramiche con biocalcareniti
4. Ceramiche con quarzo eolico
5. Ceramiche con “azolo”
6. Ceramiche con scheletro metamorfico
Gruppo 1 – Calcitic Ware
Nell’ambito di questa categoria sono stati inclusi i campioni (CGN-CCu47, CGN-CCu52) caratterizzati dalla presenza di granuli angolosi (da frantumazione artificiale) di calcite spatica, intenzionalmente aggiunta per migliorare la resistenza al fuoco; i campioni sono di difficile identificazione riguardo alla loro provenienza.
Gruppo 2 – Pantellerian Ware
Il gruppo comprende i campioni CGN-CCu19, CGN-CCu24, CGN-CCu28. Questi si contraddistinguono per la presenza di minerali di rocce vulcaniche peralcaline quali: anortoclasio, egirinaugite ed enigmatite, in alcuni camioni sono presenti anche numerosi frammenti di ossidiana e pomice. L’associazione mineralogica consente di definire con certezza la provenienza di questi campioni da Pantelleria.
Gruppo 3 – Ceramiche con biocalcareniti
Il gruppo comprende i campioni CGN-CCu9, CGN-CCu10, CGN-CCu45a, CGN-CCu54. L’elemento caratterizzante di questi campioni è la presenza di frammenti grossolani di calcarenite bioclastica a cemento calcitico e ferruginoso. Nell’impasto inoltre si rinvengono granuli arrotondati di quarzo (sia mono che policristallino) e, più raramente, di feldspato, presenti anche come inclusioni nei litoclasti calcarenitici. L’insieme delle caratteristiche mineralogiche e tessiturali risulta congruente con i prodotti agrigentini della Necropoli Paleocristiana (Alaimo e Giarrusso, 2007).
Gruppo 4 – Ceramiche con quarzo eolico
Il gruppo è rappresentato da un solo campione, CGN-CCu50. L’impasto è caratterizzato da scheletro abbondante a granulometria bimodale, con predominanza delle frazioni siltosa e sabbioso-media (massimo 0.6mm). Dal punto di vista mineralogico, sia la frazione fine che quella grossolana risultano costituite da quarzo. Nell’ambito della frazione grossolana, si distinguono numerosi granuli di quarzo eolico, caratterizzati da una
RIZZO-ZAMBITO-GIANNICI-GIARRUSSO-MULONE
585
forma arrotondata e a superficie smerigliata. I caratteri tessiturali, nel loro insieme e la presenza di quarzo di tipo eolico inducono a considerare probabile una produzione nord-africana per questo campione. Occorre rilevare che la stessa tipologia di impasto è stata individuata in alcuni campioni di ceramica da fuoco tardo-antica provenienti dalla Necropoli Paleocristiana di Agrigento (Alaimo et al. 1995; Alaimo e Giarrusso 2007).
Gruppo 5 – Ceramiche con “azolo”
Il gruppo è rappresentato da un solo campione, CGN-CCu43. Questo presenta uno scheletro smagrante mediamente abbondante a granulometria eterogenea con prevalenza delle frazioni grossolane e molto grossolane (massimo 3mm), rappresentate da frammenti angolosi di rocce vulcaniche di natura basaltica a struttura porfirica definita da fenocristalli di plagioclasio, clinopirosseno, olivina e magnetite in una massa di fondo microcristallina di analoga composizione mineralogica. La presenza di litoclasti di natura basaltica permette di stabilire come verosimile provenienza l’area etnea, dove questo materiale, localmente denominato “azolo”, viene ancor oggi usato come aggregato per la confezione di materiale ceramico.
Gruppo 6 – Ceramiche con scheletro metamorfico
Il gruppo è rappresentato da un solo campione, CGN-CCu44. Il campione presenta abbondante scheletro smagrante, a granulometria bimodale, con prevalenza delle frazioni siltoso e sabbiosa-grossolana (massimo 1mm). La frazione sabbiosa è caratterizzata da litoclasti metamorfici (gneissa tessitura grano-eteroblastica con quarzo e microclino come costituenti principali). Tra i clasti monomineralici si riconoscono, oltre al quarzo e feldspato (microclino e plagioclasio), biotite, muscovite e più raramente anfibolo. Riguardo alla provenienza, la presenza di uno scheletro metamorfico consente di escludere che si tratti di una produzione locale. Volendo restringere l’importazione in ambito siciliano, una possibile provenienza può essere ipotizzata nell’area peloritana.
F.G., R.G., A.M.
Bibliografia
Alaimo R., Di Franco, L., Giarrusso, R. and Montana, G., 1995. Roman coarse ware from western Sicily: classification and raw materials comparison inferred by mineralogical and chemical analyses. In B. Fabbri (ed.), Proceedings of the 4th European Meeting on Ancient Ceramics, 195-208. The Cultural Ceramic Heritage.
Alaimo, R., Giarrusso, R. 2007. Caratterizzazione mineralogico-petrografica dei reperti ceramici. In Bonacasa, Ardizzone, 409- 431.
Alaimo, R., Montana, G. 2003. Scienza e archeologia: le analisi archeometriche. In Santoro Bianchi et al., 52-55.
Arcifa, L. 2004. Considerazioni preliminari su ceramiche della prima età islamica in Sicilia. I rinvenimenti di Rocchicella presso Mineo (CT). In S. Patitucci Uggeri (ed.), 387-404.
Arcifa, L. 2010a. Indicatori archeologici e dinamiche insediative nella Sicilia tardo bizantina. In S. Modei, C. Miccichè (eds.), La Sicilia bizantina: storia, città e territorio, 67-89. Caltanissetta.
Arcifa, L. 2010b. Indicatori archeologici per l’alto medioevo nella Sicilia orientale. In P. Pensabene (ed.), Piazza Armerina.Villa del Casale e la Sicilia tra tardoantico e medioevo, 105-128. Roma.
Ardizzone, F. 2004. La ceramica da fuoco altomedievale della Sicilia occidentale (secc. VIII-IX). In Patitucci Uggeri (ed.), 375-386.
Arthur, P., 2007, Pots and boundaries. On cultural and economic areas between late antiquity and the early middle ages. In M. Bonifay and J-C- Tréglia (eds.), LRCW2. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean, Archaeology and Archaeometry. British Archaeological Reports, International Series 1662, 15-27. Oxford, Archaeopress.
Belvedere, O., Burgio, A., Macaluso, R. and Rizzo, M. S. 1993. Termini Imerese. Ricerche di topografia e di archeologia urbana. Palermo.
Bonacasa Carra, R. M. 1987. Agrigento Paleocristiana. Zona archeologica e Antiquarium. Palermo.
Bonacasa Carra, R. M., Ardizzone, F. 2007. Agrigento dal Tardo Antico al Medioevo. Campagne di scavo nell’area della necropoli paleocristiana. Anni 1986-1999. Todi.
Bonifay, M. 2004. Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique. British Archaeological Reports, International Series 1301. Oxford, Archaeopress.
Cacciaguerra, G. 2009. Dinamiche insediative, cultura materiale e scambi in Sicilia tra Tardoantico e Alto medioevo. Il caso del sito di Santa Caterina (Melilli, SR), Archeologia Medievale 35, 427-452.
Caminneci, V. 2010. Tra il mare e il fiume. Dinamiche insediative nella Sicilia occidentale in età tardo antica: il villaggio in contrada Carabollace (Sciacca, Agrigento, Sicilia, Italia). http://www.fastionline.org/ docs/FOLDER-it-2010-213.pdf
Caminneci, V., Galioto, G. and Franco, C. 2010. L’insediamento tardo antico in contrada Carabollace (Sciacca): primi dati sui rinvenimenti ceramici. In S. Menchelli, S. Santoro, M. Pasquinucci and G. Guiducci (eds.), LRCW3. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean. Archaeology and Archaeometry. Comparison between western and eastern Mediterranean, British
LRCW4
586
Archaeological Reports, International Series 2185, 273-282. Oxford, Archaeopress
Carsana, V., D’Amico, V. and Del Vecchio, F. 2007, Nuovi dati ceramologici per la storia economica di Napoli tra tarda antichità ed altomedioevo. In LRCW2, 423-428
Cau Ontiveros, M. A. 2007. Mediterranean Late Roman Cooking Wares: Evidence from the Balearic Islands. In LRCW2, 219-233.
Fiertler, G. 2003. La Pantellerian ware dal Quartiere Ellenistico-Romano di Agrigento. Aspetti della problematica e proposta per una tipologia. In Archeologia del Mediterraneo: Studi in onore di Ernesto De Miro, 321-337. Roma.
Fulford, M. G. and Peacock, D. P. S. 1984. Excavations at Carthage: The British Mission. The Avenue du President Habib Bourguiba, Salambo. The pottery and other ceramic objects from the site, 155-231. Sheffield.
Guiducci, G. 2003. Le forme della Pantellerian Ware. In S. Santoro Bianchi, G. Guiducci and S. Tusa, Pantellerian Ware. Archeologia subacquea e ceramiche da fuoco a Pantelleria, 61-65. Palermo.
McCormick, M. 2008. Le origini dell’economia europea. Comunicazioni e commercio 300-900 d.C., 977-1007. ed. it., Milano.
Parello M. C., Amico A. and D’Angelo, F. 2010. L’insediamento alla foce del Verdura in territorio di Sciacca (Agrigento, Sicilia, Italia). I materiali. In LRCW3, 283-291.
Patitucci Uggeri, S. (ed.), 2004. La Ceramica Altomedievale in Italia, Quaderni di Archeologia Medievale. Firenze.
Pavolini, C. 1998. Le lucerne in Italia nel VI-VII secolo d.C.: alcuni contesti significativi. In L. Saguì (ed.), Ceramica in Italia: VI-VII secolo. Atti del convegno in onore di John W. Hayes, 123-139. Firenze, All’Insegna del Giglio.
Peacock, D. P. S. 1984. Petrology and origins. In M. G. Fulford and D. P. S. Peacock (eds.), Excavations at Carthage: The British Mission, Vol. I, 2, The avenue du Président Habib Bourguiba, Salambo: The pottery and other ceramic objects from the site, 6-20. Sheffield.
Reynolds, P. 1995. Trade in the Western Mediterranean, AD 400-700: The ceramic evidence, British Archaeological Reports, International Series 604. Oxford, Archaeopress.
Ricci, M. 1998. La ceramica comune dal contesto di VII secolo dalla Crypta Balbi. In L. Saguì, (ed.) Ceramica in Italia: VI-VII secolo. Atti del convegno in onore di John W. Hayes. Firenze, All’Insegna del Giglio, 351-382.
Rizzo, M. S. 2010. L’abitato rurale nell’agrigentino nella prima età bizantina (VI-VII secolo). In S. Modeo, M. Arnone e M. Congiu (eds.) La Sicilia bizantina: storia, città e territorio, 277-295. Caltanissetta.
Rizzo, M. S. and Zambito, L. 2007. Novità epigrafiche siciliane. I bolli di contrada Cignana (Naro, AG). Zeitschrift für papirologie und epigraphik 162, 271-277.
Rizzo M. S., Zambito L. 2010. Ceramiche comuni ed anfore dal villaggio tardoantico di Cignana (Naro-Agrigento, Sicilia, Italia). In LRCW3, 293-300.
Rizzo, M. S. and Zambito, L. 2012. Ceramiche da fuoco di età tardo-antica e della prima età bizantina dal territorio agrigentino: nuovi dati da Cignana e Vito Soldano. Rei Cretariae Fautorum Acta 42, 289-297.
Sami, D. 2005. La ceramica di Pantelleria. Inquadramento tipologico e primi dati quantitativi dallo scavo subacqueo al porto di Scauri. Archeologia Medievale XXXII, 401-408.
Santoro, S. 2007. Le ceramiche da cucina prodotte in Italia ed esportate nel Mediterraneo: un primo panorama archeometrico ed archeologico sulla base di una banca dati. In LRCW2, 365-371.
Santoro Bianchi, S., Guiducci, G. and Tusa, S. 2003. Pantellerian Ware. Archeologia subacquea e ceramiche da fuoco a Pantelleria. Palermo.
Staffa, A. 1998. Le produzioni ceramiche in Abruzzo tra fine V e VII secolo. In L. Saguì, L. (ed.), Ceramica in Italia: VI-VII secolo. Atti del convegno in onore di John W. Hayes, 437-480. Firenze, All’Insegna del Giglio.
Staffa, A. 2004. Le produzioni ceramiche in Abruzzo nell’Alto Medioevo. In Patitucci Uggeri (ed.), 205-234.