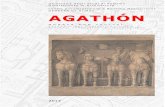Le civitates dell'Apulia et Calabria: aspetti della documentazione epigrafica tardoantica, in STAIM...
Transcript of Le civitates dell'Apulia et Calabria: aspetti della documentazione epigrafica tardoantica, in STAIM...
Bari 2010
Università degli Studidi Foggia
Dipartimentodi Scienze Umane
PAESAGGI E INSEDIAMENTI URBANIIN ITALIA MERIDIONALE
FRA TARDOANTICO E ALTOMEDIOEVOAtti del Secondo Seminario sul Tardoantico e l’Altomedioevo
in Italia Meridionale(Foggia - Monte Sant’Angelo 27-28 maggio 2006)
a cura diGiuliano Volpe e Roberta Giuliani
STAIM 2
E S T R A T T O
Introduzione. Paesaggi e insediamenti urbani dell’Italiameridionale tra Tardoantico e Altomedioevo: materiali eproblemi per un confronto
di Giuliano Volpe
La città tra V e VII secolo: archeologia e storiografia agliinizi del XXI secolo
di Gian Pietro Brogiolo
Civitates propriis destitutae rectoribus: città, giurisdi-zione episcopale e territorio diocesano nel V secolo
di Giorgio Otranto
Edilizia residenziale e società urbanadi Isabella Baldini Lippolis
Le civitates dell’Apulia et Calabria: aspetti della docu-mentazione epigrafica tardoantica
di Marina Silvestrini
Committenza e prassi epigrafica nelle città dell’Apulia etCalabria
di Donatella Nuzzo
Egnazia tardoantica: nuove indagini e prospettive di ri-cerca
di Raffaella Cassano
Nuove acquisizioni su Bari tardoantica e altomedievaledalle stratigrafie dell’area di S. Nicola e della Cattedrale
di Dario Ciminale
Modificazioni dei quadri urbani e formazione di nuovimodelli di edilizia abitativa nelle città dell’Apulia tardo-antica. Il contributo delle tecniche costruttive
di Roberta Giuliani
Relazione tra morte e aree sacre: paleopatologia di uncampione scheletrico dal sito tardoantico di San Pietro, aCanosa (BAT)
di Sandro Sublimi Saponetti, Laura De Nicola, Vito Scattarella
Matera tra tarda antichità e alto medioevodi Francesca Sogliani
Acerenza tardo-antica e il territorio alto-bradanicodi Maurizio Gualtieri
Venosa. Nuovi dati sulla frequentazione tardoantica del-l’area della SS. Trinità a Venosa
di Maria Luisa Marchi
Note su Crotone tra IV e VII secolo di Chiara Raimondo e Alfredo Ruga
Trasformazioni urbane e costruzione di una nuova iden-tità: Catania nell’altomedioevo
di Lucia Arcifa
Dai cimiteri ai luoghi santi: le trasformazioni del subur-bio siracusano
di Mariarita Sgarlata
Aspetti della trasformazione della città in Campania fraTardoantico e Altomedioevo
di Eliodoro Savino
Le città della Campania nella documentazione epigraficapubblica del tardo III-IV secolo
di Giuseppe Camodeca
Epigrafia e città nella Campania tardoantica e altome-dievale. Uomini, istituzioni, opere
di Chiara Lambert
Nuovi dati su Benevento nella tarda antichitàdi Marcello Rotili, Silvana Rapuano, Maria Raffaella Cataldo
Alife. Dalla colonia romana al gastaldato longobardo. Unprogetto di lettura interdisciplinare delle emergenze sto-rico-archeologiche
di Federico Marazzi e Enrico Angelo Stanco
Organizzazione e destrutturazione dell’insediamento diAeclanum: considerazioni
di Sandra Lo Pilato
Il paesaggio di una città altomedievale (Leopoli-Cen-celle): morfologia e analisi del territorio antropizzato
di Letizia Pani Erminie Francesca Romana Stasolla
Considerazioni conclusivedi Domenico Vera
Indice del volume
Edipuglia srl, via Dalmazia 22/b - 70127 Bari-S. Spiritotel. 0805333056-5333057 (fax) - http://www.edipuglia.it - e-mail: [email protected]
STAIM 2 · Paesaggi e insediamenti urbani in Italia meridionale fra tardoantico e altomedioevo · © 2010 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
1. Presento in apertura una tabella con la quantifi-cazione delle epigrafi tarde recuperate nella provincia,Apulia et Calabria, con l’esclusione di Benevento, chedopo alcune incertezze fu definitivamente aggregataalla Campania, nonché di Larino e Teano inserite, allametà del IV secolo, nella provincia del Samnium 1. Il li-mite cronologico superiore è individuato nella provin-cializzazione dell’Italia, avviata da Dioclezianonell’ultimo decennio del III sec., quello inferiore nel se-colo VI, nei cui decenni finali, in Italia meridionale, inpiù situazioni viene registrata la destrutturazione del tes-suto urbano, come confermato dal nostro precedenteconvegno 2. Poiché solo alcuni centri della Apulia et Ca-labria dispongono di corpora epigrafici aggiornati ecorredati di documentazione fotografica, la seguente ta-bella è orientativa e suscettibile di modificazioni, ancheconsistenti per quei centri – e sono la maggioranza – lacui documentazione di età tardo romana consta di qual-che unità. Le edizioni dei relativi documenti epigraficisono raccolte in Appendice.
Nelle sezioni relative alle epigrafi cristiane edebraiche in alcuni casi sono incluse anche iscrizioni didatazione successiva al VI sec.: delle epigrafi cristianetratta Donatella Nuzzo in questo stesso convegno. Perl’epigrafia ebraica sottolineo il caso di Taranto (delle21 epigrafi ebraiche del centro ionico, di recente ri-
proposte da Colafemmina, solo due si datano al IV-Vsec., per le altre viene indicata una cronologia tra ilVII e il IX sec.), il cui insieme appare indubbiamenteindicativo della continuità e vivacità della comunitàebraica tarentina 3. Diversamente l’epigrafia ebraica diVenusia superstite, un’imponente raccolta di 77 testi,è circoscritta tra i secoli IV e VI 4. Ho distinto le epi-grafi di carattere pubblico da altre categorie, assu-mendole come indicatore primario della vitalità deicentri, piuttosto che il numero totale delle iscrizionirecuperate (dato che rimane comunque di notevole in-teresse), poiché il numero complessivo è condizionatodal carattere della documentazione, come mostranocon chiarezza le epigrafi delle catacombe ebraiche diVenosa.
Nel valutare le iscrizioni censite assumo comepunto di riferimento il convegno L’Italia meridionalein età tardoantica del 1998: in quella sede è stata ri-badita in più contributi la gerarchia dei centri, la vita-lità di alcuni tra questi in relazione alla sede delgovernatore, alla sua attività itinerante, alla disloca-zione degli uffici decentrati 5; tenendo salda questacornice segnalo alcuni arricchimenti della documen-tazione e approfondimenti dell’indagine.
Canusium: le 10 (forse 12) epigrafi pubbliche delcentro, cui si aggiungono 12 miliari tardo romani, con-
* Dipartimento di Studi Classici e Cristiani, Università degliStudi di Bari; [email protected].
1 Cfr. Grelle, Volpe 1994, 17-22, con delimitazione dei con-fini della provincia e precedente bibliografia: anche sulla basedei confini ivi delineati Aceruntia non viene inclusa nella se-guente tabella; inoltre Grelle 1999, 118-120.
2 Volpe, Turchiano 2005; cfr. le considerazioni conclusivedi F. Grelle, 715-716.
3 Vd. Appendice, Tarentum.4 Vd. Appendice, Venusia.5 In particolare Grelle 1999, 123-131. In generale sul sistema
di finanziamento degli edifici pubblici nel IV sec. cfr. Lewin2001.
61
Le civitates dellʼApulia et Calabria:aspetti della documentazione epigrafica tardoantica
di Marina Silvestrini*
The ʻcivitatesʼ of ʻApulia et Calabriaʼ: aspects of epigraphic documentation of late antiquityThis contribution presents first the complete set of late ancient inscriptions from provincial Apulia et Calabria, exceptBenevento. Then the collocation of the late antique milestones is analysed. You found, here as in some other provinces, theincrease of the milestones, which is more remarkable, given the shrinkage of other kinds of epigraphs. As a matter of factmilestones represent a significant fraction of the whole remaining corpus. This element points out the relevance of the road-system in the late antique governmental system. The milestones of this period seem mostly placed in significant places.Finally three late antique inscriptions found in Canosa are published: the first unpublished mentions a Sinopesis, possiblya negotiator, the other two need to be studied in more details.
STAIM 2 · Paesaggi e insediamenti urbani in Italia meridionale fra tardoantico e altomedioevo · © 2010 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
fermano il ruolo della città nella provincia, città chevede una vivacità di interventi promossi sia dalla curialocale, sia dai governatori provinciali per l’intero IVsecolo sino agli inizi del V; successivamente cessa ladocumentazione. Le colonne miliari si datano nellostesso periodo. L’epigrafia di Aeclanum dispone oradella Tesi di dottorato di Silvia Evangelisti, di pros-sima pubblicazione 6, e, per l’epigrafia cristiana, del-l’edizione delle ICI, curata da Antonio Felle (1993),nondimeno rimane invariato il numero delle epigrafipubbliche rispetto alla edizione del CIL. Tarentum:alla ben nota epigrafe relativa al restauro delle TermePentascinensi, della seconda metà del IV sec. (P. 1), siaggiungono quattro frammenti con elementi di titola-ture imperiali, riferibili, nella ricostruzione di Gaspe-rini, ad età tetrarchica e costantiniana (P. 2-5). Luceria:alle tre epigrafi pubbliche già note, databili nel corsodel IV sec., si è aggiunta una importante tabula patro-natus offerta dai decurioni lucerini, precisamente da-tata al 327 d.C., recuperata nell’agro di Larino, una cuirinnovata edizione è stata curata da Nello Parma 7. Ba-
rium: si segnala un accurato studio paleografico diFioretti in ‘Scrittura e Civiltà’ del 2000, sulla epigrafemusiva della cattedrale paleocristiana di Bari, la cuiscrittura sembra risentire di influenze di derivazionegreco-orientale; la datazione dell’epigrafe musiva edel mosaico al pieno VI (in passato assai discussa) èstata ora confermata anche nel recentissimo volumededicato allo studio del succorpo della cattedrale 8.Brundisium non restituisce nessuna epigrafe pubblica,ma si segnalano tre colonne miliari tardo romane e duemiliari sono stati recuperati anche a Metaponto (suimiliari vd. oltre). Con attenzione alla cronologia, èpossibile ribadire che l’epigrafia pubblica della pro-vincia non sembra superare in nessun centro i primidecenni del V secolo e che le attestazioni più recentiprovengono comunque da Canosa.
2. La dislocazione dei miliari recuperati consentequalche ulteriore nota rispetto a precedenti osserva-zioni su questa tipologia di monumenti restituiti da sitidella provincia 9: la loro collocazione non risulta estra-
6 Ringrazio S. Evangelisti per la possibilità di consultare illavoro di Tesi.
7 Parma 2006.
8 Belli D’Elia, Pellegrino 2009.9 Cfr. M. Silvestrini, in ERC II, 210-211; Grelle 1986, 383-
385 [= Grelle 1993, 166-167]; Silvestrini 1999b.
62
Città Epigrafi
pubbliche
Epigr. votive
funer., fram.
Miliari Epigrafi
cristiane
Epigrafi
ebraiche
Totale
Canusium 10+2(?) 4 12 21 47+2 (?)
Aeclanum 7 4 1 48 60
Tarentum 4+1(?) 2+18 di
VII-IX sec. 6+1(?)+18
Venusia 4 1 6 6 77 94
Luceria 4 2 7 13
Compsa 1 1
Barium 1 1 3 1 + 1 di
IX sec. 6+1
Egnatia 1 1 2
Ausculum 1 1
Herdonia 1 1
Genusia 1 1
Neretum 1 1
Brundisium 2 (?) 3 1 4+2 (?)
Metapontum 2 2
Lupiae 1 1 2
Salapia 1 1
Aecae 1 1
Sipontum 1 1
Uria 1 + 1 di
VIII sec. 1 +1
Hydruntum 1 1
Totale 36+3(?) 14+ 2 (?) 26 87 82+20 246+4(?)+20
(VII-IX sec.)
246 + 5 (?) +20
(VII-IX sec.)
STAIM 2 · Paesaggi e insediamenti urbani in Italia meridionale fra tardoantico e altomedioevo · © 2010 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
nea al ruolo delle città nell’ambito dell’organizzazioneprovinciale. Già in occasione dell’edizione dei miliaridi Canusium avevamo osservato le seguenti coinci-denze: a Canosa da una parte rimangono tre iscrizionicon il nome di Costantino, una onoraria, posta dal cor-rector, Volusius Venustus, vir clarissimus, per l’impe-ratore e i suoi figli (P. 4, databile tra il 326-333) 10, lealtre due parzialmente conservate (P. 3 e 9), dall’altra,quattro miliari con il nome di Costantino (M. 9, data-bile nei primi sei mesi del 313; M. 2, 10-11, databili trail luglio 313 e il luglio 314) 11, uno con il nome di Li-cinio (M. 8, databile verosimilmente tra la fine del 312e il 324) 12 e uno con il nome di due figli di Costantinoe del figlio di Licinio (M. 4, databile tra il 317 e il324); quindi due basi onorarie per Giuliano Cesare (P.5 e 6, databili tra il 355 e il 361), una posta dall’ordoe dal populus Canusinus, l’altra dal corrector, AnniusAntiochus, e tre miliari di Giuliano Augusto (M. 3, 5,6, databili tra il 361 e il 363); ancora una iscrizione perTeodosio padre, curata dal corrector, Flavius Sexio (P.7, databile tra il 379 e il 394) 13 e un miliario per Teo-dosio, Arcadio e Onorio (M. 12, databile tra il 393 e il395). I nomi degli Augusti e dei Cesari sono sempre aldativo.
La relazione tra monumenti onorari e miliari, a par-tire dal III sec., è stata in più occasioni notata, sia intermini generali, in riferimento alla estrema prossimitàdei testi dei miliari al vocabolario delle epigrafi ono-rarie 14, sia in riferimento a particolari pietre miliari.Si segnala un interessante caso nella Venetia, valoriz-zato da Buonopane: un miliario con il nome di Gra-
ziano recuperato a Vicenza, posto dalla civitas (Vicen-tina) 15, identico al testo di una base onoraria (parte diuna colonna riutilizzata) che reggeva una statua diGraziano, anch’essa recuperata a Vicenza e posta an-ch’essa dalla civitas Vicentina, con l’aggiunta dellaconsueta formula, d(evota) n(umini) m(aiestati)q(ue)eius (CIL V, 3114 = Alföldy 1984, 124, n. 179) 16. Perquesti, come per molti altri esempi tardo romani, si èsottolineato il ruolo del miliario come attestazione dilealtà, mezzo di propaganda, a fronte della scarsa rile-vanza della funzione di indicatori stradali 17.
Appare particolarmente utile il riconoscimento,nella composizione dei testi dei miliari, del livello pro-vinciale, sottolineato con chiarezza da Christol, ilquale individua convincentemente nei governatori ivettori della propaganda imperiale 18. Un punto, que-sto, di notevole interesse che mostra, sotto il versantepropagandistico, il nesso tra provincializzazione e via-bilità nell’impero tardoantico, già individuato sotto ilprofilo funzionale 19. La collocazione dei miliari, il cuielemento imprescindibile, in età tardoantica, non ètanto il numero delle miglia, bensì il nome e la titola-tura imperiale, costituisce, come si è detto, una testi-monianza di lealtà, anche di ‘adesione politica’, unsegno di devozione nei confronti del centro del po-tere 20, percepibile da tutti i fruitori della viabilità pro-vinciale: l’esercito in alcune province, i funzionariimperiali, gli amministrati e tra questi in particolare icuriali 21. I miliari tardi sembrano esser stati collocatiper lo più in luoghi considerati significativi 22, luoghiche il recupero di norma non in situ di questi monu-
10 Questa delimitazione cronologica, già proposta da Cha-stagnol 1963, 367, è ripresa negli studi successivi: Cecconi1994, 218; Mennella 1994, 171.
11 La datazione circoscritta di M. 9 è determinata dal terzoconsolato, connesso alla ottava salutazione imperatoria; dallanona salutazione imperatoria consegue la datazione degli altritre miliari, cfr. Kienast 19962 , 301.
12 La datazione, possibile per l’intero arco dell’impero di Li-cinio (308-324), viene circoscritta perché appare improbabile lacollocazione del miliario prima della sconfitta di Massenzio il28 ottobre del 312.
13 Cfr. da ultimo Cecconi 1994, 219; Mennella 1994, 172. 14 Cfr. almeno Salama 1987, 56-60, 133-134; Christol 1999,
350-353, con ulteriore bibliografia.15 Il miliario, edito da Basso 1987, 123, n. 54, è ripreso da
Buonopane 2003, 347. 16 Per l’“attenzione” della comunità di Vicenza nei confronti
della casata di Valentiniano cfr. Cracco Ruggini 1987, 279-280.
17 Cfr. già Nesselhauf 1937, 175; quindi Herzig 1973, 95;Donati 1974, 162; in anni più recenti, tra gli altri, Banzi 1999,179; Witschel 2002, 370-371; Buonopane 2003, 344-345; per lestrade come locus celeberrimus cfr. Eck 2004, 25-39.
18 Christol 1999, 352-353; per il ruolo dei governatori nellacollocazione dei miliari cfr. già Pekary 1968, 77-86.
19 Cfr., in riferimento all’Africa proconsolare tardoantica,Salama 1987, 72-80; in riferimento alla provincia Apulia et Ca-labria: in generale Grelle 1999, 118; con attenzione all’ammi-nistrazione della giustizia anche in sedi decentrate, cfr. Id. 1989,116-119 [= Grelle 1993, 182-185]; Giardina, Grelle 1983, 286-295[= Grelle 1993, 234-244], per l’ adventus del governatore alfine di verificare la regolarità dell’esazione tributaria.
20 L’espressione ‘adesione politica’ è di Christol 1999, 352. 21 Per l’esercito cfr. per es. Isaac 1990, 304-309, in riferi-
mento alle province orientali.22 Cfr. per es., per il caso di Aquileia, Witschel 2002, in par-
ticolare 371-372.
63
Le civitates dell’Apulia et Calabria: aspetti della documentazione epigrafica tardoantica
STAIM 2 · Paesaggi e insediamenti urbani in Italia meridionale fra tardoantico e altomedioevo · © 2010 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
menti, particolarmente adatti al riuso, considerata laprevalente forma della colonna, permette con difficoltàdi decifrare. Tuttavia è almeno rilevabile la loro di-stribuzione non omogenea: in Apulia et Calabria ac-centrata nei territori di alcune civitates. Questaconsiderazione ovviamente non esclude la possibileconnessione tra la collocazione dei miliari e interventinella cura della viabilità.
L’indicazione esplicita sui miliari di età tardoan-tica di chi ne avesse curata la collocazione comparepiuttosto raramente nella penisola. Il nome del gover-natore provinciale è presente su cinque miliari dellaFlaminia et Picenum (quattro dei quali attribuibili adun solo governatore) 23; inoltre su un’interessante seriedi miliari-dediche della Venetia (cinque per la preci-sione, relative a strade diverse del distretto provin-ciale), il dedicante è la provincia con la formulazionedevota Venetia collocavit 24. Questa serie, oltre a con-fermare il nesso tra viabilità e province che è puntocentrale di questo discorso, fa pensare che in questocaso i miliari siano stati collocati a seguito di una de-cisione del concilium provinciae, orientata dal gover-natore provinciale 25.
Spesso si è detto che i miliari con il nome dell’im-peratore al dativo erano collocati dalle collettività lo-cali 26: né mancano in Italia alcuni, ben noti, esempi dipietre miliari poste da civitates: nella Venetia, la civi-tas (Vicentina), già sopra menzionata; nella provinciaAemilia et Liguria, Pavia, con la dizione Tic(inum)div(otum), pone un miliario-dedica per Valentiniano eValente (CIL V, 8060b) 27; un altro miliario è collocatodalla civit(as) Pisana, nella Tuscia et Umbria, per Va-lente, Graziano e Valentiniano II (CIL XI, 6665); daricordare inoltre il miliario collocato dall’ordo pos-
sessoresque Brixellanorum per Giuliano (CIL XI,6658). Si può osservare che rispetto all’insieme deimiliari tardi, nella penisola, sia quelli posti esplicita-mente da comunità locali, che quelli con il nome delgovernatore costituiscono un fenomeno limitato ri-spetto all’alto numero complessivo. Né gli uni, né glialtri presentano variazioni significative rispetto alleformulazioni consuete: sembra trattarsi di accentua-zioni diverse in un rapporto regolato e, generalmente,apparentemente equilibrato tra governatori provincialie comunità locali, sulle quali verosimilmente ricadeval’impegno economico 28. In CIL IX-X, con esclusionedi Sicilia e Sardegna, i miliari dioclezianei e postdio-clezianei costituiscono più del 40% di quelli conser-vati, un dato notevole nel quadro di crisi dellaproduzione epigrafica. In ogni caso l’uniformità deitesti dei miliari tardi rinvia ad una iniziativa politicaunitaria, guidata dal governatore provinciale, allaquale si può pensare che i curiali delle singole città po-tessero aderire con maggiore o minore partecipazionee rispetto alla quale potevano forse anche esercitareuna sollecitazione.
In Apulia et Calabria, sia pure con la prudenza im-posta dalla casualità della documentazione, le colonnemiliari mostrano in evidenza innanzitutto l’area del“capoluogo”, Canosa, con 12 miliari, recuperati nelcentro e nell’agro, collocati lungo la via Traiana, aNord e a Sud della città, ma anche Venosa, città giàper altri versi di rilievo nella provincia 29, che restitui-sce 6 miliari, 5 riferibili alla via Herculia (M. 1-5), eduno (M. 6, con i nomi dei tetrarchi al nominativo) po-trebbe essere riferito alla via di collegamento tra Ve-nosa e Canosa 30. Ancora, dal territorio di Brindisiprovengono tre colonne miliarie: due con il nome di
23 Una revisione dei miliari posti da Fl. Romulus, consula-ris Flaminiae et Piceni, in Camodeca 1978, 151-152 (MacchieS. Ginesio / Urbs Salvia) ripreso in AE 1978, 290; 152-153(Alba Fucens), ripreso in AE 1978, 284; 154 (Goriano Sicoli/ Statulae), ripreso in AE 1978, 285; 154 (= CIL IX, 5940 daAncona); legge diversamente il gentilizio del governatore delmiliario di Macchie S. Ginesio Gasperini 1980a (AE 1980,380). A questi si aggiunge il frammento di miliario da Civita-nova Marche, edito da Paci 1984/86, 496-502 (AE 1990, 309).
24 CIL V, 7993 = Basso 1987, n. 86; CIL V, 8029 = Basso1987, n. 13; CIL V, 8031 = Basso 1987, n. 10a; CIL V, 8032 =Basso 1987, n. 11a; CIL III, 11314 = Basso 1987, n. 100; suquesta serie cfr. anche Basso 1990.
25 Su questo punto mi sono confrontata con FrancescoGrelle, che ringrazio; vd. in proposito anche Cecconi 1998, 160.
26 Cfr. per es. Salama 1987, 58; Herzig 1973, 91-95, che rac-coglie le epigrafi itinerarie collocate da comunità locali; König1973; in anni più recenti anche Banzi 1999, 176, che pure rilevache i formulari erano imposti dalle autorità statali; Buonopane2003: «varie comunità (città o distretti amministrativi che fos-sero)». Anch’io in passato ho valutato positivamente questa ipo-tesi, cfr. Silvestrini 1990, 210.
27 Cfr. anche Suppl.It, 9 (1992), 250-251; da ultimo il miliarioè riproposto in Banzi 1999, 194, n. 1b, con ulteriore bibliografia.
28 Cfr. Herzig 1974, 641.29 Cfr. Volpe 1996, 109-114; Grelle 1999, 124-125. 30 Il numero di miglia (VIII) porta ad escludere che il milia-
rio possa essere riferito alla via Herculia, come supposto daM.R. Torelli 1995, 294, n. 16 (AE 1995, 352); poco convin-cente anche l’ipotesi prospettata da Fornaro 2000, 306, che at-
64
Marina Silvestrini
STAIM 2 · Paesaggi e insediamenti urbani in Italia meridionale fra tardoantico e altomedioevo · © 2010 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
Costantino al dativo e l’indicazione del quarto conso-lato (databili tra il 315 e il 319), segnalate dinanzi adue chiese di Mesagne (M.1-2), sono da riferire al per-corso della via Appia. Il terzo miliare, individuato aBrindisi, presenta il nome di Massenzio al nominativo:non è evidentemente omogeneo ai miliari-dediche dicui ci stiamo occupando, piuttosto va accostato all’at-tività di ripristino delle strade (accompagnata da mi-liari), operata da questo imperatore, ben documentatasoprattutto nel caso della via Herculia; restano cinquepietre miliari riferibili a questa strada con il nome diMassenzio, quattro delle quali con il nome al nomina-tivo 31. Per quanto concerne Metaponto, abbiamo duemiliari-dediche per Giuliano Augusto (M. 1-2): unacolonna recuperata in situ, l’altra in giacitura secon-daria, ora attribuite convincentemente alla strada Ta-ranto-Heraclea-Reggio 32.
Quindi la ricognizione dei miliari tardi, oltre aconfermare il ruolo di Canosa e Venosa nella provin-cia, pone in nuova evidenza Brindisi e in qualche mi-sura anche Metaponto: che Brindisi, punto d’arrivodella via Appia e della via Traiana, importante porto
d’imbarco per il Mediterraneo orientale, fosse area si-gnificativa per la circolazione dei messaggi politiciagli occhi dell’imperatore (Massenzio), dei governa-tori, dei curiali non sorprende, tuttavia va sottolineatoche le tre colonne miliari costituiscono l’unico nucleosignificativo dell’epigrafia locale tarda. A Metapontoi due miliari con il nome di Giuliano sono pressochéle sole testimonianze dell’epigrafia, non solo tardo an-tica 33: un dato in accordo con gli scavi archeologiciche documentano una consistente ripresa del centronel IV-V secolo, con ampliamento del quartiere por-tuale 34.
3.1. Passiamo ad esaminare alcune epigrafi tarde 35.Partiamo da questa iscrizione da Canosa, inedita, rin-venuta nella discarica di via Costantinopoli nel 1998dal Sig. Francesco D’Ambra, benemerito nel difficilerecupero di materiali antichi, già conservata nel De-posito di Palazzo Sinesi 36 (fig. 1). Rimane l’angolo su-periore destro di una lastrina di marmo (misure: alt.mass. cm 10; larg. mass. cm 12, spess. cm 2; misuredelle lettere non registrate). La superficie è segnata dascalfitture e qua e là coperta da incrostazioni. Un’ederastilizzata compare al di sopra della prima riga di scrit-tura. Il carattere esitante del tratto orienta per una da-tazione al tardo impero. Autopsia: gennaio 2001.
È leggibile il seguente testo con le restituzioni im-mediate:
[ ---e]ṭ meum titu=[lum —-]+E Sinopen(sis)[---] Calabria+[---]+ Teo[---]- - - - - -
Siamo in presenza di un’epigrafe funeraria. Poi-ché l’hedera ha spesso la funzione di riempire unospazio lasciato vuoto dal testo, è presumibile chel’epitafio fosse introdotto dalla sigla D. M. in qualche
tribuisce la pietra ad una diramazione dell’Appia. L’ipotesi cheessa si riferisca alla via Venosa-Canosa è già prospettata dal-l’Alvisi 1970, 105, nota 154.
31 CIL IX, 6058-6059, 6066 = ILS 670; CIL IX, 6067; Sil-vestrini 1996, 457-462 (= AE 1996, 458): in questa ultima pie-tra registriamo il caso dativo.
32 Buonopane 2009; questi miliari erano stati attribuiti aduna nuova strada di collegamento tra il porto e il territorio(Giardino 1982; Ead. 1991, 844-845; Ead. 1999, 349-350).
33 Rimane un’altra sola epigrafe metapontina: CIL X, 8089.34 Cfr. Giardino 1999, ivi il precedente percorso degli studi. 35 La fotografia n. 1 è di Maria Martinelli (Università di
Bari), le fotografie nn. 2-3 sono di Barbara De Nicolò.36 L’epigrafe fu da me vista e fotografata nel gennaio 2001,
attualmente non è stata rintracciata. Ringrazio per la possibilitàdi studiare questa epigrafe e la successiva (n. 3.3) la dott. Ma-risa Corrente della Soprintendenza per i Beni Archeologici dellaPuglia.
65
Le civitates dell’Apulia et Calabria: aspetti della documentazione epigrafica tardoantica
1. - Canosa, epigrafe frammentaria di un Sinopensis.
STAIM 2 · Paesaggi e insediamenti urbani in Italia meridionale fra tardoantico e altomedioevo · © 2010 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
modo coordinata con l’hedera rimasta, considera-zione che conferma che più di metà della lastrina èandata perduta. L’epitafio era strutturato secondo loschema dell’appello del defunto al lettore: la E, primalettera interamente leggibile alla l. 2, preceduta daun’altra lettera interpretabile come C o G, orienta perindividuare in questa parola il verbo lege o perlege;dunque si può pensare ad una ricostruzione del tipo:[Hospes resiste e]t meum titu/lum —- lege, che trovaconfronti per es. in CIL VI, 36202: [Hospes resi]steet titu/lum perscriptum lege 37; avremmo così unaprima riga di 23 lettere. Prima del verbo lege si puòimmaginare un avverbio: per es. in AE 1914, 276(Cesi, Umbria), leggiamo: …. amice perlege….Dopo l’appello il defunto dichiara la sua origine conl’etnico, non sappiamo se scritto per esteso o informa tronca: Sinopen/sis o Sinopen(sis); notoria-mente piuttosto comune l’indicazione della città diorigine per persone defunte lontane dalla loro pa-tria 38. Quindi ricorda nella riga successiva la provin-cia nella quale si trovava, definendola, sembra,semplicemente Calabria. Questi due elementi con-giunti (origine e indicazione della provincia) si adat-tano bene alla condizione di un negotiator (onegotians), commerciante su grande distanza: infattii negotiatores non di rado indicavano sia il luogo diorigine, sia la provincia nella quale svolgevano lapropria attività 39. In casi del genere la provincia è ge-neralmente indicata con un aggettivo: sono ben do-cumentati i negotiarores Britanniciani, Cisalpini eTransalpini 40, attestato anche un negotiat. Daciscusad Aquileia (CIL V, 1047 = ILS 7526), un negotiatorGallicanus a Cagliari (CIL X, 7612) 41. Invece nel-l’epigrafe canosina leggiamo il sostantivo Calabria
presumibilmente in caso accusativo: infatti l’ultima Adella parola è indubbiamente seguita da un’altra let-tera e le tracce rimaste, se non sono da attribuire in-tegralmente a successive scalfitture, suggerisconouna M. In questo caso la parola Calabria sarà stataaccompagnata da un verbo di movimento: si può pen-sare ad esempio ad un’espressione del tipo: Sino-pen(sis) / negotiator in Calabriam / veni...; altrepossibilità possono essere prospettate.
L’Apulia et Calabria, provincia doppia, sembre-rebbe qui essere definita soltanto Calabria, altrimentibisognerebbe pensare che la terza riga rimasta fosseoccupata quasi per intero dal nome della provincia:questa possibile riduzione del nome ad uno solo deidue elementi trova un interessante raffronto in duedediche beneventane (CIL IX, 1571-1572), databilialla metà del III sec., poste per lo stesso senatore, cheera stato iuridicus del distretto giudiziario Apulia etCalabria, così definito in una delle due (CIL IX,1572 = ILS 2939), mentre nell’altra (CIL IX, 1571) ildistretto è semplicemente denominato Calabria 42.
Nella quarta riga conservata si leggono le lettereTEO, precedute da una lettera interpretabile come E,F o T: in questa riga sarà stato indicato il nome deldefunto, tra i più comuni inizianti per Theo-/Teo-sono Theodorus, Theophilus, Theodotus 43, forse pre-ceduto dall’espressione nomine / cognomine, possi-bilità che si adatta alla traccia che rimane. Nelle lineesuccessive sarà stata verosimilmente indicata la du-rata della vita del Sinopensis.
Ciò che rileva in questa epigrafe non è tanto la ri-costruzione del testo che può solo essere propostacon approssimazione, quanto notare la presenza a Ca-nosa di un cittadino di Sinope nel IV secolo: verso
37 Numerosi, ulteriori confronti in CLE, Indices, II, 2, 868;Colafrancesco, Massaro 1986, 337-338.
38 Alcuni casi relativi a persone, di varia condizione, prove-nienti dalla parte orientale dell’impero, sepolte in Apulia et Ca-labria: … Antiochensis Syriae ad Daphnen … (CIL IX, 41 =ILS 2819 da Brundisium); … Bithynus negotiator … (CIL IX,62 = ILS 7525 da Brundisium); … Trallianos … (CIL IX, 285,cfr. Suppl.It., 8,1991, 33, da Barium); … nat(ione) Phry(gia)… (Silvestrini 2005, 204 = AE 2005, 399, da Azetium ?); M.Ael. Caesoniano Dionysio pp. Amastriano … (CIL IX, 951 =Silvestrini 1999a, 51-52, fine II-primi decenni del III d.C., daAecae), in questo ultimo caso un ufficiale dell’esercito, prove-niente, come il Sinopensis, da una città sulla costa del MarNero.
39 Un’ampia casistica della doppia indicazione del luogo di
origine e professionale è raccolta da Mennella 2000, 130, nota14, anche 132-133, per le testimonianze dei negotiatores Ci-salpini et Transalpini, con precedente bibliografia.
40 Sui negoriatores definiti Britanniciani cfr. Raepsaet-Char-lier 1988, 54-56; per i negotiatores Cisalpini e Transalpini, vd.nota precedente.
41 L’epigrafe è ora nuovamente edita da Floris 2005, 447-449, n. 177.
42 La datazione alla metà del III sec. del senatore M. Caeci-lius Novatillianus è di Camodeca 1982, 137. Sulla irrilevanzaamministrativa della doppia provincia cfr. Grelle 1999, 122-123.
43 Cfr. orientativamente la documentazione dell’Urbe, rac-colta da Solin 20032, 78-80 (Theodorus), 85-86 (Theophilus),75-76 (Theodotus).
66
Marina Silvestrini
STAIM 2 · Paesaggi e insediamenti urbani in Italia meridionale fra tardoantico e altomedioevo · © 2010 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
questo ambito cronologico orienta la paleografia,preferibilmente non oltre la metà del secolo. Si puòperaltro aggiungere che si tratta di uno degli ultimiepitafi canosini che non mostra alcun ‘segno’ di com-mittenza cristiana 44.
Sinope, importante porto naturale, collocato inposizione centrale sulla costa meridionale del MarNero, dopo la riorganizzazione dioclezianea dellaprovincia di ‘Bitinia e Ponto’ faceva parte della Pa-phlagonia: Sinope era rinomata per il commercio dellegname, del pesce salato e soprattutto di un prodottonoto come Sinopiké miltos 45 o anche Sinopis 46 o Si-nopis Pontica 47, una ocra rossa, commerciata preva-lentemente da Sinope, da cui traeva il nome, maproveniente, come attesta Strabone, dalla Cappado-cia: il geografo di Amasea (12, 540) la giudica la mi-gliore tra quelle commerciate al suo tempo, perquanto questo primato fosse allora eguagliato daquella iberica 48. Dopo Strabone ne tratta Plinio inmaniera articolata (35, 31-32, 36), ne ricorda le va-rietà, il prezzo (2 denari la libbra) e l’uso: veniva uti-lizzata dai pittori per dipingere, anche per colorare illegno e inoltre, per ricavarne, con altri ingredienti,una colla con la quale si applicava l’oro al legno; nonultimo, per usi medici 49. Ancora Isidoro, a cavallotra VI e VII sec., ricorda tra i colori naturali la Sino-pis (Orig., 19, 17). Si discute se fosse cinabro o piut-tosto un’argilla colorata da ossido ferroso 50. Sitrattava evidentemente di un prodotto destinato aduna committenza di rango elevato, sia che si pensi al-l’uso decorativo che a quello farmacologico.
Lo stato dell’epigrafe impone evidentemente pru-denza: non conosciamo la motivazione della presenzadel Sinopensis a Canosa e nella provincia, per quantol’eventualità che fosse un mercante appaia probabile,quand’anche il termine negotiator non comparisse
nell’iscrizione; né conosciamo quali prodotti com-merciasse: la grande distanza di Sinope dalla Pugliaimplica la commercializzazione di prodotti di pregio,venduti o acquistati, richiesti da una committenza eli-taria, il cui commercio remunerasse la lunghezza delviaggio 51. La Sinopis, ancora ricordata nel tardo im-pero, come documentano i già citati Vegezio ed Isi-doro, potrebbe rispondere a tali requisiti. Per quantoconcerne i possibili acquirenti in Apulia et Calabriain età tardoantica, appare sufficiente ricordare i ri-sultati delle indagini sulla residenza aristocratica diFaragola (Ascoli Satriano), ristrutturata in varie fasitra III e V secolo, che mostrano ricchezza, ricerca-tezza dei committenti, compresa l’utilizzazione dimateriali raffinati, anche di provenienza orientale: sipensi ai pannelli in opus sectile 52.
Propongo infine un’ipotesi di ricostruzione:
[D. M.] [Hospes resiste? e]t meum titu=[lum --- le]ge: Sinopen(sis)[negotiator ? in] Calabriaṃ
5. [veni, - - - nomin]e (?) Teo[dorus ?]- - - - -
3.2. Esaminiamo ora due iscrizioni già presenti inLe epigrafi romane di Canosa, I (1985), nn. 230 e 228:a suo tempo ne avemmo notizia in chiusura di volumee le inserimmo tra i frammenti finali. La prima (ERCI, 230) è una lastra conservata nel Museo di Bisceglie(n. inv. 1633) 53, proveniente dalla collezione privatadel cardinale Donato Maria Dell’Olio, raccolta nellasua casina di campagna, sita in contrada Carrara delleMonache, sulla via vecchia che collegava Trani a Bi-sceglie, collezione che comprendeva, tra gli altri ma-teriali antichi, un consistente nucleo di epigrafibrindisine e quattro iscrizioni di altra provenienza,convincentemente attribuite, in ERC, I, al territorio di
44 Cfr. su questa tematica ora Carletti 2008, in particolare48-58; la prima iscrizione canosina cristiana è datata all’anno392-393 (CIL IX, 6192 = ILCV 582 = ERC I, 103); cfr. ancheD. Nuzzo in questi stessi Atti.
45 Strab. 12, 540; anche Dioscurides Mat. medica, 5, 96; Teo-phr. de lapid., 52.
46 Pl. N.h., 35, 31. 47 Plut. de defec. orac., 47, 436 C.; Pl. N.h., 35, 36 e 50; Veg.
Mulomed., 1, 44; 2,16; 2,79; 3,10 e 28-29.48 Cfr. anche Strab. 3, 144.49 In proposito anche Celso, 5,6,1; 19,21.
50 Cfr. Magie 1950, I, 184, II, 1077, nota 22, ivi è raccolta ladocumentazione antica e indicazioni bibliografiche.
51 In generale sottolinea che i rapporti tra la Puglia e il Me-diterraneo orientale perduravano nel tardo impero Volpe 1996,334-335.
52 Cfr. Volpe, De Felice, Turchiano 2005, 278-283; Volpe2006, 320-329; di recente Volpe et alii 2008, ivi ulteriore bi-bliografia.
53 Ringrazio per la cortese disponibilità la dott. Renata Ca-ligiuri, direttrice del Museo Civico ‘F. S. Majellaro’ di Bisce-glie.
67
Le civitates dell’Apulia et Calabria: aspetti della documentazione epigrafica tardoantica
STAIM 2 · Paesaggi e insediamenti urbani in Italia meridionale fra tardoantico e altomedioevo · © 2010 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
Canusium 54. Suggerivano questa valutazione sia l’ubi-cazione della casa, che la circostanza che due di que-ste iscrizioni sono assegnabili senz’altro al centroapulo: ERC I,45, già segnalata nella cattedrale di Tranied edita in CIL IX 6180-6181, con menzione dellatribù Oufentina, ed ERC I,163, che attesta un gentili-zio estremamente raro (Mutronius), già documentato aCanusium.
La lastra in questione, in marmo, è rotta superior-mente, con un taglio leggermente obliquo, e sul latosinistro; il retro è liscio (misure: alt. da cm 28 a 29,3;largh. da cm 46 a 59,5; spess. da cm 2,6 a 3,1; lettere:da cm 7,6 a 9 [L] ) (fig. 2). I caratteri, iscritti con trattoondeggiante ed evidenti apici irregolari, orientano peril tardo impero, nondimeno sono accurati e regolari;visibili tracce della linea di guida inferiore. Autopsia:aprile 2009.
La parte rimasta preserva una formula datante, conmenzione non di una coppia consolare, ma di un unicoconsole, edita in ERC I come segue:
- - - - - -[- - - Se]cundo consule.
La prima parola è interpretabile sia come cognome,Secundus, sia come forma avverbiale per indicare l’ite-razione del consolato, utilizzata accanto ad altre forme(bis, iterum, II) nell’epigrafia tardo romana 55. L’indi-cazione di un unico console è fenomeno attestatomolto sporadicamente nel IV secolo, più frequente nelV secolo, non attribuibile a motivazioni generalizzabiliprima del V secolo avanzato 56. Poiché nessun consolecon cognome Secundus compare nei Fasti tra IV eprimi decenni del V secolo 57, è opportuno piuttostovalutare i pochi personaggi che ottennero un secondoconsolato ordinario, menzionati senza collega. Nel-l’elenco consolare si individuano due sole possibilità:
l’usurpatore Magnus Maximus (PLRE I, Maximus 39),console per la seconda volta nel 388, fino all’agostodi quell’anno (fu infatti sconfitto e poi ucciso il 28agosto; il suo consolato non fu riconosciuto inOriente) 58 e Stilicone (PLRE I, Flavius Stilicho), con-sole per la seconda volta nel 405, il quale sembra nonaver riconosciuto Anthemius, il console della parteorientale, nella prima parte dell’anno 59. La documen-tazione epigrafica del secondo consolato di MagnoMassimo è costituita da 11 iscrizioni funerarie cri-stiane (10 urbane ed una proveniente da Milano), cuisi aggiungono alcuni casi dubbi 60: in nessuna di que-ste l’iterazione del consolato, quando ricordata, si pre-senta nella forma secundo. La documentazione delsecondo consolato di Stilicone in Italia si sostanzia di17 iscrizioni funerarie, cristiane: 15 urbane, una pro-veniente da Verulae, iscritta sul lato opposto della la-stra che registra i Fasti Verulani (AE 1924, 100, cf.Inscr.It. 13, 2, 22), un’altra, in greco, da Firenze (SEGXIX 630): la forma avverbiale secundo è presente in 6casi 61. A parte la presenza di questa espressione esclu-sivamente nella documentazione riferibile a Stilicone,l’elemento che mi pare determinante per attribuirequesta datazione al generale è la tipologia dell’epi-
54 Cfr. Colafemmina 1976, che compie una verifica dei ma-teriali brindisini; V. Morizio in ERC II, 191.
55 Qualche esempio in ILS, Indices, 341: nn. 8992 (a. 417),801 (a. 420).
56 Cfr. Bagnall, Cameron, Schwartz, Worp 1987, 64-65.57 Cfr. la rassegna piuttosto recente dei consoli del tardo im-
pero, curata da Bagnall, Cameron, Schwartz, Worp 1987, in par-ticolare 2-4, per l’irrilevanza del consolato suffetto nel tardoimpero: un L. Turcius Secundus ricoprì il consolato suffetto trafine III e inizi IV sec.: PLRE I, Secundus 5.
58 Nel 388 Teodosio proclamò consoli sé stesso per la se-
conda volta e Cynegius, cfr. Bagnall, Cameron, Schwartz, Worp1987, 310-311 e 25.
59 Tuttavia Anthemius fu riconosciuto successivamente,come mostra ICUR, n.s., II, 4170 del 23 luglio, con datazionecostituita da entrambi i consoli, cfr. Bagnall, Cameron,Schwartz, Worp 1987, 344-345 e 25.
60 Cfr. Bagnall, Cameron, Schwartz, Worp 1987, 310 e 654.61 La documentazione è raccolta Bagnall, Cameron,
Schwartz, Worp 1987, 344 e 664-665: la forma secundo com-pare in ICUR n.s. I, 1463 = ILCV 693; ICUR n.s. I, 2813 = ILCV2607; ICUR n.s. VII, 17534 = ILCV 4146 F adn.; ICUR n.s.VII, 17535 = ILCV 2128; ICUR n.s. VII, 19981; AE 1924, 100.
68
Marina Silvestrini
2. - Canosa, datazione consolare.
STAIM 2 · Paesaggi e insediamenti urbani in Italia meridionale fra tardoantico e altomedioevo · © 2010 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
grafe, verosimilmente un’iscrizione pubblica (vd.oltre): sarebbe ben singolare che il nome e il conso-lato dell’usurpatore Massimo non fosse stato erasodopo la sua sconfitta, ammesso che fosse stato inciso.
Consideriamo quindi la tipologia: si deve immagi-nare che la lastra avesse una larghezza più che doppiarispetto a quella attuale, superava i 120 cm. Notoria-mente la datazione consolare è frequentissima nel-l’epigrafia sepolcrale cristiana, alla quale tuttaviaquesta epigrafe mi pare difficilmente accostabile per lastessa enfasi posta nella datazione; nel tardo impero ilnome dei consoli è talvolta presente anche su basi ono-rarie e in epigrafi che commemorano l’edificazione oil restauro di edifici pubblici 62.
C’è un altro elemento di cui tener conto: questaepigrafe non è isolata nel panorama epigrafico di Ca-nosa tra fine IV e primi decenni del V sec.; infatti siconserva un’iscrizione in onore del governatore (con-sularis) Cassius Ruferius, posta dall’ordo di Canosapro meritis et dispositione qua civitatem omni exparte renobabit (AE 1957, 43 = ERC I, 26); è stataproposta l’identificazione del consularis con il Rufe-rius, noto da una lettera di Agostino (Ep., 127, 1), dipoco successiva al 410 63. Peraltro il primo decenniodel V secolo viene considerato il termine post quemper datare l’epigrafe di Cassius Ruferius sulla basedel titolo di consularis, poiché la Notitia dignitatum,i cui aggiornamenti per gli aspetti amministrativi siritiene fossero cessati nel primo decennio del V se-colo, ricorda ancora il titolo di corrector per il gover-natore dell’Apulia et Calabria 64. Nonostante l’enfasipropria dell’epigrafia tardo romana non è dubbio chedurante il governo di Cassius Ruferius più interventiabbiano interessato gli edifici di Canosa: in questa cor-nice può bene inquadrarsi l’epigrafe di cui ci stiamooccupando, possibile testimonianza di una di questeopere di rifacimento o di restauro. Se l’ipotesi coglienel segno avremmo anche la possibilità di circoscri-vere ulteriormente il periodo di governo del consula-ris, Cassius Ruferius, agli anni contigui al 405.
In conclusione è possibile proporre la seguente edi-zione dell’epigrafe 65:
- - - - -[Fl. Stilicone v. c. se]cundo consule.
3.3. Esaminiamo ora la seconda iscrizione, sopramenzionata, già edita in ERC I, al n. 228. Anche inquesto caso si tratta di una lastra frammentaria, inmarmo, di cui si conserva integro solo il margine su-periore (misure: alt. mass. cm 21,6; largh. mass. cm12,8; spess. cm 3; lettere: l.1.: cm 5; l. 2: cm 2,2; l.3:cm 3) (fig. 3). L’epigrafe proviene da Canosa e preci-samente dall’area monumentale che ospitava il cosid-detto Tempio di Giove Toro di età antonina, area chesubì restauri e trasformazioni, di lettura non lineare,tra IV e VI secolo 66. L’iscrizione, già conservata nel
62 Cfr. per es. ILS 5696 (Ocricolum), anche 5699 (Lusita-nia); inoltre ILS 773 (Arabia), 775 (Pannonia). In generale perla natura della evidenza epigrafica tardo romana con datazioneconsolare cfr. Bagnall, Cameron, Schwartz, Worp 1987, 60-62,ove, oltre a ricordare la stragrande maggioranza di epigrafi fu-nerarie private, non si trascurano le epigrafi pagane votive e de-dicatorie e gli epitafi dei senatori e delle loro famiglie.
63 PLRE II, Ruferius 1; vd. anche nota successiva.64 Su questo aspetto cfr. Grelle 1986, 386 [= Id. 1993, 168-
169].65 Il titolo v. c., a partire dagli inizi del V sec., è considerato
elemento quasi indispensabile della formula datante, cfr. Ba-gnall, Cameron, Schwartz, Worp 1987, 63.
66 Cassano 1992, in particolare 745-747 e 757-758: dall’area
69
Le civitates dell’Apulia et Calabria: aspetti della documentazione epigrafica tardoantica
3. - Canosa, epigrafe frammentaria di pre-sumibile attribuzione a Costantino I.
STAIM 2 · Paesaggi e insediamenti urbani in Italia meridionale fra tardoantico e altomedioevo · © 2010 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
Museo Archeologico Nazionale di Gioia del Colle, at-tualmente è a Canosa, nel deposito di Palazzo Sinesi.Autopsia: maggio 2009. Vincenza Morizio, cui si devela prima edizione del testo, a proposito delle lettere nerilevava «l’andamento fortemente verticale che ne as-sottiglia la larghezza».
Questa l’edizione dell’epigrafe in ERC I:
[- - -] Const+[- - -][- - -]onio Silv. [- - -][- - -]n.aeus +[- - -][- - -]n.us [- - -]- - - - -
Nel commento V. Morizio suggeriva opportuna-mente la possibilità di leggere alla prima riga Constanso Constantinus, alla l. 2 il cognome Silvanus e alla l.3 il gentilizio, documentato a Canosa, Annaeus. Perquanto Constantinus, Constantius, Constans sianonomi attestati in età tardoantica, anche al di fuori dellacasa imperiale 67, la complessiva impostazione testualee grafica dell’epigrafe, con la differente altezza tra lariga 1 e quelle successive (la l. 1 ha un’altezza quasidoppia rispetto alle linee seguenti) e con il nome della2a riga al caso dativo (o ablativo) inducono a compiereun passo ulteriore e, anche tenendo conto della paleo-grafia e dell’area di rinvenimento, a riconoscere nellaprima riga il nome di un imperatore della seconda di-nastia flavia: in questo ambito la paleografia, pur conil suo margine di incertezza, orienta per Costantino I,peraltro già attestato in altre due iscrizioni pubblichelocali (3-4) 68. Poiché non è calcolabile la larghezzadella lastra ignoriamo se il nome di Costantino fosseseguito da quello dei Cesari, come nella base onoraria4, dove leggiamo: Salvis Ddd. nnn. /Constantino Aug./et filiis eius Caess. / etc.
La presenza di più figure in un testo epigrafico, conil presumibile nome dell’imperatore in apertura, ac-costa questa iscrizione allo schema delle epigrafi de-
dicatorie di edifici pubblici del tardo impero, nellequali compaiono più attori secondo lo schema effica-cemente definito da Chastagnol, ‘la piramide delle re-sponsabilità’ 69. Innanzitutto l’imperatore che moltoraramente interviene direttamente, ma per lo più è ri-cordato con formule ben auguranti del tipo Salvod(omino) n(ostro), oppure pro beatitudine temporumetc., segue poi generalmente il nome del curatore del-l’opera, introdotto dall’espressione curante o simili,nella forma dell’ablativo assoluto, che qui bene siadatta al gentilizio della l.2, terminante in -onio (vd.oltre). Talvolta l’opera viene realizzata a spese o conil contributo di notabili locali: questo potrebbe essereil caso dell’epigrafe in questione, infatti le ll.3-4 mo-strano un elenco di nomi al nominativo 70. Che si trattidi esponenti dell’élite canosina lo conferma il genti-lizio della l.3, ricostruibile con estrema probabilità in[An]naeus. Infatti non sono né numerosi, né molto co-muni i gentilizi terminanti in -naeus e due soli traquesti sono ulteriormente attestati in Apulia et Cala-bria: il raro Alsinaeus in un’epigrafe di Rubi, di etàrepubblicana, e Annaeus unicamente a Venosa e Ca-nosa 71. In questa città il gentilizio è documentato daun personaggio di notevole rilievo, un quinquennali-cius, T. Annaeus Rufus, dell’albo decurionale del 223d.C. (CIL IX, 338, II, 3 = ERC I, 54) e da un presu-mibile liberto, Q. Annaeus Caricus, dedicante di unepitafio per un grosso mercante di mantelli prodotti aCanosa (per L. Pontius Amemptus, negotians canusi-narius), epitafio databile preferibilmente alla secondametà del II sec. d.C. (AE 2001, 866 = AE 2003,360) 72. Invece le poche lettere restanti del gentiliziodella l. 4: [---]+ius (piuttosto che [---]n. us)non con-sentono integrazioni.
Torniamo ora al personaggio della l.2. Nella stra-grande maggioranza della documentazione di ambitoprovinciale, la figura che segue il nome dell’impera-tore, figura cui spetta per lo più la cura dell’opera, è
provengono anche nove monete romane, quattro databili al IVsec. e tre di età bizantina; Volpe 1996, 106; Sabbatini 1998,158-162; Corrente 2005, 47-48.
67 Cfr. Kajanto 1965, 258; Solin 1977, 113.68 Un interessante confronto paleografico (stesse lettere al-
lungate) è offerto da un’altra epigrafe lacunosa in marmo, re-cuperata a Taranto e segnalata da Gasperini 1980b, 570, nota 1e Tav. I, come probabile epigrafe “costantiniana”.
69 Chastagnol 1988, 60-64.
70 Cfr. per es. ILS 699 (Ravenna), 5771 (Numidia). 71 Per i nomina terminanti in -naeus cfr. Solin, Salomies
19942, 222. Alsinaeus è in Suppl.It., 5 (1989), 19-20, n. 1, da-tabile alla metà del I a.C. Annaeus è attestato a Venosa nei Fastivenosini (Inscr.It., XIII, 1, 255) da un L. Annaeus aed(ilis) (30a.C.) e da un C. Annaeus IIvir (32 a.C.), cfr. anche Anea Rufinain Suppl.It. 20 (2003), n. 62 (II d.C.).
72 L’epigrafe è edita da Silvestrini in Grelle, Silvestrini 2001,113-120.
70
Marina Silvestrini
STAIM 2 · Paesaggi e insediamenti urbani in Italia meridionale fra tardoantico e altomedioevo · © 2010 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
quella del governatore provinciale; tuttavia in qualchecaso può anche trattarsi di figure diverse, comunquedi rango elevato: cfr. per es. ILS 5570 (Africa procon-sularis): …curante Ceionio Aproniano c.v. / patronocivitatis. L’onomastica superstite non offre indizi si-gnificativi: si può ricordare che i nomi noti dei cor-rectores della provincia Apulia et Calabria, nell’età diCostantino, non si adattano alle lettere superstiti, maanche che ignoriamo chi abbia governato la provinciain particolare nel primo periodo del suo impero, tantopiù che Vibonius? Caecilianus viene ora persuasiva-mente datato al 309 73, e considerato che il governo diL. Nonius Verus si colloca tra il 317 e il 324 e quellodi Volusius Venustus tra il 326 e il 333 (Aurelius Con-sius Quartus viene inserito grosso modo nello stessoperiodo di Nonio Vero) 74.
Il ventaglio di gentilizi desinenti in -onius è estre-mamente largo, il cognome sarà stato preferibilmenteSilvanus o Silvinus 75: si possono ricordare i nominaattestati a Canosa (Antonii, Critonii, Petronii, Sem-pronii), tra i quali gli Antonii appaiono la famiglia dimaggior interesse per la posizione di prestigio che oc-cupano nell’albo decurionale del 223 e per la figura diM. Antonius Vitellianus, esponente dell’ordine eque-
stre, patronus coloniae, che fu, intorno al 250, prae-positus tractus Apuliae, Calabriae, Lucaniae, Bruttio-rum 76. Inoltre da un’epigrafe, databile al III sec. (ERCI, 136), ricaviamo un legame matrimoniale tra Antoniie Flavii, altra famiglia di grande prestigio nell’albo de-curionale, uno dei cui giovani esponenti, un praete-xtatus, porta il cognome Silvinus 77. Comunque glielementi disponibili non mi pare consentano un in-quadramento univoco del personaggio ricordato allal.2, si può solo soggiungere che la posizione da lui oc-cupata nell’impaginazione epigrafica, subito dopol’imperatore e ad una certa distanza dai presumibilicuriali, è un sicuro indizio del suo rango elevato.
Se la ricostruzione è corretta, l’epigrafe, pur nellasua lacunosità, costituisce una significativa testimo-nianza di un intervento di ristrutturazione pubblica nel-l’area monumentale di Giove Toro, nell’età diCostantino.
Ne ripropongo il testo:
[Salvo D. n.?] Consta[ntino Aug. - - - ?] [curante? —-]o.nio Silv. [- - -][- - - An]n.aeus +[- - -][- - -]+ius [- - -]- - - - -
73 Porena 2006, in particolare 138.74 Cfr. Cecconi 1994, 218, con gli aggiornamenti di Men-
nella 1994, 171 e Cecconi 1998, 178.75 Per il gentilizio cfr. Solin, Salomies 19942, 254-259.76 CIL IX, 334 = ILS 2768 = ERC I, 27+ ERC II, 27 A,
anche Silvestrini 1999a, 161-162. La posizione sociale degliAntonii di Canosa, come delineata in ERC I, 54, necessita dialcune correzioni: infatti, sulla base di AE 1998, 279 (Castel-porziano), non si deve più attribuire a Canusium, bensì al La-tium vetus, l’origo degli Antonii di rango senatorio,documentati nell’albo decurionale in qualità di patroni cc. vv.
(CIL IX, 338, I, 7 e 23 = ERC I, 35, 48 e 54); nondimeno ilruolo di quinquennalis ricoperto da M. Antonius Priscus nel223 (l’anno della redazione dell’albo), insieme con quello diaedilis, rivestito da M. Antonius Vindex nello stesso anno,fanno degli Antonii canosini una famiglia di notevole presti-gio locale nel primo quarto del III sec., prestigio che si man-tiene inalterato nella generazione successiva, come mostra ilM. Antonius Vitellianus, sopra citato.
77 CIL IX, 338, IV, 40 = ERC I, p. 57; sui Flavii nell’albo de-curionale e sui rapporti tra Antonii e Flavii cfr. Chelotti in ERCI, anche pp. 62-63.
71
Le civitates dell’Apulia et Calabria: aspetti della documentazione epigrafica tardoantica
Vengono indicate le seguenti edizioni: AE, CIL IX, ICI,Suppl.It, per Canusium ERC I-II, altre edizioni, prece-denti e successive, sono ricordate qualora giudicate si-gnificative; non viene registrato l’instrumentum (perulteriore bibliografia vd. Silvestrini 2005).
Canusium. Epigr. pubbliche: P. 1. AE 1945, 82; ERC I,5 + ERC II, 5A. P. 2. Giardina, Grelle 1983 (AE 1984,
250); ERC I, 11; Ruggeri 2003. P. 3. CIL IX, 317; ERCI, 15. P. 4. CIL IX, 329; ERC I, 16; AE 1999, 511b. P. 5.AE 1945, 84; ERC I, 17. P. 6. CIL IX, 318 ; ERC I, 18.P. 7. CIL IX, 333 = ERC I, 25; P. 8. AE 1957, 43 = ERCI, 26. P. 9. ERC I, 228; sopra, n. 3.3. P. 10. ERC I, 230;sopra, n 3.2; P. 11. ERC I, 5 + ERC II 5A (?). P. 12. ERCII, Add. 17 (?). Epigr. funerarie e frammenti: F.1. ERCI, 147 (AE 1987, 280). F. 2. ERC I, 238. F. 3. ERC I, 205
APPENDICEDocumentazione epigrafica
STAIM 2 · Paesaggi e insediamenti urbani in Italia meridionale fra tardoantico e altomedioevo · © 2010 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
+ ERC II, 205 A. F. 4. Sopra, n. 3.1. Epigr. cristiane 78:Cr. 1. CIL IX 410 e add. 659; Panciera 1974, n. 2, 157(AE 1981, 252); ERC I, 69. Cr. 2. CIL IX, 6192; Pan-ciera 1974, n. 1, 154-156 (AE 1981, 251); ERC I, 103.Cr. 3. Carletti 1981 [Id. 1984] (AE 1981, 256); ERC I,144 e ERC II, 144 A. Cr. 4. CIL IX, 413 e add. 659; Pan-ciera 1974, n. 5, 162-163 (AE 1981, 255); ERC I, 149.Cr. 5. CIL IX, 412; Panciera 1974, n. 4, 160-162 (AE1981, 254); ERC I, 166 a. Cr. 6. CIL IX, 412; Panciera1974, n. 4, 160-162 (AE 1981, 254); ERC I, 166 b. Cr. 7.CIL IX, 168; Panciera 1974, n. 3, 159-160 (AE 1981,253); ERC I, 168; Cr. 8. ERC I, 231. Cr. 9. AE 1993,526. Cr. 10. AE 1993, 527 a-d, cfr. Nuzzo 2002, 115-116e SEG XLIII (1993) 644. Cr. 11. Nuzzo, Rocco in Volpeet alii 2002, 146-152 e fig. 9 (AE 2002, 368). Cr. 12.Nuzzo in Volpe et alii 2003, 132 (VII sec.). Cr. 13. Nuzzoin Volpe et alii 2003, 131; Silvestrini 2005, 196-198, n.2. Cr. 14-15. Silvestrini 2005, 199, n. 5, 6. Cr. 16. Nuzzoin Carletti, De Santis, Nuzzo 2006-2007, 258-259 e fig.34. Cr. 17. Nuzzo in Carletti, De Santis, Nuzzo 2006-2007, 259 e fig. 35. Cr. 18. Nuzzo in Carletti, De Santis,Nuzzo 2006-2007, 263 e fig. 39. Cr. 19. Nuzzo in Car-letti, De Santis, Nuzzo 2006-2007, 226 e fig. 11; Polito2009. Cr. 20. Nuzzo in Carletti, Nuzzo 2007, 220-221 efig. 14. Cr. 21. Manganelli 2009, p. 175, fig. 87 (kore di-pinta). Miliari: M. 1. ERC I, 249. M. 2. ERC I, 250. M.3. ERC I, 257 b. M. 4. ERC I 262 a. M. 5. ERC I, 262 b.M. 6. ERC I, 272 b. M. 7-10. ERC I, 276- 279a. M. 11-12. ERC I, 280 -281.
Aeclanum. Per l’estensione del territorio di Aeclanumseguo l’ipotesi prospettata, sulla base di studi recenti, daEvangelisti 2002/2003, con esclusione, da una parte, del-l’area più orientale del territorio, la zona di Trevicum, dal-l’altra, dell’area di Gesualdo e Frigento. Epigr.pubbliche: P. 1-4. CIL IX, 1114-1117; P. 5-6. CIL IX,1119, 1127; P. 7. CIL IX, 1128; Caruso 2005; Epigr. vo-tive, funer., framm.: F. 1. CIL IX, 1093; Evangelisti2002/2003, n. 3 (III-IV sec.); F. 2. CIL IX, 1199; Evan-gelisti 2002/2003, n. 141; F. 3. CIL IX, 1213; Evangeli-sti 2002/2003, n. 158 (III-IV sec.); F. 4. CIL IX, 1253;Evangelisti 2002/2003, n. 226 (III-IV sec.). Epigr. cri-stiane: Cr. 1-48. CIL IX, 1073; 1080-1083; 1362-1400(44 numeri); Felle 1993, nn. 29-86 (57 numeri): l’A.,oltre a ripubblicare le epigrafi già in CIL, include anchequelle recuperate nell’area di Frigento, inoltre i nn. 57 e
75 e alcuni esemplari di instrumentum; Evangelisti2002/2003, nn. 359-405 (47 numeri); Lambert 2005, 293-295, prospetta una nuova edizione, corredata di fotogra-fie di CIL IX, 1396 = Felle 1993, n. 62, di CIL IX, 1377= Felle 1993, n. 45, di Felle 1993, n. 57; inoltre pubblicadue epigrafi inedite, nn. 4-5, alle pp. 302-305 (AE 2005,424-425). L’epigrafe n. 4 è presente anche nella Tesi diEvangelisti 2002/2003, n. 396. Miliari: M. 1. CIL IX,6071.
Tarentum. Epigr. pubbliche: P. 1. AE 1896, 112; ILS5700, cf. Gasperini 1980b, 570-572; P. 2. Gasperini1971, 171, A 10, cf. Gasperini 1980b, 569, fig. 1: proba-bile dedica a Diocleziano. P. 3. Gasperini 1971, 171, A 9(?). P. 4. Gasperini 1971, A 11; Lippolis 1984, 138-139,n. 4; P. 5. Gasperini 1980b, 570, nota 1 e Tav. I. Epigr.ebraiche: Ebr. 1-21: JIWE, nn. 118-133, 193, nuova-mente proposte da Colafemmina 2005, nn. 3-23 (i nn. 8,21-23 non compaiono in JIWE): si datano al IV-V sec. inn. 3-4, tra VII e IX i nn. 5-23.
Venusia. Epigr. pubbliche: P. 1. CIL IX, 120*; Silve-strini 1992-93, 130-135 (AE 1995, 347); Suppl.It. 20(2003), 123, n. 6; Porena 2006. P. 2. CIL IX, 127*; Sil-vestrini 1992-93, 130-134 (AE 1995, 346); Suppl.It. 20(2003), 126-127, n. 10. P. 3. CIL IX, 430 e Suppl.It. 20(2003), 57; P. 4. Silvestrini 1992-93, 119-130 (AE 1995,348); Suppl.It. 20 (2003), 123-125, n. 7; Epigr. funera-rie e framm.: F. 1. Suppl.It. 20 (2003), 184-185, n. 86.Epigr. cristiane: Cr. 1-6. Suppl.It. 20 (2003), 298-302,nn. 276-281. Epigr. ebraiche: Ebr. 1-77: JIWE, nn. 42-116; per ulteriori edizioni e qualche aggiornamento Sil-vestrini 2005, 55-56 e 60. Miliari. M. 1-5. CIL IX,6062-6066 e SupplIt., 20, (2003) 105; M. 6. Torelli M.R.1995, 294-296 (AE 1995, 352) = Suppl.It., 20 (2003),122, n. 5.
Luceria. Epigr. pubbliche: P. 1. CIL IX, 791a; P. 2. CILIX, 801; P. 3. Russi 1987 (AE 1988, 387); P. 4. Parma2006 79. Epigr. funerarie 80: F. 1. AE 1969/70, 159; F. 2.AE 1983, 246. Epigr. cristiane: Cr. 1. CIL IX, 933; Car-letti 1983, 433-434. Cr. 2. Carletti 1976, 139, n. 1 (AE1981, 241); Cr. 3. Carletti 1976, 139-140, n. 2 (AE 1981,242); Cr. 4. Carletti 1976, 140-141, n. 3 (AE 1981, 243);Cr. 5. Balice 1980, 34 (AE 1983, 259). Cr. 6-7. Carletti1983, 428-433 (AE 1984, 252-253).
78 Gli scavi recenti di due importanti aree paleocristiane diCanosa (S. Pietro e l’area cimiteriale del Ponte della Lama)hanno pressoché raddoppiato il patrimonio di epigrafi cristianedel centro, vd. oltre, Cr. 10 e seguenti, per i riferimenti essen-ziali.
79 Per quanto recuperata nel territorio di Larinum, nell’ot-tica di questo contributo appare opportuno inserire tra le epi-
grafi pubbliche lucerine anche la tabula patronatus, concessadall’ordo decurionale di Luceria nel 327 d.C., di recente nuo-vamente edita da Parma.
80 Le due epigrafi di seguito citate attestano lo stanziamentodi Cimbri nel territorio lucerino in età postcostantiniana, cfr.Volpe 1996, 253, con precedente bibliografia.
72
Marina Silvestrini
STAIM 2 · Paesaggi e insediamenti urbani in Italia meridionale fra tardoantico e altomedioevo · © 2010 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
Compsa. Epigr. pubbliche: P. 1. Pescatori 2005, 292-295 (AE 2005, 421).
Barium. Epigr. pubbliche: P. 1. CIL IX, 282 e Suppl.It8 (1991), 32. Epigr. cristiane. Cr. 1. CIL IX, 306 eSuppl.It 8 (1991), 33. Cr. 2. Bertelli 1981, 393-421; Ead.1994, 43-63; Fioretti 2000 (AE 2000, 358); Cr. 3. Zorzi2007. Cr. 4. Epigrafe inedita 81. Epigr. ebraiche: Ebr. 1.JIWE nn. 135-136 (VI-VII sec.); 194 (IX sec.).
Egnatia. Epigr. pubbliche: P. 1. CIL IX, 261 e 657; CILXVI, 156 e Suppl.It 11 (1993), 26; Epigr. funerarie.Suppl.It 11 (1993), 50, n. 38 82.
Ausculum. Epigr. pubbliche: P. 1. CIL IX, 661.
Herdonia. Epigr. pubbliche: P. 1. CIL IX, 687; OrdonaII, n. 8 (AE 1967, 91); Silvestrini 1999a, 83-84.
Genusia. Epigr. pubbliche: P. 1. CIL IX, 259.
Neretum. Epigr. pubbliche: P. 1. CIL IX, 10 = ILS6113 83.
Brundisium. Epigr. funer.: F.1-2. Due epigrafi inedite 84.Epigr. cristiane: Cr. 1. CIL IX, 6150. Miliari: M. 1. CILIX, 6076 85; M. 2. CIL IX, 6077; M. 3. AE 1978, 252;AE 1980, 303; AE 1983, 274.
Metapontum.Miliari. M. 1. Giardino 1982 (= AE 1983,290); M. 2. Giardino 1991, 844-845.
Lupiae. Miliari. M. 1. Susini 1962, 169, n. 135 86.
Salapia. Miliari. M. 1. Silvestrini 1983, 107-110, n. 21,cf. ERC I, 252, nota 8.
Aecae. Epigr. funer.: F. 1. CIL IX, 952 = CLE 1340 =ILCV 458.
Sipontum. Epigr. cristiana 87: Cr. 1. Serricchio 1978,81-82, n. 15 (AE 2004, 432).Uria. Epigr. ebraiche: Ebr. 1. JIWE 137 (V-VII sec.);Ebr. 2. CIL IX, 6151 = JIWE 195 (VIII sec.).
Hydruntum. Epigr. ebraiche: Ebr. 1. JIWE 134 (III-IVsec.).Alvisi G. 1970, La viabilità romana della Daunia, Bari.
81 Un’epigrafe cristiana è stata rinvenuta nell’ottobre del2008, a Bari, in piazza s. Pietro, nel corso degli scavi archeo-logici, condotti dalla Soprintendenza per i Beni Archeologicidella Puglia, con la direzione della dott. A. Riccardi. Notiziacomunicatami dal dott. Fabio Galenadro, che ringrazio.
82 L’espressione p(lus) m(inus) presente in questa epigrafeconsente di datarla al IV sec. d.C.
83 Cfr. inoltre Susini 1962, n. 23; Marangio 2002.84 Nel Museo Archeologico Provinciale di Brindisi si con-
servano due epigrafi (una con inv. 1829 e l’altra senza inv.) dicronologia tarda, non escluderei una datazione successiva al VIsec.
85 Questa colonna, a Mesagne irreperibile, potrebbe essereidentificata con una colonna miliare conservata, senza inv., nelMuseo Provinciale di Brindisi, anche alla luce dell’informa-zione di C. Pagliara (Pagliara 1967, 157), secondo cui una co-lonna miliare da Mesagne era stata trasferita a Brindisi, nelgiardino della casa del Sig. G. Cavalieri, in via Mameli 1. Rin-grazio per queste informazioni B. De Nicolò.
86 In Silvestrini 2005, 154, ulteriore, precedente bibliogra-fia.
87 Cfr. anche Silvestrini 2005, 35, e nota 11.
73
Le civitates dell’Apulia et Calabria: aspetti della documentazione epigrafica tardoantica
Bibliografia
Alföldy G. 1984, Römische Statuen in Venetia et Histria.Epigraphische Quellen, Heidelberg.
Bagnall R.S., Cameron A., Schwartz S.R., Worp K.A.1987, Consuls of the Later Roman Empire, Atlanta.
Balice M. 1980, Note di epigrafia, in appendice all’opu-scolo di V.A. Sirago, Lucera romana, Lucera, 23-34.
Balice M. 1981, Iscrizioni latine di Lucera, ArchStor-Pugl, 34, 3-39.
Banzi E. 1999, I miliari come fonte topografica e storica.L’esempio della XI regio (traspadana) e delle AlpesCottiae, Roma.
Basso P. 1987, I miliari della Venetia romana, Padova. Basso P. 1990, La devota Venetia: i miliari a servizio
dell’imperatore, in La Venetia nell’area padano-danubiana. Le vie di comunicazione, Padova, 129-136.
Belli D’Elia P., Pellegrino E. (eds.) 2009, Le radici dellacattedrale. Lo studio e il restauro del succorpo nelcontesto della fabbrica della cattedrale di Bari, Bari.
Bertelli G. 1981, Per una storia di Bari paleocristiana:note sul mosaico sotterraneo della cattedrale, Vete-raChr, 18, 393-421 [poi in Puglia paleocristiana e al-tomedievale, IV, Bari 1984, 139-167].
Bertelli G. 1994, S. Maria que est episcopio. La catte-drale di Bari dalle origini al 1034, Bari.
Buonopane A. 2003, Abusi epigrafici tardo-antichi: i mi-
STAIM 2 · Paesaggi e insediamenti urbani in Italia meridionale fra tardoantico e altomedioevo · © 2010 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
liari dell’Italia settentrionale (regiones X e XI), inAngeli Bertinelli M.G., Donati A. (eds.), Serta anti-qua et mediaevalia, VI, Usi e abusi epigrafici, Roma,343-354.
Buonopane A. 2009, I miliari della Lucania: puntualiz-zazioni e nuovi dati, c.s.
Camodeca G. 1978, Per la redazione dei Fasti delle pro-vince italiche: Fl. Romulus, consularis Flaminiae etPiceni nel 352(-3), ZPE, 28, 151-158.
Camodeca G. 1982, Ascesa al senato e rapporti con i ter-ritori d’origine. Italia: Regio I (Campania, esclusa lazona di Capua e Cales), II (Apulia et Calabria), III(Lucania et Bruttii), in Epigrafia e Ordine senatorio,II, Roma, 101-163.
Carletti C. 1976, Nuove iscrizioni paleocristiane di Lu-cera, VeteraChr, 13, 137-148 [poi in Puglia paleo-cristiana, III, Bari 1979, 93-104].
Carletti C. 1981, Iscriziome metrica rubro picta da Ca-nosa, VeteraChr, 18, 1981, 173-187 [poi in Puglia pa-leocristiana e altomedievale, IV, Bari 1984, 123-137].
Carletti C. 1983, Lucera paleocristiana: la documenta-zione epigrafica, VeteraChr, 20, 427-441 [poi in Pu-glia paleocristiana e altomedievale, V, Bari 1990,1-15].
Carletti C. 2008, Epigrafia dei cristiani in Occidente dalIII al VI secolo. Ideologia e prassi, Bari.
Carletti C., De Santis P., Nuzzo D. 2006-2007, Il com-plesso cimiteriale di Ponte della Lama (Canosa):nuove acquisizioni dagli scavi delle catacombe e del-l’area subdiale, RendPontAc, 79, 205-290.
Carletti C., Nuzzo D. 2007, La terza età dell’epigrafianella provincia Apulia et Calabria. Prolegomena, Ve-teraChr, 44, 189-224.
Caruso F. 2005, Forme dell’evergetismo tardoantico: unpatrono di Eclano (CIL IX, 1128 = ILS 5506), inVolpe, Turchiano 2005, 477-486.
Cassano R. 1992, Il tempio di Giove Toro, in Cassano R.(ed.), Principi imperatori vescovi, Duemila anni distoria a Canosa, Venezia, 741-758.
Cecconi G.A. 1994, Governo imperiale e élites dirigentinell’Italia tardoantica. Problemi di storia politica-amministrativa (270-476 d.C.), Como.
Cecconi G. A. 1998, I governatori delle province itali-che, AntTard, 6, 149-179.
Chastagnol A. 1963, L’administration du diocèse italienau Bas-Empire, Historia, 12, 348-379.
Chastagnol A. 1988, Le formulaire de l’épigraphie latineofficielle dans l’antiquité tardive, in Donati A. (ed.),La terza età dell’epigrafia, Faenza, 11-64.
Christol M. 1999, L’épigraphie latine impériale des Sé-vères au début du IVe siècle ap. J.-C., in Atti dell’XICongresso Internazionale di Epigrafia Greca e La-tina,2 voll., Roma, II, 333-357.
CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum.CLE = Carmina Latina Epigraphica, conlegit F. Büche-
ler, Lipsiae, I, 1895; II, 1897; III, Supplementum, cur.E. Lommatzsch, 1926.
Colafemmina C. 1976, Iscrizione romane di Brindisi aTrani, in Scritti di storia e di arte pugliesi in onoredell’arcivescovo mons. Giuseppe Carata, Fasano, 75-80.
Colafemmina C. 2005, Gli Ebrei a Taranto. Fonti docu-mentarie, Bari.
Colafrancesco P., Massaro M. 1986, con la collabora-zione di Ricci M.L., Concordanze dei Carmina La-tina Epigraphica, Bari.
Corrente M. 2005, Il dio con la folgore. Percorsi e im-magini del sacro a Canusium, Catalogo della mostra18 maggio -18 ottobre 2005, Canosa.
Cracco Ruggini L. 1987, Storia totale di una piccolacittà: Vicenza romana, in Broglio A., Cracco RugginiL., Storia di Vicenza, I, Vicenza, 205-303.
D’Angela C. 1979, Frammenti musivi paleocristiani coniscrizioni votive da Lucera, VeteraChr, 16, 273-281[poi in Puglia paleocristiana e altomedievale, IV,Bari 1984, 67-81].
Donati A. 1974, I milliari delle regiones IV e V dell’Ita-lia, Epigraphica, 36, 152-222.
Eck W. 2004, Strassen und ihre Denkmäler, in FreiStolba R. (hrsg.), Siedlung und Verkehr in römischenReich: Römerstrassen zwischen Herrschaftssiche-rungs und Landschaftsprägung; Akten des Kollo-quiums zu Ehren von H.E. Herzig, Bern.
ERC I = Chelotti M., Gaeta R., Morizio V., Silvestrini M.(eds.), Le iscrizioni romane di Canosa, I, Bari 1985.
ERC II = Chelotti M., Morizio V., Silvestrini M. (eds.),Le iscrizioni romane di Canosa, II, Bari 1990.
Evangelisti S. 2002/2003, Aeclanum, Ricerche di proso-pografia e storia amministrativo-sociale, Tesi di dot-torato in Storia antica, Bari
Felle A. 1993, ICI, Regio II. Hirpini, Bari.Fioretti P. 2000, L’iscrizione musiva paleocristiana della
cattedrale di Bari: un’indagine paleografica, ScrCiv,24, 17-60.
Floris P. 2005, Le iscrizioni funerarie pagane di Karales,Cagliari.
Fornaro A. 2000, Riflessioni sul percorso della via Appiatra Benevento e Taranto, JAT, 10, 301-308.
Gasperini L. 1971, Il municipio tarentino. Ricerche epi-grafiche, in Terza miscellanea greca e romana,Roma, 143-209.
Gasperini L. 1980a, Il miliario delle Macchie S. Ginesio,in Miscellanea di studi classici in onore di EugenioManni, III, Roma, 1041-1053.
Gasperini L. 1980b, Taranto tardo-imperiale e la sua cri-stianizzazione, in Settima miscellanea greca e ro-mana, Roma, 565-580.
Giardina A., Grelle F. 1983, La tavola di Trinitapoli: unanuova costituzione di Valentiniano I, MEFRA, 95,248-303 [= Grelle 1993, 193-253].
Giardino L. 1982, Metaponto tardo-imperale e Turiostu:proposta di identificazione in margine ad un milia-rium di Giuliano l’Apostata, StAnt, 3, 1982, 155-173.
Giardino L. 1991, Grumentum e Metaponto. Due esempi
74
Marina Silvestrini
STAIM 2 · Paesaggi e insediamenti urbani in Italia meridionale fra tardoantico e altomedioevo · © 2010 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
di passaggio dal tardoantico all’Alto medioevo in Ba-silicata, MEFRM, 103, 827-858.
Giardino L. 1999, La fascia ionica della Basilicata in etàtardoantica. Continuità e trasformazioni, in L’Italiameridionale in età tardoantica, Atti del trentottesimoconvegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto, 343-360.
Grelle F. 1986, Canosa e la Daunia tardo antica, Vete-raChr, 23, 379-397 [= Id. 1993, 161-179].
Grelle F. 1989, Iudices e tribunalia nella documentazioneepigrafica della regio secunda, in Castillo C. (ed.),Novedades de Epigrafía Jurídica Romana, Pamplona,115-123[ = Id. 1993, 181-189].
Grelle F. 1993, Canosa romana, Roma.Grelle F. 1999, Ordinamento provinciale e organizza-
zione locale nell’Italia meridionale, in L’Italia meri-dionale in età tardo antica, Atti del trentottesimoconvegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto, 115-139.
Grelle F., Silvestrini M. 2001, Lane apule e tessuti cano-sini, in Epigrafia e territorio. Politica e società, VI,Bari, 91-136.
Grelle F., Volpe G. 1994, La geografia amministrativaed economica della Puglia tardoantica, in Carletti C.,Otranto G. (eds.), Culto e insediamenti micaelici nel-l’Italia meridionale fra Tarda Antichità e Medioevo,Bari, 15-81.
Herzig H.E. 1973, A propos de l’administration routièredans la Vénétie Regio X, in Il territorio veronese inetà romana, Verona, 87-95.
Herzig H.E. 1974, Probleme des römischen Strassenwe-sens: Untersuchungen zu Geschichte und Recht,ANRW, II, 1, Berlin-New York, 593-648.
ICI = Inscriptiones Christianae Italiae saeculo septimoantiquiores, Bari 1985 -
ICUR = Inscriptiones Christianae urbis Romae, n.s. I-X,Roma, 1922-1992.
ILCV = Diehl E., Inscriptiones Latinae Christianae Ve-teres, Berolini, I, 1925, II, 1926, III, 1931; Moreau J.,Marrou H.J., Supplemetum, Berolini 1967.
ILS = H. Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae, I-III,Berolini 1892-1916.
Inscr.It = Inscriptiones Italiae.Isaac B. 1990, The Limits of Empire, Oxford.JIWE = Noy D., Jewish Inscriptions of Western Europe,
I, Cambridge 1993.Kajanto I. 1965, The Latin Cognomina, Helsinki.Kienast D. 19962, Römische Kaisertabelle. Grundzüge
einer römischen Kaiserchronologie, Darmastadt.König I. 1973, Zur Dedikation römischer Meilensteine
Digesta 43, 7, 2; 50,10, 3, 4, Chiron, 3, 419-427.Lambert C. 2005, Di tre epigrafi paleocristiane eclanesi
ritrovate e di due recentemente scoperte, VeteraChr,42, 289-305.
Lewin A. 2001, Urban Public Building from Constantineto Julian: the Epigraphic Evidence, in Lavan L. (ed.),
Recent Research in Late-Antique Urbanism, Por-tsmouth, Rhode Island.
Lippolis E. 1984, Le Thermae Pentascinenses di Taranto,Taras, 4, 119-153.
Magie D. 1950, Roman Rule in Asia Minor, 2 voll., Prin-ceton.
Manganelli L. 2009, La necropoli di S. Leucio, in Pensa-bene P., D’Alessio A. (eds.), Da Minerva a San Leu-cio, parco archeologico e antiquario di San Leucio aCanosa, Canosa, 171-175.
Marangio C. 2002, CIL IX, 10 e il porto di Neretum, inL’Africa romana. Atti del XIV convegno di studi,Roma, 891-904.
Mennella G. 1994, in Chelotti M., Mennella G., Letturee riletture epigrafiche nella regio II, ZPE, 103, 159-172.
Mennella G. 2000, Un negotiator vestiarius Cisalpinus etTransalpinus a Fara Novarese, Epigraphica, 62, 125-135.
Nesselhauf H. 1937, Zu den Funden neuer Leugensteinein Obergermanien, Germania, 21, 173-175.
Nuzzo D. 2002, Epigrafia cristiana a Canosa: alcuneconsiderazioni, in Bertoldi Lenoci L. (ed.), San Sa-bino. Uomo di dialogo e di pace tra Oriente e Occi-dente, Trieste, 111-124.
Ordona II = van Wonterghem F., Les inscriptions dé-couvertes pendant les quatre premières campagnesde fouilles à Ordona (1962-1966), in Mertens J.(ed.), Ordona II, Bruxelles-Rome 1967, 127-154.
Paci G. 1984/86, Nuovi miliari dal Piceno romano, Attie memorie della Dep. di storia patria per le Marche,89-91, 495-514.
Pagliara C. 1967, Note di epigrafia salentina, Athe-naeum, 45, 154-157.
Panciera S. 1974, Note in margine alle iscrizioni paleo-cristiane di Canosa, VeteraChr, 11, 153-165 [poi inPuglia paleocristiana, III, Bari 1979, 255-267].
Parma A. 2006, Un nuovo decreto decurionale di Luce-ria del 327 d.C., in Silvestrini M., Spagnuolo VigoritaT., Volpe G. (eds.), Studi in onore di FrancescoGrelle, Bari, 201-214.
Pekáry T. 1968, Untersuchungen zu den römischen Rei-chstrassen, Bonn.
Pescatori G. 2005, Città e centri demici dell’Hirpinia:Abellinum, Aeclanum, Aequum Tutium, Compsa, inVitolo G. (ed.), Le città campane fra tarda Antichitàe alto Medioevo, Salerno, 283-311.
PLRE I = Jones A.H.M., Martindale J.R., Morris J. (eds.),The Prosopography of Later Roman Empire, I, A.D.260-395, Cambridge 1971; Martindale J.R. (ed.), TheProsopography of Later Roman Empire, II, A.D. 395-257, Cambridge 1992.
Polito V. 2009, Ricomporre una storia: l’iscrizione di-pinta di Ponte della Lama a Canosa, VeteraChr, 46,113-125.
Porena P. 2006, L’Italia prima di Ponte Milvio e la car-riera di Caecilianus, Epigraphica, 68, 117-154.
75
Le civitates dell’Apulia et Calabria: aspetti della documentazione epigrafica tardoantica
STAIM 2 · Paesaggi e insediamenti urbani in Italia meridionale fra tardoantico e altomedioevo · © 2010 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
Raepsaet- Charlier M.-Th. et G. 1988, Aspects de l’or-ganisation du commerce de la céramique sigilléedans le Nord de la Gaule aux IIe et IIIe siècle notreère. II Négociants et transporteurs. La géographiedes activités commerciales, MünstBeitr, VII, 2, 1988,45-69.
Ruggeri P. 2003, L’organizzazione paganica nel BassoImpero in Occidente: contributo per una riletturadella Tavola di Trinitapoli, in Cultus splendore. Studiin onore di Giovanna Sotgiu, Senorbì, 801-834.
Russi A. 1987, Una nuova iscrizione tardoantica da Lu-ceria, in Atti del 18° Convegno sulla storia del Cri-stianesimo in Puglia, Lucera.
Sabbatini G. 1998, Canusium, trasformazioni urbane inetà tardoantica e medievale, VeteraChr, 35, 157-175.
Salama P. 1987 = Salama, Bornes milliaires d’Afriqueproconsulaire. Un panorama historique du Bas Em-pire romain, Rome.
Serricchio C. 1978, Iscrizioni romane, paleocristiane emedievali di Siponto. Manfredonia.
Silvestrini M. 1983, Miliari della via Traiana, in Epi-grafia e territorio. Politica e società, Bari, 79-134.
Silvestrini M. 1990, I miliari della via Traiana, in ERCII, 208-212.
Silvestrini M. 1992-93, Venosa: una nuova epigrafe diCostantino e il recente recupero di un corrector Apu-liae et Calabriae, Scienze dell’antichità, Stor. Arch.Antropol., 6-7, 119-135.
Silvestrini M.1996, Epigraphica: testi inediti dall’agrodi Lucera e un nuovo miliario di Massenzio della viaHerculia, in Stella C., Valvo A. (eds.), Studi in onoredi Albino Garzetti, Brescia, 431-462.
Silvestrini M. 1999a, Un itinerario epigrafico lungo lavia Traiana, Bari.
Silvestrini M. 1999b, Intervento in L’Italia meridionalein età tardo antica, Atti del trentottesimo convegnodi studi sulla Magna Grecia, Taranto, 163-164.
Silvestrini M. 2005, Le città della Puglia romana. Unprofilo sociale, Bari.
Solin H. 1977, Die innere Chronologie des römischenCognomens, in Duval M.N. (ed.), L’Onomastique La-tine, Paris, 103-146.
Solin H. 20032, Die griechischen Personennamen inRom. Ein Namenbuch (CIL, Auctarium), Berlin- NewYork.
Solin H., Salomies O. 19942, Repertorium nominum gen-tilium et cognominum Latinorum Hildesheim-Zürich-New York.
Suppl.It. 5 (1989) = Chelotti M. (ed.), Supplementa Ita-lica, n.s. 5, Rubi, Roma, 11-26.
Suppl.It. 8 (1991) = Chelotti M. (ed.), Supplementa Ita-lica, n.s. 8, Barium, Roma, 25-44.
Suppl.It. 9 (1992) = Boffo L., Ambaglio D. (eds.), Sup-plementa Italica, n.s. 9, Regio XI, Transpadana, Ti-cinum-Laumellum et vicinia, Roma, 213-347.
Suppl.It. 11 (1993) = Chelotti M. (ed.), Supplementa Ita-lica, n.s. 11, Gnathia, Roma, 11-58.
Suppl.It. 20 (2003) = Chelotti M. (ed.), Supplementa Ita-lica, n.s. 20, Venusia, Roma.
Susini G. 1962, Fonti per la storia greca e romana delSalento, Bologna.
Torelli M.R. 1995, Iscrizioni latine inedite o malnote delMuseo provinciale di Potenza, ZPE, 106, 280-296.
Volpe G. 1996, Contadini, pastori e mercanti nell’Apu-lia tardoantica, Bari.
Volpe G. 2006, Stibadium e convivium in una villa tar-doantica (Faragola-Ascoli Satriano), in SilvestriniM., Spagnolo Vigorita T., Volpe G. (eds.), Studi inonore di Francesco Grelle, Bari, 319-349.
Volpe G., De Felice G., Turchiano M. 2005, Faragola(Ascoli Satriano). Una residenza aristocratica tardo-antica e un ‘villaggio’ altomedievale nella Valle delCarapelle: primi dati, in Volpe, Turchiano 2005, 265-297.
Volpe G., Turchiano M. (eds.) 2005, Paesaggi e insedia-menti rurali in Italia meridionale fra Tardoantico eAltomedioevo. Atti del primo Seminario sul Tardoan-tico e l’Altomedioevo in Italia meridionale (Foggia2004), Bari.
Volpe G. et alii 2002, Il complesso episcopale paleocri-stiano di san Pietro a Canosa, VeteraChr, 39, 133-190.
Volpe G. et alii 2003, Il complesso episcopale paleocri-stiano di san Pietro a Canosa. Seconda relazione pre-liminare (campagna di scavi 2002), AMediev, 30,107-164.
Volpe G. et alii 2008, La villa di Faragola (Ascoli Satriano)alla luce delle recenti indagini archeologiche, in Attidel 28° Convegno nazionale sulla Preistoria, Protosto-ria e Storia della Daunia, San Severo, 405-454.
Witschel C. 2002, Meilensteine als historische Quelle?Das Beispiel Aquileia, Chiron, 32, 325-393.
Zorzi N. 2007, L’epigrafe bizantina della «Trulla» dellaCattedrale di Bari, N≈a `Rèmh, 4, 37-61.
76
Marina Silvestrini