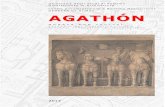CLAUDIO IMPIGLIA, L’Agro Portuense attraverso la pittura, la fotografia e la documentazione...
Transcript of CLAUDIO IMPIGLIA, L’Agro Portuense attraverso la pittura, la fotografia e la documentazione...
CIRICE 2014 - VI Convegno Internazionale di Studi
Città mediterranee in trasformazione. Identità e immagine del paesaggio urbano tra Sette e Novecento
L’Agro Portuense attraverso la pittura, la fotografia e la documentazione cinematografica: da paesaggio rurale archeologico a territorio “conurbato”
CLAUDIO IMPIGLIADipartimento di Storia, Disegno e Restauro dei Beni Architettonici, Università di Roma La Sapienza, Italia
AbstractThe Fiumicino coastal area interested by the construction of the airport, opened in 1961, is the most paradigmatic example of infrastructured countrysides, whose transformations are been analyzed by collecting photo-film material, among these the ARSIAL-Cinecittà Luce Project: «On the lands of the reformation. Light on the rural Italy» (2011). The Agro Portuense and the Trajan “Lake” near the Fiumicino coast were reclaimed during the first twenty years of twentieth century by the Prince Giovanni Torlonia (1873-1938), important landlord who undertook the agrarian and hydraulic transformations of his several properties. In this case the propaganda cine-newspapers documented the new and more modern landscape-configurations; however some picturesque lacustrine and archeological landscapes were just preserved by the engineers planning the new Portus on the strict indication of the same Giovanni, patron of the scenery painters well known as the “XXV della Campagna Romana”. The study of these plans can stimulate yet actions for protecting from the actual “conurbation” all those suggestive places that were painted and photographed by artists and archeologists.
Parole-chiave: Agro, Fiumicino, portuense, Sforza-Cesarini, Torlonia. Country, Fiumicino, port, Sforza-Cesarini, Torlonia.
IntroduzioneLa costruzione del modernissimo aeroporto di Fiumicino Toscani, Panunzi 1948, 5-27 , inaugurato nel 1961, ma in realtà già operativo in occasione delle grandi Olimpiadi di Roma del 1960, modificò in modo radicale gli equilibri del Litorale Romano che, da quel momento in poi, divenne esempio paradigmatico della infrastrutturazione delle campagne. L’Agro Portuense presso la zona fluviale di Fiumicino, con l’antico sito dei porti imperiali di Claudio e di Traiano, edificati tra il 42 a.C. ed il 112 d.C., fu quel territorio bonificato durante il primo ventennio del ‘900 dal Principe Giovanni Torlonia (1873-1938), impegnato nella trasformazione agraria e idraulica delle sue numerose tenute. I cinegiornali di propaganda documentarono con vigore i nuovi e più moderni assetti dei luoghi, tuttavia taluni pittoreschi paesaggi lacustri e archeologici furono accuratamente conservati dagli ingegneri progettisti della nuova Portus proprio su precisa indicazione dello stesso Torlonia, mecenate del gruppo di pittori paesaggisti chiamati i “XXV della Campagna Romana”. Lo studio di queste opere può essere ancora di stimolo per salvaguardare dall’attuale conurbazione almeno alcuni di quei suggestivi luoghi che furono fotografati a partire dal XIX secolo. Nel corso dei secoli alcuni archeologi hanno avuto un ruolo fondamentale nello studio dell’area Portuense, riuscendo a codificare nuovi modi di “guardare” al paesaggio: in tal senso è interessante confrontare l’opera di Luigi Canina (1795-1856) con quella di Thomas Ashby (1874-1931), studioso inglese profondamente affascinato dai paesaggi archeologici e naturalistici della Campagna Romana. In entrambi la predilezione per l’effetto del “Pittoresco” risultò alla fine complementare allo studio scientifico dei reperti antichi: se il primo riuscì a rappresentare nelle sue tavole di rilievo le suggestive qualità di un paesaggio “antichizzato” del quale si cercava di leggere l’antica configurazione, il secondo attraverso la fotografia riuscì a fissare alcune suggestive immagini di una campagna che stava per essere trasformata dalle opere di bonifica. Il seguente contributo è l’approfondimento di tematiche che sono state indagate nell’ambito della Tesi di Dottorato in Storia dell’Architettura presso l’Università di Roma La Sapienza, dal titolo: «Il Principe Giovanni Torlonia (1873-1938). Architetture, giardini e paesaggi nella tenuta di Porto a Fiumicino»: se lo studio di Tesi è incentrato sulla figura dell’”illuminato” committente in relazione alle sue tenute, con
L’Agro Portuense attraverso la pittura, la fotografia e la documentazione cinematografica
CLAUDIO IMPIGLIA
Fig. 1: Pianta del Corso del Tevere da Roma fino al Mare [G.B. Rasi, 1827].
particolare riguardo a quella Portuense, in questo contesto di studio si analizzano le diverse “rappresentazioni” del sito di Porto tra Ottocento e Novecento nella pittura, fotografia e cinematografia.
1. La tenuta Torlonia di Porto a Fiumicino
1.1 Le alterne “modernizzazioni” dell’Agro Portuense Nel vasto mosaico delle tenute che caratterizzavano l’Agro Romano Bortolotti 1988, 30-38 , l’area del Litorale Portuense (Fig. 1) Rasi 1827, 245-256 si evidenziava per essere un campione di territorio dalle qualità paesaggistiche straordinarie, un “avamposto” situato strategicamente sulla foce del Tevere e un affaccio privilegiato sul Mediterraneo. L’immagine attuale di questo territorio fluviale, compreso tra Roma ed la sua zona costiera, qui “rievocato” nella sua antica ed in parte scomparsa realtà di “Agro”, oggi si configura come un ideale “laboratorio” d’indagine nel quale sperimentare teorie legate allo studio della periferia contemporanea De Giorgi 2013, 16-73 . All’interno del settore sud-ovest di Roma, oggetto di recenti importanti seminari di studio1, si è scelto di analizzare il sito della tenuta di Porto, già Torlonia: un’area che, nonostante le dimensioni limitate, fu importantissima sin dall’antichità proprio per la vicinanza al delta del Tevere. Un luogo che, alternativamente, acquisì e perse nel corso del tempo importanti funzioni di centralità economiche: dopo i fasti riconducibili alla funzione di principale snodo portuale dell’Impero Romano2, nel successivo decadimento la città di Portus si ridusse nel corso dei secoli a “margine” paludoso, posto a “baluardo” difensivo di Roma. Il progressivo avanzamento della linea costiera e il connesso insabbiamento decontestualizzò il porto imperiale di Traiano (100-112 d.C.), la cui originaria forma esagonale difficilmente si identificava nel lago mefitico e acquitrinoso dal profilo mistilineo bordato da canneti (Fig. 2). A partire dalla seconda metà del XIX secolo iniziò una nuova fase per il sito: l’acquisto congiunto nel 1854, da parte di Alessandro Torlonia Felisini 2004, 188 , delle due tenute di Porto e Campo Salino, adiacenti il borgo di Fiumicino, costituì un’importante iniziativa destinata a segnare positivamente le fortune dell’importante famiglia romana. Il Torlonia intuì le potenzialità strategiche del sito nonostante
L’Agro Portuense attraverso la pittura, la fotografia e la documentazione cinematografica
CLAUDIO IMPIGLIA
Fig. 2: Pianta Topografica delle due tenute di Porto e Campo Salino eseguita nel 1831 al tempo della proprietà Pallavicini di Genova (per gentile concessione del Duca Ascanio Sforza Cesarini).
l’evidente insalubrità del paesaggio. Egli, contestualmente alle prime opere di bonifica Felisini 2004, 194-195 , promosse la trasformazione del casale preesistente, adiacente il “Lago” di Traiano, non ancora bonificato, in villa rappresentativa, prima anticipazione dell’immagine che questo luogo avrebbe assunto solo nel ventennio successivo. Con la proclamazione di Roma Capitale (1870) la zona fu di nuovo al centro di una serie di proposte che auspicavano la modernizzazione portuale e il miglioramento della navigabilità del Tevere Tomassetti 1975, 428-496; Setti 2009, 109-118 .
1.2 Il Principe Giovanni Torlonia (1873-1938) e la “rinascita” di Porto Si dovranno aspettare i primi decenni del XX secolo per registrare l’inizio di una nuova rinascita per l’area Portuense il cui riassetto paesaggistico costituirà uno dei principali meriti del nipote di Alessandro, il Principe Giovanni Giraldi 1985, XXIX-XXXI , figlio di Anna Maria Torlonia e di Giulio Borghese: le opere di bonifica attuate nel corso del primo trentennio del Novecento trasformarono la tenuta di Porto da luogo inospitale, nel passato utile baluardo naturale a protezione dell’Urbe Capitolina dalle frequenti incursioni piratesche, a produttiva “cittadella” rurale (Fig. 3), potenzialmente valorizzata dalle nuove prospettive commerciali della costa Laziale. Con l’avvento del Fascismo la famiglia Torlonia acquisì tra le grandi famiglie romane una posizione di spicco: grazie all’amicizia con Benito Mussolini (1883-1945), il quale a partire dal 1925 alloggiò nel Casino Nobile di Villa Torlonia sulla Nomentana a Roma, Giovanni fu favorito nei suoi piani di valorizzazione agraria delle sue tenute. Proprio durante il primo trentennio del Novecento il Fascismo identificò nel Litorale Romano quel territorio nel quale potevano applicarsi i precetti di una nuova ideologia rurale che identificava nella riscoperta del valore della “Terra” uno dei punti cardine per la “rinascita” produttiva dell’Agro Ministero dell'economia nazionale 1928, 116-117; Mussolini 1926, 27 .La stessa bonifica Portuense nei piani di Mussolini rappresentava un’importante impresa, funzionale alla auspicata “riappropriazione” di un ruolo egemonico nel bacino del Mediterraneo. Proprio sull’onda di tali ambiziose “speranze”, furono investiti nella tenuta Torlonia una serie di capitali statali e privati Eramo 2008, 60-63 , finalizzati a risolvere una serie di importanti problematiche legate
L’Agro Portuense attraverso la pittura, la fotografia e la documentazione cinematografica
CLAUDIO IMPIGLIA
Fig. 3: Filippo Magini, Pianta topografica della tenuta di Porto del Principe Don Giovanni Torlonia,1935 [G. Lugli, G. Filibeck, 1935].
alla bonifica, all’ammodernamento infrastrutturale, alla rinascita agricola, alla valorizzazione di importanti siti archeologici e di alcuni paesaggi pittoreschi. Anche se negli anni del Regime l’auspicata costruzione di un moderno porto non avrà mai luogo, facendo decadere così l’aspettativa di una egemonia economico-commerciale nel Mediterraneo, i risultati positivi della bonifica Portuense, peraltro parziali, opportunamente “registrati” in diverse forme di rappresentazione, servirono alla propaganda fascista per veicolare una vincente immagine del progresso tecnologico italiano. La nuova logica produttiva, applicandosi alla realtà della Campagna Romana, aveva però cancellato gran parte di quei suggestivi habitat naturali sostituendoli con ordinari e ripetitivi paesaggi agricoli. Le rappresentazioni pittoriche, fotografiche e cinematografiche dell’Agro Portuense hanno costituito le fonti iconografiche indispensabili per documentare quanto difficile e “traumatica” sia stata la trasformazione di questo “brano” pittoresco di Campagna Romana. Nel caso della tenuta di Porto il processo di “riqualificazione” idraulica consistette per prima cosa nel recupero dell’antico bacino di Traiano mediante derivazione idrica dal “ramo” secondario del Tevere: l’opera fu definitivamente completata nel 1924 quando le potenti idrovore, previste nel progetto di bonifica del 1921, consentirono l’immissione di acque pulite nell’invaso esagonale che funzionò da grande serbatoio idrico per la tenuta. La planimetria del nuovo insediamento dalle rigide geometrie contrastava con l’immagine, oramai quasi perduta, di un territorio costellato da saline e stagni (Fig. 2). La fondazione di questa comunità rurale fu sottesa da una visione utopistica dalla matrice paternalistica: il Principe, risiedendo nella villa sul “Lago”, costituiva il punto di riferimento per una società di agricoltori che, insediati nelle nuove e confortevoli case coloniche (Fig. 10), assimilabili a veri e propri villini rurali, contribuivano con il loro lavoro giornaliero al buon andamento della tenuta. Giovanni attraverso l’opera dei suoi ingegneri si impegnò anche nel mantenimento del carattere lacustre di alcuni siti litoranei (Figg. 5, 8), sottraendoli di fatto alla logica “geometrica” e “spianatrice” della bonifica e contribuendo al mantenimento di quello spirito pittoresco del luogo, tanto amato dai vedutisti della Campagna Romana di fine Ottocento (Fig. 4) Mammucari, Langella 1999, 13-49 .
L’Agro Portuense attraverso la pittura, la fotografia e la documentazione cinematografica
CLAUDIO IMPIGLIA
Fig. 4: Onorato Carlandi, Paesaggio del Tevere nei pressi di Fiumicino a Roma, 1930 (per gentile concessione del Duca Ascanio Sforza Cesarini).
2. Alla ricerca dei suggestivi paesaggi dell’Agro Portuense
2.1 “Riguardare” il paesaggio Portuense nella fotografia e nella cinematografia La ricostruzione storica delle trasformazioni novecentesche della Campagna Romana ha costituito un’occasione per confrontare tra loro due insiemi complementari di fonti iconografiche: da una parte i tradizionali documenti grafici costituiti da mappe, cabrei, catasti e vedute pittoriche Frutaz, XIII-XLVI ,dall’altra una serie di rappresentazioni fotografiche e cinematografiche, prodotte tra il XIX ed il XXsecolo da una variegata schiera di artefici, sia professionisti che dilettanti (artisti, archeologi, eruditi, nobili, collezionisti, tecnici, ecc.) Bonetti 2008, 46-135 .L’integrazione tra queste rappresentazioni è indispensabile per documentare in modo esaustivo le trasformazioni agrarie avvenute nel corso del ‘900 di tutte quelle tenute, in genere proprietà nobiliari, situate nell’esteso territorio dell’Agro Romano. Questa sintetica trattazione diviene l’occasione per prospettare una sorta di “piano programmatico”, in base al quale svolgere una ricostruzione storica del rapporto tra il paesaggio Portuense, e le sue diverse immagini: tra le fonti iconografiche di recente acquisizione quella cinematografica introduce problematiche dagli interessanti risvolti. In questo caso lo studio dovrà necessariamente indagare tutto il XX secolo al fine di “ridisegnare” la “parabola” di sviluppo di un’arte del cinema che si è declinata tipologicamente in diverse forme di rappresentazione (documentari, telegiornali, films, reportages),fruite, grazie alla televisione, da un pubblico sempre più vasto. Una storia della rappresentazione dell’Agro Portuense può costituire un significativo tassello ad integrazione di quel recente corpus di studi che ha avuto il merito di analizzare le complesse evoluzioni tecniche, formali e contenutistiche della cinematografia che negli anni del regime divenne lo strumento propagandistico per eccellenza Bonomo 2007, 97-138; Manetti 2012, 49-85; Toschi 2009, 115-135 .
2.2 Il Principe Torlonia e la rappresentazione del Genius Loci PortuenseQuesto studio offre l’occasione di relazionare “teatralmente” tra loro una serie di figure, le quali nel corso dei primi decenni del Novecento hanno fornito ciascuna una propria “rappresentazione” del
L’Agro Portuense attraverso la pittura, la fotografia e la documentazione cinematografica
CLAUDIO IMPIGLIA
paesaggio Portuense: Giovanni Torlonia, il principe-agricoltore; Giuseppe Lugli (1890-1967), l’archeologo-storiografo; Thomas Ashby (1874-1931), l’archeologo-fotografo; Onorato Carlandi (1848-1939), il pittore di vedute pittoresche; gli ingegneri e gli architetti dell’amministrazione Torlonia; per ultimo, l’anonimo cine-operatore del regime. Un gruppo di protagonisti, a loro modo archetipici, ciascuno manifestazione di un preciso atteggiamento nei confronti di quello che è il vero soggetto di questa storia, ossia il Genius Loci, nel tempo ricercato, esaltato, frainteso, alterato e in certi casi “ignorato” come dimostrano alcuni recenti esiti di una progettazione urbana insensibile agli autentici valori dei luoghi. La tenuta di Porto fu oggetto di una serie di campagne fotografiche realizzate prima e dopo il 1924, anno del compimento della bonifica del “Lago di Traiano”: l’inglese Thomas Ashby documentò nel corso delle sue passeggiate lo stato dei paesaggi archeologici, lacustri e fluviali Portuensi nei primi anni del Novecento. Circa venticinque anni dopo, il 25 marzo 1930, lo stesso Mussolini insieme al Principe Torlonia e a un gruppo di personalità, tra cui il Sottosegretario per la Bonifica Arrigo Serpieri (1877-1960) Marasti2001, 45-96 , volle visitare il sito lacustre, da poco riqualificato grazie all’azione delle macchine idrovore. Come anche in altre occasioni, fotografie e filmati documentarono la passeggiata di Mussolini: il materiale archivistico dell’Istituto Luce3 costituisce una testimonianza fondamentale di documentazione sui nuovi assetti della bonifica. La presenza del Duce, opportunamente “registrata” in tutte le sue fasi (l’arrivo alla tenuta, l’accoglienza del Principe Torlonia nella villa, l’affaccio sul “Lago” di Traiano, la visita alle idrovore, alle unità colturali con i casali e infine la partenza), equivaleva a sancire, da una parte l’ascesa politica-imprenditoriale del Torlonia, dall’altra a inserire idealmente quest’impresa nel più ampio programma del Regime per la valorizzazione del Litorale Romano. Nello stesso anno il Principe decise di affidare a Giuseppe Lugli, coadiuvato da Goffredo Filibeck, il compito di “celebrare” storiograficamente il sito di Porto. La pubblicazione nel 1935 del libro ad opera delle Officine dell’Istituto Italiano d’Arti Grafiche di Bergamo fu il risultato di un preciso atto di “volontà” da parte di Giovanni, una decisione “strategica”, finalizzata ad esaltare la sua “conquista” agraria Lugli, Filibeck 1935, 219-271 . Contestualmente alla bonifica delle terre, erano proseguite nel frattempo le indagini archeologiche in prosecuzione di quegli studi inaugurati da Luigi Canina quasi un secolo prima. Già nel 1930, proprio la volontà di fare il punto su queste ricerche, che in genere trovavano posto in periodici specializzati, diede l’occasione al Principe Torlonia di operare un’importante scelta editoriale equiparabile ad una sorta di “monumento” storiografico a sua futura memoria: la futura pubblicazione costituì nel Novecento forse uno degli esempi più importanti di “commissione” di uno studio storico affidata da un aristocratico romano ad un archeologo di sua fiducia. L’obbiettivo scientifico ricercato dai curatori era quello di documentare le vicende della complessa metamorfosi di un Genius Loci, che, grazie all’opera decisiva di Giovanni Torlonia, si era “rigenerato” nella immagine “riqualificata” dell’antico invaso lacustre di forma esagonale. Giuseppe Lugli, quindi, ritrascrisse la storia dei porti di Claudio e di Traiano mentre il Filibeck analizzò le fasi del “Risorgimento” agrario Portuense, dall’abbandono fino alla bonifica novecentesca attuata dal Torlonia. Un’estesa documentazione fotografica riguardò il “Lago” di Traiano (prima e dopo il 1924), i reperti archeologici (strutture e sculture), i nuovi manufatti architettonici (la villa, i casali, le idrovore, i granai e l’acquedotto) ed i paesaggi della tenuta (le pinete e le unità colturali). La programmata distribuzione di questo libro in numerose biblioteche nazionali, era così rivolta ad un ampio pubblico, costituito non solo da eruditi: la qualità più evidente dell’opera era data dal ricco e diversificato corredo iconografico (vedute pittoriche, planimetrie, rilievi, fotogrammi di riprese aeree, fotografie di paesaggi, di architetture e di reperti archeologici). La pubblicazione costituiva una sorta di “piattaforma” storiografica, nella quale erano posti sullo stesso piano di importanza le testimonianze archeologiche romane, gli originari paesaggi lacustri-fluviali, raffigurati nei dipinti di Onorato Carlandi (Fig. 4) Mammucari 1990, 121-141 e le architetture rurali dei casali, basate sull’integrazione tra procedimenti costruttivi tradizionali e nuovi materiali tecnologici (il cemento armato). L’unico sito che non fu documentato da fotografie, fu quello litoraneo con il laghetto dalla forma mistilinea (Figg. 5, 8, 9), “riplasmato” in modo opportuno ad immagine degli antichi stagni Portuensi: l’area lacustre era caratterizzata dalla cosiddetta “Casina dell’Isolotto” (Figg. 6, 7), moderno romitorio in forma di catamarano, costruito nel 1934 e progettato dallo stesso Giovanni Torlonia. Tale fatto si giustificò con la volontà del Principe di mantenere una sorta di “silenzio” storiografico nei confronti di questo eccentrica architettura, adibita a suo luogo di rifugio dalle dinamiche della “azienda” Portuense. Il paesaggio lacustre con il “catamarano”, rappresentato al momento dell’attracco sulle sponde rappresentato” nel momento dell’attracco sulle sponde dell’isolotto, dal ritorno di un viaggio, diventa
L’Agro Portuense attraverso la pittura, la fotografia e la documentazione cinematografica
CLAUDIO IMPIGLIA
Fig. 5: Veduta del paesaggio del laghetto litoraneo in direzione del mare (foto dell’autore, 2013, per gentile concessione del Duca Ascanio Sforza Cesarini).
Fig. 6: ricostruzione dello stato originario della Fig. 7: Casetta dell’Isolotto nel laghetto del LitoraleCasetta dell’Isolotto nel laghetto posto sul Litorale Portuense (Foto dell’Autore, 2013. Per gentile Portuense (Elaborazione grafica dell’Autore, 2013) concessione del Duca Ascanio Sforza Cesarini)
Fig. 8 – Il paesaggio del laghetto litoraneo visto dalla Casetta dell’Isolotto in direzione dell’aeroporto di Fiumicino (foto dell’autore, 2013. Per gentile concessione del Duca Ascanio Sforza Cesarini).
L’Agro Portuense attraverso la pittura, la fotografia e la documentazione cinematografica
CLAUDIO IMPIGLIA
nei piani del Principe immagine iconica del Genius Loci Portuense, simulacro da proteggere e quindi da celare allo sguardo altrui.
3 L’Agro come valore “residuale” nel paesaggio contemporaneo di Roma
3.1 Il paesaggio delle periferie come palinsesto urbano Le periferie contemporanee, che si sono sovrapposte agli spazi rurali del Suburbio delle grandi città, sono state oggetto in questi ultimi anni di approfonditi studi di sociologia urbana, in base ai quali, di volta in volta, sono state coniate una serie di appropriate definizioni atte a evidenziare il carattere frammentario e caotico di questi spazi urbani: le “città di latta” Desideri 2002, 7-16 , i “paesaggi ibridi” Zardini 1999, 19-24 e lo Sprawltown Ingersoll 2004, 8 sono tutti nomi diversi di una medesima
realtà periurbana che si è sviluppata senza regole e forme sul territorio, rispettando unicamente il principio della “conurbazione”, definibile in generale come quell’espansione edilizia che si è posta a congiunzione tra un nucleo urbano centrale e i centri minori gravitanti intorno ad esso Talia 2007, 82 .La periferia Romana ha costituito però un caso anomalo proprio perché questo urban sprawl,inaugurato già a partire dai primi decenni del Novecento, non ha riguardato un contesto rurale indifferenziato come quello delle città americane, ma anzi si è innestato in una campagna fortemente caratterizzata dal punto di vista storico, “mitizzata” dai viaggiatori ottocenteschi del Grand Tour per le sue suggestive realtà geologiche-naturalistiche, attraversate da antiche infrastrutture romane (vie consolari ed acquedotti) e costellate da siti archeologici come quello di Portus Keay 2012, 33-67 .Il fenomeno dell’incastellamento medievale delle campagne contribuì ulteriormente ad arricchire di emergenze architettoniche (torri, castelli e casali) questo paesaggio rurale che ha continuato ad affascinare nel corso del XX secolo una variegata schiera di vedutisti, fotografi, archeologi, scrittori e registi. Le rappresentazioni foto-cinematografiche hanno costituito delle testimonianze importanti per documentare la trasformazione di questi contesti dal grande valore storico e paesaggistico, in molti casi “aggrediti” sui due “fronti”, sia dalle bonifiche di epoca fascista che dall’edilizia abusiva Cazzola 2009, 232, 240, 318, 320; Visentini 1981, 6-16 , purtroppo fuori dal controllo di una corretta applicazione degli strumenti di pianificazione urbanistica. Nel corso del secondo dopo-guerra il paesaggio agrario della tenuta sarà pesantemente alterato da un’invasiva infrastrutturazione aeroportuale e da un’edilizia spontanea che lungo il fiume ed il Litorale si innesterà sui tracciati del tessuto agricolo: se prima l’Agro Portuense veniva vissuto come un contesto fluviale unitario, strutturato dal “ramo” navigabile del Tevere e dall’asse della via Portuense, la percezione attuale di questo territorio si è “frantumata” visivamente in una serie di luoghi tra loro diversi per forme e funzioni: il sistema di strade realizzate a servizio dell’’aeroporto e l’introduzione di nuove funzioni legate al transito delle merci ha introdotto una nuova logica di percorrenza in un sito che ha perso la sua originaria leggibilità. Attraversando il territorio metropolitano Portuense la percezione degli originari paesaggi agrari si riduce a visioni residuali e decontestualizzate, sulle quali invece prevalgono una serie di elementi costituiti dall’aeroporto e da grandi complessi edilizi, progettati in diversi periodi, come il Commercity (inizi anni Ottanta), il centro commerciale Parco Leonardo (1993) e l’Interporto Romano (2002) Carpenzano 2008, 114-125 (Fig. 9).
3.2 La proprietà Sforza Cesarini e la creazione dell’”Oasi di Porto” In questa caleidoscopica realtà la tenuta di Porto, da più di settant’anni proprietà della famiglia Sforza Cesarini, nei suoi attuali e più ristretti confini, costituisce una positiva eccezione: un’immagine pressoché integra di paesaggio agro-fluviale riguarda il territorio compreso tra il punto di massima vicinanza del Tevere alla via Portuense e la zona dell’Episcopio di Porto adiacente il “Lago” di Traiano, il cui perimetro esagonale ricalca i confini dell’antico porto di epoca imperiale. Proprio questa struttura artificiale lacustre costituisce il fulcro simbolico e percettivo della cosiddetta “Oasi di Porto” 5,parco archeologico-naturalistico, inaugurato nel 1993 dall’omonimo Consorzio, creato alla fine degli anni Ottanta e presieduto dal Duca Ascanio Sforza Cesarini. La valorizzazione del preesistente parco rustico lacustre, dagli anni Settanta agli Ottanta, è stata resa possibile dall’opera di importanti paesaggisti come Russel Page (1906-1985) Page 2010, 19-48 e Paolo Pejrone Pejrone 2008, 6,7 ,i quali hanno ridisegnato viali, giardini, orti, boschi e ambienti lacustri in armonia con le antiche strutture portuali Jakob 2009, 75-96 .
L’Agro Portuense attraverso la pittura, la fotografia e la documentazione cinematografica
CLAUDIO IMPIGLIA
Fig. 9: Lo stato attuale del territorio Portuense: 1) Lago di Traiano e Oasi di Porto; 2) Villa Torlonia, ora Sforza Cesarini, di Porto; 3) Episcopio di Porto; 4) Borgo marittimo di Fiumicino; 5) Idrovore del Lago di Traiano; 6) Laghetto e Casina dell’Isolotto; 7) Idrovore di Focene; 8) Riserva di Macchiagrande; 9) Idrovora di Traiano; 10)Idrovora di Ponte Galleria; 11) Aeroporto Leonardo da Vinci; 12) Interporto Romano; 13) Commercity; 14) Fiera di Roma; 15) Parco Leonardo; 16) Centro Commerciale da Vinci; 17) Borgata della Piana del Sole; 18) Borgata di Focene; 19) Area urbana di Fiumicino; 20) Area del futuro Porto Commerciale di Fiumicino; 21) Area del futuro Porto Turistico Riva Imperiale (rielaborazione della C.T.R. del 2005 ad opera dell’autore, 2014).
Il Protocollo d’Intesa relativo al completamento del piano strategico dello snodo portuale di Fiumicino, firmato il 24 Aprile 2013, ha posto il Consorzio “Oasi di Porto” e la Fondazione “Portus Onlus”6
all’interno di un gruppo costituito da importanti enti istituzionali pubblici e privati, ha sancito definitivamente il loro importante status giuridico ed ha prefigurato il loro ruolo decisivo nell’ambito delle future trasformazioni territoriali di natura infrastrutturale che sono state opportunamente programmate. E’ possibile riconoscere nel sito dell’”Oasi di Porto” un equilibrio tra un’archeologia industriale (se accettiamo in questo caso la definizione che si applica a tutti quei manufatti edilizi basati sulla tecnologia del ferro e del cemento armato) e un ambiente dalle suggestive qualità naturalistiche. In questi ultimi anni questo paesaggio dai caratteri così “variegati”, oscillanti tra qualità e degrado, è stato oggetto di un ampio dibattito che è arrivato a coinvolgere anche università straniere come l’Harvard Graduate School of Design (GSD) che ha dedicato un apposito workshop i cui risultati sono stati pubblicati nel 2011: il territorio Portuense è divenuto così una sorta di “laboratorio” per la verifica di una serie di proposte progettuali finalizzate a “ricucire” tra loro infrastruttura, natura ed edilizia spontanea Cerutti Fusco – Cancellieri 2011, 81-84 .La famiglia Sforza Cesarini in questi anni ha basato la valorizzazione del sito di Porto sul principio di “continuità” con i criteri d’intervento indicati da Giovanni Torlonia. Nonostante un contesto storico-politico-amministrativo completamente diverso rispetto a quello d’inizio Novecento, gli obbiettivi della proprietà continuano a essere il miglioramento delle infrastrutture idrauliche e dalla conservazione dei paesaggi naturalistici, archeologici ed agrari; a questi si è aggiunto l’impegno per il programmato restauro di alcune architetture di “archeologia industriale”, tra le quali le idrovore sul “Lago” di Traiano e la “Casetta dell’isolotto”.
L’Agro Portuense attraverso la pittura, la fotografia e la documentazione cinematografica
CLAUDIO IMPIGLIA
4. Alla ricerca dell’”Agro” nella metropoli contemporanea
4.1 La raccolta e la conservazione del materiale fotografico e audiovisivo Oggi Internet costituisce un’importante fonte per la consultazione del materiale foto-cinematografico: il principale motore di ricerca sul quale si è impostato questo studio è stato quello dell’URBS (Unione Romana Biblioteche Scientifiche)7, al quale si sono affiancati una serie di archivi e di istituti, in parte consultabili sul web, preposti alla conservazione ed alla tutela delle lastre e delle pellicole. Per quanto riguarda le raccolte fotografiche si evidenziano: l’Aerofototeca Nazionale e le collezioni fotografiche del Gabinetto Fotografico Nazionale, comprese nell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD)8, le collezioni fotografiche della British School at Rome9 e gli Archivi Alinari di Firenze10; per quanto riguarda le raccolte cinematografiche: l’Archivio Storico Luce dell’Istituto Luce Cinecittà, il Centro Sperimentale di Cinematografia11 e il Centro di documentazione sulla storia della cultura architettonica (ARCHIVARCH). Nel 2011 la collaborazione tra l’ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell'Agricoltura del Lazio), creato nel 1995, e l’Istituto Cinecittà Luce, ente creato dal Governo fascista nel 1924 per attuare l’opera di propaganda cinematografica, ha dato avvio al progetto: «Sulle terre della riforma. Luce sull’Italia agricola»12. In questo caso l’ampio materiale documentario di tipo fotografico e audiovisivo, raccolto, riorganizzato e tutelato, riguardante l’epocale trasformazione novecentesca dell’Agro Romano, rappresenta un’importante fonte documentaria al servizio della storia del territorio e può essere di stimolo per intraprendere ulteriori approfondimenti riguardanti specifici contesti agrari. L’individuazione del sito Portuense, che presenta nell’attuale realtà metropolitana tutte le caratteristiche di “palinsesto” periurbano, offre l’occasione per impostare una ricerca di quei paesaggi naturalistici e archeologici che dovrebbero essere conservati e valorizzati. La “riscoperta” di tali contesti dovrebbe essere finalizzata alla predisposizione di una strategia culturale dai risvolti economici perché connessa alla potenziale fruizione da parte di un pubblico di una serie di luoghi, nei quali permangono ancora importanti “memorie”, sia materiali che immateriali. La prospettiva di nuove importanti trasformazioni che interesseranno nei prossimi anni il Litorale Portuense, come la costruzione del nuovo porto commerciale e di quello turistico (Fig. 9), può essere di stimolo, in primo luogo per ripercorrere l’intera storia Novecentesca di questo contesto, in secondo luogo per ripensare a nuove forme di storiografia basate sulla integrazione “progettata” di testi, cartografie, fotografie, documentari, films, musiche, ricostruzioni grafiche e digitali.
4.2 Il caso del film “Sacro GRA”: riguardare la periferia dall’infrastruttura Il film documentario “Sacro GRA”, vincitore nel 2013 del premio Leone d'oro al miglior film nella 70ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, costituisce in questa trattazione un importante esempio di esperimento cinematografico: Gianfranco Rosi ha posto al centro della rappresentazione il Grande Raccordo Anulare di Roma, l’autostrada che, costruita a partire dall’immediato dopoguerra, circonda in modo ininterrotto la città. Il tema della percorrenza infrastrutturale ha consentito al regista di narrare storie, ma soprattutto di rappresentare in modo efficace gli innumerevoli contesti della periferia, molto diversi tra loro per spazi, architetture, paesaggi, riti e gruppi sociali: la morfologia “anulare” del viaggio, che informa la stessa struttura del racconto, costituisce la “chiave” per decifrare la multiforme realtà contemporanea della metropoli. In questo senso è paradigmatica la sequenza del film nella quale sono rappresentati contemporaneamente realtà tra loro in apparente conflitto: la veloce infrastruttura stradale che lambisce un tipico paesaggio della Campagna Romana con il suo lento gregge di pecore. “Sacro GRA” non è quindi un semplice film ma è in realtà un nuovo modo di guardare la periferia: il “messaggio” ha così travalicato i ristretti confini dell’opera cinematografica per trasformarsi in una “piattaforma” virtuale13, articolata in forme complementari di comunicazione come la fotografia e la scrittura. Come le perle in un filo di una collana, così i diversi paesaggi metropolitani sono messi in rapporto tra loro dal GRA, esso stesso grande paesaggio totalizzante. “Sacro GRA” è un’opera multimediale che predispone a rileggere con occhi nuovi la periferia romana e nel caso del territorio Portuense a identificare nella grande infrastruttura, rappresentata dall’aeroporto di Fiumicino, quell’opportunità grazie alla quale è possibile riguardare e comprendere i meccanismi di trasformazione della nostra periferia “ibrida” (Fig.10).
L’Agro Portuense attraverso la pittura, la fotografia e la documentazione cinematografica
CLAUDIO IMPIGLIA
Fig.10: Un casale Torlonia nei pressi dell’aeroporto di Fiumicino (foto dell’autore, 2012).
BibliografiaBONETTI, M.F. (2008). La Campagna Romana: il paesaggio e gli studi per artisti. In Roma 1840-1870: la fotografia, il collezionista e lo storico. (2008). A cura di BONETTI, M.F., DALL'OLIO, C., PRANDI, A. Milano, Roma: Peliti Associati. BONOMO, M. (2007). Autoritratto rurale del fascismo italiano: cinema, radio e mondo contadino.Ragusa: EdiArgo. BORTOLOTTI, L. (1988). Roma fuori le mura: l'Agro romano da palude a metropoli. Roma-Bari: Laterza. CARPENZANO, O. (2008). L’architettura logistica. In Interporto Roma – Fiumicino. Prove di dialogo tra archeologia, architettura e paesaggio. A cura di CARAVAGGI, L., CARPENZANO, O. Firenze: Alinea editrice. CAZZOLA, A. (2009). Paesaggi coltivati, paesaggio da coltivare: lo spazio agricolo dell'area romana tra campagna, territorio urbanizzato e produzione. Roma: Gangemi. CERUTTI FUSCO, A., CANCELLIERI, S. (2011). Metodi e temi di indagine per una riqualificazione del territorio. In Progettare paesaggio. Landscape as Infrastructure. A studio Research Report of the Harvard Graduate School of Design. A cura di CANNAVÒ, P., AEBISCHER, P., CANCELLIERI, S. Roma: Gangemi. DE GIORGI, G. (2013). Roma. Quando la città prende il largo. Roma: Prospettive Edizioni. DESIDERI, P. (2002). Città di latta: favelas di lusso, autogrill, assi attrezzati, latta e antenne paraboliche tra Roma e Pescara. Roma: Meltemi Editore. ERAMO, N. (2008). Mutui per la bonifica agraria dell'Agro romano e pontino, 1905-1975. Inventario. Roma: Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Generale per gli Archivi. FELISINI, D. (2004). Quel capitalista per ricchezza principalissimo: Alessandro Torlonia principe banchiere imprenditore nell'Ottocento romano. Roma: Nova Officina Poligrafica Laziale. FRUTAZ, P.A. (1972), Le carte del Lazio. Roma: Stabilimento Arti Grafiche Luigi Salomone, Stabilimento Aristide Staderini. GIRALDI, A. M. (1985), L'archivio dell'amministrazione Torlonia: inventario, Roma: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.
L’Agro Portuense attraverso la pittura, la fotografia e la documentazione cinematografica
CLAUDIO IMPIGLIA
INGERSOLL, R. (2004). Sprawltown: cercando la città in periferia. Roma: Meltemi. JAKOB, M. (2009). Il giardino allo specchio: percorsi tra pittura, cinema e fotografia. Torino: Bollati Boringhieri. KEAY, S. (2012). The Port System of Imperial Rome. In Rome, Portus and the Mediterranean. A cura di KEAY, S. Archaeological Monographs of the British School at Rome, 21. LUGLI, G., FILIBECK, G. (1935). Il porto di Roma imperiale e l'agro portuense. Bergamo: Officine dell’Istituto Italiano d'arti grafiche. MAMMUCARI, R. (1990). I XXV della Campagna Romana: pittura di paesaggio a Roma nella sua campagna dall'ottocento ai primi del novecento, Velletri: Edizioni tra 8 & 9. MAMMUCARI, R., LANGELLA, R. (1999). I pittori della Mal’aria: dalla Campagna romana alle paludi Pontine. Roma: Newton & Compton. MANETTI, D. (2012). Un’arma poderosissima: industria cinematografica e Stato durante il fascismo, 1922-1943. Milano: Angeli. MARASTI, F. (2001). Il fascismo rurale: Arrigo Serpieri e la bonifica integrale. Roma: Settimo sigillo. MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE, DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA. (1928). L'Agro Romano nel primo quinquennio fascista: Relazione sull'incremento del bonificamento agrario e della colonizzazione nell'agro romano dal 1 gennaio 1923 al 31 Dicembre 1927, Roma: Tipografia Cuggiani. MUSSOLINI, B. (1926). Roma antica sul mare. Spoleto: Arti grafiche Panetto & Petrelli. PAGE, R. (2010). L'educazione di un giardiniere, Torino: Allemandi. PEJRONE, P. (2008). I miei giardini. Foto di FUSARO, D. Milano: Mondadori Arte.RASI, G.B. (1827). Sul Tevere e sua navigazione da Fiumicino a Roma. Roma: nella tipografia Perego-Salvioni. SETTI, M. (2001). Caratteri e vicende del territorio portuense. In L’Episcopio di Porto presso Fiumicino: metodo e prassi nel restauro architettonico. A cura di CANCELLIERI, S. Roma: Gangemi. TALIA, I. 2007. Forme, strutture, politiche della città. Napoli: Liguori. TOMASSETTI, G. (1975). La Campagna Romana: antica, medioevale e moderna, nuova edizione aggiornata. volume VI, Vie Nomentana e Salaria, Portuense, Tiburtina. A cura di CHIUMENTI, L., BILANCIA, F. Roma: Banco di Roma. TOSCANI, C., PANUNZI, G. (1948). Commissione per lo studio e la costruzione dell’aeroporto civile di Roma. Studio di massima dell'aeroporto intercontinentale di Roma, 28 maggio 1948, Roma: Aereonautica Stabilimento Fotomeccanico. TOSCHI, D. (2009). Il paesaggio rurale: cinema e cultura contadina nell'Italia fascista. Milano: V&P. VISENTINI, P. (1981). La formazione dell’abusivismo nel territorio romano. In USPR Documenti 1: Il recupero degli insediamenti abusivi. A cura di LEONE, A.M. Roma: Tipografia Operaia Romana. ZARDINI, M. (1996). Per un ritorno del Pittoresco. In Paesaggi ibridi: un viaggio nella città contemporanea. A cura di ZARDINI, M. Foto di BARBIERI O. Milano: Skira.
L’Agro Portuense attraverso la pittura, la fotografia e la documentazione cinematografica
CLAUDIO IMPIGLIA
Note
1 Web: http://romatevere.hypotheses.org/. 2 Web: http://www.portusproject.org/. 3 Web: http://www.archivioluce.com/archivio/. 4: Web: http://www.ostia-antica.org/fulltext.htm. 5: Web: http://www.oasidiporto.it/. 6 Web: http://www.fondazioneportus.it/.7 Web: http://www.web.reteurbs.org/index.php?lang=it. 8 Web: http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/1/home. 9 Web: http://www.bsrdigitalcollections.it/. 10 Web: http://www.alinariarchives.it/internal/home.aspx. 11 Web: http://www.snc.it/. 12 Web: http://www.agristoria.it/. 13 Web: http://www.sacrogra.it/.