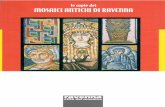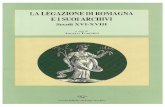Le strutture fondiarie ed agrarie, in Storia di Ravenna. II/1. Dall’età bizantina all’età...
Transcript of Le strutture fondiarie ed agrarie, in Storia di Ravenna. II/1. Dall’età bizantina all’età...
Andrea Castagnetti
LE STRUTTURE FONDIARIE ED AGRARIE
Estratto da: Storia di Ravenna
II. 1. Dall' età bizantina all' età ottoniana
Territorio, economia e società Comune di Ravenna
Marsilio Editori 1991
Andrea Castagnetti
LE STRUTTURE FONDIARIE ED AGRARIEf-, PREMESSA
La documentazione da noi utilizzabile, fra quella edita1, per la conoscenza delle strutture fondiarie ed agrarie del territorio della città di Ravenna nell' alto Medioevo è assai scarsa, essendo costituita da circa tre decine di documenti. Se da questi noi prendessimo 1'avvio per la trattazione del nostro contributo, saremmo costretti a fare riferimento continuo ad una situazione generale, soffermandoci a lungo, di volta in volta, a chiarire il significato dei termini singoli e delle realtà che essi sottendono, termini e realtà che non possono essere compresi se non si tiene presente la tradizione politica, istituzionale, sociale, economica e culturale della Romania, una regione storica comprendente l'Esarcato e la Pentapoli, che permane soggetta al governo bizantino dopo la conquista longobarda di larga parte dell'Italia.
Nell' ambito delle strutture fondiarie ed agrarie tale tradizione si concretizza nella persistenza delle strutture catastali dell' età romana, in parte anche delle strutture agrarie: essa assume risalto notevole nella comparazione con le regioni della Langobardia, quelle cioè assoggettate dai Longobardi, particolarmente le regioni dell'Italia settentrionale e della Toscana, e permette, per converso, di meglio comprendere le modificazioni radicali prodotte dalla conquista longobarda.
Necessaria, più che opportuna, appare l'illustrazione dei due aspetti ora accennati, nell' applicazione costante del procedimento comparativo. Questo, nonostante che da lungo tempo sia consigliato sul piano metodologico, non è stato sostanzialmente utilizzato per lo studio delle nostre regioni, fino a che dalla fine degli anni sessanta Vito Fumagalli non lo ha applicato nell' ambito dello studio su coloni e signori dell'Italia superiore nell' alto Medioev0 2
, ponendo in luce la diversa tipologia dei canoni nei patti colonici fra l'area longobarda e quella romanica, giungendo alla conclusione che la conquista longobarda ebbe conseguenze gravose sulle popolazioni contadine, alle quali vennero richiesti canoni in natura più pesanti rispetto a quelli tradizionali che rimasero in vigore nelle terre della Chiesa ravennate.
Pochi anni dopo chi scrive pubblicò i risultati di una ricerca, basata sul metodo comparativo, come il sottotitolo stesso dell'opera enuncia3, concernente le strutture civili ed ecclesiastiche, nonché quelle agrarie della Langobardia e della Romania, considerando due zone di confine fra le due aree - i territori modenese e reggiano, per la
--,.
55
ANDREA CASTAGNETTI
prima, quello ferrarese, per la seconda -, estendendo tuttavia l'analisi per l'alto Medioevo a tutta l'area di influenza ravennate, sulla scorta della documentazione fino ad allora edita. La diversità fra le due aree apparve ancora più profonda, conseguenza, da una parte, dei
mutamenti' radÌé:aIÌ' apportati' dal' Longobardì; dalI'àltra parte, oltre che della persistenza del sistema catastale di età romana, del ruolo determinante mantenuto dalle città e dell'introduzione di una nuova ripartizione territoriale, quella della circoscrizione ecclesiastica della parrocchia rurale assunta ai fini civili.
LA CONTINUITÀ DEL SISTEMA CATASTALE DI ETÀ
ROMANA NELLA DOCUMENTAZIONE DELL'AREA
RAVENNATE
La maggior parte della documentazione concernente la Romania aItomedioevale proviene dagli archivi della Chiesa arcivescovile ravennate e, in misura minore, da quella di altre chiese e monasteri ravennati. Ci sembra pertanto legittimo parlare di un' area ravennate, con proprie specifiche tradizioni documentarie, che ci permettono di conoscere l'organizzazione agraria del suolo, non solo e non tanto per quanto concerne gli aspetti formali, ma anche, come vedremo, gli aspetti materiali: non si tratta, in altre parole, dell'impiego di formule e termini diversi, ma questi riflettono una peculiare organizzazione catastale ed agraria.
Nei documenti ravennati, a partire già dal secolo VI,
l'ubicazione dei beni terrieri avviene mediante l'indicazione del territorium della città e del fundus 4; più tardi, dalla seconda metà del secolo VIII, iniziò ad essere introdotta l'indicazione di una struttura intermedia, quella della circoscrizione plebana, tecnica che si diffuse via via fino a divenire generalizzata 5. I confini del bene terriero, oggetto del negozio giuridico, non sono dati mediante terre di altri proprietari, come nell' area longobarda, ma, tralasciando l'indicazione eventuale di strade, corsi d'acqua, paludi o altri elementi naturali, mediante i fundi adiacenti, solitamente quattro, che, si badi, confinano non con le terre oggetto del negozio, ma con il fundus, in cui queste sono situate e del quale costituiscono una porzione, salvo il caso che oggetto del contratto non sia il fundus nella sua integrità. Non è possibile comprendere le ragioni di tale tecnica ubicatoria se non si comprende quali fossero la struttura e le funzioni del fundus.
Quando chi scrive - egli «longobardo» in terra «bizan
tina» - percepì l'esistenza di questi aspetti e la complessità dei problemi connessi, rimase a lungo perplesso: la soluzione gli si presentò gradualmente, via via che si rendeya conto che un tale sistema ubicatorio era stato proprio nel passato dei redattori del catasto in età romana. Al sistema
catastale di'questa eta rimandano, senza incertezza, l'ubicazione del fundus attraverso il territorio della città e la confinazione con altrifundi, quale appare nelle due Tavole di Velleia e di Benevento, dell'inizio del secolo II dopo Cristo; un terzo elemento è fornito dall'indicazione del pagus6
•
A fondamento della registrazione catastale stava un libro fondiario generale, elaborato durante l'impero di Augusto. Il proprietario di età augustea ha dato, in genere, il nome al fundus. La superficie deifundi poteva essere varia, come vario e complesso fu il rapporto che si venne a creare tra il fundus e l'azienda contadina: se, all' origine, le due realtà tendenzialmente coincidevano, nel prosieguo di tempo le vicende familiari connesse all' eredità e quelle connesse ai negozi giuridici poterono farle divergere anche in modo sostanziale, mediante un accorpamento o un frazionamento del/zmdus. Già nel II secolo sono documentate, proprio nelle Tavole suaccennate, grosse proprietà costituite da piùfundi; per converso, ilfundus poté essere frazionato in due fundi, che mantenevano la denominazione originaria, distinguendosi in Maior e Minor) Superior e Inferior.
Struttura territoriale intermedia per l'ubicazione delle terre in età romana fu il pagus. Esso aveva caratterizzato il tipo di insediamento delle popolazioni liguri e celtiche in età preromana; nei primi secoli dell' era volgare indicava ancora un ampio territorio rurale, il cui popolamento avveniva per vici e che manteneva, come quello minore del vicus, forme di organizzazione comunitaria - magistrati, polizia campestre, materie religiosa -, ma che aveva perduto ogni forma di autonomia in campo giurisdizionale, amministrativo e finanziario 7.
L'ubicazione delle terre mediantefundus) pagus e territorium civitatis rimase in vigore almeno fino al IV secolo: lo attesta il catasto di Volcei, elaborato durante l'impero di Costantino, che presenta una struttura identica a quella della T avola di Velleia 8.
Nel periodo di trapasso dal tardo impero al primo Medioevo la tecnica persiste, ma solo nelle regioni bizantine 9,
particolarmente nelle regioni bizantine della Romania, ove si perde tuttavia uno degli elementi di connotazione catastale, quello costituito dal pagus; non subito, invero, poiché ne rimane traccia in poche menzioni isolate: in un
LE STRUTTURE FONDIARIE ED AGRARIE
documento ravennate dell'anno 539 un terreno di venti iugerì è ubicato nelfundus di Concordiacus, nel territorio di Faenza, nel pagus Painate lO
; a questo documento va accostato un altro, di poco anteriore ll, nel quale un altro fundus, denominato Casa Caballaria, è collocato in un territorium e in un pagus, di entrambi i quali mancano i nomi per lacune nella scrittura del papiro, ma che possono essere identificati con il territorio faentino, sicuramente, e con il pagus Painate, probabilmente, dal momento che fra i proprietari dei fundi confinanti appare certo Vitterìt, scutarius dromonariorum, che corrisponde al Witterit scutarius, che nel documento del 539, sopra menzionato, è nominato quale proprietario di un fundus fra quelli confinanti. L'ultima menzione del pagus nelle regioni della Romania è presente in una registrazione, attribuibile agli anni 744-776, del Breviarium della Chiesa ravennate, noto come Codice Bavaro: il fundus Caleriano è posto nel territorio di Rimini, nel pagus Acervolcmo 12.
La continuità del sistema catastale è convalidata anche dal riferimento al catasto pubblico, che i magistrati cittadini dovevano tenere aggiornato, riferimento presente, come ha posto in luce la Ruggini!>, in documenti del secolo VI.
Un ultimo aspetto rimane da approfondire, per meglio intendere le strutture fondiarie ed agrarie della Romania, in generale, e del Ravennate, in particolare.
La descrizione dei fundi nei libri fondiari e nei catasti di età romana non segnala minuziosamente tutto ciò di cui ilfundus, in quanto azienda agraria, è provvisto per il funzionamento; viene omessa anche la descrizione degli immobili. Solo in epoca più tarda è a volte segnalata resistenza dell' edificio. N elle T avole si trovano invero elencati alcuni elementi, in modo non costante, che appaiono essere aggiunti, quali pertinenze, non facenti parte del fundus: terre boschive e prative e costruzioni, definite anche con il termine di casa. Non si tratta, nell'ultimo caso, di una costruzione edificata sul jìmdus, ma di un appezzamento staccato, autonomo, che è aggiunto nella descrizione catastale a1fundus, poiché esso è considerato meno importante. A riprova, è possibile constatare che esso può essere registrato a sé stante, con una propria ubicazione per confini, come avviene per il jìmdus. L'indicazione di casa, pertanto, non può essere assunta come indizio per lo studio dell'insediamento rurale: un edificio abitativo esiste certamente ove il termine compare, ma ciò non esclude che ne esistano anche dove il termine non compare. Ancora, l'accostamento di jìmdus e casa non implica 1'esistenza di una
azienda agraria complessa, con il fundus per centro e la casa come pertinenza: in questa direzione vi è solo un suggerimento. Quando compare l'espressione «fundus [ ... ] et casa [ ... h, con la casa dotata di un nome proprio, dobbiamo considerare l'espressione stessa equivalente a «fundus L..] et fundus [ ... ]», designante quindi due parcelle catastali, contigue o meno 14.
La documentazione ravennate ci permette di cogliere la persistenza della presenza di casa, la sua corrispondenza con il fundus e, infine, la sua evoluzione nel termine di casale, impiegato nelle stesse funzioni, con alcune caratteristiche specifiche.
In un inventario, breve, di beni mobili e immobili, redatto a Ravenna nell'anno 564, sono elencati abitazioni in città, domus, e alcuni predia ruralia 15
: oltre aifundi e ad un casale, sul quale ci soffermeremo poco oltre, vengono nominate quattro unciae -1'uncia corrisponde ad un dodicesimo -, ovvero un terzo, di una «casa que appellatur Casa Nova», posta nel territorium di Ravenna. Delle proprietà rurali non vengono dati i confini.
I confini sono invece forniti in un documento della prima metà del secolo, già utilizzato 16, in cui viene venduto un fundus, probabilmente in territorio di Faenza lI, denominato Casa Caballaria, dotato di un edificio proprio, «cum ponione aedificii», e altre pertinenze, che sono descritte in un passo successivo: «. .. finibus terminisque earum [scil.: unciarum], campis, pratis, pascuis, silvis, salectis, sationibus, vineis, arbustis, arboribus fructiferis diversis generis limitibusque suis omnibus omnique iure proprietateque earum», il tutto come era stato posseduto dal proprietario precedente, che 1'aveva venduto. I confini delfundus sono costituiti da altri duefundi, non da quattro, forse perché sono elencati solo ifundi che confinano con la porzione acquisita, un terzo del fundus. Evidente appare il processo, che sarà proprio, come vedremo, anche del casale in periodo più tardo, per cui un appezzamento, dapprima privo probabilmente di una propria individualità e collegato forse ad un fundus, viene ad assumere via via un ruolo sempre più autonomo, fino ad essere considerato, anche nella definizione terminologica, oltre che nella realtà aziendale, quale un fundus. Il processo era avvenuto certamente in un tempo anteriore non breve, dal momento che la casa/fundus aveva già subito un processo di frazionamento, rappresentato dalla sua suddivisione in terzi, una suddivisione effettiva, non semplicemente a livello di proprietà, poiché la porzione inventariata è stata dotata in modo tale da rappresentare una azienda autonoma, con propri edifici, anzitutto, e la propria parte di pertinenze e confini, infine, propri.
57
ANDREA CASTAGNETTI
Una traccia ancora dell'esistenza di casae a sé stanti è fornita dal documento dell'anno 539, che concerne il territorio faentino e il pagus Painate J8
, sul quale pure ci siamo soffermati. Tra i confini del fundus Concordiacus , venti iugerì del quale vengono ceduti, viene nominato, assieme a duefundi e ad un limes publicus, il possedimento di Casa Nova, che non è definito in alcun modo, se non attraverso il nome del proprietario: anche in questo caso siamo in presenza di una casa, dotata di un nome proprio, che viene considerata ormai alla stregua di unfundus, pur se ancora cosÌ non definita.
Le casae tendono ad assumere, oltre che il ruolo, anche la connotazione ufficiale difundi, come è deducibile dalla presenza di fundi che portano la denominazione composta da Casa e da un nome proprio. TI fenomeno, non limitato certo alla Romanié9
, è attestato nelle registrazioni del Breviarium della Cbiesa20 e in altri documenti21
• Il termine casa indicante una parcella catastale a sé stante scompare presto dalla documentazione ravennate, ma non ne scompare la sostanza, poiché esso viene sostituito dal termine casale, che ne assume il ruolo, un termine, del resto, non del tutto nuovo, poiché esso, pur impiegato raramente, era conosciuto dagli agrimensori romani, per i quali poteva assumere un significato duplice: confine di unfundus e proprietà a sé stante22
•
Una considerazione superficiale delle attestazioni documentarie potrebbe suggerire che il casale costituisse una pertinenza posta sulfundus, ad esempio nelle espressioni «fundus cum casaIibus» o «massa cum fundis et casalibus». L'impressione è smentita fÌn dal primo documento, fra quelli a noi noti, nel quale appare il termine casale, quello stesso inventario rogato a Ravenna nel 564, ave è presente il termine . Vi si nomina un casale Petroniano, in territorio bolognese, del quale sono possedute solo due unciae. Poco tempo dopo, con un atto rogato in Ravenna nel 57224 , vengono ceduti beni in territorio riminese, costituiti da una porzione di cinque unciae del fundus Custinis, con la sua porzione di edificio, e da due unciae deI casale Bassianum, al primo pertinente: fundus e casale, pur essendo il secondo legato, pertinens, al primo e per di più contigui, come è deducibile dalle confinazioni, costituiscono due parcelle catastali distinte, poiché, in caso contrario, non sarebbe stato possibile frazionarli in quote diverse, cioè in cinque e due dodicesimi. Dal documento riceviamo ancbe la conferma che il casale non può indicare il complesso della superficie dedicata alle abitazioni, dal momento che ilfundus è dotato di propri edifici.
Osservazioni analoghe sono deducibili da un documento posteriore di due secoli, la cui registrazione, attribuibile
agli anni ì44-ì69, è inserita nel Breviarium 25 : concerne la
concessione integrale del fundus Fabrica, in territorio riminese, e di quattro uncz'ae del casale Turtiano, fra loro contigui, i cui confini sono comuni: tra le confinazioni, oltre ad un altro casale, sono elencate le rimanenti quattro unciae del casale Turiano.
Un documento dello stesso periodo, dell' anno ì 31, che registra in forma non notarile, poiché si tratta di un'iscrizione celebrativa, una permuta tra chiesa arcivescovile di Ravenna e il monastero di Sant'Apollinare, menziona il fundus Gammillaria, in territorio ravennate, ceduto dalla prima al secondo, in cambio di duefundi in altri territo.ri26
• Il fundus è circondato da casaZza «undique vallatus cum suis terminibus» -, che non ne rappresentano, tuttavia, pur suggerendo tale impressione, i confini, poiché i confini in senso proprio sono costituiti dai termini. Il fundus, che viene definito ferttlis, adatto alla coltivazione, incorpora superfici non coltivate o, con maggiore probabilità, si trova all'interno di una più ampia zona nella quale prevalgono gli spazi incolti, ricchi di legname e di piante ghiandifere: «fundus ... fecundus ignis ad usum lignamem et. .. quod pabulent silvarum grandifera poma». Tali caratteri ambientali rinviano ad una regione occupata in larga parte da superfici boschive; il fatto, poi, che il fundus non confini con altrifundi, ma sia da ogni parte circondato da casalia induce a ritenere che non solo esso sia al centro della regione, ma anche cbe ì casalia, ad esso legati, siano appezzamenti a sé stanti, relativamente autonomi, particolarmente atti allo sfruttamento e alla riduzione a coltura del suolo incolto: essi svolgono un ruolo secondario rispetto al fundus, ma sono destinati nel lungo periodo, secondo un processo generale, come subito constatiamo, a conseguire autonomia completa, assumendo una denominazione individuale e divenendo fundi a pieno titolo.
Nelle innumerevoli registrazioni, poco meno di duecento, di documenti che ci sono giunte attraverso il Breviarium della Chiesa ravennate, le quali coprono il periodo dalla fine del secolo VII a quella del x, le attestazioni, non generiche, di casalia, individuati cioè con il nome specifico, sono presenti soprattutto nei documenti attribuibili agli episcopati degli arcivescovi Damiano - anni 688-ì09 - e Sergio - anni ìì4- ì 69 -, comprendenti il periodo più antico cui sono assegnate le registrazioni del Brevzarium, periodo che corrisponde a quello della concessione del fundus Fabrica e del casale Turiano, e dell'iscrizione del ì31, poco sopra considerate. Casalia appaiono anche in documentazione della
LE STRUTTURE FONDIARIE ED AGRARIE
prìma metà del secolo IX, ma le ultime menzioni sono I
incluse nell' espressione generica di «massa cum fundis et casalibus»21.i .
Questa espressione è presente in un altro documento consimile della Chiesa ravennate, il Regestum bonorum della fine del secolo X, concernente possessi della Chiesa ravennate nel Ferrarese, costituito da due parti: inventario delle proprietà e petidones dei singoli teuti28
• L'espressione appare nella prima parte, mentre nella seconda sono nommati solo fundi specifici: ci sembra lecito dedurne che il casate viene tenuto presente ormai solo in modo generico, quale elemento costitutivo o appendice eventuale, come il fundus, di una massa, ma che, al momento della concessione, la realtà effettuale è ormai rappresentata dal fundus, non vi fossero più casalia o fossero essi ormai considerati a tutti gli effetti fundi. Tracce di tale processo si rinvengono, come era accaduto per casa, nell' attribuzione ad alcuni fundi del nome Casate, da solo o seguito da un nome proprio: non manca l'attestazione della suddivisione del casate in due porzioni che, mantenendo lo stesso nome, si differenziano, come ilfundus romano, in de Supra e de Subto 29
•
Il casale, in quanto parcella catastale a sé stante, ha assunto, nella maggioranza dei casi, una fisionomia che lo ha reso sostanzialmente equivalente al fundus. Ciò può essere av'Venuto soprattutto dopo che il casale ha cessato di svolgere, secondo quanto da noi proposto, il ruolo di avanguardia ed elemento propulsore dell' attività colonizzatrice.
I casalia non scompaiono definitivamente nel secolo IX. Segnaliamo, come esempi di sopravvivenza, il casale de Casa, facente parte della massa Maratiana in territorio riminese 30
, corrispondente all'odierna Marazzano: il nome del casale, che nel 993 fu assegnato livello nella sua interezza31, rìnvia, assai significativamente, al termine casa, che in romana esprìmeva una realtà analoga e di cui casale è l'erede diretto. le confinazioni del casale Casa appare un altro casale, il casale Augusto, già presente m un documento precedente fra le confinazioni di tm fundus e della massa Ma1'atiana 32 •
Casalia continueranno ad essere presenti nella documentazione dell' area ravennate, ma il termine, a partire dal secolo XI, assumerà nuovi significati. Come la casa, con un processo ampiamente documentato nel secolo
, indica non più una parcelJa catastale, ma l'edificio per l'abitazione, così il casale, in alcune zone caratterizzate da una consistente presenza dell'incolto e della palude, designa il complesso dell' edificio, dell' aia e dell' orto,
nonché del prato e della vite di vecchio impianto, annessi alla sede abitativa34
•
IL «FUNDUS» E LA REALTÀ ORGANIZZATIVA AGRARIA
DELL'ALTO MEDIOEVO IN AREA RAVENNATE
Abbiamo accennato al distacco progressivo, llllzlato già dopo l'elaborazione del libro fondiario, tra la parcellazione catastale infundi e l'organizzazione delle proprietà. Il fundus cessò in molti casi di costituire una unità di proprietà, di conduzione ed anche, come vedremo, di coltivazione. Unfundus poteva essere diviso, pur mantenendo l'unità catastale, fra due proprietari, in porzioni reali o ideali, o poteva entrare a fare parte di una proprietà più ampia, costituita a volte da fundi contigui, designata come possessio o massa; un fundus poteva essere affidato a più conduttori come più fundi a uno solo; poteva infine essere frazionato in parcelle, che costituivano l'unità materiale di coltivazione, quell'unità che il fundus aveva perduto, venendo a mancare la correlazione con 1'azienda contadina. Esso cessò frequentemente di costituire una struttura agraria, sia sotto 1'aspetto della proprietà che sotto quello della conduzione e della coltivazione - i due ultimi aspetti non coincidono necessariamente: il conduttore o affittuario può non essere e spesso non è un coltivatore, come nel caso dell' enfiteuta -; non possiamo pertanto considerarlo un «podere», nel significato che per 1'alto Medioevo a tale termine si assegna nella Langobardia, cioè una unità di conduzione e di coltivazione, costituita da parcelle di terra, anche non confinanti, denominata variamente massa1'iàa) coloniàa) so1's) mansus -, né ancor meno in quello bassomedioevale e moderno di azienda contadina a conduzione unifamiliare, di superficie maggiore del mansus e tendenzialmente compatta.
L'esemplificazione non manca nella documentazione ravennate. Fin dal secolo VI i documenti, pur assai rari, mostrano il frazionamento cui giungevano i fundi attraverso le vicende familiari: l'inventario del 564, già utilizzat035
, registra fundi frazionati fino ad un ventiquattresimo. Le vicende ereditarie potevano vanificare gli sforzi attuati in precedenza per la ricomposizione, ove possibile, dell'unità fondiaria: dal medesimo inventario risulta che quote delfundus Verutiano erano state acquistate in precedenza da proprietari diversi, che ne avevano ceduto un quarto, un altro quarto e un ottavo; ma nella partizione ereditaria un singolo acquisisce il diritto ad un terzo del patrimonio, quindi ad un terzo anche delle
59
ANDREA CASTAGNETTI
quote del fundus Verutiano, che viene pertanto suddiviso - per il momento, con ogni probabilità, solo in modo «ideale» - in due dodicesimi ed in un ventiquattresimo. Non si effettuava, in questo caso e nella generalità dei casi, una spartizione di beni per singole unità o singole quote già esistenti, ma tutti i beni, non importa se già frazionati, venivano ripartiti, in quanto ogni erede aveva diritto ad una porzione di tutto.
L'obiettivo del riaccorpamento poteva essere raggiunto integralmente in modo più facile, ne] caso che il fundus avesse subito una sola suddivisione, attuata non necessariamente in due metà: nell'anno 572 un funzionario bizantino acquista cinque uncìae o dodicesimi di un fundus che confina con il rimanente del fundus, che egli già possiede36 ; alla fine del secolo un altro funzionado bizantino compera da persone diverse due metà di un fundus 3ì
•
Il processo di frazionamento del fzmdus si accentua, prevalendo di gran lunga su quello di riaccorpamento. Citiamo, ad esempio, un rinnovo di enfiteusi da parte dell' arcivescovo ravennate a due coppie di coniugi: molte quote di fundi, espresse in dodicesimi, già in possesso di Leone, sono assegnate agli eredi per due terzi, segno che l'eredità è stata partita in tre quote, due delle quali appunto, per il momento in modo indiviso, sono assegnate alle due famiglie 38
; in un' altra enfiteusi viene assegnata la metà di due parti, su tre, di cinque dodicesimi di un fundus 39
•
Per ultimo, indichiamo un documento del 1028, che concerne direttamente il territorio ravennate: l'abate del monastero di Sant'Apollinare Nuovo assegna a livello un mans0 40
, che va ripartito in tre parti rispettivamente per due, quattro e altre due coppie di coniugi41
•
La frequenza della ripartizione in quote del fundus e, per converso, anche l'eventuale raggruppamento difundi numerosi in massa e o in curtes - ne riparleremo pongono il problema della corrispondenza del fomdus con 1'organizzazione aziendale agraria, se esso cioè possa essere ancora considerato un' azienda agraria, riflettendone l'organizzazione, o sia ormai una parcella catastale, un involucro rispetto alla organizzazione effettiva della terra e perfino alla suddivisione di questa rispetto alla proprietà e alla conduzione. Per quanto concerne i proprietari ed anche, in minor misura, i conduttori, che, ricordiamo, sono generalmente costituiti da enfiteuti, il fundus mantiene ancora una sua funzione, proprio perché offre ad essi la possibilità della individuazione, ubicazione e certificazione della proprietà o della disponibilità della terra. Non riflette, invece, quasi più la
realtà organizzativa agraria, soprattutto delle aziende contadine.
La divaricazione tra il fundus e l'azienda agraria contadina non è totale; esempi di coincidenza sussistono fino all'inizio del secolo XI: lo attestano concessioni a livello degli anni 882 42
, 912 4\ 918J~, 941-942 45, 943 46,
9524ì, 972 48 , 993 49, 9975°, 983.9985;, 100852 • Ma in alcuni
dei livelli citati è in atto il processo di frazionamento, nei casi nei quali il fundus è affidato a più persone, che non sembrano legate fra loro da alcun legame di parentela: quattro persone nel livello dell'anno 912, tre coppie di coniugi in quello del 941-942, due coppie di coniugi in quello del 943, due persone in quelli degli anni 993, 997 e 983-998. A volte il proprietario qui l'arcivescovo - si preoccupa di mantenere l'integrità del fundus, vietando la possibilità di vendita se non fra i coloni richiedenti, come nel livello del 993. Allo stesso tìne è diretta la clausola del livello del 952 che prevede, in caso di decesso senza eredi di uno dei coloni, la trasmissione delle quote al fratello o ai suoi eredi)).
L'intento di riaccorpamento poteva essere perseguito con successo, parziale, anche dai coloni: nel 1005 54 un abitante delfundus Casale, nella pieve di Santo Stefano in Colorita in territorio di Ravenna, secondo il documento, ma in realtà in quello di Faenza55
-, riceve in livello una quarta parte dello stesso /undus, del quale, come egli stesso dichiara, aveva ricevuto con un livello precedente un' altra quarta parte.
Se nella maggior parte dei casi i coltivatori ricevevano in livello porzioni di singoli fundi - ne tralasciamo i riscontri documentari, che possono essere facilmente reperiti attraverso l'elenco aggiornato fornito dal Montanari 56
-, non mancano esempi che mostrano come le terre affidate ad un contadino, che erano destinate pertanto a costituire, certo con scarsa organicità - oltre alle difficoltà derivanti dall'assegnazione di porzioni, si tenga presente che spesso i destinatari di livelli non erano una, ma più persone -, la sua «azienda», potevano corrispondere a porzioni di più fomdì: nel 983 1'abate del monastero di Sant'Apollinare Nuovo concede a livello, con obbligo di residenza, metà di una porzione di terre - la possibilità della loro individuazione doveva essere legata ad una concessione precedente dislocate in tre fundì, fra loro contigui, posti nella pieve di San Cassiano in Decimo, territorio ravennate5ì
•
Sfuggono in molti casi i criteri, se e quando vi fossero, che ,presiedevano all'assegnazione delle terre ai coltivatori. E probabile che, pur nel processo continuo ed accentuato di frazionamento del fundus, si cercasse di
60
LE STRUTTURE FONDLARIE ED AGRARIE
assegnare le porzioni relative, espresse comunemente unciae o dodicesimi e nei loro multipli, non mediante terreni compatti, ma con terre ubicate variamente e di natura diversa, in modo che ogni quota potesse comprendere, per quanto possibile, terre per la casa, 1'orto ecc. e terre a vite, seminative, prative, boschive ecc. I documenti non ci informano generalmente sulla ubicazione delle porzioni e delle terre, limitandosi, ribadiamo, a indicare le quote di uno o più fundi. Sussistono, tuttavia, alcuni indizi: nel 944 1'arcivescovo assegna a livello a due coppie di coniugi sortes ubicate «in diversis locis» all'interno della lnassa Alaratiana58
; un secolo dopo, nel 1035, le sortes et porciones di due fundi sono ripartite «per singulis peciis»59.
Possiamo concludere che l'azienda contadina è sempre meno legata alla struttura delfundus, che giunge progressivamente a perdere ogni connotazione agraria. Si creano in tal modo le condizioni, da un lato, perché ìl termine fundus assuma un significato prevalentemente prediale, fino a designare, come già avveniva da secoli in Langobar
, ìl territorio di un centro demico della consistenza di un villaggio, mentre l'ubicazione dei beni terrieri è data attraverso i «luoghi detti» o microtoponimi61
, dall'altro perché si inizi a ricorrere, la designazione dell' azienda contadina, a un termine specitìco, ancora una volta di importazione, quello di mansus, documentato a partire dai primi decenni del secolo XI 62 : il fenomeno è presente, come vedremo, nel territorio ravennate, ove il termine viene precocemente impiegato anche come unità di misura ideale, sulla quale si commisura la possibilità della costituzione appunto dell' azienda contadina 63.
UN TERMINE DI CONFRONTO INELUDIBILE:
LE STRUTTURE AGRARIE DELLA «LANGOBARDIA»
I Longobardi, abituati ad organizzarsi in gruppi legati da rapporti personali e sotto la guida di un capo, potevano con difficoltà concepire ed accogliere l'istituto romano della proprietà delle terre e della loro rigida ubicazione mediante la partizione catastale, basata, come subito vedremo, sull'indicazione del fundus, del pagus e del territorium civitatis, ignorando il vicus, che non aveva rilevanza alcuna ai fini appunto dell'ubicazione delle terre. Per i Longobardi, invece, per i quali il rapporto con la terra era eminentemente personale, questa di regola era descritta attraverso il rapporto con il proprietario, che solitamente abitava nel vicus, il villaggio cui faceva riferimento un territorio determinato, un locus,
nel quale erano ubicati i beni terrieri, rimanendo l'indicazione del vicus legata alla residenza dei liberi longobardi, a meno che costoro risiedessero, owiamente, nelle città.
Il termine fundus continuò ad essere impiegato, in modo occasionale, in età longobarda, nel significato approssimativo, non costante, del territorio di un villaggio. Si diffuse a partire dalla fine del secolo VIII, ma il suo significato cambiò profondamente rispetto a quello dell' età romana, che, invece, persistette nell'Italia bizantina.
Il fenomeno va posto in relazione alla tendenza, matasi in carolingia, alla territorializzazione dei distretti, maggiori, quali le contee, e minori, quali i territori dei villaggi. Il territorio del victts iniziò ad essere indicato con termini fissi, che divennero presto «tecnici»: tale significato stabile assunse in molte zone della Langobardia l'espressione focus et fundus, a volte fundus et focus. Entrambi i termini che la compongono risalgono all' età romana: fundus è la parcella di base del sistema catastale;
ne indica una ripartizione interna 64.
Ne consegue che vano risulta il tentativo, tante volte posto in atto, di risalire dai fundi documentati nei secoli a cavallo del Mille a quelli dell'età romana: si tratta di due realtà diverse. All' occasione, con l'impiego tuttavia di metodologie assai più complesse e sofisticate, si potrebbe risalire dal nome del vicus, del quale il locus et fundus esprime semplicemente il territorio afferente, a quello di un fundus romano, che avrebbe potuto dare il nome al villaggio, su di esso eventualmente esistente o più tardi sorto.
Accertato che nella Langobardia il termine fundus non indica un podere contadino né, tanto meno, un insediamento demico, minore o maggiore, quale potrebbe essere, nel secondo caso, quello della consistenza di un villaggio, rimane da indicare, in modo assai sommario, l'organizzazione agraria del territorio rurale, ai fini non solo della comprensione migliore delle strutture agrarie della Romania, ma anche per sottolineare con forza l'impossibìlità dell' attribuzione delle strutture delle regioni longobarde a quelle romaniche: è sufficiente in quest'ambito rammentare lo studio del Guillou, che attribuisce, sulla scorta di un documento del secolo VIII, riedito quale autentico in appendicé5, ma da tempo dimostrato falso in edizioni critiche precedenti, un'organizzazione poderale per massariciae, affidate a coltivatori66
, quando il termine stesso rinvia senza alcun dubbio alle regioni della Langobardia, affermatosi in età longobarda per designare il podere dipendente, dislocato nel territorio del villaggio, coltivato ed abitato da massari owero da coltivatori dipendenti, per lo più di condizione servile.
6r
ANDREA CASTAGNETTI
La grande proprietà di età romana non era scomparsa con l'insediamento dei Longobardi, ma subì una trasformazione: mentre i latifondi vennero frazionati, gruppi di poderi contadini dipendenti, a volte di superficie notevole, per il largo spazio occupato alloro interno dalle superfici incolte, poterono essere raggruppati in complessi detti casalia, costituenti la grande proprietà 67. Aumentò il numero dei piccoli e dei medi proprietari, abitanti nei vici, soggetti agli obblighi militari 6S, le cui tradizioni confluirono nel ceto degli arimanni dell' epoca carolingia, liberi proprietari collegati con il potere pubblico 69.
Nell' età carolingia la grande proprietà tese a strutturarsi in curtes, grandi aziende complesse, costituite da terre dominiche, a conduzione diretta, coltivate attraverso il lavoro dei servi e le prestazioni d'opera dei coloni dipendenti, e da terre massaricie, sulle quali risiedevano appunto i contadini, liberi e servi, prowisti di un podere, che, oltre a fornire le prestazioni, erano tenuti alla corresponsione di censi in denaro e canoni in natura 70.
«MASSA» E ~<C15RTIS» NELLA «ROMANIA»
ALTOMEDIOEVALE
Nella Romania non si verificò, come avvenne invece nell'Italia occupata dai Longobardi, l'interruzione della grande proprietà, ecclesiastica e laica, por se subirono
specialmente la seconda. Prima fra gli enti ecclesiastici, la Chiesa ravennate, detentrice fin dalla tarda età romana di grandi proprietà nell'Esarcato, nella Penta poli e in altre regioni, anche molto lontane, come in Lazio e in Sicilia, arricchita largamente dopo la guerra gotica con i beni confiscati alle chiese ariane, conservò buona parte delle sue proprietà, perdendo quelle che si trovavano regno longobardo o troppo lontane. Le grandi famiglie laiche, che continuarono a risiedere di prevalenza nella città e a gravitare nell' orbita degli enti ecclesiastici, mantennero anch' esse proprietà cospicue e altre ne ricevettero dalle chiese, soprattutto da quella arcivescovile, che abbondarono in concessioni, mediante lo strumento dell' enfiteusi, che prevedeva l'assegnazione di terre, solitamente assai estese, che potevano essere costituite anche da molti fundi, per una lunga durata, fino alla terza generazione, dietro corresponsione di un censo in denaro, raramente remunerativo. Destinatari delle enfiteusi furono abitualmente persone e famiglie appartenenti ai ceti dominanti, fra i quali figuravano anche alti funzionari bizantini, che si cercava in tale modo di legare all' ente attraverso un rapporto di clientela 71.
La continuità sostanziale di vicende istituzionali, sociali ed economiche rende ragione della continuità di organizzazione fondiaria della terra, che ripeteva sostanzialmente i modi dell'età imperiale; parimenti rimase in vigore la connotazione catastale.
L'esame che noi 72 ed altrF3 abbiamo potuto condurre di alcuni territori plebani, di molti dei quali possiamo constatare l'appartenenza alla Chiesa ravennate o ad altri enti ecclesiastici, conferma la persistenza della grande proprietà ecclesiastica - ne vedremo l'esemplificazione anche per il nostro territorio -, sia pure sottoposta a processi di frazionamento e di larvata alienazione, rappresentato soprattutto il secondo dalle concessioni enfiteutiche.
Le carte ravennati raramente ci testimoniano l'esistenza di piccoli proprietari terrieri; i rapporti con gli enti ecclesiastici, dai primi secoli del Medioevo, sono tenuti, per donazioni o, assai più di frequente, per concessioni enfiteutiche ricevute, da persone che sono già in una posizione economica e sociale di rilievo. Né vale in proposito la considerazione che la documentazione utilizzata è di provenienza ecclesiastica: analoga è anche la situazione documentaria della Langobardia, ma non certo quella delle campagne, nelle quali sussiste, come abbiamo accennato, un ceto di piccoli e medi proprietari, che detengono proprietà appunto piccole o medie, coltivate da massari, residenti i secondi non nel vicus, ma sul podere affidato. Le carte ravennati lasciano l'impressione, certamente da verificare, ma inevitabile, che i piccoli proprietari quasi non esistessero 74.
Secondo la tradizione della tarda età romana, le grandi proprietà, costituite da numerosi fundi, contigui per lo più tra loro, erano denominate massae: esse designano pertanto un aggregato di fundi a base geografica?5. Per alcune di esse studi recenti hanno individuato un processo di colonizzazione in atto 76.
Poiché le massae in molti casi traevano il nome dal più importante dei che le componevano, diffusa era la possibilità di confusione tra le due strutture fondiarie?? La massa non era provvista di un centro domocoltile né ripartita, come la curtis di area longobardo-franca, in terre dominiche e terre massaricie: quand' anche alcuni indizi in merito sussistessero, manca pur sempre il rapporto organico costituito dalle prestazioni d'opera sulle terre dominiche da parte dei coltivatori delle terre massaricie. L'impossibilità dell' esistenza di una organica struttura aziendale è testimoniata dal fatto che il centro stesso della massa, ilfundus più importante ed omonimo, ed ancor più altri fUl1di potevano essere concessi ad
LE STRUTTURE FONDIARIE ED AGRARIE
altri, in enfiteusi, solitamente, ma anche a livello78,
quando non era concessa l'intera massa. In quest'ultimo caso, invero, una concessione in enfiteusi non comprometteva in se stessa un' eventuale articolazione aziendale coffi1?lessa della massa, poiché l'enfiteuta avrebbe potuto mantenerla attiva, se esistente; ma certo una tale eventuale organizzazione veniva irrimediabilmente compromessa quando tutta la massa era ceduta in livello a un gruppo di coltivatori, come accadde alla metà del secolo x per la massa di Copparo, nel territorio ferrarese, non lungi da quello ravennate, allivellata dall' arcivescovo di Ravenna a più di venti consorti, con parenti e altri consortF9.
La denominazione di curtis, assegnata a volte a grandi proprietà della Chiesa ravennate, è la conseguenza, sul piano terminologico, dell'influenza delle regioni della Langobardia, che si diffonde nella Romania soprattutto a partire dalla fine del secolo IX, quando la regione entrò a fare parte del Regno Italico, un'influenza che si esercitava in forme molteplici e su piani vari è sufficiente ricordare nell'ambito istituzionale l'immissione di conti preposti ai territoria civitatis, che iniziarono, di conseguenza, ad assumere dalla metà del secolo X la qualifica di comitatus80
-, e che era iniziata fin dall' età carolingia attraverso, se non altro, una politica di legami familiari.
È il caso del matrimonio della franca Engelrada, figlia di Ucpoldo, conte di palazzo, con il duca ravennate Martino, della famiglia dei Duchi81
• A questo avvenimento specifico noi abbiamo fatto risalire la motivazione della sola menzione certa nella documentazione dell' area ravennate di una massa organizzata secondo i criteri del «sistema curtense», un'azienda curtense che appunto è stata impiantata su beni di proprietà di Engelrada. Costei nell'889 82 allivella a due coloni con moglie e figli alcuni appezzamenti si noti che essi sono designati attraverso misure di superficie, mentre non viene data l'ubicazione attraverso il fundus -, posti nella massa Prata, nella circoscrizione plebana di San Giovanni di Axcigala, in territorio di Faenza; i canoni richiesti non si discostano di molto da quelli in uso nella Romania, anche se sono fra i più consistenti, mentre caratterizzante è l'obbligo per i due coloni di fornire ciascuno due giornate di lavoro la settimana nella curtis, denominata Axcigata maior, di Engelrada. Pur non essendo l'obbligo delle due giornate settimanali fra i più gravosi riscontrabili nella Langobardia, è fra i più onerosi 83
•
La richiesta, relativamente diffusa anche nella Romania, di prestazioni d'opera ai coloni, in quantità esigua, riguarda servizi di trasport0 84
• Ancora, i canoni corrisposti dai coloni non confluiscono ad un centro curtense,
ma, pur provenendo da località ove si trovano delle massae o, a volte, essendo le stesse terre, concesse a livello, incluse in massae, debbono essere dai coloni medesimi, per obbligo contrattuale, trasportati nei centri di raccolta, situati nelle città, o anche a Ravenna; negli altri casi debbono essere condotti alle naves domnicae, al più vicino punto dì attracco, sulle quali per via ±1uviale giungevano ai magazzini della Chiesa ravennate, a Ravenna o in altre città 85. Alle massae non spettava nemmeno il compito, elementare, di raccolta dei prodotti provenienti dai canoni delle terre allivella te.
All'in±1uenza derivata dalla presenza di Engelrada va fatta risalire la terminologia, solo quella, adoperata per la definizione dei cospicui beni terrieri donati dalla prima al figlio Pietro, diacono della Chiesa ravennate86
: i beni fanno capo a curtes, ma non si tratta certo di curtes organizzate secondo il modello dell'area longobardo-franca. I beni sono costituiti dafundi e casalia, i secondi sostanzialmente assimilabili ai primi, non poderi, ma parcelle catastali in via di sparizione in quanto tali e di trasformazione in fundi. Una curtis - questa in territorio ravennate - è denominata Casale: essa ha assunto il nome, come vedremo, dal suo fundus Casale, probabilmente il nucleo originario o il più importante. Nonostante che queste grosse proprietà siano denominate curtes, sono nella sostanza equivalenti alle massae. Tale equivalenza risulta da un documento del secolo successivo, che concerne, in parte, gli stessi beni, donati da Pietro duca al monastero di Sant' Apollinare N uovo 87: sono ricordate quattro «curtes cum fundis et casalibus», espressione, come sappiamo, di per sé generica, di formulario, ma due delle quali - una è la curtis Casale sono costituite effettivamente da otto-dieci fundi; tutte le confinazioni sono indicate «regolarmente» in fundi. Si tratta pertanto non di curtes, ma di massae, costituite tendenzialmente da fundi contigui.
Possiamo concludere che non solo la massa non può essere assimilata alla curtis dell'area longobardo-franca di età carolingia, o postcarolingia, poiché non è un'organica azienda agraria, ma anche che le curies della Romania sono semplicemente frutto di un'in±1uenza terminologica della prima area sulla seconda, trattandosi di grandi proprietà che non si distinguono nella loro costituzione e nella loro funzione dalle massae, costituite, come sono, da un agglomerato di fundi, che non rappresentano, se non in casi ormai sporadici, un podere contadino, ma riflettono l'antica struttura catastale, valida ancora per l'ubicazione delle terre e 1'accertamento dei diritti di proprietà e di possesso, non riflettente la realtà organizzativa agraria dell'azienda contadina.
ANDREA CASTAGNETTI
Massae e curtes nella Romania non hanno svolto, né potevano svolgere la funzione di concentrazione di terre ed uomini, con la conseguente concentrazione del lavoro, come nella Langobardia, ave rappresentarono un richiamo per i contadini privi di terra o dotati in modo insufficiente, ma nello stesso tempo svolsero un' azione sopraffattrice dell'indipendenza economica degli uomini liberi, piccoli proprietari.
Non avvenne pertanto nei secoli IX e X una riorganizzazione agraria della grande proprietà, anzi continua e si accentua il frazionamento di questa come delle singole unità catastali e poderali. Per di più - questo è 1'elemento maggiore di differenziazione ai fini delle strutture agrarie, non solo, ma anche dei rapporti di potere e di produzione nelle campagne -, non viene posta in atto alcuna azione «correttiva», come avviene nella dia con la formazione della curtis. In tale mancato processo è ravvisabile una delle cause principali della mancata riorganizzazione territoriale del secolo ':"-,~;U~_H.\.., che nelle regioni longobardo-franche si processo di incastellamento; ivi curtis e castrum, con le necessarie differenze di epoca, struttura e finalità, hanno svolto funzioni in parte analoghe: concentrazione e controllo degli uomini, ristrutturazione delle terre in senso agrario ed insediativo 88
•
IL TERRITORIO DI RAVENNA MEDIOEVO
La definizione di territorium per indicare il distretto rurale facente capo alla città discende direttamente dall' età romana. Il termine è il solo che continua ad essere impiegato nella regione della fino a che nel secolo X non inizia ad apparire quello di comitatus, mutuato, come in altri casi, dagli usi del Regno Italico, coevo alla comparsa nella regione dei conti, ufficiali, come nel Regno, preposti all' amministrazione degli antichi territoria 89
•
Poiché il fundus non una ripartizione amministrativa del né nella Romania svolge tale funzione il vicus, la sola ripartizione intermedia tra territorium e fundus fu la circoscrizione ecclesiastica parrocchiale, quella della pieve rurale, che inizia ad essere documentata nella seconda metà del secolo VIII e diviene generale in seguito: tutta la circoscrizione plebana, tendenzialmente, ad essere formata in modo «regolare» da fundi. tecnica ubicatoria delle terre si stabilizza attraverso il riferimento alfundus, alla plebs e al territorium civitatis. Va sottolineato che la circoscrizione
parrocchiale offre il supporto alla distrettuazione civile, ma la in quanto tale non assume alcun ruolo in
contesto, se non quello di punto di riferimento ntTr<lrlrn per i fundi che sono inseriti nella sua circo
'-U,U"""U'- ovvero nel territorio che da essa dipende sotto ecclesiastico 90.
delineazione di una carta storico-topografica delle rurali di un territorium ne precisa al contempo
e i confini. Esulando questo obiettivo dai nostri compiti, noi ricorriamo alla carta tracciata dal Vasina, che riporta l'ubicazione delle pievi delle diocesi dipen· denti dalla Chiesa metropolitana di Ravenna 91.
Il di Ravenna risulta essere costituito, oltre che dalla circoscrizione facente capo alla Chiesa cittadina, comprendente la città e i suoi dintorni, che, pur non delineati nella carta, si presentano assai ampi ne portiamo subito un'esemplificazione -, dalle ni parrocchiali facenti capo a undici pievi, che \"~'-.H'-,H~,,mo per zone. Nella regione nord-orientale, verso il Ferrarese, sono dislocate le pievi di San Venanzio di Coccanile, al limite estremo settentrionale, poi, "".. \.H\.1\..l.1
do, San Pietro di Ostellato, Santi Vito e Modesto di Dogato e Libolla, San Martino di Maiero, Santa Maria di Porto Maggiore, San Giorgio di Argenta; a sud di Ravenna, verso Cesena e Forlì, nella zona di Decimo· Decimano, San Cassiano, San Zaccaria, Santa Maria in Alfiano presso Casemurate, San Pietro in Quinto, San Pietro in Cistino.
La maggior parte dei documenti altomedioevali, da noi reperiti ed utilizzati, per il periodo dalla del secolo IX
ai primi decenni del secolo , concernenti direttamente il territorio di Ravenna e consistenti tre decine, fa solitamente riferimento, tranne che caso dei primi tre documenti dei secoli VI-VIlI, ad una pieve per l'ubicazione dei beni oggetto del giuridico e riguarda terre situate nelle pievi della zona meridionale di Decimo-Decimano93, soprattutto nella pieve di San Cassiano, poi in quella di San Zaccaria; due soli documenti concernono la di San Pietro in Quinto e uno quella di San Pietro in Cistino, situate sempre nel territorio di Decimo. Pochi documenti riguardano la zona a nord-ovest: la circoscrizione della pieve di Santa Maria di Porto; ad essi può essere aggiunto un inventario di beni, cui accenneremo.
Sfuggono o male si adattano all'ubicazione per territori plebani e, tantomeno, per fundi gli ampi spazi incolti che ancora sussistono presso la città di Ravenna e in altre zone del suo territorio.
A nord della lungo il litorale, si stendeva per una
LE STRUTTURE FONDIARIE ED AGRARIE
ventina di chilometri e una profondità di due l'insula di Palazzolo: donata alla metà del secolo IX, all'atto della fondazione, al monastero di Santa Maria di Palazzolo, era costituita in prevalenza da superfici incolte, una caratteristica che, nonostante gli sforzi di «colonizzazione» della comunità monastica, la connotò per lungo temp094: il documento di donazione95 ne indica l'ubicazione attraverso confini naturali, quali il mare e i corsi d'acqua96
•
Anche di una curtis di formazione probabilmente recente, sorta un luogo incolto, non è data l'ubicazione per pieve e fundi, ma attraverso fiumi, fosse e paludi, che la attorniavan0 97
: si tratta della curtis Molino, situata presso il canale Montone, a sud-est della città, donata dall'arcivescovo ai canonici cantori della Chiesa ravennate98
•
Un'ampia superficie di terra, situata da entrambe le parti del Savio, connotata quale Iaea integro, certamente in prevalenza incolta, e delimitata da confini naturali mare e corsi d'acqua -, si estende in due circoscrizioni plebane di due diversi territoria: pieve di San Cassiano in Decimo, in territorio di Ravenna, e pieve di Santo Stefano Pisiniano, in territorio di Cesena99 •
LE STRUTTURE FONDIARIE NEL TERRITORIO DI RAVENNA NEL PRIMO MEDIOEVO (SECOLI VI-VIII)
Le strutture fondiarie riflettono la ripartizione catastale delle terre e corrispondono solo in pochi casi, per quanto possiamo alle strutture dell'azienda agraria: esse concernono prevalentemente l'assetto e la distribuzione della proprietà e del possesso dei grossi concessionari di enfiteusi. Ci soffermiamo dapprima sulle strutture fondiarie del territorio ravennate nei secoli VI-VIII, poiché esse mostrano più di quelle dei secoli seguenti la continuità con le strutture fondiarie di età romana.
Il primo fttndus situato territorio di Ravenna, il fttndus Pie/tili, di cui non è l'ubicazione per pieve come è ov\1io, poiché questa ubicatoria entra in uso più tardi -, è menzionato nell'anno 504 10°, in occasione di una vendita di una superficie di terra indeterminata, spatium agri, situata al suo interno; non ne sono forniti i confini, come non sono indicati per il fundus Saviliano, elencato in un inventario dell'anno 564101: il fundus è frazionato, poiché al proprietario appartengono solo due unciae o due dodicesimi, mentre gli appartengono quattro unciae di una casa, in territorio ravennate,
denominata Casa Nova, che riflette direttamente quello impiegato nelle descrizioni fondarie delle tavole di Velleia e Benevento del II secolo.
La sostituzione del casa con casale, in un significato e una funzione analoghi, è provata dal documento successivo, che concerne direttamente il nostro territorio, a distanza di due secoli. Si tratta dell'iscrizione epigrafica dell' anno 731, nella quale è descritto, senza indicazione di territorio plebano, il fundus Gammillaria, definito fertilis, fecondo perciò di prodotti agricoli. Esso è circondato da casaZza: ricordiamo le funzioni di avanguardie colonizzatrici dei casalia, qui confermate, poiché si tratta di una zona, come si deduce dalla descrizione stessa, ricca di superfici incolte, parte certamente ricoperte da selve, che non dobbiamo giudicare, tuttavia, del tutto improduttive, perché esse potevano offrire legna da ardere, come il documento afferma, e ghiande in abbondanza, essenziali per il pascolo dei porci. Esse avrebbero certamente potuto fornire anche legname da costruzione, se non altro le piante produttrici di ghiande, ma è probabile che verso queste essenze arboree fossero stabiliti vincoli protettivi. Non ci soffermiamo oltre sull'argomento, oggetto di un saggio specifico all'interno della presente Storia.
LE STRUTTURE FONDIARIE NEL TERRITORIO DI RAVENNA DALLA FINE DEL SECOLO IX AL QUARTO DECENNIO DEL SECOLO XI: «MASSA» E «CURTIS»
Il periodo che va dalla fine del secolo IX al quarto decennio del secolo XI, periodo che supera di poco il C"-'-UilJ.i' del secolo X stabilito per i contributi al nostro volume, presenta una sua unità, in quanto alla fine del secolo IX assistiamo, da un lato, alla ripresa della documentazione concernente direttamente il territorio di Ravenna, dall'altro all'introduzione nello stesso territorio del termine mutuato dalle regioni della Langobardia, COS1 come il terzo e il quarto decennio del secolo XI viene introdotto, proprio nel territorio delle pieve di San Cassiano in Decimo, su cui più ampiamente ci ~offermeremo, il termine mansus, di analoga derivazione. E bene, tuttavia, ricordare che, mentre l'introduzione del primo termine rappresenta una semplice sovrapposizione terminologica alla realtà fondiaria della massa, quella del secondo risponde ad una esigenza pratica, alla necessità cioè di esprimere le forme effettive dell' organizzazione agraria, che si concretizza appunto nei modi di organizzazione delle terre ai coloni per la coltivazione, la
ANDREA CASTAGNETTI
cui strutturazione di base dovrebbe essere costituita - ma non sarà così in tutti i casi - dalla singola azienda agraria contadina, per l'indicazione della quale la terminologia notariJe in uso nella documentazione dell' area ravennate non offriva un termine specifico.
I La massa, come sappiamo, indica una grossa proprietà
fondiaria, costituita da fundi tendenzialmente contigui. Le grandi proprietà della chiesa ravennate nei territori della Romania erano, ancora nel secolo x, articolate in massae. Mancano, tuttavia, le attestazioni dirette per il territorio di Ravenna, tranne che per la zona nord-occidentale, al confine con il Ferrarese.
Un Regestum bonorum della Chiesa ravennate del secolo x, databile più precisamente, almeno in alcune sue parti, agli anni 970-982, concernente il territorio ferrarese e le zone ravennati finitime delle pievi di Santa Maria di Porto Maggiore, di San Martino di Maiero e di San Pietro di Ostellato 102, riporta fra i beni inventariati le massae di Grasile, Veteraria e Maiero.
La massa di Maiero reca lo stesso nome, forse la ospita sulle sue terre, della pieve di San Pietro di Maiero. In relazione con la massa Veteraria va posto il fundus di Porto Veteraria, inventariato nello stesso Regestum, nonché quello di Veterana, documentato in un livello del 955,03, incluso espressamente nella pieve di Santa Maria di Porto, in territorio ravennate: è probabile che si tratti non di due, ma di un solo fundus, costituente, in questo caso, ilfundus più importante delIa massa, alla quale dà il nome. La massa Grasile infine torna ad essere documentata nel 1034, inclusa nella medesima pieve di Santa Maria 104.
Altrettante curtes sono attestate nel territorio di Ravenna: oltre alla curtis Casale, sulla quale ci soffermiamo nel paragrafo seguente, quella di Molino, della quale abbiamo già detto, e quella di Maliano. Di quest'ultima, che sarebbe stata dotata difundi e casalia, secondo l'espressione di formulario impiegata nel 973!O5, ben poco conosciamo, se non la sua ubicazione nella pieve di San Zaccaria in Decimo e il fatto che essa confina per tre lati con altrettanti fundi, sui quali avremo occasione di tornare a soffermarci. Come già sappiamo !06, si tratta in questo caso non di una curtis organizzata secondo il «sistema curtense», tipico della Langobardia, ma di una massa, tendenzialmente compatta, confinante con altri fundi, la cui costituzione effettiva ci sfugge: potrebbe essere costituita da una sola vasta superficie, come potrebbe essere al suo interno ripartita in più o meno numerosi fundi.
LA «CURTIS CASALE»
La curtis Casale è di gran lunga la più documentata fra le tre note del territorio ravennate. Nella sua prima comparsa, nell' atto di donazione dell'896 da parte della contessa Engelrada al figlio Pietro, essa è definita con l'espressione generica di «curtis cum fundis et casalibus» ed è situata nella pieve di San Cassiano in Decimo, in territorio ravennate, senza alcuna indicazione di confini. Anche a questa curtis abbiamo già fatto riferimento in merito alla sostanziale equivalenza delle curtes della Romania con le massae. Nel caso specifico l'equivalenza è provata da un documento posteriore, quello del 973 ora ricordato, concernente la stessa curtis, che ce ne mostra la sua struttura, sia pure a distanza di un secolo: non solo la curtis confina su quattro lati con quattro fundi, ma dei fundi, dei casalia e delle appendiciae, compresi nella consueta formula generica, sono indicati il nome e la natura. Veniamo ad apprendere che nel concreto esistono solo fundi, ben dieci - invero, come vedremo, dovevano essere undici, con il fundus Casale -, tutti con il loro nome, situati nelle circoscrizioni di due pievi, quelle di San Zaccaria e di San Cassiano, evidentemente in zone confinanti, dal momento che essi debbono essere fra loro contigui, considerato che la massa è presentata come se fosse ma non lo era, come vedremo - compatta, poiché le confinazioni sono costituite su quattro lati da quattro fundi: Matumano, Penaciano, Casa Marciani, Paoni. I fundi della curtis sono Man"tima, Sorciano, Cistano, Casella, Turicla, Gumano, Aviltano, Coriliano, Filcioni, Lisiniano. Un altro fundus doveva essere necessariamente compreso nella curtis, quello di Casale, non solo in forza dell' argomentazione che in generale la curtis-massa porta lo stesso nome del suo fundus più importante, ma perché esso, nel nostro caso, è effettivamente attestato in due documenti degli anni 1007 ,07 e 1028 108
, posto secondo entrambi nella pieve di San Cassiano. Questo di per sé non sarebbe sufficiente a darcene la certezza, stante la diffusione del nome, ma nel primo documento il fundus Casale appare quale confinante del fundus Turicla, che conosciamo qualefundus della curtis Casale. Ne deduciamo che nella descrizione della massa, descrizioni invero poco frequenti, viene omesso il fundus omonimo alla massa stessa, il che ci fa comprendere in concreto come potesse awenire che uno stesso nome fosse impiegato per una massa e un suo fundus.
La compattezza territoriale della curtis-tnassa al suo interno non è forse totale: due deifundi che la compongono, Aviltano e Coriliano, appartengono al proprietario
66
LE STRUTTURE FONDIARIE ED AGRARIE
solo parzialmente, rispettivamente per sei e quattro once, ovvero per una metà e un terzo. Poiché le confinazioni
t. sono fornite per fundi, anche nel caso della eurtis Casale dobbiamo presupporre che esse concernano non le porzioni dei due fundi, ma i due fundi nella loro interezza, come per i fundi rimanenti. Le motivazioni di tale situazione possono essere sostanzialmente due: la curtis nel suo processo di costituzione ha potuto acquisire due fundi solo in parte o le parti mancanti dei due fundi sono state concesse ad altri, scorporandole dalla massa. Dal momento poi che non conosciamo a quale titolo la contessa Engelrada detenesse la eurtis, se in proprietà, propria o dal marito, cioè, o in enfiteusi, non possiamo assegnare a lei l'iniziativa di una delle due azioni, che potrebbe essere stata effettuata in un tempo anteriore dalla Chiesa o dal duca Martino.
Alcuni documenti posteriori, che concernono pochi fundi della eurtis, ci permettono forse di comprenderne meglio la struttura. Iniziamo da quei fundi che confinano con altri fundi della eurtis. Un gruppo compatto era costituito daifundi Sordano-Sortiano) Maritima e Turicla, fra loro contigui o eoerentes, come afferma un documento degli anni 982-983 109
• La contiguità fra Sordano e Turicla è ribadita da un documento del1007l10, dal quale apprendiamo che entrambi confinano con il fundus Casale, quello che ha dato il nome alla eurtis: i fundi contigui salgono a quattro: Maritima) Sorciano) Turicla e Casale.
Osservazioni interessanti circa la struttura della eurtis provengono dalla constatazione che tra le confinazioni dei singoli fundi appaiono quelli confinanti con la eurtis, ma anche altri, del tutto estranei,
Una confinazione dei fundi Sorciano e Turicla è costituita dal n'volo Paoni, che può con facilità essere collegato alfundus Paoni, uno di quelli confinanti con la eurtis. Un altro di questi, il fundus Mathoniano, appare tra le confinazioni di unfundus CoL] - il testo è guasto: forse si tratta del fundus Coriliano -, assieme ai fundi Sortiano e Cisano, entrambi compresi nella eurtis, e al fundus Casaliclo, non compresovi tll, Possiamo quindi accostare anche Cisano-Cisiano ai quattro fundi contigui sopra ricordati, confinanti, in modi difficilmente accertabili nella loro configurazione concreta, con due fundi a loro \701ta confinanti della curtis: Paoni e Mathoniano. Nessun indizio abbiamo rinvenuto per le altre due confinazioni della eurtis, i fundi Casa Marciani e Penaciano.
TI fundus Cisiano è vicino nello spazio non possiamo dire che ne sia confinante - aifundi Sortiano e Mathoniano, il primo della eurtis, il secondo una sua confinazione.
Poiché esso è situato al limite della curtis, ci aspetteremmo che fra le sue confinazioni ci fossero solo fundi della eurtis e fundi confinanti con la eurtis; invece una delle sue confinazioni è costituita dalfundus Feleeti, che non appare né fra i primi né fra i secondi. Dobbiamo supporre che fra le confinazioni del fundus Cisiano fosse il fundus Mathoniano, presente fra le confinazioni della eurtis: il che può essere, poiché i due fundi erano indubbiamente vicini, confinando entrambi con uno stesso fundus, forse Co[riliano).
Le confinazioni della curtis, anche nella zona del gruppo di fundi ora esaminato - lvIaritima, Sorciano, T uticla, Casale e Cisiano -, erano fornite certamente in modo sommario: non ci spiegheremmo altrimenti perché fra esse non compaia ilfundus Felecti, confinante delfundus Cisiano, Né possiamo supporre che il primo potesse non trovarsi all'esterno della euttis, ma costituirne un'enclave, poiché esso confina o è collegato a sua volta con altri fundi: Feleeti confina con ifundi Campiliano e Ustilianum; Campiliano confina, oltre che con Feleeti e Usti/iano, con Felidano. Poiché Feleett~ Campiliano e Ustiliano non fanno parte della eurtis, riteniamo probabile supporre che essi ne fossero posti all' esterno; ci sembra che vada rifiutata l'ipotesi che essi costituissero un' enclave: da un lato, questa apparirebbe troppo vasta, dall'altro, non si rinvengono tra i confini altrifundi della eurtis, come ci aspetteremmo in questo caso.
Analoga considerazione potrebbe essere fatta per il fundus Casaliclo, se accettiamo l'ipotesi dell'identificazione del fundus, con il quale confina, Co[riliano] , con il fundus appunto di Cori/iano della eutlis Casalis; in ogni caso esso è situato assai vicino alle due confinazioni, costituite da due fundi della eurtis, Sorciano e Cisano. Orbene Casaliclo appare in un altro documento 112 quale confinante del/tmdus Sempruniano, posto nella circoscrizione plebana di San Zaccaria, presso la chiesa plebana stessa,
Non solo viene confermato che una buona parte dei fundi della eurtis sono ai confini della circoscrizione plebana di San Cassiano, come è deducibile, d'altronde, dal fatto che la eurtis è ubicata, ricordiamo, nelle due circoscrizioni e ribadito dall'appartenenza, che subito constateremo, delfundus Lisiniano alla pieve di San Zaccaria, ma l'edificio di quest'ultima doveva trovarsi a poca distanza dai confini della circoscrizione della prima. Può essere prospettata l'ipotesi di una costituzione più tarda della pieve di San Zaccaria rispetto a quella di San Cassiano.
N ella circoscrizione plebana della pieve di San Zaccaria doveva essere situato il fundus Lisiniano, ai limiti della eurtis: in un documento del 959 esso è elencato, con altri
ANDREA CASTAGNETTI
fundi, non noti - Pangualicclo, Kasa Hulianula, Eruniano - tra le confinazioni di due fundi contigui, Glaudiano e Cisan elio , collocati appunto nella pieve di San Zacca~ ria 113; perché, ancora, in analogia alle considerazioni sopra esposte, tutti ifundi ora nominati sono estranei alla curtis. Il fatto che nessuno di questi ultimi appaia fra le confinazioni della curtis ribadisce quanto abbiamo asserito circa la sommarietà della descrizione relativa; per le stesse ragioni, per il fatto cioè che ilfundus Lisiniano non è collegato a nessun altro fundus della curtis, siamo indotti a supporre che non fosse ad essi contiguo, il che confermerebbe ulteriormente quanto abbiamo affermato circa la non compattezza territoriale della curtis, deducibile dalla presenza di frazioni di fundi.
La maggioranza dei fundi della curtis era inclusa nella pieve di San Cassiano; vi erano compresi sicuramente i fundi di Maritima, Sorciano, Turicla l14, Casale l15 e Cisiano 116.
Rispetto alla dislocazione della curtis, dei fundi e delle pievi nel territorio di Decimo-Decimano possiamo ancora fare notare come il fundus Turicla, assieme al fundus T uricla Maiore - i due fundi sono probabilmente frutto di una suddivisione antica e perciò li possiamo ritenere fra loro contigui -, confini con il fundus Arzilioni, situato nella pieve di San Pietro in Quinto, anch' essa nel territorio di Decimo 117.
Non conosciamo quale fosse la situazione della curtis nel 973, al momento dell'elencazione dei fundi, per quanto concerne la conduzione, in merito ad eventuali concessioni enfiteutiche, e la lavorazione delle sue terre, in merito ad eventuali assegnazioni in livello. Certo è che di organizzazione curtense non è possibile parlare. I documenti posteriori, tra gli ultimi decenni del secolo X e i primi del successivo, concernono contratti di livello l18
,
nei quali non solo è assente l'obbligo di fornire prestazioni d'opera da parte dei coltivatori delle terre allivellate sulle terre dominiche, ma non sono nemmeno richiesti, tranne che in un caso l19, servizi di trasporto, presenti, invece, con frequenza, sia pure in quantità non elevata, nei livelli della ROma11ia 120
•
Infine, i canoni, anche nel livello del 1028 che ha per oggetto terre poste nelfundus Casale, ilfundus che dava il nome alla curtis omonima, debbono essere trasportati a Ravenna; in un livello 121 viene richiesto il loro trasporto presso un punto di attracco dove possa giungere la navis domnica.
LE STRUTTURE FONDIARIE NEL TERRITORIO
DI RA VEt--;NA: IL «F(;t--;DUS»
Il territorio ravennate presenta, nel periodo prescelto, una ripartizione del suolo agrario in fundi, unità fondia~ rie che meglio potremmo definire quali parcelle catastali; mancano del tutto i casaZza, dei quali rimane ricordo solo nella toponomastica. Come abbiamo ormai ripetutamente affermato, il fundus indica una porzione di suolo agrario, tendenzialmente stabile nel tempo, con confini certi, costituiti su quattro lati da altri fundi o da elementi naturali.
Se si eccettua il riferimento, non frequente, ad una massa o curtis, nella quale il fundus sia compreso, riferimento che avviene per la descrizione della massa, come nel caso della curtis Casale, o perché scorporato da questa, «ex corpore massae ...», l'ubicazione «regolare» del fundus avviene mediante il riferimento al territorium della città e alla circoscrizione plebana.
La scarsità di documentazione concernente il territorio ravennate, in senso proprio, permette poco più che un elenco difundi, sparsi per pievi, tranne che nel caso della pieve di San Cassiano in Decimo, per la quale sussiste la documentazione più ampia fra quella da noi esaminata, interessante quarantotto fundi rispetto al totale di settantatré, corrispondente ai due terzi.
Degli undici fundi della curtis Casale e dei quattro confinanti abbiamo detto. Numerosi/undi sono nominati in una concessione enfiteutica da parte del monastero di San Martino a Maria, figlia di un console e vedova di un console e tribuno 122
; metà delfundus Soboriana-Floriana e un quarto del fundus Balneolo nella pieve di San Cassiano; essi confinano rispettivamente con i fundi Aguciano, Luùanula, Moriana e Curiano e con i fundi Iulianum Maiore, Vispiciano, Folomano Maiore e Foloniano Minore. Si notino, da un lato il frazionamento dei fundi concessi, dall' altro l'esistenza di un processo precedente di suddivisione di fundi, indicato dai nomi di Foloniclno Maiore e Foloniano Minore, nonché da Luliano Maiore e Lulianula.
Più consistente la concessione enfiteutica assegnata dall'arcivescovo di Ravenna ad un Traversara 123
: unfundus intero, Munnù; uno o più fundi senza nome per le lacune del documento; un terzo del fundus Domicilii; il fundus lvIauronico detto anche Incianicus, forse intero; due terzi del fundus Ripulis; due metà dei fundi Buruniano e Casarza. Tra le confinazioni, elencate parzialmente, appaiono i fundi Albone, Murcione, Mecuana, Columnata, Carbonianum, Apollinis, Campilione, Rovorata, Cenuclata.
68
LE STRUTTURE FONDIARIE ED AGRARIE
del fundus Funianula Minore viene soffermarci a ripercorrere tutte le considerazioni data in nel 959 124
, Dei due fundz: Felecti e Campiliano, concessi nel 974 in enfiteusi per dieci once a un membro di una famiglia ducale, e deifundi confinanti già abbiamo trattato 125; il fundus Campiliano appare anche in un documento dell'anno precedente l26
; abbiamo trattato anche del fundus Co[riliano] e delle sue confinazionP27 e dei fundi, fra cui Casale, che appaiono nel 1007 128
• Un'enfiteusi del 982 concerne la terza parte del fundus Corneliano, ma manca descrizione dei confini 129. Un terzo dei fundi Casanovula e Casavetere sono oggetto di una concessione nel1007 13c
• Ilfundus Casale è nuovamente presente con un fundus Porcile in un livello del 1028 l31 •
Diciassette fundi presenti nella nostra documentazione sono inclusi direttamente o sono nominati come confinanti di fundi inclusi nella pieve di San Decimo, poco più di un quinto del totale e di un terzo dei fundi documentati per la pieve di San Cassiano.
Un' enfiteusi del 959 concerne due metà dei fundi contigui Glaudiano e Cisianello, che confinano con i fundi Lisiniano, Pangualicdo) Kasa Hulianula e f 'J'ZJY"'''
. Un'altra enfiteusi del 964. concessa ad un vir eiarissimus, ha per oggetto il fundus intero Sempruniano w , confinante con ifundi Cursinianum) Parucianum e Casalido 134
• Due livelli degli anni 1000 e 1005 interessano ancora la pieve: con il primo 135 sono assegnati beni nei fundi contigui di Maliano e Casaveda: non sono descritti i confini; questi sono nominati nel secondo livello 136
, con il quale sono assegnate a più persone porzioni varie degli
fundi, che sono detti confinare con i fundi MelonAncariano, Trungnano e Variaula. Nel 1034, infine, nominato il fundus Panigale 137.
Nel territorio di Decimo, come sappiamo, erano incluse le circoscrizioni di altre due pievi. Per la di San Pietro in Quinto una concessione del 965 ricorda i fundi Albuciano lvlaiore e Albuciano Minore, sembra integralmente, e due once del fundus denominato Silva Prati o Petritulum 138; in un livello del 980 è assegnata una metà del fundus A rzilioni, che confina con i fundi Casula, Turida e T uricla Alaiore, gli ultimi inclusi nella pieve di San Cassiano 139. Nella pieve di San Pietro in Cestino un documento del 998 ricorda i fundi Subtalmo e Maluano, concessi dall' arcivescovo ai figli di un conte Lamberto 14o
•
Dalla scarna documentazione della zona nord-occidentale traiamo i seguenti nomi difundi: Ostellato, senza indicazione di pieve 14
\ e Veteraria l42 , fundus omonimo
della massa Veterarié"3.
relative ai fundi, svolte nella prima parte, ci limitiamo il sottolineare uno degli aspetti di rilievo, connessi alla proprietà e alla conduzione della terra, quello che concerne le porzioni e la quantità dei fundi che risultano appunto in proprietà o in possesso enfiteutico di chiese e laici. Quando la loro disponibilità è ampia, di frequente essi sono posseduti in integro. Otto dei dieci fundi della curtis Casalis sono posseduti per intero, ovvero i quattro quinti; solo due in porzioni ovvero un quinto. Unfundus intero è assegnato nell'enfiteusi del 964 144; due fundi interi, con altri frazionati, sono assegnati nell' enfiteusi del 965 145 ;
altri due nel 998 146•
Costantemente frazionati appaiono, come è naturale aspettarsi, i fundi nei contratti di livello.
IL «FUNDUS» E LE STRUTTURE AGRARIE
La possibilità di illustrare la realtà dell' organizzazione agraria del suolo, ai fini cioè della sua coltivazione, è fornita solo dai contratti di livello, poiché non esiste per il territorio ravennate, come per la Romania in genere, quella documentazione, preziosa per l'aspetto specifico, rappresentata nella Langobardia dagli inventari di terre, coloni e redditi, la cui redazione, d'altronde, è legata alla diffusione del «sistema curtense» .
I livelli interessanti direttamente il territorio ravennate sono cinque per la seconda del secolo x, quattro dei quali dal 980 in poi; uno x e XI secolo, due nel primo decennio, uno nel terzo decennio del secolo XI, secondo l'arco cronologico adottato.
Non sussistono esempi di coincidenza, pur presenti in altri territori 148, tra fundus e terre assegnate a una o più famiglie contadine per la coltivazione. Quattro volte è fatto riferimento a porzioni della metà dei/undi I49
, una ad un terzo 150 ed una ancora ad un quarto l51
, porzioni che, come subito vedremo, subiscono ulteriori frazionamenti. In altri casi vengono concesse terre, definite in modo generico quali l'es, senza riferimento a porzioni precise di fundi 152
• In alcuni casi la dispersione delle terre è attenuata dal fatto che i fundi sono tra loro contigui 153.
Ciò che maggiormente colpisce è, più che il frazionamento in sé deifundi, il processo ulteriore di frazionamento che essi subiscono nei nuovi contratti di livello, attraverso due vie: da un lato la suddivisione delle terre assegnate rispetto alla condizione precedente; dall' altro il numero, frequentemente elevato, di destinatari, che porterà inevitabilmente ad altri, anche intensi, frazionamenti.
A~DREA CASTAGNETTI
quanto concerne la prima via, un caso viene assegnato un terzo delle res, già poste in due fundi, MaZiano e Casavecla, prima detenute da un altro colono, residente su uno dei fundi, senza indicare la proporzione con la totalità dei fundi 154
; pochi anni dopo, un terzo dei medesimi fundi certamente costituito da terre non coincidenti con quelle oggetto del livello precedente è ripartito in due metà assegnate a due coppie di coniugi 155. Poco oltre illustriamo un esempio di frazionamento esasperato, che contraddice un precedente tentativo di «razionalizzazione» nell' organizzazione agraria 156.
Per quanto concerne la seconda via, i destinatari, oltre una sola persona 157, possono essere due coniugi 158
con altri parenti 159 ; tre frateUi160; ma anche più di otto persone: due coppie di coniugi ed almeno altri quattro individui il testo è lacunoso 161 -; fino a giungere ad otto coppie di coniugi con altre due persone 162.
Tali fenomeni induco; lO a ritenere che, conformemente a processi generali, accertabili per l'Italia padana, la popolazione fosse in forte e rapido incremen~o e che a questo si facesse fronte attraverso la riduzione dell'incolto e l'aumento della superficie coltivata, destinata soprattutto alla cerealicoltura.
Una situazione così complessa poteva rendere vani anche gli sforzi di riaccorpamento che pure sembra di poter intravedere dalla nostra pur scarsa documentazione, tentativi che scaturivano dalla constatazione della difficoltà per i coloni nella coltivazione della terra, ripartita vieppiù in appezzamenti ridotti e staccati, nonché dall' ancor maggiore difficoltà per il proprietario di mantenere un pur minimo grado di efficienza nell' amministrazione' basata su alcuni elementi essenziali: annota-
delle"variazioni nelle persone dei coltivatori e nelle superfici assegnate e corrispondenti variazioni nella quantità e modalità di riscossione dei canoni.
Indizio di una volontà di «razionalizzazione» è rappresentato dall'impiego del termine mansus in due documenti del terzo e quarto decennio del secolo XI, termine, come sappiamo 163, d' «importazione» dalla Langobardia, ove esso designa un «podere» contadino. Ma se il documento del 1034 ci mostra effettivamente l'intento raggiunto, poiché si dichiara che tre appezzamenti all'interno di una massa costituiscono un manso ,il secondo documento, di poco precedente, ci mostra un fallimento completo.
Nel 1028 1'abate del monastero di Sant'Apollinare Nuovo concede a livello un manso, costituito da appezzamenti, non descritti, situati in due fundi contigui; il manso costituisce la metà di quanto prima deteneva un
altro colono qui sembra che si persegua da parte del proprietario un intento di riorganizzazione o almeno di «razionalizzazione terminologica»: alla metà delle terre coltivate in precedenza si assegna il nome di manso, al momento della nuova concessione. Ma se poniamo attenzione alla descrizione dell' oggetto e ai destinatari del livello, possiamo subito constatare come si ricada, esasperandolo, processo solito di frazionamento: la metà, denominata manso, viene ripartita in tre parti e ciascuna di queste viene assegnata a più persone, rispettivamente due coniugi e due cognati, quattro e due coppie di coniugi. Da una singola unità lavorativa, costituita da una sola persona e, presumibilmente, dai suoi familiari, si passa a sei unità lavorative. Di fronte ad una tale complessità, poco vale che fra gli obblighi contrattuali, al momento di fissare quello della residenza, consueto livelli, l'abate imponga che almeno tre di loro vi risiedano stabilmente. Le divisioni reali, per la necessità di coltivazione e di introito dei redditi e di pagamento dei canoLli, nonché, di lì a pochi o molti anni, le inevitabili successioni ereditarie frazioneranno le terre e i gruppi di coltivatori in un modo, che non esitiamo a definire caotico, cui certamente non porrà rimedio, da sola, l'adozione di un termine nuovo, mansus, come l'introduzione alla fine del secolo IX del termine curtis non aveva mutato la realtà fondiaria ed agraria della grande proprietà.
! Gli elementi delle fonti edite quasi tutte deducibili dalle note seguenti. sono stati da noi forniti alla nota 3, pp, 9-13 e in A. Castagnetti, Società a Ferral'a dall'età postcarolingia alla estense (secoli X-XIIIJ, 1985, pp. 9-10; si aggiungano ora le fonti a cura di C Curradi G, Muzzioli. citate anch' esse nelle note
V, Fumagalli, L'evoluzione dell'ec~nomia agraria e dei patti dall'alto al bassa medioevo, SM, s, III, XVIII (1977), pp, 1036-1037, con i rinvii ai suoi studi anteriori.
) A. del territorio rurale nel medioevo, Circoscrizioni ed «Langobardia» e nella «Romania», lo ed, Torma 1979, 2' ed, Bologna 1982.
4 Ibidem, pp, 271-272. 5 Ibidem, p, 243, 6 Ibidem, p, 271. 7 G.I, Cassandra, Storia delle terre comuni e usi civici nell'Italia
me"u1t,?na,le, Bari 1943, 50-54; E, Sereni, rurali nell'Italia antica, 329 58,; Laffi, Problemi
e molisane, in <<i\thenaeum», n.s., LII pp.
8 A. Castagnetti, L'organia.a:done ... , cit" p. 271, nota 1. 9 Per un'esemplificazione concernente il territorio romano si veda avanti,
nota 19; per la Sicilia Tjiider, I, nn. 10-11, anno 489. lO Ibidem, II, n. anno 539. 11 Ibidem, pp.
Breviarium, reg. 34, p. 20.
LE STRUTTURE FONDIARIE ED AGRARIE
Sulla grande proprietà fondiaria nel secolo VI si veda L. Ruggini, Economia e società nell',dtalia am~01.ltm'a». Milano 1961, pp. 429 ss.
l'A. Castagnetd, pp. 238-239. I, n. 8,
;6 II p 43· supra nota Il, 17 Cfr. supra: t~sto'corrispond~nte alle note 10-11. 18 Tjader, II, n. 30, anno 539. 19 Ibzdem, n. 17, inizio secolo VII, Roma: tra i di una massa
denominati Casa Porcinare, CaJa Vitz; Lari, Casa Basilz; Ginz; Trù Casas.
20 Breviarium, sub indice. 21 V. Federici, di S. Apollinare Nuovo, Roma
959 giugno 8: Kasa n. 2, 973 maggio 11: Casa gennaio 16 e n. 16, 1005 30: Casa Veda; G. Muzzioli, monastero di S. Andrea di Ravenna, 896-1000, Roma 1961 verità Roma 1988), 11, 942 16: Casa Marisi; n. 10, 949 23: Casa Merati; n. 951 gennaio 8 e n. 960 ottobre Casa Galandi; Fanruzzi, I, p. 390, reg. 40, 1007 dicembre 15: Casanovula e Casa Vetere.
22 A.
24
25
26 A. mc.(ep,gna'an"e dans l'Empire au Wl' siècle. et de d'Italie, Roma (Istituto storico italiano per il Medioevo, fasce. 75-76), app., n, 4, 731 gennaio 29,
A. Castagnetti, L'or!'!,an/Zz,zzum 28 Regestum saecuti X edito in A. Vasina, La
chiesa ravennate il Ferrarese intorno a11\1Iilte, in Romagna medievale, Ravenna 1971, pp. 65-70.
29 A. Castagnetti, dt., pp. 242-243. 30 e G. Pasquali, Agricoltura e società rurale in
Romagna Bologna 1984,. pp. 125-127. 31 C. Curradi, del ten'Ìtorio riminese nei WJ(.,miCTtIt al Afille. Il
""n!fwJfn cristiano del termine ottobre 17, n, 941/942
rinvio a a partire da n. 7, 907 febbraio 1. 34 A. Castagnelti, L'organizzazione... , cit., p. 24.5, ») I, n. 8, 564 luglio 17. 36 II) n. 35, 572 giugno 3. 37 Ibidem, n. 36, anni 575-591. 38 G.L. Amadesi, In antistitum Ravennatum chronotaxim, Faenza 1783, Il,
n. 970 agosto 16. Muzzioli, Le carte del monastero di S. Andrea... , cit., n. 14, 953
novembre 17. 40 Per il manso cfr. avanti, L paragrafo: Il «/undus» e la realtà organizzativa
dell'alto lvfedioevo in area ravennate, e la parte finale del paragrafo: Il e le strutture agrarie,
41 V, Federici, Regesto di 5 . .IH'Ollttlllre Nuovo, cir., n, 19, 1028 giugno. luglio 9,
42 Fantuzzi, IV, n, 6, 882 ottobre 10. 43 C. Curradi, M. Mazzotti, Carte del Montefeltro nell'alto Medioevo (723
in «Studi MontefeltranÌ», VlII, S. Leo 1981, n. 2, 912 agosto 31. Curradi, Pievi.. , cit., n, 13, 918 maggio 27.
45 Ibidem, n. 17, 941-942 aprile 21. 46 Ibidem, n. 18, 943 aprile 20. 47 Ibidem, n. 20, 952 giugno 27. 48 Ibidem, n. 27 bis, 972 giugno 1.
Ibidem, n. 34, 983 ottobre 17. 50 Ibidem, n, 38, 997 19. 51 Ibidem, n. 40, anni
P. Federici, Codex alZ)IO''nattC,~s P()1'h!1)()Jianus. in appendice a Rerum Pomposianarum historia monumentis n. 36, 1008 ottobre 29.
Si vedano altri due livelli: Fantuzzi, II, n. 19,981 maggio 3; n. 24, 1007 febbraio 19.
~ ~.
55 A. /W'''M'wn'a delle pievi della provincia ecclesiastica di Ravenna. Vl('U""rrit. in «Ravennatensia», Cesena 1977, p. 444.
56 ;vI. nHJlllt""ll1, città fra e «Romania», Firenze 1988, pp, 62-63.
57 V, Federici, Regesto di S. AllOt"tn,zre Nuovo, cit., n. 7, anni 982·983. C. Curradi, Pievi... , 944 giugno 11. P, Federici, Codex... , 1035 9. A. Castagnetti, cit., p.
61 Ibidem, p. 324. 62 Ibidem, pp. 236-237; IV!, nota 54, i dubbi circa l'autenticità di un
documento dell'873, nel quale compare il termine mansus. 63 Cfr. il paragrafo: Il «/undus» e le strutture in fine,
A. pp. cit" app., n. 3, 752 febbraio
ignorata veda L. Schiaparelli, Codice aZl-"(}I7IUI:ZW 'v"·x"'>u, uv, I, Roma 1929, n.
A. Guillou, et ùtdépendance .. " cir., pp, 179 55,; cfr. A. Castagnerti, L'organizzazione... , cit., pp. 226 ss.
67 V, Fumagalli, Terra e società nell'Italia I secoli IX X, Torino 1976, pp, 25 ss.
6B G. Fasolì, Aspetti di vita economica sociale nelntalia del secolo VII, in Caratteri del secow VII in Occidente, CISAM 5, Spoleto 1958, p. 24,
G. Tabacco, I liberi del re nell'Italia carolingia e postcarolingia, Spoleto 1966.
B, Andreolli, M. Montanari, L'azienda curtense in Italia, Bologna 1983. A. Casragnetti, Società e a Ferrara dall'età postcarolingia alla
signoria estense (secoli X·XIII) , 1985, p, 219. 72 Id., L'organizzazione... , cit., pp. 255-262. 73 G, Pasquali, cit., pp, 61-112. 7
L A. Castagnetri, cit., p. 278; Id" Arimanni in «Romania» fra conti 1988, pp. 11-21.
75 Id., 247. G. Pasquali, pp. 93-95, 122. Esemplificazione in A. Castagnetti, L'organizzazione... , cit" p, 248. Ibidem, p. 250.
79 Ibidem, p. 206. 80 Rinviamo a Arimanni in «Romania>, ... , cit., pp. 28-30. 8, Sulla famiglia Duchi SI veda G, Buzzi, RIcerche per la storia di
Ravenna e di Roma ali U8, in «ArchlVlo della RegIa SOCIetà romana di storia patria», a. XXXVIII (19L5), pp. 195-197.
82 Fantuzzi, n. 4, 889 novembre 29. A. Castagnerti, L'organizzazione... , pp, 250-251.
il4 B. Andreolli, M, Montanari, curtense... , dt., p, 169. A. Castagnetti, L'organizzazione... , cit" p, 249.
S6 V, Federici, G. Buzzi, Regesto della chiesa di Ravenna. Le carte dell'Archivio Estense, 2 voll., Roma 1911-1931, Re!, 7 e 13, I, n. l, 896 settembre 8.
87 V, Federici, Regesto di S. Nuovo, cit., n. 2, 973 maggio 11. 88 A. Castagnetti, L Orl1ah'ZZ2:aZi·Olle. dt., pp, 254-255. 89 Cfr. Jupra, nota 80. 90 A. Castagnetti, L'organizzazione... , cit" p. 306,
A, Vasina, La carta... , cit" p. 442. 92 Utilizziamo alcuni documenti dei primi decenni del secolo XI, interes
santi per lo la zona di Decimo; cfr. avanti, particolarmente il paragrafo: La «cur!Ìs
93 Per il territorio di Decimo-Decimano si veda A. Campana, Decimo, ut'Llrr.!an,rJ. Dismano. Ricerche di topografia romana e medioevale della pianura rollza,enola, in Emilia Romana, Firenze 1941, pp, 1-38.
Agricoltura ... , cit., pp. 33 ss" 244 ss, II, n, 4, anno 858.
Per la mancata ubicazione secondo la tecnica tradizionale dei fundamenfa delle saline, Fantuzzi, I, n. 430, 965 agosto 7; per le saline ~i veda G. Pasquali, Agricoltura... , cit., pp, 45 -51.
97 Fantuzzi, Il, n. 17, 974 febbraio. 98 A. Vasina, Lineamenti di vita comune del clero presso la cattedrale
ANDREA CASTAGNETTI
ravennate nei secoli XI e XII, in La vita comune del clero nei secoli XI e XII, II, Milano 1962, p. 213.
~9 Fantuzzi, v, n. 95, 1020 novembre 8. ")0 Tjader, II, n. 29, fulvenna, anno 504. Wl Ibidem, I, n. 8, 564 luglio lì. L'appartenenza del fundus al territorio
ravennate è probabile, non certa, poiché esso è elencato dopo un possedimento situato in territorio ravennate e dopo di esso sono elencati possedimenti in altri territori.
Wl cit., pp. 65-70. I beni sarebbero posti tutti nel territorio ma la «ferrarese» è stata aggiunta da un notaio redattore fra Xl e XII secolo (ibzdem, p. 52); fra le pievi è nominata solo quella di Santa Maria di Porto.
103 Fantuzzi, Il, n. 8, 955 settembre 17. JG4 V Federicì G Buzzi cit., I, n. 3, 1034 agosto 27. 105 V: Federici: Re~esto d;' S. Nuovo, cit., n. 2, 973 11. :v6 Cfr. supra, il paragrafo: «curtis» nella «Romania» ait/?m.edte
vale. 107 Fantuzzì, II, n. 24, 1007 febbraio 19. '08 V. Federici, Regesto di S. Nuovo, cit., n. 19, 1028 giugno-
luglio 9. Ibidem, n. 7, anni 982-983. Fantuzzi, II, n. 24, 1007 febbraio 19.
11; V. Federici, Regesto dì S. Apollinare Nuovo, cir., n. 15, secoli IX·X:
Fantlizzi, II, n. 24, 1007 febbraio 19. ll2 Fantuzzi, I, n. 40, 964 febbraio 4. 113 V. Federìci, Regesto di S. Nuovo, cit., n. 5, 959 giugno 8. 114 Ibidenz) n. 7) anni 982-983. 115 Fantuzzi, II, n. 24, 1007 febbraio 19 e V. Federici, Regesto di S.
r1.I/V"'''''' c Nuovo, cit., n. 1028, giugno-luglio 9. 116 Fantuzzi, n. 3, aprile 22. m V. Federid, di S. Apollinare Nuovo, cit., app., n. 1, 980 mag
gio 6. 118 Documenti citati avanti, al paragrafo: li «fundusN e te strutture agrarie. lI9 V. Federici, Regesto di S. Apollinare Nuovo, cit., n. 16, 100.5 aprile 30. 120 M. Montanari, Contadini... , cit., p. 62, elenca un livello dell' anno 918
quale interessante il territorio di Ravenna; ma si tratta di un errore del notaio estensore che ha posto la pieve di Santo Stefano di Panicale nel territorio dì Ravenna, invece che in quello di Faenza, si veda A. Vasina, La carta... , dt., p. 444.
12: Fantuzzi, II, n. 8, 955 settembre 17. 122 G. Muzzioli, Le carte del monastero di S, Andrea.. " cit.; n. 1,950 marzo
6. ili F antuzzi, II, n. 15, anno 971.
Ibidem, J, n. 33, 959 dicembre 6. 125 Cfr. supra, testo seguente nota 111. [26 Documento citato sopra, nota 105. [27 V. Federici, Regesto di S. Apollinare Nuovo, cit., n. 15, secoli X-XI
novembre. l2d Fantuzzi II n. 24, 129 V. Fede;ici: n. 5, anno 982. lJO Fantuzzi, I,
BI V. Federici, 9. Ibidem, n. l, 959 giugno 8. Fantuzzi, I, n. 40, 964 febbraio 4.
lJ4 Per il fundus Casalldo cfr. supra, testo seguente la nota 110. m V. Federici, Regesto diS. Apollinare Nuovo, cit., n. 13, 1000 gennaio 16. ';6 Ibidem, n. 16, 1005 aprile 30.
P. Federici, Codex... , cit., n. 82, 1034 maggio 7. G. Muzzioli, Le carte del monastero di S. Andrea... , cit., app., n. 1,965
aprile 3. 1;9 V. Federici, Regesto dì S. Apollinare Nuovo, cit., app. n. 1, 980 giu
gno 6. Fantuzzi, II, p. 367, 26, 998 febbraio 26.
14; Regestum saeculi X ... , p. 67. Fantuzzì, II, n. 8, 955 settembre 17.
14) Cfr. supra, testo corrispondente alle note 102-103.
144 Fantuzzi, I, n. 40, 964 febbraio 4. 145 G. Muzziolì, Le carte del monastero di S. Andrea .. , cit., app., n. 1, 965
aprile .3. l"; Fantuzzi, p. 367, reg. 26, 998 febbraio 26. 147 Inventari terre, coloni e redditi, a cura di A. Castagnetti, M. Luzzati,
G. Pasquali, A. Vasina, Roma 1979 104). Cfr. supra, testo corrispondente note 42-52.
149 V. Federici, RegeJto di 5. Nuovo, cit., n. 5, anno 982; n. 11, 984 gennaio 24; n. 15, secoli X-XI novembre; Fantuzzi, II, n. 24, 1007 febbraio 19.
V. Federici, Regesto di S. Apollinare Nuovo, cit., n. 16, 1005 aprile 30. m Fantuzzi, II, n. 24, 1007 febbraio 19. 152 Ibidem, n. 8, 955 settembre 17; V. Federici, Regesto di S. Iipow:na;re
Nuovo, cit., n. 7, anni 982·983; n. 13, 1000 gennaio 16. Oltre agli ultimi due documenti alla nota precedente, ibidem, n.
16, 1005 aprile 30; Fantuzzi, n. 24, 1007 febbraio 19. 154 V. Federici, RegestodiS. Nuovo, cit., n.1.3, 1000 gennaio 16.
Tbidem, n. 16, 1005 aprile 156 Cfr. avanti, testo corrispondente alle note 164-165.
V. Federici, Regesto di' S. nuovo, cit., n. 7, anni 982·983. 158 Ibidem, app., n. l, 980 maggio 6; n. 13, 1000 gennaio 6. 159 Ibidem, n. ]6, 1005 aprile 30. 160 Ibidem, n. 11, 984 gennaio 24. 161 Fantuzzi, Il, n. 8, 955 settembre 17. :62 V. Federicì, RegcJto di S. Apollinare Nuovo, dt., n. 19, 1028 giugno
9; si veda anche P. Federici, Codex ... , cit., n. 82, 1034 maggio 7, concernente l'acquisto da pane di sette persone di res in un fondus.
16; Cfr. il paragrafo: Il «/undus» e la realtà organizzativa agraria dell' alto in area ravennate.
V. Federici, G. Buzzi, l\.t'~ejf;U ..... cit., I, n. 3, 1034 agosto 27. [65 V. Federici. Regesto di S. r1.{'()"m"re Nuovo, cit., n. 19, 1028 giugno
luglio 9.
72
























![M. David, "I dittici 'cuspidati' e gli strumenti della propaganda di Stato nel Mediterraneo del V secolo", in Felix Ravenna, CLVII-CLX, 2001-2004 [2010], pp. 35-55.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6335ecafcd4bf2402c0b4abc/m-david-i-dittici-cuspidati-e-gli-strumenti-della-propaganda-di-stato-nel-mediterraneo.jpg)