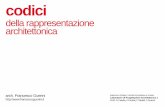La villa genovese nella Bormida Astigiana: il palazzo Di Negro Pallavicini a Mombaruzzo
Il catalogo di una biblioteca genovese del Settecento e alcune vicende dei codici di Filippo Sauli.
Transcript of Il catalogo di una biblioteca genovese del Settecento e alcune vicende dei codici di Filippo Sauli.
A L B E R T O P E T R U C C I A N I
CATALOGO DI UNA BIBLIOTECA GENOVESE DEL 700
Estratto dalla Rivista ACCADEMIE E BIBLIOTECHE D'ITALIA
Anno LIV - N. 2 1986
R O M A FRATELLI PALOMBI EDITORI
1986
IL CATALOGO DI UNA BIBLIOTECA GENOVESE DEL "^^ev^a^uvò
1 0 studio delle biblioteche private e dei cataloghi librari, accanto a fonti più episodiche come documenti contabili e carteggi, si è
^ dimostrato prezioso per ricostruire la circolazione del libro, e quindi i l clima culturale,di un luogo o di un'epoca'. Nonostante si ab
bia notizia di numerose biblioteche private a Genova nel Settecento, e di un non trascurabile commercio librario, scarsissima è la documentazione finora emersa: non si conoscono cataloghi a stampa di biblioteche, e pochissimi devono essere quelli pubblicati da librai della città^ Almeno due ne diffuse Pietro Paolo Pizzorno^: uno in latino, nel 1764, e l'altro in italiano, non datato, da cui ha preso le mosse questa ricerca^
Alla scarsità delle indicazioni fornite dal catalogo stesso supplisce, nell'esemplare della Bibhoteca Universitaria di Genova (segnato 6.U. 1.36), la
1 Cfr. il classico Daniel MORNET, Les enseignements des bibliothèques privées fl750-1780)S^-vue d'histoire littéraire de la Franca? 17 (1910), pp. 449-96, e Henri-Jean Martin, Livre, pouvoirs et société à Paris au XVII' siede, Genève, Droz, 1969; Michel Marion, Recherches sur les bibliothèques privées à Paris au milieu du XVIlf siede (1750-1759), Paris, Bibliothèque Nationale, 1978; Buch und Sammler. Private und óffentliche Bibliotheken im 18. Jahrhundert, Heidelberg, Winter, 1979. Da noi si segnala la ricerca promossa da Luigi BALSAMO [Produzione e circolazione libraria in Emilia nel secolo XVIH, in: Scienza e letteratura nella cultura italiana del Settecento, Bologna, Il Muhno, 1984, pp. 445-451) e, come campione, lo studio dello stesso Balsamo sul libraio G.B. Kross (in Produzione e circolazione libraria in Emilia (XV-XVIII sec), Parma, Casanova, 1983, pp. 147-61).
2 "Mentre si sa che alcuni patrizi) avevano fatto stampare un catalogo delle loro quadrerie per farne un presente ai visitatori, non risultano cataloghi a stampa di biblioteche genovesi" (Luigi MAR-CHINI, Biblioteche pubbliche a Genova nel Settecento, "Atti della Società ligure di storia patria", n.s., 20 (1980), n.2, 40-67, p. 48). Genova nOn è fra le v^ntidue città delle quali descrive cataloghi Simonetta NICOLINI (Bibliografia degli antichi cataloghi a stampa di biblioteche italiane (secoli XVII e XVIII), Firenze, Sansoni antiquariato, 1954); La Liguria è rappresentata soltanto dalla Biblioteca Aprosiana di Angelico Aprosio (Bologna 1673).
3 Pietro Paolo Pizzorno, con bottega presso Banchi, fu iscritto all'Arte dei Librai nel 1734, per primo della sua famigUa; lo seguirono i figli Francesco e Pietro Agostino nel 1749 e Giuseppe (con bottega nel vico del Filo, fino dal Quattrocento strada dei cartolai) nel 1776. Altri Pizzorno, non saprei se parenti, erano stampatori a Pisa.
" CATALOGO / DE'LIBRI, / CHE SI TROVANO VENDIBILI/ APPRESSO /PIETRO PAOLO PIZZORNO / LIBRARO IN GENOVA. S.n.t. i: rri A-Cc» ^ i ; 0t], 418 p. Questo catalogo fu visto da Niccolò GIULIANI , che lo cita a proposito di una edizione cinquecentina in esso erroneamente datata, ma non risvegliò il suo interesse {Notizie sulla tipografia ligure sino a tutto il secolo XVI, "Atti della Società ligure di storia patria", 9 (1869), 5-324, p. 209 n.).
32
A C C A D E M I E E B I B L I O T E C H E D ' I T A L I A - Anno LIV (37° n. s.) n. 2
Stampigliatura in oro sul dorso della legatura, in pergamena, del tempo: " L I B R E R I A C E N T U R I O " . Si tratta, infatti, come vedremo, non di un catalogo di assortimento, bensì di quello della biblioteca del marchese Lorenzo Centurione, conosciuta finora soltanto attraverso la notizia degU "Avvisi" di Genova che ne segnalava l'acquisto da parte della più antica biblioteca pubbHca della città, quella dei Missionari Urbani di S. Carlo.
«La copiosa^e sceltissima Libreria del fu Signore Lorenzo Centurione - si legge negU "Avvisi" - è stata ultimamente comprata daUi molto Reverendi Sacerdoti della Congregazione di S.Carlo, per unirla a quella, che da più anni tengono aperta a comodo pubblico in una casa nella salita di S. Caterina (!..). Questa preziosa raccolta di libri contiene molte magnifiche Edizioni delle Opere principali, non poche rare, alcuni pregiabiU Codici manoscritti, tutte le migUori produzioni moderne, che possono anche minutamente interessare la Storia Ecclesiastica, e la più compiuta serie di Memorie, Transazioni, Giornah, Atti , Effemeridi di tutte quasi le Società letterarie dell'Europa^». La notizia è dell'11 aprile 1778; i l proprietario, Lorenzo di Tommaso (o Gio. Tommaso) di Lorenzo Centurione, era morto l'S dicembre 1776*. Verso questi anni ci conduce anche l'esame del catalogo: l'ultima data che vi figura, infatti, è i l 1774\o Centurione era nato i l 10 gennaio 1714^ e probabilmente la vecchiaia o la malattia avevano negli ultimi anni della sua vita diminuito la cura della biblioteca: lo mostra l'arrestarsi delle collezioni dei periodici in anni che vanno dal 1769 al 1774. Queste collezioni, segnalate come di particolare interesse dal redattore degli "Avvisi", sono davvero notevoH, soprattutto se consideriamo che solo negli ultimi decenni del secolo i l numero delle accademie scientifiche avrà un vivace incremento. Troviamo gh "Acta eruditorum" di Lipsia, le "Phi-losophical Transactions" della Royal Society, gli atti delle Accademie delle Scienze di Parigi e di Bologna, queUi della Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, e diversi giornali e gazzette, dal "Journal des savants" (solo uno spezzone) e dai "Mémoires de Trevoux" alle "Nouvelles ecclésiastiques" e al "Giornale de' letterati". Per verificare l'attendibilità dell'indicazione dataci dal dorso dell'esemplare ricordato (unico individuato in bibhoteche genovesi), non resta che confrontare i l catalogo con le notizie che abbiamo della Bibhoteca delle Missioni Urbane.
La Biblioteca fu raccolta dall'abate Girolamo Franzoni (1653-1737),
5 "Avvisi" di Genova, n. 54 (11 aprile 1778), p. 337. * Cattalogo di cavalieri, e dame ammogliati... dal 1760 a questa parte, come altresì la di loro
morte..., ms. B. VI. 9 della Biblioteca Universitaria di Genova, p. 702. ' Oltre che da diversi libri, l'anno 1774 è rappresentato dall'ultima annata completa delle "Nou
velles ecclésiastiques" (p. 291). Alla p. 327 figura, con la data del 1787, De la puissance de l'Église di Antoine Charlas, ma si tratta di mero errore per 1687.
8 Guelfo GUELFI CAMAJANI, // "Liber nobilitatis Genuensis" e il governo della Repubblica di Genova fino all'anno 1797, Firenze, Società italiana di studi araldici e genealogici, 1965, p. 130.
33
A C C A D E M I E E B I B L I O T E C H E D ' I T A L I A - Anno LIV (37° n. s.) n. 2
di un'illustre famiglia genovese che contò numerosi bibliofili: proprio a un nipote di Girolamo, l'abate Paolo Girolamo (1708-1778), si deve la fondazione di un'altra biblioteca pubblica tuttora esistente, quella della Congregazione degli Operai Evangelici (oggi Franzoniana), aperta verso i l 1757'. Con il suo testamento, nel 1727, Girolamo Franzoni destinò la propria raccolta libraria, insieme ad un fondo per la cura e l'accrescimento di essa, ad utilità pubblica, affidandola alla Congregazione cui apparteneva. L'apertura, per resistenze governative, ebbe luogo soltanto nel 1739: Genova ebbe così la sua prima biblioteca pienamente pubblica, cui seguirono la Franzoniana, quella dell'abate Berlo, oggi Civica, e infine l'Universitaria, costituita con i fondi gesuitici ai quali si aggiunsero poi quelli dei conventi soppressi'".
Alcune notizie sulla Biblioteca delle Missioni Urbane si traggono dalle Cartas familiares dell'abate Juan Andrés, che la visitò nel 1791"; informazioni più ampie, con elenchi di manoscritti e di stampati di particolare pregio, furono date da Luigi Grassi in un contributo al volume Genova e le due riviere di Giuseppe Banchero'^ Purtroppo la Biblioteca andò distrutta nei bombardamenti dell'autunno del 1942: ne restano oggi solo un centinaio di volumi, depositati alla Franzoniana, fra i quali i famosi manoscritti greci appartenuti a Filippo SauU, vescovo di Brugnato, altri codici e sette incunaboh".
Proprio i l controllo dei manoscritti elencati nel catalogo di Pizzorno con quelli delle Missioni Urbane descritti dal Grassi, dal Bertolotto e dall'Ehrhard'" conferma inequivocabilmente l'identificazione della raccolta, permettendo di ricostruire una vicenda ignorata della preziosa raccolta Sauli, la storia della quale, tuttavia, rimane in buona parte oscura.
Nel catalogo Pizzorno-Centurione figura, al termine della lettera C, un elenco di 56 Codices manuscripti tam graeci, quam latini (pp. 121-29), descritti molto sommariamente ma con l'indicazione della materia scritto-ria, del formato e del numero delle carte; altri quarantaquattro manoscritti, molti dei quali moderni, sono inseriti con gli stampati nell'ordine alfabetico. Non presenta difficoltà l'identificazione dei primi 39 codici con quelli
' Giuseppe PIERSANTELLI, La Biblioteca Franzoniana degli operai evangelicì)'henow&. 47 (1967), n.2, pp. 11-19, e n. 3, pp. 19-23; MARCHINI cit., pp. 41 e 57-60."̂
10 MARCHIMI cit., pp. 52-53. " Juan ANDR^S,Cartas familiares..., Madrid, Sancha, 1786-1793, voi. 5, pp. 198-205. '2 Luigi GRASSI, Biblioteca della Congr. de' RR. Missionari Urbani, in Giuseppe BANCHERO,
Genova e le due riviere, Genova, Pellas, 1846, pp. 497-523. 13 La ricostruzione delle biblioteche italiane dopo la guerra 1940-45. I : I danni, Roma, Palombi,
1949, p. 34; MARCHIMI cit., p. 55. GRASSI, cit., pp. 500-520 (157 codici); Girolamo BERTOLOTTO, // codice greco sauliano
di S. Atanasio, "Atti della Società ligure di storia patria", 25 (1892), n. 1, pp. 7-63 (con elenco dei 39 codici greci alle pp. 51-63); Albert EHRHARD, Zur Catalogisirung der ìtleineren Bestànde griechi-scher Handschriften in Italien, "Centralblatt fùr Bibliothekswesen", 10 (1893), pp. 189-218 (poi in Catalo-gi codicum Graecorum qui in minoribus bibliothecis Jtalicis asservantur..., accuravit C. Samberger, Lipsiae, Zentral-Antiquariat, 1965-1968, voi. 2, pp. 263-92) (con elenco dei 39 codici greci alle pp. 196-218).
34
A C C A D E M I E E B I B L I O T E C H E D ' I T A L I A - Anno LIV (37° n. s.) n. 2
descritti dal Bertolotto e daH'Ehrhard: sono comprensibili piccole discrepanze nel conteggio delle carte (che si riscontrano perfino fra i due cataloghi moderni), mentre corrispondono anche dettagli specifici come mutilazioni o miniature tagliate. Particolarmente importante, inoltre, è la coincidenza della numerazione del catalogo Centurione con quella antica dei codici'^
I manoscritti di Filippo Sauli, quindi, non giunsero direttamente dall'Ospedale degli Incurabili di Genova, al quale i l dotto prelato li aveva lasciati col suo testamento, alla Biblioteca delle Missioni Urbane, come finora si era ritenuto'*. Le note manoscritte in alcuni codici, in effetti, si Hmita-no ad indicare che l'Ospedale lì aveva venduti nel 1746, ma non ne nominano l'acquirente'^ La testimonianza più vicina, ma non finora notata, è quella dell'Andrés, che indica, sia pure vagamente, più passaggi: "Monse-"Sor Sauli dexo en su testamento unos 300 volumenes grie^os manuscritos al hospital de los incurables, y una porcion de estos, despues de varias vicisitudines, ha parado en està biblioteca, y la ha hecho en està parte muy respetable"'*. Le circostanze nelle quali i manoscritti Sauli giunsero dall'Ospedale a Lorenzo Centurione restano quindi ancora da chiarire ma, come vedremo, non è da esse che si potranno trarre elementi per ricostruire la consistenza originaria di questa raccolta.
La biblioteca di Filippo SauH (1493-1528)", vescovo di Brugnato, doveva essere fra le più ragguardevoli che si contassero allora in Liguria, a giudicare dall'elogio che ne faceva i l cardinale Gregorio Cortese^". La sua consistenza quantitativa e i l suo preciso contenuto, così come parte delle sue vicende, ci rimangono in larga misura ignoti. Mi auguro di potere, in un prossimo contributo specifico, ridurre queste aree di oscurità; in questa sede vanno comunque sintetizzati gli elementi più rilevanti. I classici repertori del Soprani e dell'Oldoini hanno tramandato la credenza che la raccolta sauliana contenesse numerosi manoscritti medici e addirittura trecento codici greci: verificando diligentemente la quindicina di fonti ricordate dai due non si risale però oltre la prima metà del Seicento. La prima notizia è data
'5 BERTOLOTTO, cit., pp. 51-63; Friedrich BLUHME, Bibliotheca librorum manuscriptorum Italica..., Gottingae, impensis bibliopolii Dietericiani, 1834, pp. 1-5.
GRASSI cit., pp. 497 e 499-500; BERTOLOTTO, cit., pp. 15-17; MARCHINI, cit., p. 54. BERTOLOTTO, cit., nn. 2,7,8,19,26, 27 , 30 e 33.
18 ANDRÉS, cit., p. lOOCO'rik^ i/W'^j, 1 ' Entrambe le date sono discusse. Secondo Placido TOMAINI (Brugnato città abbaziale e vesco-
vikj Città di Castello, Unione Arti Grafiche, 1957, pp. 258-64) la nascita risalirebbe al 30 luglio 1491 e la morte al 1531 (come nell'Ughelli e nelle numerose fonti che lo seguono). La data del 1528, riportata anche nella lapide nella basilica di Carignano a Genova, è confermata dal codicillo al proprio testamento redatto il 7 agosto, quando il Sauli era già "pestis gravatus"; il 15 settembre dello stesso anno il Consiglio degliAnziani ratificava il suo testamento, non redatto nelle forme dovute per la morte, nella stessa pestilenza, del testatore e del notaio che ne era incaricato (Archivio di Stato di Genova, Notaio Raffaele Monterosso, I (se. 164), n. 88; Notaio Vincenzo Molfino, XVII (se. 158), s.n.).
^ Gregorio CORTESE, Epistolarum familiarium liber, Venetiis, apud Franciscum Franciscium, 1573, p.- 63.
35
A C C A D E M I E E B I B L I O T E C H E D ' I T A L I A - Anno LIV (37° n. s.) n. 2
dal Soprani sulla fede dello Schiaffino, la seconda dall'Oldoini attraverso rUghelli^'. I due elenchi di libri greci accuratamente editi da Giovanni Mercati (il primo limitato ai manoscritti, l'altro includente anche gli stampati) risalgono rispettivamente all'ultimo quarto del Cinquecento e al 1602: entrambi sono incompleti e in totale, con l'approssimazione dovuta alla loro imprecisione, superano appena la sessantina di volumi, almeno quindici dei quali a stampa^^ Nessuno fra essi è riferibile, sia pure in senso lato, alla medicina.
Con il suo testamento, redatto poco prima della morte nella gravissima pestilenza del 1528, i l Sauh aveva distinto in due blocchi la sua biblioteca: tutti i manoscritti, con gh stampati greci, dovevano andare all'Ospedale degh Incurabili, detto l'Ospedaletto, mentre gli stampati latini dovevano essere conservati nel convento dei domenicani di Brugnato ad uso del suo successore e dei canonici". I l primo lascito, che può apparire sorprendente, si spiega certamente con il legame che i l Sauli doveva avere col rettore dell'Ospedaletto, i l medico Giovanni Di Negro, al quale i hbri erano confidati fino alla sua morte,e che doveva anche ricevere, e decidere se distruggere o conservare a suo piacimento, tutte le scritture che non riguardassero la diocesi. E' difficile che i l Di Negro si interessasse alla patristica (alla quale appartengono quasi tutti i codici che conosciamo), ma doveva essere persona di buona cultura e migliore conoscitore del greco dei frati predicatori di Brugnato^". L'Ospedale degh Incurabih, inoltre, quale roccaforte della Confraternita del Divino Amore, era un polo culturale di notevole importanza^^
Del lascito al convento dell'Annunziata di Brugnato abbiamo un elenco fatto redigere da Girolamo Grimaldi, successore del SauU, nel 1531: esso consiste di 155 voci, in grandissima maggioranza testi giuridici, come giuridici erano stati gli studi del Sauli, che gli avevano procurato l'amicizia e
21 Raffaele SOPRANI, Li scrittori della Liguria, e particolarmente della maritima , Genova, Pietro Giovanni Calenzani, 1668, p. 93 (e cfr. Agostino SCHIAFFINO, Annali ecclesiastici della Liguria, 111, ms. B.VI.3 della Biblioteca Universitaria di Genova, p. 923); Agostino OLDOINI, Athenaeum Ligusticum seu syllabusscriptorum Ligurum..., Perusae, apud HH. Laurentij Ciani & FranciscumStesi-derium, 1680, p. 474 ( e cfr. Ferdinando UGHELLI, Italia sacra... IV, RomJ? typis Vitalis Mascardi, 1652, col. 1389).
22 Giovanni MERCATI, Per la storia dei manoscritti greci di Genova, di varie badie basiliane d'Italia e di Palmo, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1935, pp. 219-25.
23 Archivio di Stato di Genova, Notaio Vincenzo Molfino, XVII (se.158), s.n.j20.5.1528. La parte che riguarda l'Ospedaletto è stata pubblicata in CASSIANO da Langasco, Gli ospedali degli incurabili, Genova, Spedali civiH di Genova, 1938, pp. 261-62.
2'' Giovanni Di Negro figura ancora medico all'Ospedaletto in un documento del 1552 (CASSIAMO cit., p. 264); egli morì nel 1589 alla venerabile età di 96 anni (Giovanni Battista PESCETTO, Biografia medica ligure, Genova, Tip. del R.I. Sordo-Muti, 1846, p. 120). Il Sauh e il Di Negro erano quindi coetanei.
25 Cfr. Rodolfo SA V E L L I , Dalle confraternite allo Stato: il sistema assistenziale genovese nel Cinquecento, "Atti della Società ligure di storia patria", n.s., 24 (1984), n. 1, pp. 171- 216.|lal ms. C.V. 18 della Biblioteca Universitaria di Genova risulta che il Di Negro apparteneva, dal 1528, alla Confraternita (cc.32r e 47v). Ringrazio il prof. Savelli per numerose utili segnalazioni.
36
A C C A D E M I E E B I B L I O T E C H E D ' I T A L I A - Anno LIV (37° n. s.) n. 2
la Stima dell'Alciato^*. Sorprende non tanto l'assenza di testi umanistici (salvo un Pico e un Erasmo) quanto soprattutto quella delle letterature classiche (rappresentate solo da un Plinio e da un Plutarco). Questa composizione pare difficilmente credibile, anche perchè il testamento fa riferimento a una raccolta pertinente sì al diritto civile e canonico e a materie ecclesiastiche, ma anche alle "humanae litterae" tanto poco presenti. Sembra lecito sospettare, quindi, che nei tre anni fra la morte del Sauh e questo elenco la sua raccolta sia stata depauperata.
Nell'inventario del 1602, come si è detto, compaiono quindici stampati greci, e fra le quattro opere delle quali non si indica i l carattere ritengo probabile che ve ne fossero altri due: i Moralia di Aristotele (cioè la quinta parte dell'edizione aldina del 1498) e la Vita di Luciano (cioè una delle edizioni di suoi scritti, quella fiorentina di Lorenzo d'Alopa del 1496 o le aldine del 1503 e del 1522).
Per tredici di questi stampati i l catalogo Centurione suggerisce delle identificazioni: l'Omero fiorentino (1488), il Gaza (1495), l'Aristofane (1498), il Luciano (1503), Moralia (1509) e Vite (1519) di Plutarco, Platone (1513), Esichio (1514) e Snida (1514), tutti aldini, VEtymologicum veneziano (1499) e i l Favorino Guarini romano (1523) di Callierges, la Bibbia poligfctta com-plutense (1514-1517)̂ ''. Non troviamo invece nel catalogo Centurione i l Salterio (con ogni probabilità l'edizione aldina di fine Quattrocento), i l Moscopulo (che sarà piuttosto il Dictionarium aldino del 1524 con l'aggiunta di altri scritti), i l Senofonte0^irenze, Filippo Giunta, 1516, oppure Venezia, Aldo Manuzio, 1525, a meno che non si tratti della Storia greca, edita ancora da Aldo nel 1503) e i l secondo Luciano". In quei tredici casi poteva trovarsi nella biblioteca Centurione proprio l'esemplare sauliano, ma questa ipotesi non ha possibilità di verifica perchè nessuna di queste edizioni figura fra i libri scampati all'incendio della Bibhoteca delle Missioni.
Per quanto riguarda i manoscritti, e rimandando ad altra sede una verifica puntuale delle indicazioni dei due inventari (tentata solo per i l primo, ma con elementi insufficienti, dal Mercati), possiamo prendere come punto di partenza l'elenco dei 56 codici tenuti separati nel catalogo Centurione. Non vi sono criteri di materia o di antichità che li distinguano dagli altri quarantaquattro dispersi nel catalogo: è vero che vi si trovano tutti i greci, ma fra i latini testi ecclesiastici, classici, umanistici o medici si incontrano in entrambi i gruppi. Una conferma sicura del loro raggruppa-
2* Archivio di Stato di Genova, Notaio Niccolò Costa, I (se.216), s.n.̂ 1.1.1531. Il documento è stato segnalato per primo da Gian Giacomo MUSSO, Libri e cultura dei genovesi fuori Genova tra medioevo ed età moderna, "Atti e memorie. Società savonese di storia patria", n.s., 10 (1976), 109-34. p. 121.
'̂̂ Dubbie sono le identificazioni del Snida (che potrebbe essere l'edizione milanese del 1499), delle Vite di Plutarco (anche Firenze, Filippo Giunta, 1517) e di Esichio (anche Firenze, eredi di Filippo Giunta, 1520).
37
A C C A D E M I E E B I B L I O T E C H E D ' I T A L I A - Anno LIV (37° n. s.) n..2
mento in base alla provenienza ce la dà un manoscritto della Biblioteca Civica Berlo (segnato m.r. VI.5.5.), che contiene un'altro inventario (o più precisamente due) fra i molti di cui questi codici sono stati oggetto. Le ce. 50-56 contengono l'elenco, compilato nel 1737 da Sebastiano De Paoh, chierico regolare della Congregazione della Madre di Dio, dei codici allora conservati nella cancelleria dell'Ospedaletto: vi troviamo i 39 codipi greci e i 17 latini che corrispondono al 56 del catalogo Centurione e, ii^ine, la descrizione della Bibbia poUgétta. Precede questo elenco un altro catalogo, Umitato ai 38 codici greci di carattere ecclesiastico, che è palesemente di diverso compilatore, assai più competente. Questi infatti non solo non "abbocca" alle indicazioni generiche o in diversi casi errate de|l|/«apiY e dei titoli recati dal dorso dei volumi, ma collaziona attentamente i testi con le edizioni a stampa allora disponibih, come quelle famose dei padri Mauri-ni. Proprio i riferimenti bibhografici ci permettono di stabilire un termine post quem per questo catalogo, che è i l 1742, anno di uno dei volumi dell'edizione romana di Efrem^*.
Poiché sappiamo che in quegli anni vi era a Genova uno studioso particolarmente versato nella conoscenza delle lettere greche, lo scolopio Pietro Maria Ferrari (o De Ferrari), che nel 1744 egU ebbe in visione uno alla volta (come i l compilatore dell'inventario beriano, a quanto si ricava dalla descrizione delle due parti del codice di Crisostomo su Matteo)'manoscritti dell'Ospedaletto, redigendone un catalogo i l cui autografo pervenne più tardi alla Bibhoteca delle Missioni Urbane^', l'anonimo compilatore sembra poter essere facilmente identificato. Andato perduto l'originale conservato nella Biblioteca delle Missioni Urbane, l'ipotesi può essere ugualmente convah-data confrontando le descrizioni del codice beriano con le osservazioni manoscritte inserite in alcuni dei codici greci sauUani, e talvolta riportate dal Grassi, che riprendono le conclusioni del Ferrari^».
L'inventario del De Paoh ci assicura che, pochi anni prima della vendita da parte dell'Ospedaletto, in esso rimanevano tutti e soltanto i 56 manoscritti elencati a parte nel catalogo Centurione (e forse, con la Bibbia poU^tta, altri stampati). Ma non possiamo, naturalmente, arguirne che provenissero dalla raccolta SauU anche i l trentanovesimo codice greco e i diciassette latini. Sicuramente sauUani erano tre di questi, i "tria magna volumina in materia conciUorum" espUcitamente ricordati,insieme aUa Bibbia "Tolletana" (la complutense), nel testamento '̂. Possiamo escludere, invece, i l Martiro-
28 Biblioteca Civica Bario, Genova, ms. m.r. VI 5.5, c. 3''. 2« BERTOLOTTO, cit., pp. 17-18. Sul Ferrari (1668-1749) cfr. Francesco Antonio ZACCARIA,
Excursus litterariiper Italiani..., Venetiis, ex Remondiniano typographio, 1754, pp. 22—23; Religiosi Scholarum Piarum quiprovinciae Liguri et Pedemontanae... adscrìpti fuerunt, I, Florentiae, ex officina Calasantiana, 1893, pp. 137-39.
30 GRASSI, cit., nn. 11, 23 e 31; BERTOLOTTO, cit., n. 24, pp. 56-57. 31 Cfr. GRASSI, cit, nn. 48-49 e p. 498; BLUHME, cit., nn. 48-50.
38
A C C A D E M I E E B I B L I O T E C H E D ' I T A L I A - Anno LIV (37° n. s.) n. 2
logio, per la sua provenienza dal monastero femminile S. Colombano, ceduto con tutti i suoi beni da Giulio I I , nel 1512, all'Ospedale degli Incurabili'^. Accanto ad alcuni codici isolati (fra i quali uno di lettere del Panormita, razziato nel periodo napoleonico e quindi scampato alla distruzione della biblioteca, ma ricercato invano dal Kristeller a Parigi"), spicca un gruppo significativo di manoscritti scientifico-medici: le cinque parti dei Canones di Avicenna, i l commento ad essi di Gentile da Foligno, un commento a Galeno, un trattatalo fisico di Aristotele e le Questìones di Alberto di Sassonia, cui si può aggiungere anche il trentanovesimo e isolato codice greco, un commento aristotehco di SimpUcio", Note di possesso in sei di questi codici (quattro Avicenna, l'Aristotele e l'Alberto di Sassonia) \o appartenuti a due medici di Gavi, Alessandro di Montaldo e suo figho Achille". Nella raccolta dell'Ospedaletto si dehnea quindi un altro fondo omogeneo, certo esiguo ma forse depauperato da una consultazione alla quale saranno verosimilmente sfuggiti, se non altro per la sede, i codici patristici. Non sembra verosimile che anche questo gruppo di manoscritti provenga dal Sauli, mentre potremmo intravedervi l'orizzonte intellettuale di quel Giovanni Di Negro di cui sappiamo così poco. Dalla presenza di questo gruppo di codici, di provenienza meno illustre e forse dimenticata, lo Schiaffino, nel primo Seicento, avrà potuto inferire l'attribuzione al SauU di una raccolta di testi medici. Ma torniamo, ora, alla biblioteca di Lorenzo Centurione.
La biblioteca Centurione non ha le caratteristiche di una raccolta bi-bUofiUca, come, per esempio, queUa che proprio in quegU anni iniziava a formare Giacomo Filippo Durazzo'*. Potremmo rintracciare motivazioni di questo tipo, forse, solo neU'acquisto dei codici SauU, che potrebbe però essere stato dovuto anche al desiderio di evitarne la dispersione o a un effettivo interesse per la materia di essi. Se non possono mancarvi alcuni pezzi di prestigio (manoscritti dei classici, incunaboli, aldine, ecc.), l 'immagine deUa raccolta è tuttavia moderna e improntata ad interessi di studio e di lettura.
Un'anaUsi sistematica, e quantitativa, della composizione della raccolta è resa difficile daU'ordinamento alfabetico del catalogo, che non fa trasparire l'importanza relativa deUe diverse componenti. Spicca certo per la
52 Giovanna PEZZI, Codici dei secoli XII-XIV nelle biblioteche genovesi, "Atti della Società ligure di storia patria", n.s.,3 (1963), n. 1, 51-138, pp. 121-22; CASSIAMO cit., pp. 78-86.
33 BLUHME, cit., n. 41; GRASSI, cit., p. 520; Paul Oskar KRISTELLER, Iter Italicum, I, London, Warburg Institute; Leiden, Brill, 1963, p. 241.
3* GRASSI, cit., nn. 40 e 148-156. Si conservano oggi alla Franzoniana soltanto l'Aristotele e l'Alberto di Sassonia (nn. 149 e 148).
35 Due deUe note di Achille sono datate, l'una da Lione 1489 (n. 155), l'altra da Tours 1493 (n. 156). 3* / manoscritti della raccolta Durazzo, a cura di Dino PUNCUH, Genova, Sagep, 1979; Alberto
PETRUCCLWI, Bibliofili e librai nel Settecento: la formazione della biblioteca Durazzo (1776- 1783), "Atti della Società ligure di storia patria", n.s., 24 (1984), n. 1, pp. 291-322.
39
A C C A D E M I E E B I B L I O T E C H E D ' I T A L I A - Anno LIV (37° n. s.) n. 2
sua ricchezza, come notavano gh "Avvisi", i l settore religioso, ricco di strumenti di lavoro e di opere di patristica, teologia, storia ecclesiastica, fino ai pamphlets contemporanei della polemica giansenisti-gesuiti. Mi sembra che meriti di essere segnalata, in questo settore, la presenza degh Opera omnia di Lutero, Melantone, Calvino e Zwingh.
Largamente sviluppato è anche i l settore storico, e in particolare, ma non solo, quello locale, con la presenza puntuale anche delle opere di storia genovese uscite all'estero e di diversi manoscritti (a cominciare dai classici repertori araldico-genealogici). I l settore filosofico e scientifico è rappresentato con meno ampiezza ma con scelta sicura: VEncyclopédie (nell'edizione originale e in quella, allora in corso, di Livorno), ben sedici edizioni di Voltaire, otto di Rousseau, poi Montesquieu, Helvétius, Beccaria, e diverse opere di matematica, fisica, storia naturale, medicina. Ha il suo spazio anche la cultura giuridica del tempo, nei hmiti, naturalmente, di un interesse non professionale.
Colpisce di più, almeno rispetto aUa fisionomia di altre raccolte di carattere dotto, la ricchezza del settore letterario, e più di quello moderno che di quello classico. Particolarmente rappresentato è i l Cinquecento ita-lianOj nelle edizioni dei Giunti, di Torrentino, di Giolito; interessanti sono anche aicune presenze della narrativa contemporanea, dalla Clarissa e dal Grandison di Richardson al Sentimental journey di Sterne e al recentissimo e curioso An deux mille quatre cent quarante di Louis-Sébastien Mercier.
Sempre interessante è l'esame degh strumenti bibhografici presenti in una raccolta privata per chiarirne le motivazioni e la formazione: la bibhoteca Centurione è ricca soprattutto di bibliografie e repertori specializzati, in particolare nell'ambito storico-religioso, ma vi troviamo anche i tre repertori più importanti allora disponibih per la conoscenza del libro antico (il Maittaire, i l Meerman e l'Orlandi) e le classiche bibUografie itahane di Haym e di Fontanini e Zeno (oltre ali*due Librarie di Anton Francesco Doni).
Non sappiamo come i l Centurione si procurasse hbri per la biblioteca, ma è significativa la massiccia presenza di edizioni straniere (olandesi, francesi, tedesche, inglesi), sia dei secoh precedenti che recentissime. Conoscendo le difficoltà del commercio librario internazionale del tempo, non solo a Genova, si deve supporre che il Centurione, come più tardi i l Durazzo, ricorresse ad una estesa rete di legami d'affari che non dovevano mancare al membro di una famigha che aveva notevoh interessi finanziari in Europa.
Dal raffronto fra il catalogo di Pizzorno e le notizie che abbiamo della Bibhoteca delle Missioni Urbane appare chiaramente l'importanza deU'ac-quisto della raccolta di Lorenzo Centurione. Questa conteneva, secondo una stima approssimativa, circa 4.500 titoh, per quasi diecimila volumi: una quota notevolissima rispetto ai 25.000 volumi a cui i l Grassi stimava la consistenza della Biblioteca quasi a metà dell'Ottocento, includendovi quindi i l fondo franzoniano, i numerosi legati, gh acquisti di un secolo
40
A C C A D E M I E E B I B L I O T E C H E D ' I T A L I A - Anno LIV (37° n. s.) n. 2
(che però non saranno stati numerosi) e i fondi di conventi soppressi entrati nel 1811 e 1814, quando la Bibhoteca era passata, per breve tempo, nelle mani del Comune". Sotto l'aspetto quahtativo i l rilievo del fondo Centurione è anche più evidente: non a caso l'abate Andrés faceva riferimento alla raccolta Sauh e segnalava come di particolare interesse, nella Biblioteca delle Missioni Urbane, due codici sui concih, quello del Panormita, un Plutarco latino, un autografo di Kaspar Schoppe e due incunaboli {l'editio princeps di Omero e la Commedia di Niccolò Tedesco con le figure in rame), tutti di provenienza Centurione'^. Con la sua raccolta entrarono alle Missioni Urbane cento manoscritti,sui trecento circa che la Bibhoteca venne ad annoverare, tra i quali però molti erano i moderni''. Andato distrutto anche il catalogo, la fonte più completa di cui disponiamo è l'elenco di 157 codici del Grassi, nel quale riconosciamo come Centurione tutti i 39 manoscritti greci e 40 dei 117 latini (cui vanno aggiunti i due perduti nel periodo napoleonico). Si tratta di quasi tutti i più antichi, o quelli di maggiore interesse: i tre codici petrarcheschi, i l Tacito, i l Plutarco e i l Flavio Giuseppe già Trivulzio, Lorenzo Valla, Jacopo da Varazze^ ecc. Un settore separato di manoscritti, tra l'altro, fu probabilmente costituito proprio con l'ingresso della biblioteca Centurione, mantenendo la numerazione dei 56 codici tenuti insieme nel catalogo e aggiungendovi di seguito quelli dispersi neUa serie alfabetica. Ne fa fede l'elenco di 66 manoscritti dato dal Bluhme, del quale solo i l Lattanzio non trovo nel catalogo Centurione'"'.
Con la bibhoteca Centurione entrarono anche 43 incunaboli (cinque dei quali potevano essere appartenuti al Sauh); ne ritroviamo 29 fra i 43 elencati dal Grassi (anche in questo caso, quindi, selettivo), ma nessuno è purtoppo fra i sette scampati all'incendio e conservati ora alla Franzoniana. Lo stesso deve dirsi per le otto cinquecentine di provenienza Centurione che i l Grassi elencava fra quelle di maggior pregio, e per altre edizioni famose come le quattro Bibbie poliglotte e queUa Sistina del 1590"'. In assenza di termini di confronto, è più difficile valutare l'importanza del fondo Centurione per quanto riguarda le discipline storico-ecclesiastiche alle quali particolarmente la Biblioteca delle Missioni Urbane era dedicata. Complessivamente, comunque^ l'acquisto deUa raccolta Centurione avrà ah'incirca
37 GRASSI, cit., pp. 497-98. 38 ANDREAS, cit., pp. 198-205. 3 ' La cifra è data da Francis MOLARD, Rapport sur les bibliothèques de Crenes, "Archives des
missions scientifiques et littéraires", 3 sér., 5 (1879), 137-212, p. 190. L'Annuario delle biblioteche italiane 1933-34 (Firenze, Bemporad, 1933) ne dichiara però soltanto 234 (p.lU). Si basa sui soli codici descritti dal Grassi, ed è quindi inattendibile, la valutazione data in La ricostruzione cit., p. 34.
'•o Non considero il Messale e il Curzio Rufo che il Bluhme elenca senza numerazione in fondo, perche sono ovviamente i due codici della Biblioteca Universitaria, attribuiti per errore alle Missioni Urbane.
••i GRASSI cit., pp. 498-99; Giovanna BALBI, Gli incunaboli della Biblioteca Franzoniana di Genova, in: Miscellanea di studi storici, I, Genova, Bozzi, 1969, pp. 365-84.
41
A C C A D E M I E E B I B L I O T E C H E D ' I T A L I A - Anno LIV (37° n. s.) n. 2
raddoppiato la consistenza di una Biblioteca che era la prima fra le pubbliche, a Genova, per origine come per ampiezza.
Basandosi sulla morte del proprietario, la stampa del catalogo si può assegnare con ragionevole certezza al 1777: esso doveva servire per la ricerca di un acquirente disposto ad una compera in blocco. I Missionari Urbani beneficiarono, come testimoniano gli "Avvisi", di un trattamento di favore: Nobilissimi Eredi'* del predetto fu Signore Lorenzo hanno con generosa, e deUberata facihtà contribuito a questo generale benefizio contentandosi di un prezzo, che forse non arriva alla metà del costo, e pagabile in piccole annuah partite nel corso d i 12. a 13. anni senza alcun interessef̂ . Ciononostante l'esborso doveva essere considerevole, e non stupisce che la Bibhoteca ricorresse subito al sistema usuale, quello della vendita dei duplicati, in questo caso certamente numerosi. L'acquisto doveva essere avvenuto entro i primi giorni di aprile del 1778, e già ai primi di agosto Giacomo Filippo Durazzo comperava, per 1891 lire, diversi duphcati: sette voluminose edizioni patristiche dei Maurini di Parigi (29 volumi in tutto), i l Mercurio e le Memorie recondite di Vittorio Siri (25 volumi), gli Annales typographici del Maittaire (6 volumi), le opere di Giusto Lipsio, Ld^ Bibliotheca sacra del Le Long e alcuni hbretti di minore importanza"'. Considerando anche la rateazione del pagamento di cui ci informano gh "Avvisi", la vendita dei duplicati dovette durare a lungo: i l Durazzo compì infatti un altro acquisto, molto pili limitato, nel marzo del 1782"". Tutti i volumi acquistati in queste due occasioni sono ancora conservati nella Bibhoteca Durazzo PaUavicini, ma non recano tracce di provenienze interessanti ai nostri fini. Alcuni di essi, tuttavia, conservano la legatura che avevano nella raccolta Centurione: solide legature in pergamena con cartellino in pelle rossa i l Crisostomo (Parigi 1718-1738, 13 voh.) e i Carmina del Volpi (Padova 1725), non ineleganti legature in vitello con impressioni in oro, e guardie di carta marmorizzata, i l Basiho (Parigi 1721) e i l Gregorio Magno (Parigi 1705, 4 voli.). Come ci mostra i l catalogo, che indica quasi sempre i l tipo di legatura, i l Centurione non doveva ricercare i l lusso della presentazione esteriore: moltissimi volumi erano in cartone, o in pergamena, mentre le rare legature in marocchino erano riservate a codici o edizioni di grandissimo pregio.
Un'ultima notizia degh "Avvisi" ci informa che per la fine del 1781 la Biblioteca delle Missioni Urbane, arricchita, trasferita in una nuova sede più ampia e riordinata, fu pronta per riaprire al pubblico, alla presenza dell'Arcivescovo. «Martedì 4,detto'̂ alla mattina fu riaperta a pubbhco vantaggio la Libreria della Congregazione della Missione Urbana di S. Carlo di Genova arricchita recentemente d'una straordinaria quantità di sceltissi-
42 "Avvisi", cit., p. 337. Archivio Durazzo, Genova, Conti di scrittura, n. 393/354. Ivi, n. 399/258.
42
A C C A D E M I E E B I B L I O T E C H E D ' I T A L I A - Anno LIV (37° n. s.) n. 2
mi libri d'ogni genere, mediante l'acquisto, che ha fatto della celebre Libreria del fu M. Sig. Marchese Lorenzo Centurione f . j . Detta Librerìa per maggior comodo di tutti è stata collocata nella parte più comoda di tutta la Città, cioè presso la Chiesa di S. Matteo nell'appartamento superiore, e più ampio, d'un Palazzo, che sul principio della salita a mano dritta ivi possiede i l M . Sig. Carlo Doria del M . Ambrogio, e starà aperta in tutti h giorni feriah d'Inverno 3. e mezza alla mattina, e 2.ore al dopo pranzo, e neUe altre stagioni alquanto più a proporzione della maggiore lunghezza del giorno»''^
A L B E R T O P E T R U C C I A N I
"5 "Avvisi" di Genova, n. 49 (8 dicembre 1781), p. 387.
43