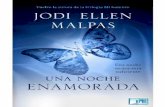Una chiesa incompiuta e una casa irriconoscibile: le vicende infauste del complesso dei Teatini a...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Una chiesa incompiuta e una casa irriconoscibile: le vicende infauste del complesso dei Teatini a...
A T T Id e l l ’ A c c A d e m I A
d e l l e s c I e n z ed I f e r r A r A
Estratto
Volume 90Anno Accademico 190
2012-2013
Volume 90Anno Accademico 190
2012-2013
Proprietario e copyrightAccademia delle scienze di ferrara44121 ferrara - Via de’ romei, n. 3tel. - fax (0532) 205209e-mail: [email protected] web: http://www.accademiascienze.ferrara.it
Direttore responsabileProf. roberto rizzo
Redattoredott.ssa Giuliana Avanzi magagna
Periodicità annualeAutorizzazione n. 178 reg. stampa in data6 maggio 1972 del Tribunale di ferrara
Composto per la stampasara storaristudio editoriale fuoriregistrovia zucchini, 79 - 44122 ferrarae-mail: [email protected]
IndIce Generale
consiglio direttivo pag. 5
note storiche » 7
Comunicazioni scientifiche » 11
InauGurazIone del cxc anno accademIco » 13
lucIo rossI
la scoperta del bosone di Higgs e le nuove prospettive di ricerca all’lHc del cern » 17
enrIco lIsta, GIan matteo rIGolIn, Francesco cavazzInI,antonIo cuneo
Terapie innovative delle leucemie acuteIl paradigma della leucemia a promielociti » 47
antonIo Pastore
la roncopatia e la sindrome da apnee notturne » 59
mIchele caPuto
The homogeneity of european economies (an econometric approach) » 67
Paolo sturla avoGadrI
ferrara 1333: la vittoria dimenticata » 79
laura GrazIanI secchIerI
Una chiesa incompiuta e una casa irriconoscibile: le vicende infauste del complesso dei Teatini a ferrara » 93
5
le cronache e gli storiografi più accreditati, in quanto contemporanei o quasi agli avvenimenti che descrivevano, hanno tramandato in modo impreciso o, per lo meno, incompleto quanto è avvenuto dal momento in cui i chierici regolari Teatini(1) si sono insediati in ferrara e, poiché non esiste uno studio che sia insieme documenta-to ed esaustivo sulla nascita del complesso edilizio ferrarese(2) riferito a tale ordine(3), è innanzitutto imprescindibile prendere in esame il carteggio storico che sottende alla costruzione e della chiesa e della casa(4) dei Padri stessi. In gran parte composto da atti notarili e piante policrome, questo carteggio è conservato per la quasi totalità nel fondo Teatini dell’Archivio storico diocesano di ferrara.
come è intuibile, la costruzione di tale organismo ha determinato lo stravolgi-mento dell’area urbana prescelta che da secoli si era andata pienamente consolidan-do in edilizia abitativa e commerciale, fino a giungere addirittura all’inglobamento di un tratto di asse stradale, per quanto secondario. È, invece, molto meno prevedibi-le che del vasto insieme architettonico siano rimaste solo deboli tracce: a parte l’im-ponente mole della chiesa (che già durante le fasi costruttive spaventava il cardinale legato preoccupato di perdere la visuale che godeva affacciandosi dalle finestre del castello) all’apparenza è sopravvissuto ben poco della struttura del complesso re-sidenziale dei chierici regolari, che è stata frazionata, smembrata e trasformata di nuovo in edilizia abitativa e commerciale. l’area coinvolta in questa articolata vicenda è compresa fra quattro assi stradali: a nord corso Giovecca(5), ad est via Bersaglieri del Po (in antico: strada dei Bastardini per la presenza dell’omonimo ospedale o ricovero di esposti e orfanelli)(6), a sud via cairoli (in precedenza: via Borgo nuovo)(7) e ad ovest via dei Teatini (anticamente: strada dei naranci e strada delle Berline)(8) posto ai margini settentrionali della città medievale e attraversato orizzontalmente dalla strada del Gambero(9) che correva parallela alle mura, l’isolato era urbanizzato già in epoca altomedievale, come dimostra la documentazione ar-
Laura Graziani Secchieri
UnA cHIesA IncomPIUTA e UnA cAsA IrrIconoscIBIle: le VIcende InfAUsTe del comPlesso deI TeATInI A ferrArA
Relazione svoltanella seduta accademica
del 25 ottobre 2012
6
Laura Graziani Secchieri
chivistica che è inerente le preesistenze edilizie (diverse per dimensione e tecniche costruttive, in gran parte di diretto dominio del vescovo o di altri enti ecclesiastici), che non ho ritenuto opportuno e necessario richiamare in questo studio in quanto non sono determinanti ai fini della conoscenza del nucleo edificato dai chierici re-golari di san Gaetano Thiene.
la forza e la vivacità delle idee riformiste avevano portano non meglio iden-tificati «personaggi grandissimi»(10) a richiedere l’introduzione in ferrara di nuo-vi ordini religiosi quali i Teatini: il duca Alfonso II aveva sempre risposto che gli ecclesiastici in città erano adeguati per consistenza quanto per moralità e che non intendeva aumentarne il numero poiché desiderava che fossero sostenuti in modo consono dalla carità sua e dei suoi cittadini, fino a lasciarsi convincere ad invitare da Vicenza «la nobil famiglia Tieni di san Gaetano»(11) che però si estinse dopo poco, con la morte del conte ottavio scandiano, ultimo della terza generazione di Teati-ni. Questa vicenda tratteggiata da scalabrini adombra una prima venuta in ferrara di un gruppo di chierici regolari presto scomparsi(12) di cui non ho trovato alcuna traccia nella documentazione conservata nel fondo omonimo, all’Archivio storico diocesano di ferrara. le richieste finalizzate all’introduzione della congregazione dei Padri Teatini in città hanno, poi, preso rinnovato vigore a cavaliere dei due primi decenni del XVII secolo, in particolare per opera di alcuni devoti cittadini fra cui spiccava lucrezia seghizzi: di origine senese, era stata dama di corte della duchessa di Urbino. neofita, si dimostrò non solo devotissima e osservante, ma soprattutto at-tivissima in questa come in altre circostanze(13) in cui la fede cristiana esigeva opere di azione e propaganda: molto spesso l’attivismo dei neofiti ha superato persino le aspettative dei rispettivi protettori cristiani. e questo deve essere stato il caso anche di lucrezia seghizzi, le cui reiterate istanze (durate 18 anni, secondo scalabrini(14)) riuscirono ad ottenere che il vescovo di ferrara, Giovanbattista leni, consentisse l’introduzione in città dei chierici regolari: il primo trattato è stato sottoscritto dai Giudici dei savi nell’aprile del 1610(15) fino ad arrivare al 20 giugno 1616 quando giunsero infine a ferrara don Giovanpaolo fornari(16) e don Vincenzo ravenna, che vennero temporaneamente accolti proprio nell’abitazione della stessa seghizzi.
con maggiore proprietà, l’introduzione in città dei Teatini, dei frati del terz’or-dine di san francesco e degli Agostiniani scalzi è stata opera del vescovo Giovanni Battista leni: il suo episcopato ha avuto detrattori, che gli hanno imputato soprat-tutto la mancata residenza a ferrara, con il conseguente demandare a collaboratori i propri doveri pastorali, ma anche l’interesse eccessivo rivolto alle rendite e alle tassazioni dei benefici ecclesiastici. ma ha visto anche estimatori in quanti gli hanno
7
Una chiesa incompiuta e una casa irriconoscibile: le vicende infauste del complesso dei Teatini a Ferrara
riconosciuto «i meriti di una sistematica perlustrazione della diocesi, della celebra-zione dei sinodi, dell’attenzione quasi ossessiva per la formazione -anche cultura-le- del clero»(17). In quest’ottica sono da leggere in special modo le introduzioni dei nuovi ordini appena citati, e in particolare quella dei Teatini, appunto.
Il 22 giugno 1616, il vescovo leni scriveva da roma al vicario locatelli cal-deggiando la permanenza dei religiosi a ferrara e sollecitando l’assistenza da pre-stare loro:
Per quel che Vostra signoria mi tocca, circa il negotio de i padri theatini, devo dirle che mi è caro di sentire che camini bene, et che possa in breve sperarsi l’introdutione loro in cotesta città, dove sono aspettati con tanto desiderio.Vostra signoria nono manchi, dove può aiutare, e promovere l’opera con la sua dili-genza, che ne sentirò molto gusto; et per li due padri, che s’aspettano, mi contento che per qualche tempo sia data loro comodità di quelle due stanze, solite da concedersi a’ predicatori, et nel resto approvo tutto ciò che da lei è stato fatto sin hora in servitio loro(18).
In effetti, già il 24 giugno 1616 don Giovanpaolo iniziò a predicare nella chiesa episcopale, «con grandissimo concorso di popolo»(19) e relativo apprezzamento, ed è del 20 luglio la successiva lettera attraverso la quale il vescovo leni ribadiva di aver
veduto la capitolazione fattasi per i padri teatini, i quali meritano d’esser aiutati, et spero che in servitio dell’anime faranno ottimi progressi. non manchi ella di far quel che può in servitio loro, ch’io ne haverò gusto(20).
Infine, è datata 11 agosto la «raccomandatione» perché venisse accettata la «loro religione» in ferrara che il cardinale carlo emanuele Pio di savoia «seniore» ha inviato da casale al maestrato dei savi(21).
Poco significative le notazioni al riguardo effettuate dai cronachisti contempora-nei. faustini(22) ha segnalato in modo generico nel 1616 che
vennero in questi giorni a piantar casa in questa città non senza dispiacer d’animo di quelli che per la venuta di questi buoni religiosi pubblicamente se ne lamentarono.
Un anonimo(23) ha riportato cheVennero in detto anno [1616] i padri Teatini a ferrara, li quali sin che ebbero edificato una chiesa per modo di provisione dedicata alla santissima Vergine, officiarono la chiesa dei Bastardini.
8
Laura Graziani Secchieri
la data precisa è riportata da olivi(24), insieme a qualche altro dettaglio: furono introdotti in ferrara del 1616 il 20 giugno facendo dar principio a detta chiesa sopra la via della Giovecca, avendo acquistate le case di francesco Paino su la Gio-vecca e dal cardinale carlo Pio di savoja, che li donò alcune case a detti religiosi.
Infine, Ubaldini(25) ha annotato che, durante la legazione del cardinale serra,s’introdussero i padri teatini nella nostra città, e piantarono la loro chiesa sulla strada della Giovecca, incontro il palazzo de’ magnanini, i quali padri poscia anno dato rag-gio non ordinario della loro bontà e frequenza nelle cose del servizio di dio, eccitando con quest’azioni la frequenza della città alla loro chiesa, la quale poi indi a X anni co-minciarono a dilatare, quanto si vede per il disegno da essi gettato, assai più di quella parca misura di cui nel loro ingresso protestarono di contentarsi, e con demolizione di molte case de’ particolari cittadini, che ad essi gli anno vendute.
Peraltro, questi brani anticipano alcuni momenti della vita dei Teatini a ferrara che avremo modo di analizzare: la realizzazione di una prima chiesa, le dimostra-zioni offerte dai chierici regolari di possedere profonde doti cristiane e di prati-care l’esercizio delle azioni di carità e di apostolato, l’attrazione e la devozione dimostrate dalla cittadinanza nei loro confronti e, infine, dopo solo dieci anni dalla consacrazione della prima chiesa, la costruzione di un secondo tempio molto più prestigioso, forse anche più di quanto i Teatini avevano in principio mostrato di desiderare, almeno secondo quello che lasciano intendere le parole non troppo velate di Ubaldini. ma tale progetto e la sua concretizzazione si accordavano in modo perfetto con la regola dei chierici regolari Teatini dettata da san Gaetano da Thiene:
sia povera la casa, scarsa la mensa, lacero il vestito, ma sia ricca, sia ornata, siabella la chiesa(26).
Appena installati a ferrara, i Padri Teatini trovarono una collocazione provvisoria dove officiare nella chiesa di san cristoforo annessa al conservatorio dei Bastardini, sull’odierna via Bersaglieri del Po. stabilirono peraltro la loro prima abitazione nel vicino Borgo nuovo (l’attuale via cairoli), in un edificio concesso loro dagli eredi di Gaspare levalori, Teologo della cattedrale, ad ulteriore dimostrazione dell’ap-prezzamento riscosso a tutti i livelli(27). così prossima alla cattedrale, alle residen-ze del vescovo e del cardinale legato, quest’area deve avere riscosso il gradimen-to del piccolo nucleo di chierici regolari, decisisi a trasformarla nella loro sede
9
Una chiesa incompiuta e una casa irriconoscibile: le vicende infauste del complesso dei Teatini a Ferrara
ferrarese visto che già il 12 dicembre 1616 essi hanno acquistato dal «coramaio» francesco del fu Ippolito Paino due edifici con cortili, pozzi, due botteghe e una stalla posti sulla via della Giovecca nella contrada del sesto di san romano, confinanti da un capo con la stessa via, dall’altro capo in parte con il conte ercole Trotti e in parte con Giovanni da como, da un lato con i fratelli Girolamo e Alessandro magnanini e dall’altro lato con gli eredi del maestro sebastiano Bonaccioli(28). del resto, dopo pochi giorni, il 17 dicembre, il Preposito dei Teatini dichiarava espressamente di aver comperato tali edifici sulla via Giovecca «pro fundatione eorum religioni»(29). sul terreno appena acquistato sono subito iniziate le opere per la costruzione della «chie-siola» il cui sedime è individuabile nell’area contigua al sagrato dell’odierna chiesa, mentre non altrettanto riconoscibili sono le sue linee architettoniche primitive: si trat-ta infatti dell’ormai anonimo edificio che da fine settecento è stato sede dell’Agenzia dei Beni nazionali del Basso Po della municipalità centrale Provvisoria di ferrara, quindi, dell’Ufficio Postale e poi proprietà del demanio dello stato.
I lavori di costruzione di quello che fu il primo tempio dei Teatini in ferrara sono documentati nel volumetto intitolato a posteriori Spese nella fabrica della chiesa vec-chia, che testimonia come il 10 ottobre 1617 si sia iniziata l’impresa demolendo le «case ove s’havea da edificar la chiesa»(30) che aveva affaccio diretto sulla strada della Giovecca, priva del filtro naturale costituito da un sagrato antistante. dallo schizzo frettoloso allegato al piccolo libro (fig. 1) e dalle piante che avremo modo di analiz-zare in seguito, possiamo ricavare che, inizialmente, la «chiesiola» era una semplice stanza rettangolare a 2/3 della quale era una parete curvilinea ad abbozzare l’abside. solo in seguito, dopo il probabile intervento di luca danese, il corpo di fabbrica ha as-sunto una più modulata architettura interna, assumendo la funzione di oratorio (fig. 4).
ma ritorniamo al 1616 quando, al fine di agevolare le maestranze, è stato com-missionato all’architetto Giovanni Battista Aleotti(31) il disegno per un modello in legno della erigenda prima chiesa(32). le opere costruttive si sono protratte per circa due anni, durante i quali i Teatini hanno continuato ad officiare nella vicina chiesa di san cristoforo dei Bastardini, dove hanno effettuato anche qualche spesa per piccoli interventi testimoniati nel già citato volume delle Spese, quale la realizzazione di un pulpito per le prediche della Quaresima del 1617.
l’ultimazione della costruzione della piccola (in confronto al più maestoso tem-pio che ammiriamo ora) chiesa, completa di apparati decorativi, è stata festeggiata con la funzione pubblica di benedizione da parte del cardinale legato Giacomo serra, il giorno 8 settembre 1618, con grande affluenza di credenti(33). forse proprio per il grande consenso suscitato dai Padri Teatini fra i ferraresi, l’edificio appe-
10
Laura Graziani Secchieri
na consacrato si è dimostrato ben presto insufficiente determinando nei chierici regolari la necessità e il desiderio di realizzare un nuovo complesso edilizio che comprendesse insieme sia un più adeguato luogo di culto sia una residenza per loro stessi maggiormente consona. Il programma di acquisizione fondiaria è stato serrato soprattutto nei decenni 1620 e 1630, per subire un deciso rallentamento e poi riprendere vigore nell’ultimo lustro del XVII secolo. oltre agli atti di acquisto, sono state frequenti anche le vertenze per la definizione delle giuste valutazioni da corrispondere ai venditori.
che i Teatini si fossero stanziati stabilmente fra le vie Borgo nuovo e del Gam-bero è evidenziato anche dalla richiesta datata ottobre 1617 che essi hanno inoltrato ai Giudici dei savi per poter costruire un raccordo in quota che consentisse loro di raggiungere la chiesa dalla loro prima casa senza dover scendere in strada(34):
I Padri Teatini, desiderando che Vostra signoria Illustrissima le conceda che possano far un transito che passa sopra la stradella del Gambaro nella parte ch’è più propinqua al castello, per servizio dell’andare dalla casa, ch’al presente habitano nel Borgo alla Giovecca, dove faranno la chiesa loro.
la concessione di realizzare «uno ponte sopra la stradella incontro a san cristo-fano»(35), cioè via del Gambero che correva fino di fronte a san cristoforo dei Bastar-dini, veniva elargita il 27 ottobre 1617, «stando che non impedirà il transito publico di detta stradella, nè meno offenderà». si tratta del primo evidente passo della ‘co-lonizzazione’ dei due isolati originari. oltre alla situazione patrimoniale e fondiaria, una pianta policroma alquanto schematica forse di mano di luca danese(36) mostra, in modo efficace sebbene un po’ rozzo, la soluzione distributiva messa in pratica per superare la non-contiguità fra la casa ed il primo tempio: per la pochezza della tecni-ca utilizzata (una lunga striscia mobile di carta bianca incollata solo ad un estremo), non può essere definita come un’effettiva riproduzione della soluzione architettonica realizzata, della quale non ci rimane traccia(37). ritengo che questa sia la più antica fra le piante conservate nel fondo Teatini dell’Archivio diocesano (fig. 2): essa propone la perimetrazione delle unità immobiliari prima degli acquisti, con indicazioni dei nominativi dei rispettivi proprietari e dei livelli che erano pagati al momento (e che gli stessi Teatini avrebbero dovuto continuare a pagare anche in seguito, a meno che non avessero affrancato il livello o permutato il bene con altro immobile libero da livello).
nella pianta, si legge dall’alto:– su via Borgo nuovo: «sestola; Padri Teatini pagano alla cattedrale del duomo di
ferrara; Piganti pagano alla camera Apostolica, al duomo e a san domenico»
11
Una chiesa incompiuta e una casa irriconoscibile: le vicende infauste del complesso dei Teatini a Ferrara
– sul fronte sud della strada del Gambero: «filatoiero»– sulla strada dei naranci: «Piganti fideicommisso; naranci stalla non paga; monal-
dino»– in angolo fra le strade del Gambero e dei naranci: «carpi stalla non paga»– sul fronte nord della strada del Gambero: «Trotti cortile paga/rimessa magazzino»
(confinante con la prima chiesa).– in angolo fra strada dei naranci e via Giovecca: «magnanino fideicommisso»– su via Giovecca: «chiesa dei Teatini.»
Il 28 settembre 1621 la famiglia levalori ha promesso di vendere ai Padri Teatini un edificio affacciato sia sulla contrada di Borgonuovo sia sulla via del Gambero, che confinava da un lato con il dottor ercole Piganti e dall’altro lato con i fratelli sestola(38); di diretto dominio della fabbrica del duomo, l’immobile è stato orga-nizzato distributivamente come prima casa per i confratelli. ma, come evidenzia chiaramente la richiesta del 1617 già esaminata, levalori doveva averlo già conces-so loro in affitto (sebbene non si sia trovata traccia di questa transazione nel fondo Teatini): una conferma di ciò ci arriva in via trasversale da un atto di compravendita del 15 agosto 1621 (che analizzeremo in seguito) che è stato rogato proprio nel con-vento dei Padri Teatini.
Il 4 dicembre 1628, infine, levalori ha ceduto loro in modo definitivo questo fabbricato con le sue pertinenze: conosciamo la struttura interna e l’articolazione della casa, abitata dai padri probabilmente già dal 1616, attraverso due piante po-licrome(39), che si possono ipotizzare essere di mano di luca danese per i motivi esposti nell’analisi dello schizzo di pianta che presenta il collegamento in quota fra casa e prima chiesa dei Teatini; entrambe le planimetrie sono arricchite da una legenda piuttosto complessa, oltre a presentare le indicazioni relative alle vie che identificavano gli isolati ormai uniti e che sono parte integrante delle piante. nella prima(40) si leggono queste indicazioni toponomastiche:
strada Principalissima detta la Gioveccastrada detta de naranci da Borgo nuovo in Gioveccastrada frequentata detta Borgho nuovostrada frequentata detta di san cristoforo o Bastardini dalla Giovecca a Borgonuovo e in piazza per diritto
Utilizzando un codice misto (grafico, alfanumerico e cromatico), la legenda della tavola riporta:
1 – siti di diverse persone da comprarsi col tempo, e comodità per ampliatione della casa.
12
Laura Graziani Secchieri
2 – siti del signor Geronimo magnanino da comprarsi con comodità fatta la chiesa per farne la Piazza.3 – due casette del signor Geronimo magnanino da comprarsi necessariamente per la nuova chiesa. 4 – stalletta e rimessa del signor mazzolino da comprarsi necessariamente per la fabbrica della nuova chiesa.5 – stanziola del signor sinardo da comprarsi necessariamente per la fabbrica della nuova chiesa.6 – Pezzo di stradello da ottenersi in dono dalla comunità, per ampliatione della casa col tempo.Verde – siti in campo verde compri dal principio per habitatione de padri dalli leva-lori(41).marrone – siti in campo morello compri da messer francesco Paino per ergervi la prima chiesa dal principio.Giallo – siti in campo giallo compri nuovamente da diversi per fondarvi la seconda chiesa.rosso – siti in campo rosso compri ultimamente per farvi sagristia et oratorio, ovvero stanze, dal menegatti(42).7 – Pezzo di strada in campo giallo donato dalla comunità, e già incorporata nella nuova chiesa(43).8 – stalla del signor dottor monaldino già compra, et atterrata per la nuova chiesa(44).9 – stalle delli signori Trotti, e carpi già comprate et atterrate per la nova chiesa(45).10 – rimessa del signor Trotti già comprata l’altri suoi siti per la nuova chiesa, ma non ancora atterrata.11 – Parte dello stradello donato et incorporato nel corridore che conduce di casa in chiesa.12 – cortiletto e giardinetto del signor Piganti già compri, e necessari per la fabbrica della nuova chiesa.13 – siti già compri dal signor Piganti, e da atterrarsi necessariamente per la fabbrica del coro della nuova chiesa(46).14 – Tre stanze della ragione della casa del signor levaloro già atterrate per causa della fabbrica della nuova chiesa.15 – Gallinaro della ragione della casa già atterrato come necessario sito per la chiesa nuova.16 – Tre stanze ristorate di nuovo invece delle tre atterrate della ragione della casa per la nuova fabbrica.17 – due stanze oscure da illuminarsi in atterrare i siti del coro.18 – corridore di piedi 48 da atterrarsi parte nella fabbrica del coro nuovo.19 – otto stanze fra la casa antica, e la nuova oltre le tre stanze solite ad habitarsi da sacerdoti.20 – Tre stanze per fratelli laici a quali di sotto corrisponde la sagristia con l’atrio.21 – saletta a cui disotto corrisponde il portico vicino la porta.
13
Una chiesa incompiuta e una casa irriconoscibile: le vicende infauste del complesso dei Teatini a Ferrara
22 –Atriolo a cui di sotto corrisponde in parte l’oratorio ed in parte l’atrio della porta di casa.23 – cucina a cui di sotto e denanzi corrisponde cortiletto e luogho da tinazzi.24 – dispensetta a cui di sotto corrisponde i parte l’oratorio.25 – scala dal portico un saletta, et atriolo che va in vestiario, che corrisponde di so-pra, e di sotto li lochi soi(47).26 – lumacha che conduce di sopra al Granaro e di sotto al corridore che va in giar-dino, e in chiesa.27 – refettorio, a cui di sopra corrisponde il Graaro, e di sotto la cantina.28 – stanzetta per le robbe del refettorio, a cui di sotto corrisponde una dispensetta, o custodia.29 – corridore di pietre e calce coperto che conduce di casa in sacristia, chiesa e giardino.30 – due già notate stanze, e di sotto vi è la stanza grande dal fuoco, e serve anche per forastieri.31 – due stanze sotto la camera dei reverendi Padri regolari che servono per Priore e fratelli con il corridorietto denanzi.32 – Gallinaro della casa comprata del Piganti già atterrato in parte, e da atterrarsi tutto per causa della fabbrica.33 – cortiletto della casa del signor levaloro già nostra il quale va scemato un poco per causa della fabbrica di chiesa.34 – Giardinetto di casa del quale una picciola parte va incorporata nella nuova chiesa.35 – Vialetto che stava davanti l’oratorio il quale corrispondeva sotto le tre notate stanze tutto atterrato.36 – [rosso] oratorio all’angolo della casa compra dal signor levaloro di longhezza piedi 81 ½ e largo da un parte 15 e dall’altra 14.37 – [rosso] Botegha sul cantone con due stanze appresso che si affittano nella casa havuta dal signor Piganti.38 – [rosso] magazzinetto imprestato al signor lanzi notaro nostro che gratis ne ser-ve, cavato dalla casa del signor Piganti.39 – [rosso] stanze a terra per cantina, legna calce sabbione etc. da atterrarsi parte resta in piedi. notili che le linee fate de punti(48) significano le mura dell’appartamento di sotto.40 – sito, e positura della nuova chiesa e piazza di lei.41 – Parte di casa coperta comprata dai Padri dal signor Geronimo sestola coperta posseduta da Padri di sopra in mezzo e di sotto a piano terra, confina da mezzo giorno la contrada predetta di Borgo nuovo, e da ponente i padri medesimi.42 – Parte di casa coperta comprata dai Padri e posseduta da loro dal signor Geronimo sestola e posseduta da loro solamente nella parte di sopra, ma in mezzo e tutto a piano d terra posseduta dal signor dottor Pierro Bosco, confina a mezzogiorno con la strada pubblica di Borgo nuovo e da levante col maestro Pietro Bocco fruttarolo.43 – Parte della suddetta casa coperta comprata da’ Padri dal signor sestola e pos-
14
Laura Graziani Secchieri
seduta da loro solamente nella parte di sopra, ma in mezzo dal signor dottor Piero Bosco, e nel di sotto a terra dal magistro Gioan Giacomo rizzola filatoiero, confina da levante col magistro Pietro Bocco fruttarolo, da tramontana con Gioan Giacomo rizzoli filatoiero.44 – cortile scoperto della casa comprata da’ Padri dal signor Gerolamo sestola e da loro posseduto confina da ponente coi padri, da tramontana con la stradella del Gam-baro mezza chiusa ed a levante col magistro Gioan Giacomo rizzoli.45 – stalletta coperta comprata da’ padri dal signor Gerolamo sestola e da loro posse-duta in tutto, confina da levante col magistro Gioan Giacomo rizzoli e da tramontana col stradello del Gambaro mezzo chiuso.
Già dal 15 agosto 1621 era iniziata l’articolata campagna di acquisti finalizzata ad ottenere la totale disponibilità dell’intera area dei due isolati originari, compresa la sede stradale di via del Gambero che sarà annessa: il freddo formulario notarile non entra nel dettaglio delle volontà dei Padri, volontà che sono, però, chiaramente leggibili nella realtà dei fatti e nelle piante. È possibile, infatti, inanellare la lunga te-oria di rogiti di compravendita, ad iniziare da quando, in quella data(49) i contraenti si sono trovati davanti al notaio «ferrariae in conventu infrascriptorum reverendorum patrum Teatinorum». A nome proprio e di suo fratello Giovanni, il mercante ercole di Giacomo mazzolini ha venduto al prezzo di 1200 lire ai padri Vincenzo raven-na genovese, Geminiano mazzoni modenese, Vincenzo Bottaro genovese, Antonio dattilo piacentino, carlo clementino riminese, emanuele Porro genovese e Tomaso moles napoletano «quali comprano per il monastero e casa loro di ferrara» una stanza «ad uso di stalla e di rimessa da carretta o carrozza» in muratura, coperta di coppi e con solaio, pozzo e altre pertinenze.
Poco dopo, il l6 ottobre dello stesso anno, Girolamo sestola ha alienato un edifi-cio posto fra le strade di Borgonuovo e del Gambero(50). sono molto dettagliati i patti stretti a tal riguardo da venditore ed acquirenti(51). la stima dell’edificio era stata eseguita dal perito Girolamo ferri(52).
Il 24 febbraio 1628, rogando «in aedibus infrascriptorum reverendorum patrum Teatinorum in contracta Burgi novi» Paolo menegatti ha venduto un edificio in via del Gambero(53). l’anno seguente, è stata la volta del conte orazio del fu Alfonso Trotti, della contrada di Borgonuovo, che ha ceduto 2 parti su 3 di una stalla con fie-nile, corte e pozzo e altre pertinenze, nella contrada del Gambero, che era di diretto dominio della sagrestia del duomo e dei Padri serviti della consolazione. conte-stualmente, anche il dottor Paolo carpi ha venduto la sua porzione di proprietà sulla stalla(54). l’assoluzione dell’avvenuto pagamento di 750 scudi di moneta vecchia è
15
Una chiesa incompiuta e una casa irriconoscibile: le vicende infauste del complesso dei Teatini a Ferrara
stata rogata il 15 dicembre nell’abitazione dei chierici regolari posta nella contrada di Borgonuovo(55).
nell’agosto 1626(56), i Teatini sono ricorsi al Giudice dei savi per ottenere di po-ter usufruire in modo permanente ed esclusivo di una porzione di via del Gambero:
si ritrovano in necessità di tanta parte di quella stradella che divide in due isolette la loro chiesa dalla loro casa, quanto occupano i siti, che la presente hanno sopra di essa, et che occuperanno quelli del signor dottor Pigante, et monaldino ottenuti, che gli haveranno da essi a fine di poter fabbricare, et unire le suddette loro chiesa et casa.
la richiesta è stata seguita da una relazione redatta dal perito delle comunità, ercole morandi, datata 31 agosto 1626, cui è allegata una pianta esplicativa (fig. 3):
Gli Padri Teatini vorebbero asserare la stradella detta di Gambareto che referisce con un capo agli Bastardini, et dall’altro alla strada delle Berline, però tanta parte di quel-la quanto siano il sito da loro occupato al presente et che vogliono occupare, come dicono: per farvi la nova chiesa emonasterio, et per cheVostra signoria Illustrissima possa più facilmente conoscere il fatto, lo dimostro con i segni che fanno forma del sito e fabriche occupate, et che vogliono occupare, necessarie a loro volendo fare la nova chiesa, la stradella à l’ingresso da ogni capo, chiusa che sarà, restarà come vul-garmente si dice una strada senza capo, e vero che non fa danno che alle nove casete descritte et quella del sestola: ma questa ha il suo ingresso nel Borgo, le due altre delmisolo e Berni per la strada de bastardini, dove che il scomodo restarà solo a sette casete, et è scomodo di non potere hire per la stradadella delle Berline la solita entrata et uscita, dicono anco che nel richiesto luoco vi entra con la chiesa due porte picciole che per il giorno sarà aperto l’ingresso, la parte che vorebero le fosse conceduta, è la segnata di giallo senza la quale non possono fare la detta chiesa stando il disegno a me dimostrato, non hanno ancora le case delli signor Pigante e monaldino, ma son a partito come quelle del signor magnanino e naranzi segnate di pavonazzi luoco apunto dove andarà la chiesa, et questo è quanto ho veduto et inteso da essi reveren-di padri, i quali dicono non volere al presente altro sito che quanto le dimostro nelli pochi segni, et perciò richiedono in gratia la detta parte di stradella et la vorebbero credo anco che non l’habbino bene bene dichiarato hauto luoco delli signori Pigante e monaldino, chiudere, per poter fare novo passaggio terreno e chiuso; per potere anda-re alla di presente chiesa e fuggire l’ingiurie del giorno e note da quale restano offesi et facendole riverenza quanto ho inteso e visto le riferisco il di ultimo Agosto 1626
ercole morandi perito della Illustrissima comunità
case che restano nella strada di Gambareto quando si asseri per gli Padri Teatini Item contiguo a loro dal destro latto vi è la casa delli signori Heredi di GiovanniBattista sestola et Gerolamo Parolino, ed a l’ingresso per la strada di Borgo novo mareferisse anco in detta stradella
16
Laura Graziani Secchieri
Item contigua a lei una caseta di madonna claudia mazzonaItem contigua lei una caseta di messer francesco moletaItem contigua a lei una caseta delli heredi di messer Giovanni Battista BonettoItem contigua a lei et fa cantone et a l’ingresso bella strada de Bastardini una casetadelli heredi di messer Giovanni Antonio Berna
da l’altro latto per contiguo a detti reveredi Padri per sinistraItem una caseta delli heredi di messer Giovanni stampatoreItem contigua una caseta di messer marcantonio e fratelli di nogaraItem contigua una caseta di messer Giovanni Battista santinazzoItem contigua una caseta delle reverende madre di san GuilelmoIten contigua et fa cantone et a l’ingresso nella strada de Bastardini una caseta dimesser ludovico misolo.
la licenza veniva concessa l’11 settembre 1626 mentre, il 14 dello stesso mese, il dottor ercole del fu Girolamo monaldini, della contrada di Borgonuovo, ha cedu-to per 600 scudi una stalla in muratura, coperta di coppi, con solaio e pozzo, posta nella contrada dei naranci nella parrocchia della cattedrale, in angolo fra due vie e confinante da un capo con i fratelli naranci e da un lato con il dottor Piganti, che egli aveva avuto come dote di lucrezia sogari(57). dettando l’atto «in domo et manaste-rio infrascriptorum patrum positis in contracta Burgi novi», i Teatini dichiaravano di effettuare l’acquisto «ad finem compliendi eorum ecclesiam et monasterium in hoc civitate ferrariae».
Il 30 agosto 1627, il giureconsulto dottor ercole figlio di cesare Piganti, della contrada di Borgonuovo sotto la parrocchia della cattedrale, aveva ceduto ai Padri Teatini per 1300 scudi un edificio di diretto domino della fabbrica del duomo e del convento di san domenico; con una bottega da barbiere, con cortile e giardino, era posto sulla stessa via di Borgonuovo vicino alle aedes dei Padri Teatini e confinava sul lato posteriore in parte con via del Gambero e in parte con i medesimi acquirenti, da un lato ancora con questi e dall’altro lato in parte con la stradella di Borgonuovo, in parte con francesco Isnardi, in parte con il dottor Antonio naranci e in parte con gli stessi Padri Teatini con le ragioni dei monaldini(58). In questo atto viene indicato esplicitamente che i chierici regolari effettuavano l’acquisto per completare i loro chiesa e monastero nella città di ferrara:
ad finem compliendi eorum ecclesiam et monasterium in hoc civitate ferrariae.
Quello stesso giorno, nell’abitazione del notaio camillo lanzi nella contrada di Borgonuovo, la nobile ferrarese Vittoria del fu domenico correggiari ha alienato per
17
Una chiesa incompiuta e una casa irriconoscibile: le vicende infauste del complesso dei Teatini a Ferrara
1100 scudi un edificio che aveva acquistato il 14 giugno dello stesso anno da Antonio maria scannabecchi alias dal sole(59): in muratura, coperto di coppi e con solai, con cortile e pozzo, era posto nella stradella di Borgonuovo nella parrocchia di san ro-mano e confinava, oltre che con la stradella stessa, in parte con i muzzarelli e in parte con la viazzola esistente dietro e in parte con i conti romei, da un lato con il dottor Antonio naranci e dall’altro con suo fratello Giovanni Agostino(60). Girolamo ferri ha eseguite due perizie estimative dell’edificio prospiciente la via «detta de’ naranzi» di proprietà di Vittoria correggiari, la prima datata 1° aprile 1628 e la seconda del 3 dicembre 163(61).
Il 4 dicembre 1628, levalori ha ceduto l’edificio già concesso in affitto e nel quale i Padri Teatini aveva istituito la loro prima casa(62) mentre, l’anno seguente, cesare Turchetti di Belgrado, neofita battezzato a modena, ha venduto ai chierici regolari la terza parte, posseduta pro indiviso con altri, di un fabbricato in via del Gambero(63). Il 27 ottobre dello stesso anno 1629, francesco Isnardi ha alienato loro una stanza a piano terreno utilizzata come magazzino, posta nella stradella di Bor-gonuovo(64). la perizia estimativa era stata eseguita da Girolamo ferri(65). nell’am-bito della campagna immobiliare, i Padri Teatini hanno risolto di permutare un loro edificio nella contrada di Borgo dei leoni con altro in via Borgonuovo di proprietà dei fratelli Bonazzoli, pervenuto da Vittoria correggiari(66).
Interrompo la serie delle acquisizioni per citare l’atto del 29 agosto 1630 attra-verso il quale la fabbrica del duomo investiva i Padri Teatini di tutti i beni di suo di-retto domino; in particolare il rogito d’investitura evidenzia come l’edificio, che nel 1627 era stato venduto loro da ercole Piganti, al momento fosse confinante verso nord con le ragioni donate dalla comunità di ferrara agli stessi acquirenti nella via del Gambero: come abbiamo già avuto modo di analizzare, la municipalità aveva ceduto la sede stradale stessa per consentire la realizzazione del piano ambizioso di costruire un complesso religioso in pieno centro urbano.
Il 15 aprile 1631, i fratelli ercole e Giovanni mazzolini hanno ratificato la vendi-ta ai Padri Teatini effettuata il 15 agosto di dieci anni prima: oggetto era una stalla e rimessa, ancora nella stradella di Borgonuovo(67). Giuliana marcolini(68) ha utilizzato proprio la data dell’acquisto dai fratelli mazzolini quale punto di riferimento per datare una pianta(69) che riporta le indicazioni dei proprietari delle diverse cappelle oltre ad alcuni interessanti appunti:
queste due stanziole in campo giallo sono del signor mazzolino – vagliono da 300 scudi in corso e sono necessarie per la fondazione della capella delli signori correg-giari […] queste due casette in campo giallo sono […] signor magnanino e sono di
18
Laura Graziani Secchieri
valuta in corso […] 500 scudi e sono necessarie per la elevazione della capella delli signori corradi tutta la chiesa non potendo al presente […].
che ci permettono di chiarire che le cappelle erano già state attribuite prima an-cora di avere acquisito il terreno sul quale venivano realizzate:
tutti i pilastri et archi coloriti di rosso […] già tutti edificati e murati […].
del 3 dicembre 1631 è la perizia estimativa eseguita da Girolamo ferri relativa a un piccolo edificio prospiciente via del Gambero, di proprietà di marsilio Grandi(70) mentre è senza data la stima firmata da Girolamo Toselli sulle due casette, che Gi-rolamo magnanini affittava(71).
Quest’ultimo aveva mosso causa ai Padri Teatini ottenendo sentenza favorevole dal cardinale sante marcello, legato di ferrara, che aveva imposto ai religiosi di attenersi al valore degli edifici e alla relativa rendita, nella valutazione del prezzo degli immobili da acquistare(72); così il 5 dicembre 1634, egli ha ceduto due piccoli edifici nella strada di connessione fra via Borgonuovo e corso Giovecca(73). Testimo-nianza della lunga controversia è attestata anche dalle perizie estimative dei periti eletti dai Teatini Giacomo Toselli (senza data) e Girolamo ferri, del 23 luglio 1626 e poi riproposta il 10 marzo 1632(74).
che il programma di conseguimento fosse monitorato passo dopo passo dai chierici regolari e dai loro tecnici è attestato dall’elenco intitolato Stime de siti parte comprati e parte da comprarsi da padri Teatini per la loro fabrica come dal-le autentiche si può vedere(75), che testimonia il rigore e l’attenzione dei religiosi nell’affrontare la lunga serie di acquisti. In tale lista, sono indicate sommariamente le perizie eseguite dai due tecnici, Girolamo ferri e Giacomo Toselli, sugli edifici del dottor Piganti, di magnanini e di Alfonso Isinardi.
non sembri un’inutile divagazione interrompere a questo punto l’excursus dei documenti di acquisto per riportare che il 14 ottobre 1627 i Teatini hanno stipulato un contratto con l’architetto luca danese, attraverso il quale gli affidavano la pro-gettazione e la direzione dei lavori per la realizzazione della nuova chiesa. Viene spontaneo chiedersi quale significato attribuire all’introduzione di un nuovo proget-tista che tale incarico professionale indica: i religiosi non erano stati soddisfatti del modellino in legno di Giovanni BattistaAleotti per la prima chiesa, se mai effetti-vamente egli lo ha eseguito? oppure l’Argenta era troppo impegnato? Al contrario, forse, la figura emergente di luca danese rispondeva a diversi stimoli e differenti intenti? se, da un lato, è accertato che l’architetto ravennate sia stato al servizio del-
19
Una chiesa incompiuta e una casa irriconoscibile: le vicende infauste del complesso dei Teatini a Ferrara
la camera Apostolica di ferrara fra il 1627 ed il 1638(76) progettando e costruendo le chiese di santa chiara delle cappuccine e di santa maria dei servi oltre a quella in esame dei Teatini, restaurando e rinnovando il soffitto del duomo e disegnando alcuni interventi nelle cappelle di santa maria in Vado(77) e di san Paolo, meno noto è che egli abbia lavorato ancora per i Teatini nel 1668, quindi poco prima della sua morte, allorché ha effettuato una perizia su un piccolo immobile «in capo alla stra-della morta che è nella strada de Bastardini»(78). la figura di questo architetto mostra ancora molti lati non indagati e sconosciuti, così come la sua opera nei dettagli e, spesso, anche nell’insieme(79). In ogni caso, anticipando i temi sviluppati a san ro-mualdo di ravenna(80), l’espressione più complessa e definitiva (ma non completa, poiché la facciata è tuttora incompiuta) della sua cifra artistica in ambito ferrarese sembra essere proprio santa maria della Pietà dei Teatini. Il legame dell’architetto con l’oggetto progettato si è spinto fino a tal punto che l. danese ha voluto essere sepolto in questa chiesa.
Già il 24 ottobre, quindi dopo soli dieci giorni dalla stipula del contratto, luca danese ha steso una relazione sulle tecniche costruttive più adatte a realizzare le fondazioni della chiesa: in essa indicava la sua preferenza per una struttura sorretta da archi riversi che aveva ricavato studiando leon Battista Alberti(81) e di cui rap-presentava una porzione(82). A rafforzare la sua teoria, aggiungeva che l’adozione di tale sistema avrebbe evitato il cedimento delle fondamenta dell’interasse tra le due prime colonne della navata sinistra nella chiesa di santa maria in Vado. nella real-tà, un abbassamento impegnativo si è verificato anche nel tempio dei Teatini, nella cappella ricci(83): quindi, o la teoria di Alberti sposata da danese non era così valida; oppure quest’ultimo non l’aveva applicata correttamente; o, infine non sono state effettivamente realizzate dalle maestranze le fondazioni progettate. A ben vedere, proprio il processo, tenutosi fra il 1638 ed il ’40 per definire il finanziamento delle spese effettuate dopo il crollo di una parete di tale cappella, consente di retrodatare l’attività di danese per i Padri Teatini ad un periodo certo precedente il conferimen-to dell’incarico che ho citato. Il 26 aprile 1638(84) l’architetto ha dichiarato:
Io fui quello, che feci il dissegno della chiesa, che dovevano far fabbricare, come in effetto si fabbrica, li reverendi Padri Theatini, sempre fui assistente, mentre si lavorò ai fondamenti della chiesa, et anco parte della fabbrica sopra terra.
egli espone, quindi, di essere stato progettista della chiesa nel suo insieme, av-valorando l’ipotesi che siano dovuti alla sua mano se non tutti, almeno gran parte dei disegni preparatori di progetto del tempio. Inoltre dichiara di avere seguito le
20
Laura Graziani Secchieri
opere di cantiere, in particolare delle fondamenta e di una porzione della muratura fuori terra. l. danese ferma poi l’attenzione sulla cappella ricci, indicandone la data di fondazione al 5 ottobre 1627: almeno una parte delle piante e progetti che analizzeremo sono stati ideati e disegnati, pertanto, prima della formalizzazione del suo incarico professionale.
P. massarenti ha supposto (e G. marcolini ha supportato tale teoria) che le cinque piante dell’intera area di pianificazione, contrassegnate da collocazioni sequenziali nel fondo Teatini(85), siano altrettanti progetti preparati in successione da luca da-nese: è opportuno precisare subito che nessuna di esse peraltro corrisponde com-pletamente a quanto effettivamente realizzato nell’intero isolato. Pur concordando con l’attribuzione all’architetto ravennate, l’ipotesi di cinque diversi progetti non mi trova d’accordo, in quanto si tratta prima di tutto di rappresentazioni di quote differenti della stessa progettazione: ottengono così risposta alcuni dubbi espressi dalla stessa massarenti in modo più o meno esplicito.
la prima pianta è per certo relativa alle fondazioni, come evidenziano nume-rosi fattori quali la presenza della cloaca nel primo vano della casa verso corso Giovecca, la mancanza di porte e finestre oltre che di scale sia nella casa sia nel campanile, i setti murari continui fra le fondamenta dei pilastri e le pareti esterne della chiesa. Infine, anche la forma absidale a poligonale, che aveva intrigato P. massarenti(86), trova la sua ragione d’essere nel livello interrato non visibile fuori terra: la larghissima muratura di fondazione di questa planimetria si ‘predispone’ ad essere il basamento su cui realizzare il più snello muro arcuato dell’abside alla quota superiore.
la seconda pianta è l’unica relativa al livello del piano terra, come si evince dalla presenza delle porte verso l’esterno della casa (su via Borgo nuovo, con una piccola scalinata che si protende sulla via oltre il filo della facciata) e della chiesa (ampia quella al centro del prospetto, verso il sagrato; più piccole quelle nei due corti lati dell’avancorpo che, in pianta, è un connubio fra il protiro greco e il pronao paleocristiano), oltre a quella verso la strada laterale, appena al di là del transetto. da non trascurare anche la spia costituita dalla presenza dei nomi delle strade, uni-che indicazioni di confine possibili visto il coinvolgimento di un intero isolato(87), presenti solo in questa seconda planimetria della serie di cinque:
– Givecca(88)
– strada de mazzolini(89)
– Borgo nuovo– strada de Bastardini
21
Una chiesa incompiuta e una casa irriconoscibile: le vicende infauste del complesso dei Teatini a Ferrara
sul recto, nell’angolo in basso a destra è segnato solo: seconda pianta. la legen-da è ancora una volta ricca e dettagliata e fornisce la struttura distributiva dell’intera casa:A chiesa nuova in color rancioB sagristia in color morelloc due atrii denanzi la sagristia in color morellod stanza per le robbe del sepolcro e della novena in color morellof cimitero in color morelloG sprone che sostenta il coroH scala che conduce alla stanza de prelati sopra la capella picciola del corno dell’epistola, e al
choro de musici sopra l’atrio della porta laterale del corno dell’epistola, e sono la stanza delle machine del sepolchro e della novena in coloro rancio e morello
I Atriolo denanzi la porta della chiesa, che conduce in casa color morelloK cortile longo scopertol cortilem claustron Porta e antiportao 4 camere alla porta per la confessioneP scala che conduce alle camere sopra il claustroQ claustro copertor corridore copertos scala che conduce a 20 camere verso la piazza della chiesa e sopra le camere della loggia del
giardino e sopra il corridore di sopraT loggia verso il giardino de 9 archi e sotto di essa la cantinaV due stanze in capo al giardinoX scala che dal piano del giardino conduce a tutte le parti di sopra e a tutti i luoghi comuniY luochi comuniz oratorio@ Giardino+ cinque camere per forastieri1 stanza da prelati2 scala che conduce al corridore coperto di sopra et alla loggia scoperta sopra detto corridore
coperto, et alla libraria3 refettorio4 atrio denanzi al reffetorio5 cucina6 atrii denanzi alla cucina7 stanza da lavare i piatti8 stuffa e forno e fornello9 loggietta denanzi alla cucina10 cortile per carri, legna, tinazzi11 piazza denanzi alla chiesa
22
Laura Graziani Secchieri
non mi infonde alcuna certezza la datazione attribuita a questa pianta dedotta dalla denominazione della strada laterale attribuita dopo l’acquisto dell’edificio dai naranci: la nomenclatura delle strade è stata per lungo tempo qualcosa di incerto e variabile, come si può verificare anche solo dai rogiti di compravendita citati in pre-cedenza. e la dizione di strada dei Mazzolini era comunque motivata dal fatto che tale famiglia vi risiedeva in precedenza e ha continuato a risiedere anche in seguito in un fabbricato proprio prospiciente questa via.
la terza planimetria è relativa al primo piano(90): nelle pareti perimetrali di tutto il complesso disegnato sono infatti presenti solo le 4 porte della chiesa, evidentemente di notevole altezza, mentre su via Borgo nuovo è disegnata una sorta di coperto sporgente sulla strada a protezione della sottostante gradinata esterna d’ingresso. Quanto alla distribuzione interna della casa, è obiettivamente differente rispetto a quella presentata nella seconda pianta, proprio come può esserlo una quota diversa dello stesso immobile adibita a differenti funzioni. sono nella medesima posizione i vani scala, i gruppi di servizi igienici, le murature principali sia perimetrali sia interne strutturali, mentre diversa è la suddivisione degli spazi perché derivante da una differenziazione degli utilizzi.
Altrettanto dicasi per la quarta pianta, a mio avviso relativa al secondo piano(91), dove non compaiono più porte neppure nelle murature della chiesa ma in essa sono, invece, messi in evidenza i raccordi fra le cappelle, le catene fra i pilastri di sostegno e gli sviluppi della cupola e delle volte: in fin dei conti, una pianta non è che una sezione orizzontale e, in questo caso, alla quota del secondo piano residenziale cor-risponde una quota ibrida nel tempio. del resto, attraverso quella sola planimetria al progettista serviva fornire dati differenti rispetto alle due diverse strutture: se della chiesa si propongono i livelli di imposta delle volte e della cupola, della casa si pre-sentano solo le distribuzioni interne dei corpi che raggiungono tale livello, mentre gli altri mostrano unicamente la linea del coperto.
A sua volta, la quinta ed ultima planimetria (92) sembra riproporre il disegno del piano terra della chiesa: sono presenti le quattro porte verso il sagrato e la via latera-le, e identica è la ripartizione spaziale dei vani retrostanti l’abside, verso via Borgo nuovo; la pianta è arricchita da un abbozzo di studio di visione prospettica interna del tempio. Per quanto concerne la casa, viene proposta una distribuzione interna riferibile al terzo piano del lungo corpo parallelo e tangente la chiesa, mentre l’in-gombro degli altri elementi costruiti è definito solo da un segno sottile, che potrebbe riprodurre la linea delle coperture.
Queste planimetrie sembrano rappresentare solo la fase progettuale (oppure mo-
23
Una chiesa incompiuta e una casa irriconoscibile: le vicende infauste del complesso dei Teatini a Ferrara
menti successivi di fasi progettuali, una sorta di meta-progetto) ancora a livello propositivo, più specificamente dettagliata (e in seguito realizzata) soprattutto per quanto concerne la chiesa: difficile riconoscere nelle differenti proposte della casa gli elementi costruttivi o distributivi tuttora superstiti. In particolare, la prima pianta inerente le fondazioni si discosta moltissimo dal progetto sviluppato dalle succes-sive quattro tavole che, invece, presentano a quote diverse la medesima soluzione progettuale, oltre a proporre la persistenza della primitiva chiesa, poi effettivamente integrata nel complesso come oratorio.
Ben diverso il discorso se si analizzano altri disegni (alcune piante complete, al-tre parziali) dell’isolato, che fino ad ora non sono state mai prese in esame(93): logore, schizzate a matita, corrette e ricorrette, quasi martoriate, presentano una discreta riconoscibilità degli elementi fondamentali della casa che sarà possibile ritrovare successivamente, quali la portineria-ingresso, il refettorio, lo stesso campanile per il quale non erano valide le soluzioni proposte nelle cinque tavole presentate da P. massarenti. È plausibile che questi disegni corrispondano alla soluzione preferita dai committenti, sulla quale l. danese ha continuato a lavorare forse addirittura anche in cantiere, come mostrano il grado di logoramento dei fogli e la quantità di revisioni apportate(94). nello stesso fondo si conservano anche interessanti schizzi relativi alle chiavi di ferro e alle catene o arpesi(95), progettati e commissionati per il cantiere dei Teatini. Terminata la costruzione dell’imponente tempio nel 1653, è stato consacrato nel 1678.
meno logorato è il disegno che riproduce le fattezze dell’oratorio annesso alla chiesa, nato dalla trasformazione della prima chiesetta fondata dei Teatini(96): la pianta è affiancata dal prospetto/sezione della parete laterale e dal prospetto della zona absidale, che presentano un assetto che, nel complesso, si connota severo ed elegante (fig. 4). si deve ritenere che tale progetto sia databile alla seconda parte del seicento stando alla descrizione del 1650 che offre un quadro completo della situa-zione sia dei chierici Teatini sia delle loro casa e chiesa alla metà del secolo e che definisce la prima chiesa «rozza et piciola»:
la casa di ferrara de padri teatini è sopra la strada di Borgo novo essendovi diciot-to camere. fu pigliata dell’anno 1617 con consenso et autorità dell’eminentissimo e reverendissimo signor cardinale serra legato di ferrara, e dell’eminentissimo e reve-rendissimo signor cardinale leni vescovo di ferrara. Ha la chiesa sopra la strada della Giovecca, la qual è rozza et piciola per essere stata fatta per modum provisionis, et in fretta. Il titolo è la madonna della Pietà. Alcuni anni dopo se ne principiò un’altra più grande da alcuni nostri amorevoli, ma non è anco fornita.
24
Laura Graziani Secchieri
Gli soggetti che al presente sono assegnati di stanza in questa casa tanto sacerdoti, quanto fratelli laici sono il reverendo padre Teodosio negrisoli ferrarese preposito; il padre don Gaetano Guarini ferrarese vicario […] Tutti li detti soggetti sono professi.
non vi è rendita, né stabili di sorte alcuna, havendo solamente un casino fuori dalla Porta di santo Giorgio, donato alli padre dalla signora Barbara lotta, acciò vada-no qualche volta a pigliare aria, massime per li convalescenti, vivendosi in comune d’elemosine incerte, e quotidiane, che vengono, le quali tra danari, grano, vino, legna, robba mangiativa apprezzata, et danari delle messe si vive senza far debiti un anno per l’altro in dodeci, et anco in quatordeci persone, essendo l’introito da sei anni in qua scuti romani 936 in circa per ogni anno, et l’esito quasi l’istesso, cioè per vitto comune… somma tutto scuti romani 939 (97).
Gli acquisti immobiliari sono proseguiti per tutto il seicento, come attestano le perizie estimative eseguite da Alessandro malacoda relativamente a un edificio in via Borgo nuovo di proprietà di caterina franchini e a un fabbricato sulla via dei Bastardini di proprietà di daniele Biassioni, contigui alla casa dei Teatini(98).
nonostante la presenza di un vero e proprio seminario cui si affiancava la scuola pubblica dei Gesuiti, l’oratorio dei Padri Teatini ha rivestito una funzione importan-te nell’educazione e nella crescita morale del clero ferrarese tanto che, nell’agosto del 1695, veniva deliberato che i settantacinque ordinandi potessero praticarvi gli esercizi spirituali nell’oratorio anziché al seminario in quanto ritenuto troppo angu-sto e «mancante di molte provisioni necessarie»; al contrario, per la sua collocazio-ne urbana centrale l’oratorio dei Teatini poteva consentire ai chierici «d’andar alle loro case sera e mattina»(99).
diversamente da quelle presentate in precedenza, sono molto chiare e nel dise-gno e nell’indicazione progettuale altre due piante (fig. 7), parziali rispetto all’intera proprietà, relative alla sola area fra le strade dei Bastardini e di Borgonuovo: ancora una volta, anche esse sono prive di data, di indicazione del progettista e di colloca-zione archivistica(100).ma credo si debbano allo ‘studio di progettazione’ (per dirla in modo attuale) di Vincenzo santini e dei suoi figli Angelo e francesco. Infatti, sotto l’auspicio e la committenza dei vescovi dal Verme e ruffo, questi imprenditori ve-neti trapiantati in ferrara sono diventati parte integrante di un grandioso progetto di riqualificazione e nuova impaginazione degli elementi che costituiscono il ‘polo ec-clesiastico’ dell’intero centro cittadino articolato nel Palazzo Arcivescovile, nell’in-terno del duomo e nella piazza antistante con la loggia dei merciai, le botteghe e gli edifici di via Adelardi(101). di volta in volta, il progetto e l’esecuzione sono stati affidati a francesco muzzarelli, Agapito Poggi, Gaetano Barbieri, Giorgio foschini e Giuseppe campana, tutti affiancati a diverso titolo dai santini: ad Angelo è stata,
25
Una chiesa incompiuta e una casa irriconoscibile: le vicende infauste del complesso dei Teatini a Ferrara
del resto, commissionata la cura della sede prestigiosa del seminario trasferito a Palazzo Trotti in via Borgonuovo.
sull’onda delle ristrutturazioni in facies settecentesca, i Teatini stessi hanno commissionato a Vincenzo santini e ai suoi figli Angelo e francesco(102), appunto, la ristrutturazione e l’ampliamento degli edifici di proprio uso e la realizzazione di botteghe e fabbricati da cedere in affitto a terzi, saturando così l’intero isolato che comprende la chiesa di santa maria e del quale erano, infine, divenuti unici proprie-tari. Infatti, il 28 gennaio 1739,
considerato necessario il fare certa fabrica della di cui qualità, quantità e sorta ne hab-bino proposta l’invenzione alli magnifici Vincenzo, Angelo e francesco padre e figli ripettivamente de’ santini capi mastri muratori in questa città di ferrara
che hanno stipulato il contratto di appalto obbligandosi a consegnare tutte le bot-teghe e tutte le abitazioni dei conversi per il giorno di san michele del 1739. All’atto è allegato l’inserto che descrive le concordate:
fabrica ataco al convento dei rr. PP. Teatini, e questa parte per comodo d’essi r. PP. e il restante per uso di botteghe e case da affittare, il tutto conforme alli due disegni di Pianta e prospetto da me esibiti.
I lavori programmati comprendevano anche la ristrutturazione del refettorio, della cucina e del chiostro, l’elevazione a 12 metri della facciata dell’edificio in angolo fra le strade di Borgo nuovo e dei Bastardini, per portarsi a livello con il fabbricato vecchio che ospitava la «portaria» della casa. Questa fase prevedeva la realizzazione di fondamenta nuove «dove faccia bisogno il farlo o ingrossare quelli vecchi», oltre ad «alzare le muraglie vecchie di questa parte di refettorio che si converte in casa da affittare segnata 2 nella pianta», purtroppo non unita al capitolato ma una cui copia è all’Asdfe, come anticipato (figg. 6 e 7). I santini si impegnavano anche «ad alzare la muraglia tra il refettori e la portaria (3)», a realizzare «nella muraglia vecchia porte finestre, scaffe per botteghe; a fare la muraglia che forma il di dietro delle botteghe e camere verso i Bastardini (4 e le relative tramezze; muraglia fra le botteghe A – B e il cortile della cucina alta quan-to la facciata sopradetta» e altrettanto nelle altre botteghe, tutte individuate con lettere e tutte con un piano ammezzato; infine, a realizzare «i due archi mancanti del chiostro». la gronda a gola rovescia «o navicella» sarebbe stata costruita con tavelle in gesso o lunette. le facciate dovevano essere «stabilite in calcina ordina-ria», ossia intonacate; dovevano poi essere imbiancate tutte le muraglie e i volti,
26
Laura Graziani Secchieri
e tinteggiate le cornici e «d’attorno alle» finestre di facciata, che dovevano essere tutte fornite di scuri e di vetri.
A ricordo tangibile delle opere eseguite, i Padri Teatini fecero murare una la-pide tutt’ora visibile sulla facciata del fabbricato all’angolo fra le vie Bersaglieri del Po e cairoli. da evidenziare l’innovativa speculazione edilizia (da intendersi nel senso positivo di un investimento edilizio al fine di ottenere una rendita) realizzata proprio nella porzione di tale edificio prospiciente via Bersaglieri del Po: sono state predisposte sei unità commerciali indipendenti, ciascuna fornita di ingresso, ampia finestra a scaffe e piccola scala a chiocciola di collegamento al piano superiore di pertinenza. le botteghe erano articolate in modo speculare a coppie in modo che ogni pozzo, posizionato a cavallo della parete divisoria, potesse servire le due unità contigue. si tratta di una progettazione molto origi-nale che non trova esempi nell’edilizia contemporanea: per assistere a qualcosa di simile si dovrà attendere la realizzazione del Teatro della municipalità(103) con la sua lunga teoria di negozi prospicienti il castello estense e corso Giovecca, cospicua fonte di reddito comunale.
Un’immagine generale della chiesa e della casa dei Teatini alla metà del set-tecento è fornita dalla Pianta e Alzato della Città di Ferrara di Andrea Bolzoni (fig. 8); purtroppo, la vista da sud offerta dall’incisione limita la conoscenza del complesso all’assetto generale e non permette la visione delle facciate del tempio e del vicino oratorio, per cui degli edifici si intuiscono solo articolazioni e dimensioni volumetriche. In ogni caso, su via Borgo novo è benissimo indi-viduabile il muro di cinta perimetrale dello scoperto retrostante l’abside della chiesa (e di cui avremo modo di parlare in seguito) cui è affiancata l’imponente facciata della ampliata casa dei Teatini. lungo la via de Bastardini, è ancora ben visibile il permanere dell’arretramento rispetto al fronte stradale in corrispon-denza del tratto superstite della soppressa viazzola fra vicolo del Teatro e via del Gambero: solo nel XIX si giungerà all’allineamento del fronte sulla via con l’ultimo inglobamento di sede stradale, come vedremo. All’interno dell’isolato, è leggibile la presenza dell’area a chiostro, ma non ne sono valutabili i lineamenti architettonico-decorativi.
Un articolo del «corriere Padano» datato 1950(104) tratteggia un progetto settecen-tesco di completamento della facciata, realizzato dall’architetto Giovanni Battista mannini per il podestà dell’epoca, sindino cicognara. senza proporne la riproduzio-ne né riportarne la collocazione, l’anonimo articolista ha fornito una descrizione del prospetto:
27
Una chiesa incompiuta e una casa irriconoscibile: le vicende infauste del complesso dei Teatini a Ferrara
peristilio sporgente sulla piazza con in facciata quattro colonne lisce e capitelli com-positi e base attica su dado, architrave a festone, per tutta la lunghezza, recante scolpiti tutti i paramenti e gli ‘ori’ sacri del culto. Al di sopra del peristilio il frontone della facciata: al centro di questo una finestra a semicerchio tra due angeli, ai lati del fron-tone mistilineo due vasi ornamentali.
l’unica citazione di tale progetto che ho individuato è proposta da questo artico-lo, che è invero impreciso in alcuni punti(105). Ad essa affianco anche il disegno del prospetto attribuito ad Antonio foschini (fig. 9) e datato 1765(106): in mancanza di altri dati (non si può mai ritenere conclusa la ricerca documentaria) si deve pensare a due fasi propositive autonome, testimonianza ulteriore che l’incompiutezza della facciata ha certo gravato pesantemente sulla sensibilità e dei Padri Teatini e della comunità di fedeli che ad essi faceva riferimento. ma, visibilmente, neppure quelli erano tempi propizi per il compimento decorativo del tempio e il prospetto è rimasto incompleto. Anzi; sul finire del secolo (7 giugno 1798), a seguito della venuta delle truppe francesi, la soppressione degli ordini religiosi ha determinato una fortissima e, in un certo senso, definitiva cesura nella vita dei chierici regolari Teatini a ferra-ra: furono trasferiti i confratelli e requisiti i locali della casa, fu in concreto sospesa la vita religiosa nella stessa chiesa, fu forzatamente interrotta l’implementazione dello stesso ricco archivio. solo dai carteggi dell’Agenzia dei Beni nazionali del Basso Po della municipalità centrale Provvisoria di ferrara, apprenderemo il desti-no dell’area della casa che, smembrata, verrà ceduta, dopo stime peritali, ai cittadini che ne avevano fatta richiesta in cambio di beni utili al casermaggio, mentre la chie-sa sarà preservata insieme ad alcuni vani contigui, ad uso del parroco. I quotidiani locali daranno festosamente la notizia del rientro dei Teatini in città e nella chiesa di corso Giovecca solo nell’autunno del 1934(107).
In ogni caso, una delle prime, positive innovazioni apportate dai francesi al loro arrivo in città è stata l’introduzione della numerazione civica stradale, nel 1797(108). e questo ci permette di affrontare con qualche elemento conoscitivo in più la com-plessa fase di frazionamento della casa, che è risultato essere una vera e propria lottizzazione. dalla Numerazione civica stradale del 1797, appunto, apprendiamo che «chiesa, e convento dei Teatini» avevano ingresso dai nn. 1708 di via Berline, 1709 di via Borgonuovo, 1710 di via Borgonuovo e commercio, 1739 e 1742 di via del commercio, senza altre indicazioni di specifica. Gli altri ingressi interessanti per questo studio erano ai seguenti numeri civici:
– n. 1740 di via del commercio: «ragioni chiccoli Penacchiere»
28
Laura Graziani Secchieri
– n. 1741 di via del commercio: «don soncini Parroco della cattedrale»– n. 1742 di via del commercio: «ragioni de’ Teatini»– n. 1743 di via del commercio: «Borsari Teresa»– n. 1744 e 1745 di via del commercio: «Pio luogo delle esposte»– n. 1746 di via del commercio: «Bottoni domenico»
Anche il semplice confronto con la successiva Numerazione civica stradale del 1804 rende evidente la trasformazione intervenuta:
– n. 1708 di via Berline: «chiesa de Teatini - convento»– n. 1709 di Borgonuovo: «fabbri Giovanni Battista con parte della fabbrica che ap-
parteneva ai Teatini affittata superiormente a Giuseppe Vallini da esso»– n. 1710 di via Borgonuovo e commercio: «Guitti Antonio e lorenzo con parte della
fabbrica, che apparteneva ai Teatini in parte affittata a don rocco duo, e parte da lui abitata»
– n. 1739 di via commercio: «chiesa, oratorio e convento de Teatini»– n. 1740 di via del commercio: «ragioni chiccoli Penacchiere»– n. 1741 di via del commercio: «don soncini Parroco della cattedrale»– n. 1742 di via del commercio: «ragioni de’ Teatini»– n. 1743 di via del commercio: «Borsari Teresa»– n. 1744 e 1745 di via del commercio: «Pio luogo delle esposte»– n. 1746 di via del commercio: «Bottoni domenico»
Ulteriori modifiche sono testimoniate nella Numerazione civica stradale del 1828:
– n. 1708 di via Berline: «chiesa e convento de Teatini»– n. 1709 di Borgonuovo: «Giovanni Antonio Torri»– n. 1710 di via Borgonuovo e commercio: «faccini Giuseppe»– n. 1739 di via commercio: «faccini Giuseppe»– n. 1740 di via del commercio: «Bianchi Gaetano»– n. 1741 di via del commercio: «Bianchi Gaetano»– n. 1742 di via del commercio: «Posta delle lettere»– n. 1743 di via del commercio: «frassoldati maria Bergamini»– n. 1744 e 1745 di via del commercio: «Pio luogo delle esposte»– n. 1746 di via del commercio: «Armani lodovico.»
le grandi trasformazioni di proprietà e di utilizzo verificatesi negli ultimi anni del XIX secolo trapelano già, soprattutto quando si consideri che il quartier generale dell’Agenzia dei Beni nazionali del Basso Po della municipalità centrale Provvi-soria di ferrara, con archivio annesso, aveva trovato posto proprio al primo piano
29
Una chiesa incompiuta e una casa irriconoscibile: le vicende infauste del complesso dei Teatini a Ferrara
sopra l’oratorio dei Teatini e che, nel 1802, si attendeva solo una sua nuova collo-cazione per istituirvi la Posta delle lettere(109):
6 brumale anno X repubblica cisalpina
l’Agenzia dei Beni nazionali del Basso Po della municipalità centrale Provvisoriadi ferrara
cittadini,Trovasi collocato nelle stanze superiori del locale de’ Teatini l’Ufficio dell’Archivio di quest’Agenzia. Quando lo stabilimento dell’Ufficio della Posta delle lettere possa farsi nell’istesso locale indipendentemente dall’Archivio, e senza che questo vi nasca variazione è contenta l’agenzia di secondare colle premure del commissario straordi-nario anche quelle del cittadino Pavesi sopraintendente Generale delle Poste.
salute e fratellanzaf. zaffarini
carli segretario
Poichè il seguire le traversie patrimoniali di ogni unità immobiliare di nuova formazione svierebbe alquanto il filo conduttore di questo studio, mi limito ad inse-rire alcuni esempi significativi delle compravendite, delle perizie estimative, delle trasformazioni proprietarie e di consistenza che hanno coinvolto l’intero isolato. detto questo, ritorno indietro, agli ultimi anni del settecento, per ricostruire, attra-verso alcuni atti notarili e qualche stima, quella fase di frazionamento della casa dei Teatini che già è trapelata dalla trasformazione dei proprietari che abbiamo verifi-cato nelle differenti Numerazioni civiche stradali. Il 16 maggio 1799(110), l’Agenzia dei Beni nazionali del dipartimento del Basso Po ha venduto a domenico Bottoni diversi immobili fra cui «una casa con bottega poste nella contrada della Giovecca di provenienza della soppressa casa dei Teatini, come da stima 149», contro tanti effetti di casermaggio pari a scudi 601:66:9: si tratta dell’edificio che attualmente ha ingresso da corso Giovecca 8, che vedremo essere il mappale 1365.
Il 17 maggio(111), l’Agenzia dei Beni nazionali del dipartimento del Basso Po ha venduto ad Anselmo nagliati un edificio con tre botteghe, già della soppressa casa dei Teatini, in angolo fra le vie del commercio e di Borgonuovo. nella loro somma-ria perizia n. 144 allegata all’atto, matteo Tieghi ed Antonio manfredini (quest’ul-timo come perito dell’acquirente) hanno riportato di avere in precedenza redatto la relazione inerente la restante parte del fabbricato (sia a piano terra sia alle quote superiori) in quanto già «petizionata» e acquistata dallo stesso nagliati: purtroppo, però, la perizia n. 143 relativa all’edificio non è allegata. modesta la descrizione
30
Laura Graziani Secchieri
che viene fornita delle tre botteghe, poste una sulla via del commercio e le altre prospicienti via Borgonuovo:
l’ampiezza delle suddette tre botteghe è assai ristretta. In una di esse evvi un pozzo, ed in un’altra trovasi una canna di un comodo, che rende deforme la medesima. I suoi muri sono buoni, ed invece del solaro vi è un volto reale.l’annua netta cavata dalle medesime, avuto riguardo alla loro situazione, la giudichiamo di scudi 16; e però alla ragione del cento per sei riesce il suo capitale di scudi 266:66:8dal quale si calano per la Tassa Prediale baiocchi 20:10 per ogni scudo reale, che cor-rispondono alla proprietà di denari 15 di milano, e però in tutto scudi 55:55:6Il valore di dette tre botteghe netto dalla tassa rimane di scudi 211:11:2
Il 21 maggio(112), l’Agenzia ha venduto a Vincenzo Bighi del fu Antonio due ap-partamenti affittati a ludovico Turolla e Venanzio Vallini e tre botteghe affittate a francesco cavallini, Alberico secondi e Giuseppe modonini «della soppressa casa de’ Teatini situato nella medesima», contro tanti effetti di casermaggio pari a scudi 356:25. l’immobile era descritto nell’allegata perizia n. 152, dei periti matteo Tie-ghi e Antonio manfredini, datata 29 fiorile anno VII repubblicano, di cui riporto i passi più interessanti:
consiste la medesima al pian terreno in un ristretto portico, in tre botteghe, con sito della scala, e della cantina. sopra di questi vi sono due piani, ciascuno de’ quali con-tiene una sala, e due camere. Al di sopra de’ medesimi trovasi il granaro.I suoi muri sono di pietre in calcina stabiliti dentro e fuori. Il suo coperto è di coppi in tavelle con legname di campagna ed i suoi solari sono volti realizzati di pietre.Una di dette botteghe ha l’ingresso nel detto portico con sommo incomodo di quelli che abitano in detti due piani. Parimenti nel sito ad uso di cantina, il quale non più largo di piedi 6 trovasi una canna da cloaca, la quale arriva sino all’ultimo piano.Questa rende qualche fettore in pregiudizio non solo del vino colà esistente, ma anche all’abitazione suddetta, oltre di che la rende difforme. Il pozzo, esistente tra la cantina e la bottega ad essa contigua, contiene acqua suffi-ciente. Il tetto sporge circa due piedi al di fuori dalla base, ed al medesimo vi è unagola, con un zorno di latta, sostentato da varie zegognole.I confini di detta fabbrica sono i seguenti cioè a tramontana ed a ponente le ragioni della suddetta casa de’ Teatini, ad ostro la via detta di Borgo nuovo ed a levante il cittadino Anselmo nagliati, acquisitore di altra fabbrica di ragione della stessa sop-pressa casa de’ Teatini.l’annua netta cavata di questa fabbrica, avuto riguardo che è priva di scoperto, che le sue camere sono di una mediocre grandezza e agli enunciati difetti, la consideriamo di scudi 27; e però alla ragione del cento per sei riesce il suo capitale di. scudi 450:-:-
31
Una chiesa incompiuta e una casa irriconoscibile: le vicende infauste del complesso dei Teatini a Ferrara
dal quale si difalcano per la Tassa Prediale baiocchi 20:10 per ogni scudo reale, che corrispondono alla proprietà di denari 15 di milano, e però… scudi 93:75:- rimane il valore di detta fabbrica netto dalla Prediale di scudi 356:25:-.
nel 1806, i periti stefano Pasi e Vincenzo Bertoni hanno eseguito un sopral-luogo per verificare se la finestrella aperta da Giuseppe Bergamini nel muro di sua proprietà che chiudeva la corte dell’Ufficio Postale (fig. 10): il restauro della parete lateralmente alla finestra e la mancanza di testimoni ha però impedito di verificare se si sia trattato di una nuova apertura oppure del trasporto di una luce già esistente(113).
Il giorno 8 ottobre 1807(114), il perito luigi casoni ha effettuato la stima dell’edi-ficio «già di ragione della soppressa casa dei Teatini» posta al n.c. 1739 di via del commercio. Gli schizzi delle piante del piano terra e dei piani superiori sono alle-gati alla sintetica descrizione:
[...] diviso in due appartamenti con ingresso comune.I suoi muri sono di pietre in calcina, ed il suo coperto di coppi in tavelle con legno di monte. I solai sono fatti di pietre con volti.e confina ad ostro col [...], a tramontana col carlo casanuova, e colle ragioni dema-niali, a levante colla detta strada, a ponente colle ragioni demaniali.siccome il capitale £ 500.72.8sono d’Italia £ 2690.22
la situazione che propongono la mappa del cessato catasto fabbricati di ferrara del 1832 e i relativi registri(115) è ormai estremamente frammentata ed è complesso seguire le trasformazioni di tutti i mappali appena costituiti, cui se ne sono aggiunti altri per ulteriori frazionamenti. Inizio, quindi, tracciando il primitivo assetto cata-stale generale dell’isolato:– mappale 1355: Corte in comune; via Gambero n.c. 1742, proprietà: Amministrazione dei Beni
Ecclesiastici e Camerali, Direzione delle Poste e Camera Apostolica, consistenza: -.– mappale 4810 sub 1: Casa del Parroco; via Borgo Nuovo n.c. [aggiunto a matita: 1708], pro-
prietà: Chiesa di San Gaetano detta Teatini calcolata di ragione di direttaria come la Chiesa, consistenza: -.
– mappale 4810 sub 2: Casa di proprio uso; via - n.c. - ; proprietà: Amministrazione dei Beni Ecclesiastici, consistenza: -2° livello: 13 vani.
– mappale 1356 sub 1: Casa d’affitto con botteghe; via Borgo Nuovo n.c. 1709; proprietà: Malusar-di Fortunato del fu Antonio, consistenza: 1° livello: 4 vani; 2° livello: 4 vani; 3° livello: 4 vani.
– mappale 1356 sub 2: Bottega d’affitto; via - n.c. - ; proprietà: Parasida [?] Francesco del fu Pietro, consistenza: 1° livello: 1 vano.
32
Laura Graziani Secchieri
– mappale 1357: Casa d’affitto con cinque botteghe; via Commercio [corretto in: Borgo Nuovo] n.c. 1710; proprietà: Giuli Antonio del fu Lorenzo, consistenza: 1° livello: 3 vani; 2° livello : 7 vani; 3° livello: 7 vani.
– mappale 1358 sub 1: Tre botteghe d’affitto; via Commercio n.c. - ; proprietà: Massari conte Vincenzo e Galeazzo fratelli, del fu Giovanni Battista, consistenza: 1° livello: 3 vani.
– mappale 1358 sub 2: Stanze superiori di propria abitazione; via Commercio n.c. - ; proprietà: Faccini Giuseppe del fu Francesco, consistenza: 2° livello: 3 vani.
– mappale 1359: Tre botteghe d’affitto; via Commercio n.c. 1740; proprietà: Casanova Carlo del fu Antonio, consistenza: 1° livello: 3 vani.
– mappale 1360: Casa di propria abitazione; via Gambero n.c. 1741, Commercio n.c. 1742 [corretto ad inchiostro in: 1740]; proprietà: Bianchi Gaetano del fu Federico, consistenza: 1° livello: 4 vani; 2° livello: 6 vani.
– mappale 1361: Casa di propria abitazione; via Commercio n.c. 1743; proprietà: Bergamini Tommaso del fu Giuseppe, consistenza: 1° livello: 3 vani; 2° livello: 3 vani; 3° livello: 3 vani; 4° livello: 3 vani.
– mappale 1362: Casa d’affitto con bottega; via Commercio n.c. 1744; proprietà: Pio Luogo degli Esposti, consistenza: 1° livello: 3 vani; -2° livello: 2 vani; 3° livello: 2 vani.
– mappale 1363: Casa con bottega d’affitto; via Commercio n.c. 1745; proprietà: Pio Luogo degli Esposti, consistenza: 1° livello: 3 vani; 2° livello: 3 vani; 3° livello: 3 vani.
– mappale 1364: Casa con due botteghe d’affitto; via Commercio e Giovecca n.c. 9 ; proprietà: Bottoni Domenico del fu Giovanni, consistenza: 1° livello: 4 vani; 2° livello: 5 vani; 3° livello: 5 vani; 4° livello: 3 vani.
– mappale 1365: Casa con due botteghe; via Giovecca n.c. 8; proprietà: Piva Antonio del fu Andrea, consistenza: 1° livello: 4 vani; 2° livello: 3 vani; 3° livello: 3 vani.
– mappale 4811: Casa di proprio uso; via Giovecca n.c. 7; proprietà: Direzione delle Poste, consistenza: 1° livello: 9 vani; 2° livello: 17 vani.
– mappale 4812: Casa di proprio uso; via - n.c. - ; proprietà: Camera Apostolica, consistenza: 1° livello: 1 vano.
– mappale 4813: Casa di propria abitazione con 2 botteghe; via Commercio n.c. 1739; proprie-tà: Faccini Giuseppe del fu Francesco, consistenza: 1° livello: 1 vano; 2° livello: 2 vani; 3° livello: 4 vani.
– mappale 4814: Bottega d’affitto; via Commercio n.c. 1740; proprietà: Martinelli Alessandro del fu Pietro, consistenza: 1° livello: 1 vano.
– mappale 4815: Casa d’affitto ad uso d’Osteria; via Commercio n.c. 1746; proprietà: Armani Lodovico del fu Antonio, consistenza: 1° livello: 3 vani; 2° livello: 3 vani; 3° livello: 3 vani.
Per avere un quadro di confronto complessivo, riporto la situazione nel 1878, al momento del nuovo Impianto, cui fa riferimento la mappa del cessato catasto Urbano del 1882:– mappale Z: Chiesa sotto il titolo di San Gaetano detta dei Teatini; via Giovecca 54, Borgonuo-
vo 23, Teatini 1-3; proprietà: - , consistenza: - .
33
Una chiesa incompiuta e una casa irriconoscibile: le vicende infauste del complesso dei Teatini a Ferrara
– mappale 1355: Casa con uso d’andito al mappale 5963; comprende i mappali 4810, 4811 e 4812; via Giovecca 58-60, Borgonuovo 25; proprietà: - , posizione del fabbricato: Ottima; stato del fabbricato: Buono; consistenza: P.t.: 24 vani; 1°p : 9 vani; 2°p.: 39 vani; 3°p.: 6 vani.
– mappale 4810 sub 1: Casa del Parroco direttaria come la Chiesa; via Borgo Nuovo [aggiunto a matita: 1708]; proprietà: di Chiesa di San Gaetano detta Teatini calcolata di ragione, posi-zione del fabbricato: - ; stato del fabbricato: - ; consistenza: - .
– mappale 4810 sub 2: Casa di proprio uso; via - ; proprietà: Amministrazione dei Beni Ecclesia-stici, posizione del fabbricato: ; stato del fabbricato: ; consistenza: 2°p.: 13 vani.
– mappale 1356: Casa con due botteghe che si estende col 1° e 2° piano sopra il mappale 5763; via Borgo Nuovo 27-29-31; proprietà: - , posizione del fabbricato: Ottima; stato del fabbrica-to: Mediocre; consistenza: 1°p.: 3 vani; 2°p.: 4 vani; 3°p.: 4 vani.
– mappale 5763: Una bottega sopra la quale si estende il mappale 1356; via Borgo Nuovo 33; proprietà: - , posizione del fabbricato: Ottima; stato del fabbricato: Buono; consistenza: p. t.: 1 vano.
– mappale 1357: Casa con cinque botteghe; comprende i mappali 4813 e 5227; via Borgo nuovo 35-37-39-41; Commercio 48-50-52; proprietà: - , posizione del fabbricato: Ottima; stato del fabbricato: Mediocre; consistenza: p. t.: 6 vani; 1° p.: 6 vani; 2° p.: 6 vani.
– mappale 5764: Casa con due botteghe che si estende col 1° e 2° piano sopra 1/3 del mappale 1360; via Commercio 42-44-46; proprietà: - , posizione del fabbricato: Ottima; stato del fab-bricato: Mediocre; consistenza: p. t.: 3 vani; 1° p.: 5 vani; 2° p.: 5 vani.
– mappale 1358: Soppresso ed unito ai mappali 1360 e 5764; via - ; proprietà: - , posizione del fabbricato: - ; stato del fabbricato: - ; consistenza: - .
– mappale 1359: Soppresso ed unito al mappale 1360; via - ; proprietà: - , posizione del fabbri-cato: - ; stato del fabbricato: - ; consistenza: - .
– mappale 1360: Casa che si estende sopra l’andito al mappale 5963 e sopra 1/3 della quale si estende il mappale 5764 con uso dell’andito al mappale 5963 stesso; via Commercio 30; proprietà: , posizione del fabbricato: Ottima; stato del fabbricato: Buono; consistenza: p. t.: 9 vani; 1° p.: 6 vani; 2° p.: 6 vani.
– mappale 1361: Casa; via Commercio 18-20; proprietà: - , posizione del fabbricato: Ottima; sta-to del fabbricato: Mediocre; consistenza: p. t.: 3 vani; 1° p.: 3 vani; 2° p.: 3 vani; 3° p.: 3 vani.
– mappale 1362: Casa con una bottega. Comprende il mappale 5632; via Commercio 12-14-16; proprietà: - , posizione del fabbricato: Ottima; stato del fabbricato: Mediocre; consistenza: p. t.: 2 vani; 1° p.: 3 vani; 2° p.: 3 vani.
– mappale 1363: Casa con una bottega; via Commercio 8-10; proprietà: - , posizione del fabbri-cato: Ottima; stato del fabbricato: Mediocre; consistenza: p. t.: 2 vani; 1° p : 3 vani; 2° p.: 2 vani; sottotetto: 2 vani.
– mappale 1364: Casa con tre botteghe; via Commercio 2-4; Giovecca 66-68-70; proprietà: - , posizione del fabbricato: Ottima; stato del fabbricato: Mediocre; consistenza: p. t.: 3 vani; 1° p : 5 vani; 2° p.: 5 vani.
– mappale 1365: Casa con una bottega; via Giovecca 62-64; proprietà: - , posizione del fabbri-cato: Ottima; stato del fabbricato: Mediocre; consistenza: p. t.: 2 vani; 1° p : 2 vani; 2° p.: 2 vani; 3° p.: 2 vani; 4° p.: 3 vani; 5°p.: 1 vano.
34
Laura Graziani Secchieri
– mappale 4811: Compreso nel mappale 1355; via - ; proprietà: - , posizione del fabbricato: - ; stato del fabbricato: - ; consistenza: - .
– mappale 4812: Compreso nel mappale 1355; via - ; proprietà: - , posizione del fabbricato: - ; stato del fabbricato: - ; consistenza: - .
– mappale 4813: Soppresso ed unito al mappale 1357. Comprende il mappale 5228; via - ; pro-prietà: - , posizione del fabbricato: - ; stato del fabbricato: - ; consistenza: - .
– mappale 4814: Soppresso ed unito al mappale 1360; via - ; proprietà: - , posizione del fabbri-cato: - ; stato del fabbricato: - ; consistenza: - .
– mappale 4815: Casa con una bottega; via Commercio 6; proprietà: - , posizione del fabbricato: Ottima; stato del fabbricato: Infimo; consistenza: p. t.: 2 vani; 1° p.: 2 vani; 2° p.: 3 vani.
– mappale 5963: Accesso comune al mappale 1360; via - ; proprietà: - , posizione del fabbricato: - ; stato del fabbricato: - ; consistenza: - .
nel marzo 1822(116), motivando la richiesta con la ristrettezza della sua abitazione al n. 1743 di via del commercio, Angelo roversi ha domandato alla commissione municipale d’ornato di potere alzare di due piedi tutta la gronda dell’edificio per trasformare il granaio in un piano abitabile, oltre ad aprire un piccolo portone ad uso della cantina, fra due finestre del piano terra. entrambe le richieste hanno trovato accoglimento. nella nuova istanza inoltrata nell’aprile del 1825(117), A. roversi ha richiesto di poter eseguire alcune modifiche esterne nell’edificio di sua proprietà, confinante con il «piccolo stradello che mette nella corte dell’ex monastero così det-to dei Teatini», poiché aveva la necessità di «allungare l’ambiente all’ultimo piano abitabile»; nel disegno allegato è la soluzione proposta: un aggetto a sporto sul filo della parete esterna. Pur trovando la soluzione non gradevole all’occhio anche «del non intelligente», l’ingegnere comunale Giovanni Tosi si sarebbe uniformato alla de-cisione del Gonfaloniere che, viceversa, ha negato l’autorizzazione all’esecuzione.
nel 1829(118), è maria roversi, la vedova di Angelo, ad inoltrare petizione: sull’angolo della sua Locanda detta del Casino posta nella strada del commercio vi è una pilastrata di marmo a protezione della muratura che è stata urtata dalla dili-genza postale per Venezia in uscita dal deposito, nel curvare a sinistra. dopo avere riconosciuto il danno, l’ingegnere comunale ne ha indicato la causa nella strettezza della via, facendo richiesta al cardinale legato perché trovi una soluzione al proble-ma, cioè una differente sede. non appare però, alcuna intenzione di sanare il danno procurato. nel 1833(119), Alessandro Brunelli, di via Borgonuovo, ha richiesto che la commissione di sanità effettuasse un sopralluogo e prendesse provvedimenti avversi al suo vicino Giovanni malusardi a causa del letame.
Ancora nel 1833(120), Giuseppe faccini ha richiesto di poter sostituire con un por-tone «la porticella con scaffale» corrispondente ad una bottega nel suo fabbricato
35
Una chiesa incompiuta e una casa irriconoscibile: le vicende infauste del complesso dei Teatini a Ferrara
in via Borgonuovo: la commissione d’ornato ha concesso il nulla osta purché la nuova apertura fosse eseguita «con i fusti all’esterno» come negli altri portoni già esistenti in facciata.
Un quadro della porzione strettamente pertinente ai Teatini è tratteggiato da f. Aventi, nel 1838(121):
Posta delle letterela parte di fabbrica, che apparteneva al convento de’ Teatini, e che guarda sulla strada della Giovecca, dopo la soppressione di quei religiosi avvenuta nel tempo del gover-no italiano, fu destinata alla posta delle lettere. Qui per conseguenza s’impostano e si distribuiscono, e vi risiede il direttore, che tiene in questo luogo gli uffizii delle diligenze, delle spedizioni e di quant’altro appartiene all’amministrazione postale.
nel 1839(122), michele Bellonzi ha inoltrato alla commissione d’ornato la ri-chiesta di innalzare una parte del suo fabbricato in via del commercio n.c. 1744 portandolo tutto alla medesima quota e realizzandovi due finestre in simmetria con le sottostanti: il parere dell’ufficio municipale è stato favorevole.
nel 1845, Giovanni Antonio Torri ha istituito a favore di Paolo Violetti un vita-lizio per la vita natural durante sua e di sua moglie maria mazzoni. Insoddisfatto della rendita ricavata da tale accordo, il 3 aprile dell’anno seguente ha fatto eseguire da Giuseppe mangarini la perizia sull’edificio posto al n.c. 1709 di via Borgonuovo. dopo avere ricordato che Giovanni Antonio Torri ha acquistato tale immobile con atto del notaio Antonio ferraguti del 27 gennaio 1829 e che vi ha apportato rilevan-ti miglioramenti (soprattutto la realizzazione di un condotto di scarico sotterraneo per le acque piovane che ristagnavano nella corte), il perito è passato a descrivere l’edificio a cominciare dai confini: a mezzogiorno via Borgo nuovo, a tramontana ed a ponente i residui dei Beni demaniali ed a levante Giuseppe faccini con ragioni provenienti dagli stessi residui demaniali,
[...] entro il qual perimetro, si avverte, restavi alla destra dell’ingresso una bottega fuori di questa ragioni quantunque interposta a ponente e levante alle stesse ragioni del signor Proprietario Torri, a mezzodì colla detta strada ed a levante il signor fac-cini suddetto, per cui gli ambiente che la compongono al pian terreno sono un portico ove esiste il pozzo interrato nella stanza della legnara, alla destra una cantina un volta bottega che si unisce, retro una lunga stanza distinta in due parti, a mezzo di un arco aperto, la quale si estende col suo contatto sino al termine della bottega esclusa, alla sinistra vi è il luogo della scala che a quattro rampanti di quadri in ottimo stato divisi a due a due da un muro di una testa, che va sino al terzo piano, e poscia di mattoni
36
Laura Graziani Secchieri
con altri due rami prosegue sino al granajo, ed un’altra Bottega che ha l’ingresso dalla sunnominata strada, al alto di tramontana s’incontra la carte la metà circa sel-ciata di ciottoli a mortaletto e la metà circa coltivabile ad uso di piccolo orto, cinta da muri esclusi da queste ragioni, salvo quello di ponente, che per la maggior parte è di questa proprietà, dove trovasi una cisterna che è di metà coll’Amministrazione demaniale incorporata ne’ beni della chiesa di santa maria della Pietà una volta detta de’ Teatini o san Gaetano presentemente, e dove ancora trovasi una fornacella per comodo del bucato; dopo i due primi rami della nominata scala s’incontra un piano di mezzanini composto di una cucina fornita di camino alla rustica con altra aruola [= rola] formata a fornello ed appresso la latrina e sciaquatojo con vasca di mattoni, coperta questa da un armadio di legno, indi un tinello con suo camino di cotto alla moderna, di due camere da letto lateralmente a detto tinello un camino in angolo e parimenti di cotto questa in confine ai Teatini dopo ancora altri due rami di detta scala si entra in un quartiere similmente disposto come il sopradetto con camino di cotto alla rustica in cucina, latrina e sciaquatojo ed altro caminetto di cotto alla destra nel tinello. finalmente a corpo d’altri due rami di scala, questa come si è detto di mattoni, si ascende al granajo, ove vi esiste un camerino che può servire anche da letto, e due spaziosi ambienti.I suoi muri che la cosituiscono sono tutti di mattoni in calcina riboccati ed intonacati tanto nell’interno che all’esterno ed ai piani secondo e terzo anche in qualche eleganza dipinti, sono robusti, e senza difetti sorta, vi sono soli due solai uno nella prima parte della legnara di tavole, travi e terzi, legnara di monte, ed uno nel tinello dei mezzanini coperto da incannicciata e travi incassati quasi nuova, ed i rimanenti sono di volte reali a mattoni in taglio in ottimo stato.Il coperto è di coppi in tavelle con buona resistente travamenta ed insestatura di monte in plausibile condizione.I minuti di corredo consistono in selciate di pietre di piazza la pianterreno nel portico e botteghe sud descritte a tutto il piano de’ mezzanini quelle quasi nuove ed al piano nobile salvo quello del tinello che quivi è di quadri d’oncie otto ed indi tornano al granajo di mattoni di piazza. Tutte le porte finestre sono fornite di serrande, vetrate e ferriate alle finestre inferiori delle scale, legnaja e cucina, e le vetrate delle finestre dei mezzanini e del piano nobile sono di lastre grandi fornite con all’esterno di persiane con buona ferramenta e tutte in ottimo stato, oltre a serranda a bussola, il che tutto insieme si presenta nello stato della più desiderata decenza, e quale unitamente ai comodi che si contengono non può essere abitata che da persone civili.nella così descritta casa infine si sono trovati i seguenti materiali:- mattoni nei muri n°. 1114208 che atteso alla loro descritta condizione si sono valutati sc. 5 del mille e quindi importano scudi 571:04:0- solari surriferiti in complesso di piedi quadri compresi i trebbi [= ballatoi] delle scale 202.1 a bajocchi 6 - scudi 12:12:6- coperto succitato a scudi 0.15 del piede quadro sono piedi 725.10 scudi 108:7:5 minuti già dettagliati nella minuta originale compresi in questi il pozzo, la cisterna ed
- mattoni nei muri n°. 1114208 che atteso alla loro descritta condizione si sono valutati sc. 5 del mille e quindi importano
- solari surriferiti in complesso di piedi quadri compresi i trebbi [= ballatoi] delle scale 202.1 a bajocchi 6
- coperto succitato a scudi 0.15 del piede quadro sono piedi 725.10 - minuti già dettagliati nella minuta originale compresi in questi il
scudi 571:04:0
scudi 12:12:6scudi 108:7:5
37
Una chiesa incompiuta e una casa irriconoscibile: le vicende infauste del complesso dei Teatini a Ferrara
il muro della corte risultanti del complessivo ammontare di scudi 442:28:9sommano scudi 1134:33:0- Terreno coperto delle botteghe n.2 assieme di piedi quadri 163.7 che trovato il suo valore risulta le istruzioni portate dal Girri riesce del costo di scudi 0.75 del piede quadro che essendo come sopra piedi 163.7 importa scudi 122:68:7- Più il terreno coperto del rimanente della casa stimato colle suddette basi, è riescito del costo di bajocchi 29.5 del piede quadro che essendo della complessiva superficie di piedi 369.10 importa scudi 109:10:1- Ascende il terreno coperto a scudi 231:78:8- Altro scoperto della corte piedi quadri 342.1 a bajocchi 15 il piede quadro importa scudi 51:31:2- Vale il terreno coperto e scoperto scudi 283:10:0- Totale importo della casa col suo terreno sottoposto scudi 1417:43:0- la prediale sull’estimo pagante riesce in ragguaglio di scudi 6.50 annui il di cui capitale al % per 5 sono scudi 130:0:0- restano netti scudi 1287:43:0Il qual valore di materiali sta in corrispondenza al valore della rendita depurata dalle annue riparazioni e dal capitale della tassa casatica che è quanto.
Gli schizzi di piante e sezioni, le planimetrie in scala e la descrizione dei «mi-nuti», cioè delle parti non strutturali, completano la perizia che è stata consegnato al Tribunale, il quale ha nominato quali periti Giuseppe forlani, Gaetano squarzoni e leopoldo ferlini. Il 3 settembre 1846, i tecnici hanno effettuato un nuovo sopral-luogo che ha dato origine ad una diversa relazione e ad una (di poco) differente valutazione dell’immobile, pari a 1233.97.4 scudi. riporto solo la parte descrittiva che in alcune parti risulta essere più dettagliata della precedente:
[...] la casa del signor Giovanni Antonio Torri è a quattro piani: il piano terra coll’in-gresso sulla via di Borgonuovo al civico n. 1709. si compone di uno stretto vestibulo a levante del quale a levante due stanze ad uso di legnare in cui è il pozzo e la latrina e prendono lume dal cortile compreso nelle stesse ragioni Torri; e due locali il primo ad uso di cantina e l’altro ad uso di bottega costeggiano la via pubblica di Borgonuovo sulla quale hanno i loro ingressi: la bottega peraltro compresa in questo casso di fabbri-ca appartiene di presente al signor Giuseppe faccini: a ponente poi dell’indicato ve-stibolo un ambiente col muro di prospetto sopra terreno di ragione della commissione camerale dei residui contiene la scala a sei rampanti di comunicazione coi piani su-periori, ed una bottega non comunicante colla casa ha sulla via comune il suo partico-lare ingresso: in produzione del portico, cantina e la prima delle due lagnare vedesi il
pozzo, la cisterna ed il muro della corte risultanti del complessivo ammontare di
- Terreno coperto delle botteghe n.2 assieme di piedi quadri 163.7 che trovato il suo valore risulta le istruzioni portate dal Girri riesce del costo di scudi 0.75 del piede quadro che essendo come sopra piedi 163.7 importa
- Più il terreno coperto del rimanente della casa stimato colle suddette basi, è riescito del costo di bajocchi 29.5 del piede quadro che essendo della complessiva superficie di piedi 369.10 importa
- Ascende il terreno coperto a- Altro scoperto della corte piedi quadri 342.1 a bajocchi 15 il
piede quadro importa- Vale il terreno coperto e scoperto - Totale importo della casa col suo terreno sottoposto - la prediale sull’estimo pagante riesce in ragguaglio di scudi 6.50
annui il di cui capitale al % per 5 sono - restano netti Il qual valore di materiali sta in corrispondenza al valore della rendita depurata dalle annue riparazioni e dal capitale della tassa casatica che è quanto.
scudi 442:28:9 sommano scudi 1134:33:0
scudi 122:68:7
scudi 109:10:1scudi 231:78:8
scudi 51:31:2scudi 283:10:0
scudi 1417:43:0
scudi 130:0:0scudi 1287:43:0
38
Laura Graziani Secchieri
terreno scoperto con fornacella nell’angolo che forma il muro di gronda della casa col muro di confine a ponente: è ripartito lo scoperto in un cortiletto con selciato di ciotto-li a martello e doccia che porta le acque di pioggia mediante lungo conduttore in cotto alla doccia comune, ed in poco ortivo; sul confine di ponente avvi una conserva d’ac-qua o cisterna goduta in comune colla ripetuta commissione camerale dei residui.si compone il secondo piano di un salotto nel quale sbocca la scala ascendente dal pri-mo piano; tre camere prendono lume dalla via pubblica di Borgonuovo; a tramontana poi la cucina con fornello, sciacquatojo, e conduttore di latrina con sedile, ed il casso delle scale sono contraposte a due delle menzionate tre camere sula via pubblica, men-tre le terza sul confine di levante si estende dall’uno all’altro muro di gronda. Una simi-le distribuzione vedesi nel terzo piano al quale si ascende mediante altri due rampanti di scala e viene abitato dalla famiglia del proprietario signor Giovanni Antonio Torri.Il quarto ed ultimo piano è quello coperto dal tetto, ripartito in tre campi dai muri colmigna; una cameretta a comodo di persona di servizio cinta di pareti di mattoni in taglio vedesi allo smonto della scala nel primo dei tre campi, ed altre pareti consistenti in intelaiature di legno con tessuti di canna incrostati di calce compongono altri am-bienti a comodo della famiglia nel terzo campo sull’opposto confine.[…] la casa dell’altezza di piedi trentatré in colmigna e di piedi ventotto e undici on-cie in gronda e quindi della media di piedi trentuno trovasi in ogni sua parte in ottimo e decente stato di conservazione: i muri sono di mattoni in calce stuccati, impellicciati parimenti in calce ed imbiancati, le pareti interne del secondo e terzo piano unitamen-te alle soffitte sono ornate con tinte semplici a scomparti. le vetriate di lastre grandi con telari e contorni e scuretti insieme alle persiane nelle finestre sulla via pubblica sono in buona condizione, al pari delle altre aperte nel muro di gronda a tramontana: le imposte e controimposte con contorni che serrano gli uci colorite con tinte a colla, e le seconde con tinte ad olio sono in buono stato; i pavimenti hanno le selciate di mattoni e tavelle in buona condizione; la camera di mezzo del terzo piano è selciata di quadri; le soffitte sono nel primo, secondo e terzo piano di volte in cotto a sesto scemo di una testa o mattone, meno la parte di mezzo nel secondo piano che è un assito sopra terzi e travi con sottoposta incannicciata in gesso e calce a fasciatura.
nel 1854(123), Petronio Bellonzi ha richiesto alla commissione d’ornato di poter modificare «l’ortografia» ossia l’assetto stilistico della facciata della propria abi-tazione in corso Giovecca n. 8 secondo quanto indicato nel disegno di progetto allegato, che prevedeva la sostituzione dell’antiquata apertura con scaffa con una più moderna apertura larga e semplicemente architravata per il negozio a fianco al portoncino d’ingresso. sebbene convinta che la riforma proposta andasse a peggio-rare il prospetto, la commissione d’ornato si risolveva a dare parere favorevole «in-giungendo soltanto di applicare una tinta generale del colore di calce mora all’intero prospetto della casa suddetta».
39
Una chiesa incompiuta e una casa irriconoscibile: le vicende infauste del complesso dei Teatini a Ferrara
nel 1859(124), Giuseppe rossi ha chiesto di poter aprire una bottega da fabbro ferraio al n. 1709 di via Borgonuovo, mentre, nel 1862(125), il farmacista Gaetano schömman [?], affittuario di GiuseppeAntonio Torri (ma il tecnico comunale ri-porta Paolo Violetti) ha richiesto un sopralluogo della commissione di sanità per problemi agli scarichi nell’edificio di via Borgonuovo n. 1709: la commissione ha ordinato la veloce esecuzione delle riparazioni, che risultano essere stati realizzati prima del 14 luglio.
nel 1864(126), sante Benassi ha presentato la richiesta di modifica delle facciate in angolo fra la via del commercio e via Giovecca secondo il progetto accluso: sulla prima chiedeva di allargare una stretta porta architravata trasformandola in un ac-cesso per negozio e di ampliare una bassa porta modificandola in portoncino a sesto pieno (chiudendo la finestrella della quota superiore); nella seconda chiedeva di trasformare il portoncino d’ingresso a sesto pieno in un accesso per negozio (chie-dendo tre piccole finestre ed aprendone altre due, in simmetria con le altre aperture in facciata). Tutte le richieste sono state accolte prontamente.
dopo avere fatto eseguire opere alle murature, ai solai e agli infissi nell’edificio di via del commercio nn.cc. 1740 e 1741 di cui era affittuario, Pietro fabbri ha ri-chiesto la restituzione dei 786:44:5 scudi spesi; poiché il proprietario don Giuseppe Bianchi non era in grado né aveva intenzione di liquidarlo, i due si sono accordati per la cessione dell’edificio con tre botteghe con alcune clausole, fra cui che la definizione del prezzo di vendita fosse determinata dalla perizia dell’ing. Antonio maestri e di luigi Gasperi(127). Il fabbricato era pervenuto a don Giuseppe Bianchi in eredità dal padre che lo aveva acquistato tramite quattro distinti contratti: il 5 set-tembre 1801 i fratelli Girolamo ed Andrea soncini gli avevano venduto «la casetta con ingresso sul vicolo del Gambero» (indicata con la lettera A nella pianta acclusa) per la quale si pagavano 10 scudi annui che il nuovo proprietario ha affrancato nel 1819. Il 28 maggio 1802 filippo chioccoli gli ha ceduto la casetta con ingresso sulla strada del commercio (indicata con la lettera B nella pianta unita).
nel 1871(128), Gaetano novi ha richiesto di poter innalzare di un piano la propria abitazione in via del commercio n. 30: la commissione ha dato parere favorevole alla semplice facciata indicata nel disegno allegato. nuova richiesta nello stesso anno(129), finalizzata ad eliminare le aperture di due botteghe, realizzando un porton-cino in posizione centrale e due finestre in simmetria con le soprastanti: anche in questo caso è stato concesso il nulla osta.
nel 1873(130), avendo acquistato le tre botteghe con ingresso ai nn. 32, 34 e 36 attigue al piano terra della propria abitazione posta al n. 30 di via del commercio,
40
Laura Graziani Secchieri
Gaetano novi ha chiesto alla commissione municipale d’ornato di modificarne le aperture trasformandole il finestre ed adeguandole al restante prospetto dell’edificio di proprietà crema, come il disegno accluso illustrava: la concessione è stata rila-sciata nel giro di due sole settimane.
Il 9 giugno 1873(131), Gaetano santini ha richiesto di poter aprire una nuova porta nel suo edificio di via del commercio n. 12: la commissione d’ornato ha imposto che la seconda apertura (da realizzare entro otto mesi) fosse simile al portoncino a tutto sesto esistente e non una semplice porta con volto molto ribassato come indi-cato nel disegno accluso alla domanda.
nel 1875(132),Alfredo licini ha chiesto di poter apporre sopra l’ingresso della sua bottega in via Borgonuovo n. 25 una tabella in lastra di ferro di 80 x 65 cm, verni-ciata di blu, con l’iscrizione in carattere romano in color oro.
Cassa generaleDelle
Assicurazioni Agricolecontro l’incendio
Direzione
nel 1879(133), avendo ceduto la sua macelleria in angolo fra le vie di Borgonuovo e del commercio, Giuseppe Paglierini ha richiesto di essere cancellato dai ruoli dei commercianti.
Il 12 novembre 1884 l’Intendenza di finanza per conto del demanio dello stato ha ceduto alla chiesa dei Teatini sotto il titolo di santa maria della Pietà e san Ga-etano il mappale 6363 nato dal frazionamento del mappale 1355:
- Possessore primitivo:demanio dello stato.mappale: 1355. Ubicazione: Giovecca 58 e 60, Borgonuovo 25.natura dei fabbricati e loro uso: casa con uso dell’andito al mappale 5963.consistenza: p.t.: 24 vani; 1° p.: 9 vani; 2° p.: 39 vani; 3° p.: 6 vani.- nuovi possessori:demanio dello stato.mappale: 1355. Ubicazione: Giovecca 58 e 60, Borgonuovo 25.natura dei fabbricati e loro uso: casa con uso dell’andito al mappale 5963.consistenza: p.t.: 20 vani; 1° p.: 3 vani; 2° p.: 9 vani; 3° p.: 6 vani.chiesa dei Teatini. mappale 6363. Ubicazione: Borgonuovo. 25. natura dei fabbricati e loro uso: casa. consistenza: p.t.: 4 vani; 1° p.: 6 vani; 2° p.: 9 vani.
Appena adombrato da questo passaggio proprietà è il complesso carteggio durato oltre un decennio, intercorso fra la direzione generale del demanio ed il ministero
41
Una chiesa incompiuta e una casa irriconoscibile: le vicende infauste del complesso dei Teatini a Ferrara
di Grazia e Giustizia e dei culti, che si è concluso con la convenzione concordata dall’Amministrazione demaniale e don stefano levizzani, cappellano e custode della chiesa di santa maria della Pietà detta dei Teatini in ferrara riguardo la cessio-ne di una parte del fabbricato ex conventuale annesso alla predetta chiesa per uso di abitazione del custode della chiesa, del 19 gennaio 1884(134), conclusosi appunto con il frazionamento del mappale 1355 e la realizzazione del nuovo mappale 6363(135).
nel 1885, è stata realizzata una ristrutturazione dell’intera sede dell’Ufficio delle Poste con importanti modifiche anche ai due prospetti dell’ex oratorio dei Teatini sia su corso Giovecca sia sul sagrato della chiesa(136).
Il 30 marzo 1894(137), il sarto Gaetano santini ha richiesto di poter modificare la porta del proprio negozio mettendo in opera il serramento ligneo di cui allegava il progetto: la commissione d’ornato ha approvato il 10 aprile.
Ancora un frazionamento del mappale 1355 nel 1902(138): dalla proprietà del de-manio nazionale (via Giovecca 60, via del commercio 22: «Uffici governativi ed orto») viene stralciata una porzione in favore di eugenio obici (via Giovecca 64: «Terreno ad uso di orto») attraverso la creazione del mappale 6542.
nel 1919, in qualità di rettore e custode della chiesa di santa maria della Pietà detta dei Teatini sussidiaria della metropolitana di ferrara, don filippo orta ha fatto esegui-re non meglio identificati lavori di ripristino della stessa chiesa da vari artisti: la liqui-dazione non entra nel merito né del tipo di opere né del genere di artisti impegnati(139).
Queste le documentazioni archivistiche rintracciabili: pur con la tecnologia e la modernizzazione (o, forse, proprio a causa della tecnologia e della modernizzazio-ne), il XX secolo si dimostra più avaro di informazioni sia strutturate sia casual-mente rintracciabili. Gli enti più moderni non sembrano nutrire quel rispetto della propria istituzione mostrato da precedenti istituti che pure potevano sfruttare solo modesti mezzi e tecniche più laboriose e faticose: la storia della propria istituzione si scrive ogni giorno, attraverso la cura e la conservazione della documentazione prodotta e di quella lasciata. Qualche indicazione ci viene da Gualtiero medri che, nel 1933(140), ha indicato che, presso la chiesa,
l’attiguo convento dei Teatini è stato ridotto a Uffici. le tracce delle arcate del chio-stro si possono vedere, messe in evidenza da un restauro compiuto in quest’anno, nel cortile in cui si entra dalla prossima via bersaglieri del Po al n. 22.
ormai, dalla fine del secolo scorso, le planimetrie catastali di prima denuncia del 1938-’40, fondamentali per conoscere la distribuzione interna dei fabbricati prima della seconda guerra mondiale, sono per la maggior parte perse o non digitalizzate (e
42
Laura Graziani Secchieri
quindi non consultabili), presso l’Agenzia del Territorio; per quanto ci riguarda, sono state rintracciate le sole planimetrie di denuncia catastale a firma dell’ing. Giuseppe stefani, in data 29 gennaio 1940, relative alla zona post-absidale, per il piano terra, ed a due piccole aree della ex casa dei Teatini, per primo e secondo piano: vista l’esiguità, non risultano essere significative per la conoscenza e la comprensione del complesso.
Altrettanto poco rilevanti sono le superstiti richieste di concessione edilizia al comune di ferrara: si è conservato un registro di carico delle domande inoltrate che copre solo una ventina d’anni, mentre le pratiche relative sono andate perdute. Poco significanti le indicazioni di trasformazione individuabili nel foglio 384 del cessa-to catasto Urbano del 1942. difficile, quindi, verificare a pieno quanto gli eventi bellici abbiano inciso su questo comparto urbano: Alfonso sautto ha sintetizzato la situazione nel 1959(141), descrivendo brevemente come gli
incompiuti facciata e campanile [sono stati] danneggiati dall’incursione aerea del 28 gennaio ’44. la parte dell’ex convento che trovasi nel corso Giovecca è occupata dagli Uffici, Attici Giudiziari e Bollo demaniale.
Una foto storica dell’archivio della Ferrariae Decus(142) mostra che danni sono stati prodotti più all’interno della chiesa e della casa che alla facciata del tempio, che è stata oggetto dell’articolo del «corriere Padano» del dopoguerra che ho già citato(143). esso descrive altre due fasi inerenti l’incompiuto prospetto, presentan-do dapprima il progetto realizzato nel 1928 dall’architetto enrico Alessandri(144): si trattava di impiegare il lascito di un nobile benefattore che doveva permettere il completamento della chiesa. ma, utilizzati i fondi per altri lavori ritenuti più urgen-ti, il frontespizio non era stato eseguito. Il progetto veniva poi riproposto da padre stanislao maria Kaminski nel 1950: presentato alla cittadinanza in attesa di verifica e revisione, come sappiamo non è stato in ogni caso eseguito.
nel 1953, rappresentanti di associazioni culturali ferraresi e di enti di vario ge-nere (fra cui la direzione provinciale del Partito liberale Italiano, il presidente della Ferrariae Decus, il direttore della Gazzetta Padana) hanno cercato di aprire una vertenza affinché non venissero eseguite le opere di demolizione del muro di cinta intorno all’abside della chiesa nel tratto fra le vie cairoli e Teatini, e di realizzazio-ne dei fabbricati prospicienti le dette strade. la contestazione non ha avuto (e non poteva avere) alcun seguito in quanto i lavori erano già stati autorizzati, come al presidente della Ferrarie Decus, che
avrebbe visto con favore la sostituzione del muro attuale con una appropriata cancel-lata di ferro, che rivelasse in pieno l’abside circondata da un manto verde,
43
Una chiesa incompiuta e una casa irriconoscibile: le vicende infauste del complesso dei Teatini a Ferrara
ha ricordato il 10 aprile ’53 il soprintendente A. Buonomo, che faceva presente come
l’approvazione relativa già concessa in data 23 marzo 1951 sia da considerarsi come atto di larga misura, nei confronti della richiesta dei proprietari(145).
Attualmente della superstite antica casa, è in piccola parte di proprietà del de-manio dello stato, mentre una buona porzione è ritornata all’ordine dei chierici regolari Teatini insieme alla chiesa che, al pari di tutti i templi antichi fra la città ed il modenese, ha subito i danni creati dagli eventi sismici del maggio 2012: una nuova, ardua difficoltà che l’ordine religioso potrà superare anche con il supporto della comunità dei credenti che ad esso fa riferimento.
44
Laura Graziani Secchieri
note
Abbreviazioni e sigle: Asdfe = Archivio storico diocesano di ferrara; fPT = fondo Padri Teatini; fde = fondo documenti episcopali; Asfe = Archivio di stato di ferrara; AnAfe = Archivio notarile Antico di ferrara; rsBV = regio subeconomato dei benefici vacanti di fer-rara, Bondeno, copparo; Ascfe = Archivio storico comunale di ferrara; Ascofe = Archivio storico del comune di ferrara.
(1) l’espressione ‘chierici regolari’ è molto antica: è menzionata già nel 748 nelle Exceptio-nes di sant’egberto, vescovo diYork, e fino al secolo XVI ha indicato i ministri ordinati che vi-vevano in comunità e sotto una regola. Gli stessi monaci rientravano sotto questo ordo: in pratica il termine era sinonimo, in modo indistinto, della nostra più comune espressione ‘religiosi’. Tale forma è andata in disuso dal secolo XVI dopo la fondazione nel 1524 dei primi chierici regolari detti Teatini, che furono fra i più validi strumenti di riforma dei costumi del clero in epoca pre e post tridentina. con il concilio di Trento ed attraverso l’approvazione pontificia, l’appellativo si è diffuso distinguendo questi preti riformati dagli antichi ordini monastici e mendicanti, che pure sono stati investiti dal rinnovamento spirituale attraverso ‘l’osservanza’. In questo tessuto ecclesiale di grande fermento, per mezzo della pratica dei consigli evangelici, con la pubblica professione dei voti, attraverso la vita in comune sotto la regola e con la missione apostolica, i nuovi chierici hanno incarnato le urgenze della riforma ecclesiale tanto attesa ed hanno rinnova-to la vita consacrata, infondendo nuovo impulso all’azione missionaria della chiesa. I chierici regolari Teatini, Clericorum Regularium vulgo Theatinorum, sono un istituto religioso di diritto pontificio: pospongono al loro nome la sigla c.r.
F. andreu, Chierici Regolari Teatini, in Dizionario degli Istituti di Perfezione, diretto da G. PellIccIa (1962-1968) e G. rocca (1969-), roma 1975, volume II, pp. 978-999.
(2) sono, infatti, principalmente incentrati sulle vicende storiche ed architettoniche della sola chiesa gli studi più recenti. P. massarentI, Luca Danese e l’architettura ecclesiastica, disegni inediti per la chiesa di Santa Maria della Pietà dei Teatini a Ferrara, in Ristrutturazione urba-nistica e architettonica di Comacchio 1598-1659. L’età di Luca Danese, supplemento al volume 69 degliAtti dell’Accademia delle scienze di ferrara, ferrara 1994, pp. 123-149; G. marcolInI, Restaurato un dipinto per la chiesa di Santa Maria della Pietà e San Gaetano dei Teatini a Fer-rara, in Bollettino della Ferrariae Decus 22, 31 dicembre 2005, pp. 37-64.
(3) l’ordine dei chierici regolari Teatini è nato e si è realizzato nel clima e nell’ambiente dell’oratorio del divino Amore di roma: ha rappresentato, soprattutto nei primi anni della sua vita e della sua attività, un centro di perfezione in una società ecclesiastica che aveva, ormai, perduto di vista la pietra angolare della verità e della carità cristiane. nei primi decenni del cin-quecento e, precisamente, fino al sacco, roma era stata più vicina allo spirito dell’antica Babilo-nia (in una lettera a laura mignani la ha definita così proprio san Gaetano Thiene (P. PaschInI, San Gaetano Thiene, Gian Pietro Carafa e le origini dei Chierici Regolari Teatini, roma 1926, p. 14) che non a quello della sede del successore di Pietro. Il clero, sia regolare che secolare, dava uno spettacolo poco edificante ed offriva motivo di amare critiche, di feroci accuse e di
45
Una chiesa incompiuta e una casa irriconoscibile: le vicende infauste del complesso dei Teatini a Ferrara
apocalittiche previsioni (P. tacchI-venturI, Storia della Compagnia di Gesù in Italia, I, roma milano 1910; - l. Pastor, Storia dei Papi, IV, I, roma 1908, pp. 3-4; - P. PaschInI, San Gaetano Thiene, pp. 4-6).
l’ordine venne fondato a roma il 14 settembre del 1524 da Gaetano Thiene (poi assurto alla santificazione) e dai suoi primi compagni: Gian Pietro carafa, vescovo di chieti (in latino Thea-te, da cui il nome Teatini; P. B. lauGenI, Una vita per la Chiesa. Gian Pietro Carafa 1476-1559, roma, 1995, pp. 109-110) e primo superiore del nuovo ordine che salì al soglio di Pietro con il nome di papa Paolo IV , Bonifacio de’ colli e Paolo consiglieri: erano tutti membri dell’orato-rio dell’Amor divino che adunava lo stato maggiore degli uomini che volevano più fortemente la riforma. scopo primario del nuovo ordine era «stabilire la vita comune tra i sacerdoti addetti alle cattedrali e alle parrocchie affinché essi potessero adoperarsi più efficacemente a riformare i costumi del clero e del popolo cristiano». fondando l’ordine, i chierici regolari si sono uniti nel proposito di servire il signore con più calma, di avvicinarsi ancor più ad esso, rispettando tre voti fondamentali: la povertà, l’astensione e l’obbedienza. Attraverso la vita clericale, i Teatini si proponevano di dedicarsi con umiltà e devozione al servizio di dio con l’aiuto della sua grazia, in immediata sottomissione e speciale protezione, per essi e per la sede apostolica: resasi poco efficace la riforma del clero mediante decreti e relativi provvedimenti pontifici e conciliari latera-nensi, i chierici regolari la attuavano in sé stessi, con la costante revisione interiore e l’esercizio delle azioni di carità e di apostolato, adatte alle esigenze dei tempi e luoghi in cui operavano. Per poter ottenere effetti più incisivi in un secolo in cui gli interessi materiali, molto evidenti anche fra gli ecclesiastici, si rivelavano radice di ogni male, essi fecero un passo importante nella strada indicata da cristo, professando e vivendo la povertà evangelica, rinunciando a benefici e prebende per vivere apostolicamente «de altari et evangelio», cioè dei soli proventi del sacro ministero e delle oblazioni, non questuate ma offerte spontaneamente dai fedeli. Già prima della professione del settembre 1524, momento di costituzione ufficiale del nuovo ordo, il 24 giugno papa clemente VII aveva emesso il breve Exponi nobis appositamente per il piccolo gruppo for-mato da Gaetano e dai suoi compagni, attraverso il quale concedeva loro la facoltà di emettere la professione solenne dei consigli evangelici; di vivere in comunità in qualunque luogo onesto avessero scelto; di eleggersi ogni anno un superiore con il nome di Preposito, che poteva essere confermato nella carica ma non oltre un triennio; di ammettere altri, chierici o laici di qualsiasi dignità, alla professione, da farsi dopo un anno di prova; di prendere tutti quei provvedimenti a modo di statuti e costituzioni che avessero giudicato più confacenti al moro modo di vivere, in particolare riguardo alla celebrazione degli uffici divini, che dovevano essere approvati in ogni caso dall’autorità pontificia, dopo l’esperimento. Attraverso questo breve, venne di fatto sancita la rinascita dei preti secolari che, ormai offuscati da secoli nella vita della chiesa, sono stati sostanzialmente presi a modello ed imitati dagli ordini regolari successivi. dopo la rinuncia dei loro benefici e proprietà, dunque, il 14 settembre 1524 i quattro preti riformati (Thiene, carafa, de’ colli e consiglieri) emisero la solenne professione nella basilica di san Pietro, ai piedi di monsignor Giambattista Bonziani, vescovo di caserta e delegato di papa clemente VII. nel dipinto sopra il coro nell’abside della chiesa dei Teatini di ferrara, il pittore clemente majoli ha rappresentato questo episodio, descritto anche da Brisighella: «Il santo rinunzia co’ suoi compagni a piedi di un vescovo le dignità e co’ voti solenni fondano sulla divina provvidenza
46
Laura Graziani Secchieri
la religione de’ chierici regolari; nell’atto vi figurò la Provvidenza con cornucopia ed alcuni angioli ed al di sotto l’eresia dispettosa ed infuriata»; in c. BrIsIGhella, Descrizione delle pitture e sculture della città di Ferrara (sec. XVIII), a cura di m. A. novellI, ferrara 1991, p. 43.
In quello stesso 14 settembre, Gian Pietro carafa fu eletto Preposito della nuova comunità ed istituzione. Il mondo della curia romana non capì l’atto generoso compiuto dai quattro sacerdoti, deridendoli: il termine “teatino” divenne in certi ambienti sinonimo di zelo eccessivo. ma il loro esempio finì per portare frutti copiosi alla chiesa (Aspetti della riforma cattolica e del Concilio di Trento. Mostra documentaria, catalogo a cura di e. alendrI Barletta, ministero degli Interni, Pubblicazioni degli Archivi di stato, lV, roma 1964; in particolare: pp. 24-34: L’origine dei Chierici Regolari Teatini; p. 35: Il Sacco di Roma).
ebbero dimora prima in via leonina a ripetta, presso l’attuale chiesa di san nicola dei Pre-fetti, in campo marzio, dove attendevano agli uffici divini ed all’orazione, si dedicavano allo studio delle scienze sacre ed, insieme, all’assistenza degli incurabili del vicino ospedale di san Giacomo in Augusta. Verso la fine del 1524, si trasferirono sul Pincio, presso l’odierna villa me-dici: ben preso la loro casa divenne un cenacolo di vita riformata, frequentata anche da prelati e dignitari della corte pontificia.
durante il sacco di roma del 1527 da parte dei mercenari lanzichenecchi, papa clemente VII fu costretto a rifugiarsi in castel sant’Angelo difeso dal corpo delle Guardie svizzere, che subì pesanti perdite negli scontri. come tanti altri ecclesiastici, anche san Gaetano Thiene fu seviziato dai lanzichenecchi e imprigionato nella Torre dell’orologio in Vaticano; fu liberato da un ufficiale spagnolo: sempre nell’abside della chiesa Teatina di ferrara, lateralmente al dipinto inerente la rinunzia dei primi Padri Teatini, clemente majoli ha rappresentato i drammatici mo-menti vissuti da san Gaetano e compagni durante il sacco, che Brisighella ha descritto così: «Il santo maltrattato dalli soldati nel tempo del sacco di roma, affinchè confessasse l’oro che da essi si credeva nascosto» e «Il santo medesimo co’ suoi compagni liberati dalle carceri di roma ad instanza d’un colonnello, il quale convitato da un capitano non volle accettare l’invito se pri-ma non vide il santo ed i suoi compagni in libertà» (c. BrIsIGhella, Descrizione delle pitture, p. 43). Quindi, con i compagni dell’Istituzione. san Gaetano ha trovato rifugiò a Venezia presso la chiesa di san nicolò dei Tolentini, dove venne nominato Preposito al posto del carafa, che si trasferì a Verona, dove fondò una nuova casa Teatina.
Ancora una volta, i Teatini sono stati punto di riferimento per uomini di cultura e per religiosi di spicco, legati allo stesso spirito riformistico. Tra questi, il beato Giovanni marinoni, canonico di san marco e poi Teatino, che avrebbe avuto funzione fondamentale nella vita spirituale di sant’AndreaAvellino a napoli. come in precedenza a roma, anche aVenezia i chierici regolari lavorarono per la popolazione cristiana curando i poveri e gli ammalati ricoverati presso l’ospe-dale degli incurabili, prima durante la peste e poi nel corso della successiva carestia. I Teatini veneziani hanno intrattenuto rapporti anche con sant’Ignazio di loyola, giunto nella città lagu-nare ai primi del 1536: in quest’occasione si evidenziarono quei temi di divergenza riguardo alla riforma che andarono acuendo nel tempo.
nel 1533 per volere del papa clemente VII, san Gaetano Thiene si è trasferito nel Vicereame di napoli insieme al beato Giovanni marinoni, stabilendosi prima all’ospedale degli Incurabili, fondato in quel tempo dalla nobile spagnolamaria lorenza longo, e poi, insieme ad altri sei
47
Una chiesa incompiuta e una casa irriconoscibile: le vicende infauste del complesso dei Teatini a Ferrara
confratelli veneziani, nella Basilica di san Paolo maggiore posta nel cuore del centro storico di napoli, nella città greco-romana, che venne riedificata in forme sontuose su progetto del Teatino francesco Grimaldi. come in precedenza a Venezia, a napoli i Teatini applicarono la riforma a partire proprio dall’aula della loro chiesa, dove vollero divisa negli spazi per gli uomini e per le donne, e dove portarono il coro dietro l’altare. I riti sacri erano celebrati con semplicità ma ugualmente con molto decoro; senza musica e neppure canto fermo, la recita del divino ufficio era sostenuta da una leggera flessione cadenzata, uso che si sarebbe presto diffuso negli ambienti riformati con il nome di recita more theatino. Inoltre, i Teatini tolsero le sepolture dal sacro re-cinto aprendo sul sacrato un piccolo cimitero, dove avrebbe trovato sepoltura lo stesso fondatore san Gaetano, insieme ai suoi primi confratelli e senza alcun segno di distinzione.
l’attività di san Gaetano si esplicherà a napoli fino alla morte, potenziando l’ospedale degli Incurabili e fondando ospizi per anziani ed i monti di Pietà, da cui nel 1539 sorse il Banco di napoli, il più grande Istituto bancario del mezzogiorno. Ha suscitato nel popolo la frequenza assidua ai sacramenti, rimanendo vicino alla gente durante le carestie e le ricorrenti epidemie come il colera, che flagellarono la città in quel periodo, peraltro agitato da sanguinosi tumulti.
Per ironia della sorte, fu proprio il teatino co-fondatore Gian Pietro carafa, divenuto papa Paolo IV, a permettere che nell’Inquisizione, imperante in quei tempi, si usassero metodi dia-metralmente opposti allo spirito della congregazione teatina, essenzialmente mite, permissiva e rispettosa delle altrui idee. e quando le autorità civili vollero instaurare il tribunale dell’Inquisi-zione nel Viceregno di napoli, il popolo napoletano si ribellò, unico nella storia triste dell’Inqui-sizione in europa. la repressione spagnola fu violenta e ben 250 napoletani vennero uccisi, per difendere un principio di libertà. In quel triste momento, san Gaetano fece di tutto per evitare il massacro e, quando si accorse che la sua voce non era ascoltata, offrì a dio la sua vita in cambio della pace; morì a napoli il 7 agosto 1547 a 66 anni, consumato da stenti e preoccupazioni e due mesi dopo la pace ritornò nella città partenopea.
l’opera che più l’aveva assillato nella sua vita era stata senza dubbio la riforma della chiesa: egli ha attuato la riforma operando dal basso verso l’alto al contrario del contemporaneo martin lutero, attraverso la formazione del clero e la dedizione all’apostolato fra i poveri, i diseredati e gli ammalati, specie se abbandonati. A quanti gli facevano notare che i napoletani non potevano essere così generosi negli aiuti, come i ricchi veneziani, rispondeva: «e sia, ma il dio di Venezia è anche il dio di napoli». In ogni caso, fu sempre papa Paolo IV a favorire il ritorno dei Teatini a roma, dove costruirono il grandioso tempio di sant’Andrea della Valle, ancora oggi sede della loro casa Generalizia.
Alla morte del fondatore nel 1547, i Teatini non contavano che due case: a Venezia ed a napoli, in cui avevano professato, fino ad allora, una cinquantina di sacerdoti. nel 1555 si erano insediati a roma. A causa della scarsezza di personale e per la rigida osservanza della povertà, la famiglia teatina ha attraversato un periodo di crisi che ha messo in pericolo la sua stessa esi-stenza, cui si è cercato di rispondere prima con la fusione con i somaschi e poi con l’erezione di case con annessi studentati: primo quello aperto da sant’Andrea Avellino a napoli nel 1565. nello stesso anno, si stabilivano a Padova ed a cremona. nel 1569, chiamati dal confratello vescovo Paolo Burali d’Arezzo erano a Piacenza; nel 1570 erano a milano invitati da san carlo Borromeo e guidati dai padri Geremia Isacchino e da sant’Andrea Avellino che diventerà ben
48
Laura Graziani Secchieri
presto la guida spirituale dell’élite della capitale lombarda. seguirono a brevi intervalli le fonda-zioni di sant’Andrea dellaValle a roma e di altre case a napoli, e poi a Genova, lecce, firenze, Vicenza, Bergamo, Bologna, modena, Palermo, ferrara, Verona, cosenza, Parma, Brescia, To-rino: dall’inchiesta ordinata da papa Innocenzo X sui chierici regolari d’Italia, risultava che il numero dei Teatini ammontava a 1090 nel 1650 e, alla fine del seicento, l’ordine contava oltre cinquanta case in Italia. oltre che nel nostro Paese, oggi i Teatini sono presenti in olanda, Bra-sile, Argentina, spagna, messico, colombia e stati Uniti d’America: alla fine del 2005, l’ordine contava 33 case e 199 membri.
l’ispirazione che san Gaetano Thiene aveva sentito impellente era di formare, per donarli alla chiesa, sacerdoti che vivessero la primitiva norma della vita apostolica, perciò non ebbe fretta a stendere una regola, perché questa doveva essere il santo Vangelo, letto e meditato ogni mese, per potersi specchiare in esso. le costituzioni dell’ordine furono infatti emanate solo nel 1604. I suoi chierici non dovevano possedere niente e non potevano neppure chiedere l’elemo-sina, accontentandosi di ciò che i fedeli spontaneamente offrivano e di quanto la Provvidenza mandava ai suoi figli, avendo sempre presenti con le parole di Gesù: «cercate prima il regno di dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta». Tutte le prime case teatine erano organizzate come centri di forte e salda spiritualità, come seminari di uomini apostolici, pur come preti destinati all’attività esterna, la quale non veniva in ogni caso a pregiudicare od a rallentare la formazione interiore e la testimonianza evangelica. e furono proprio questi gli elementi in cui si riconobbero e cui aderirono uomini assai diversi tra loro, anche per capacità ed interessi, ma tutti ugualmente legati dal medesimo ideale di spiritualità sacerdotale, ben sintetiz-zato dal motto dell’ordine stesso: Quaerite primum Regnum Dei.
l’Ordo Clericorum Regularium vulgo Theatinorum: c.r. ha il blasone «d’oro (talvolta d’ar-gento) alla croce latina di rosso su tre colli. lo scudo sostenuto da rami d’alloro e di quercia e timbrato da una corona».
san Gaetano Thiene ha scelto la croce nuda come insegna, dandole un significato program-matico: «Il sacerdote vive la sua vita con cristo crocifisso e ancora I chierici regolari nasce-ranno come inno dedicato alla croce». I tre colli rappresentano per alcuni il calvario, per altri il monte delle beatitudini o i tre voti religiosi. Il colore rosso interpreta invece il sangue di cristo. Gli elementi ornamentali dello scudo sono presenti negli stemmi di diversi ordini religiosi. In altri stemmi teatini la quercia e l’alloro sono sostituiti dal giglio e dalla palma. I tre monti sono anche tracciati ‘all’italiana’ e non allineati in palo.
ricordiamo che tra i Teatini vi furono grandi teologi, storici, liturgisti, giuristi ed architetti, come Guarino Guarini, uno degli esponenti più alti dell’arte barocca. Anche se non raggiunse mai un numero di religiosi pari a quello di altri ordini, come ad esempio i francescani, i dome-nicani o i Benedettini, i chierici regolari Teatini ne possono annoverare molti di grandissimo valore nella storia della chiesa, tra cui tre che hanno raggiunto la gloria degli altari: san Gaetano Thiene, canonizzato nel 1571, sant’Andrea Avellino, canonizzato nel 1712, e san Giuseppe Tomasi di lampedusa, canonizzato nel 1986. si contano anche un papa, il già citato Gian Pietro carafa eletto nel 1555 con il nome di Paolo IV, nove cardinali e ben duecento Vescovi, tanto che l’ordine Teatino fu detto «seminario dei Vescovi».
nonostante le soppressioni sette-ottocentesche e i conseguenti momenti di crisi che ne de-
49
Una chiesa incompiuta e una casa irriconoscibile: le vicende infauste del complesso dei Teatini a Ferrara
rivarono, l’ordine Teatino ha tuttora rappresentanti in Italia e nel mondo. I Teatini di oggi con-tinuano nella missione di san Gaetano, fedeli alla propria vocazione che li vuole: radicati nel-le virtù e nelle glorie dei Teatini di ieri; nel presente attivi nel servizio ecclesiale pastorale e nell’educazione culturale dei giovani; attenti a perpetuare domani nella chiesa e per la chiesa i benefici del loro carisma e del loro ministero di chierici consacrati al regno di dio.
(4) l’edificio o l’insieme di fabbricati ad uso comunitario dei Padri Teatini (in quanto ordine religioso nel senso canonico del termine) è definito casa, «domus regularis», e non monastero o convento, come per gli ordini mendicanti.
(5) sulla controversa origine e sul significato del nome di tale via: l. GrazIanI secchIerI – s. suPerBI, Il cimitero ebraico del Sesto di San Romano: prime riflessioni, in «Analecta Pompo-siana. miscellanea di studi per sessantennio sacerdotale di mons. Antonio samaritani», XXXIV, 2009, pp. 171-251, in particolare pp. 229-233, dove si riprende lo studio di c.m. sanFIlIPPo, Fra lingua e storia: note per una ‘Giovecca’ non giudaica, «rivista Italiana di onomastica», IV, nº 1, anno IV, aprile 1998, pp. 7-19. Anche: m. calzolarI, I nomi delle vie di Ferrara dal 1810 al 2010, ferrara 2011, p. 73: «Giovecca – non puossi credere nato da Giudecca come luogo degli ebrei: è ignota la provenienza di detto nome comune a molte altre città.»
(6) G.melchiorri, Nomenclatura ed etimologia delle piazze e strade di Ferrara, ferrara 1918, pp. 19-20: Via Bersaglieri del Po.
l’ospedale dei Bastardini o ca’ di dio e, soprattutto, l’annessa chiesa di san cristoforo avranno parte importante nell’iniziale permanenza a ferrara dei Teatini. Il tratto di via verso corso Giovecca ha preso talvolta anche il nome di strada del Gambero dalla stradella che lo
attraversa perpendicolarmente, e non viceversa, come affermato da mel-chiorri. la denominazione successiva di via del commercio era, ovvia-mente, motivata dalla presenza di una sequenza quasi ininterrotta di bot-teghe nelle due cortine stradali (anche se melchiorri non se ne spiegava la ragione); infine, il 4 dicembre 1905 il consiglio comunale ha votato l’attuale nome in memoria ed onore della compagnia dei Bersaglieri del Po, capitanata nel 1848 dal nobile concittadino march. Tancredi Trotti estensi mosti, poi senatore del regno, che si è distinta a Vicenza ed a cornuda sotto il comando del generale livio ferrari.
(7) Inurbato un antico borgo extra moenia dopo la costruzione del duomo, al suo asse stra-dale principale è stato attribuito il nome appunto di Borgo nuovo, come succederà poi alle varie ‘strada di Terranuova’ nelle diverse addizioni. Per approfondimenti sulla genesi di tale area urba-na, riferimenti etimologici e bibliografia: l. GrazIanI secchIerI – s. suPerBI, Il cimitero ebraico del Sesto di San Romano, in particolare pp. 209-212.
Il 20 settembre 1889 il consiglio comunale ha votato l’attuale nome in memoria ed onore di Benedetto cairoli, grande patriota, ministro del regno d’Italia e cittadino onorario di ferrara.
(8) G. melchIorrI, Nomenclatura ed etimologia, pp. 212-213: Via dei Teatini. concordo con melchiorri sull’etimo di strada dei naranci (famiglia che risiedeva all’angolo con corso Giovec-ca), mentre nutro dubbi riguardo la sua teoria che faceva derivare il settecentesco nome di via
50
Laura Graziani Secchieri
delle Berline dalla condanna alla berlina praticata prima del 1468 nella piazza di san crispino, presso la porta di san Paolo e fuori mura, nel borgo di san Giacomo. ovvia, invece l’etimologia della denominazione attuale.
(9) Ivi, p. 99: Vicolo del Gambero. melchiorri riporta (erroneamente, come in altri casi) una priorità temporale del nome attribuita a via Bersaglieri del Po, oltre a non riportare la reale estensione della via in antico, che correva, parallelamente alle mura settentrionali, dalla Porta dei leoni fino a palazzo Paradiso. Trasformazioni urbanistiche, quali l’inclusione nel Teatro comunale, nella chiesa e casa dei Teatini, ne hanno determinato il profondo snaturamento; l. GrazIanI secchIerI – s. suPerBI, Il cimitero ebraico del Sesto di San Romano, in particolare pp. 213-214 e fig. 3 a p. 251.
(10) G. A. scalaBrInI, Memorie istoriche delle chiese di Ferrara e de’ suoi borghi, ferrara 1773, p. 145.
(11) Ivi, p. 146.
(12) Abbiamo visto nella storia dell’ordine Teatino le difficoltà a mantenere vitali tutte le case fondate, soprattutto alla fine del ’500.
(13) In particolare, è interessante sottolineare che proprio lucrezia seghizzi era fra i princi-pali sostenitori dell’opportunità di non includere la chiesa di san Giacomo nell’area destinata al ghetto. A. FrIzzI, Memorie per la storia di Ferrara, vol .V, ferrara 1809, p. 74.
(14) G. A. scalaBrInI, Memorie istoriche, p. 146.
(15) Ascfe, Ascofe, libro 54, fascicolo 26: aprile 1610.
(16) Il volume miscellaneo composto in occasione dell’assunzione al dogato di Tommaso spinola (ed edito per i tipi del Pavoni nel 1614) si presenta composto di tre distinte parti: la seconda è l’Oratione fatta in Genova nella chiesa di San Lorenzo per la coronatione del Serenis-simo Duce Tomaso Spinola, di Giovanni Paolo fornari.
(17) l. PalIotto, Ferrara nel Seicento. Quotidianità tra potere legatizio e governo pastorale, Parte seconda, ferrara 2009, p. 45.
(18) Asdfe, fde, busta 160, 22 giugno 1616, in l. PalIotto, Ferrara nel Seicento, Parte seconda, p. 253.
(19) m. A. GuarInI, Compendio historico dell’origine, accrescimento e prerogative delle chiese e luoghi pii della città e diocesi di Ferrara, ferrara, 1621, libro I, p. 37.
(20) l. PalIotto, Ferrara nel Seicento..., Parte seconda, nota 12 a p. 253: fde, busta 160, 20 luglio 1616.
(21)Ascfe,Ascofe, libro 67, fascicolo 85: 11 agosto 1616; anche in l. PalIotto, Ferrara nel Seicento, Parte seconda, nota 12 a p. 253.
(22) BcAfe, collezione Antonelli, ms 595: G. FaustInI, Indice cronologico e genealogico de’ defonti nobili [...] dall’anno 1579 sino al presente anno 1770.
51
Una chiesa incompiuta e una casa irriconoscibile: le vicende infauste del complesso dei Teatini a Ferrara
(23) BcAfe, collezione, ms Antonelli 294 c: Notizie riguardanti, 1616.
(24) c. olIvI, Annali, p. 40.
(25) uBaldInI, Istoria c. 59r.
(26) ringrazio leopoldo santini per avermi fornito questa informazione.
(27) «nelle sue case poste nella contrada de Bastardini furono ricevuti la prima volta li Preti regolari detti li Teatini». - BcAfe,ms cl I, n. 125: G.A. scalaBrInI, Notizie storiche del capi-tolo di Ferrara dalla sua origine fino al 1760, cc. 246v-247r.
credo che il seguente passo un po’ sibillino di G. A. scalabrini (che è stato male o strana-mente interpretato) indichi che Gaspare levalori abbia accolto in città i Padri Teatini «la prima volta» quando ancora era vivente Alfonso II, in quanto invece egli era già morto prima del loro secondo arrivo: «la di lui [ndr: di Gaspare levalori] morte vien narrata ne i libri della sagrestia» [della cattedrale] «nel seguente modo: “1616 alli 29 genaro: fatto l’offitio da morto per l’anima del quondam monsignor Gaspare levallori già canonico teologo di questa chiesa». - BcAfe, ms cl I, n. 125: G. A. scalaBrInI, Notizie storiche, cc. 246v-247r. e’ evidente, quindi, che lo storico faceva riferimento alla documentazione relativa ai successori di Gaspare, che vedremo succes-sivamente, tanto è vero che nel Registro delle cose notevoli del fondo Padri Teatini Gaspare levalori non compare neppure.
Per un quadro complessivo della figura di monsignor Gaspare levalori: e. Peverada, Ricordi di San Carlo Borromeo a Ferrara, in Pastorale e cultura nel Ferrarese prima e dopo l’erezione del Seminario (1584), in «Analecta Pomposiana» IX, 19184, pp. 327-328 e nota 16.
(28) Asfe, AnAfe, notaio camillo lanzi, matr. 819, pacco 15, Protocollo 1616, cc. 213v- 215r, atto 12 dicembre 1616. Qualche discrepanza è stata rinvenuta fra il testo dell’atto ed il regesto trascritto da Alessandro Pasi. – BcAfe, Archivio Pasi, strade: via Borgonuovo).
Guarini ha invece riferito che gli edifici di Paino fossero stati comperati dal cardinale carlo emanuele Pio di savoia e da questi donati ai padri Teatini; m. A. GuarInI, Compendio historico dell’origine, p. 37. mentre scalabrini ha attribuito l’acquisto al canonico Gaspare levaloro in-sieme allo stesso cardinale Pio; G. A. scalaBrInI, Memorie istoriche, p. 146. Al contrario non ho trovato menzione di ciò nell’atto di lanzi: ipotizzo una sovvenzione da parte del cardinale non riportata nel rogito ma rimasta nella memoria popolare, così come i successivi aiuti economici sostenuti dai fedeli per l’acquisto dell’area e per la realizzazione della chiesa e della casa che sono ricordati dallo storico ma non compaiono nella documentazione notarile.
(29) Asfe, AnAfe, notaio camillo lanzi, matr. 819, pacco 15, Protocollo 1616, c. 16v, atto del 17 dicembre 1616.
(30) Asdfe, fPT, 73, Scritture spettanti alla fabrica della chiesa, Libro della fabrica. A, c. 1r.
(31) dalla ricca bibliografia sulla figura dell’Argenta: A. FraBettI, Aleotti e i Bentivoglio, in «Il canobio», n. 9, 1983; Giovan Battista Aleotti architetto. I disegni dell’album borromeo, a cura di c. cavicchi, Argenta 1997; G. scherF, G. B. Aleotti (1546-1636), “Architetto mathema-tico” der Este un der Päpste in Ferrara, marburg 1998; Giambattista Aleotti e gli ingegneri del
52
Laura Graziani Secchieri
Rinascimento, atti del convegno di Bologna 1994 a cura di m. rossi, firenze 1998; f. ceccarel-lI, La Città di Alcina, Bologna 1998.
(32)Asdfe, fPT, 73, Scritture spettanti alla fabrica della chiesa, Libro della fabrica A, c. 6r.
(33) m. A. GuarInI, Compendio historico dell’origine..., p. 38.
(34) Ascfe, Ascofe, libro 70, fascicolo 11: Registro AB dei Memoriali del 1617, c. 8.
(35) Ascfe, Ascofe, Indice alfabetico: Teatini, p. 326.
(36) l’attribuzione non si può certo desumere dalla qualità del disegno, invero affrettato ed incerto, quanto dalla grafia delle iscrizioni apposte: non è la scrittura ordinata abbinata ad pro-duzione grafica quasi scolastica che compare nelle tavole presentate da martina frank in Inediti di Luca Danese. Disegni tra Roma e Venezia (in Ristrutturazione urbanistica e architettonica di Comacchio 1598-1659. L’età di Luca Danese, supplemento al volume 69 degliAtti dell’Ac-cademia delle scienze di ferrara, ferrara 1994, pp. 187-216) e da lionello Puppi in Inediti di Luca Danese rinvenuti in Canada. Disegni per Comacchio e miscellanea di esercizi grafici (in Ristrutturazione urbanistica e architettonica di Comacchio 1598-1659. L’età di Luca Danese, supplemento al volume 69 degli Atti dell’Accademia delle scienze di ferrara, ferrara 1994, pp. 217-246). È la scrittura affrettata e sbilenca di chi appunta e schizza. ma la mano pare la medesima.
(37) lo schizzo di pianta dei due isolati originari con indicazione delle aree già in possesso dei Teatini (prima casa e prima chiesa, alcuni fabbricati contigui) è stato pubblicato da P. mas-sarentI, Luca Danese e l’architettura ecclesiastica, p. 140, fig. 5: Mappa dei siti di pertinenza dei Teatini di Ferrara. In questa sede, si è preferito riportare in allegato raffigurazioni inedite ad esclusione della presente circostanza in cui, alla fig. 1, si presenta la planimetria appena descritta con l’aggiunta del collegamento cartaceo fra la prima casa e la prima chiesa dei Teatini reso attraverso una semplice striscia di carta incollata ad un lembo che, a ben vedere, appare quindi un’immagine inedita.
(38) BcAfe, Archivio Pasi, strade: via Borgonuovo. Asfe, AnAfe, notaio camillo lanzi, matr. 819, pacco 19, atto 28 settembre 1621.
(39) Asdfe, fPT, disegni, m6 f2 n2, senza data, pubblicate da P. massarentI, Luca Danese e l’architettura ecclesiastica, p. 138, fig. 3: Mappa dei siti di pertinenza dei Teatini di Ferrara; p. p. 139, fig. 4: Mappa dei siti di pertinenza dei Teatini di Ferrara.
(40) BcAfe, Archivio Pasi, strade: via Borgonuovo. Asfe, AnAfe, notaio camillo lanzi, matr. 819, pacco 26, atto 4 dicembre 1628.
(41) l’acquisto è datato 7 dicembre 1628.
(42) l’acquisto è stato effettuato il 24 febbraio 1628.
(43) l’acquisto è datato 11 settembre 1626.
(44) l’acquisto è del giorno 14 settembre 1626.
53
Una chiesa incompiuta e una casa irriconoscibile: le vicende infauste del complesso dei Teatini a Ferrara
(45) l’acquisto è datato 10 dicembre 1625.
(46) l’acquisto è stato effettuato il 30 agosto 1627.
(47) sic.
(48) Ho reso con il colore quanto è indicato in pianta ed in legenda con linea formata da una sequenza di punti.
(49) Asdfe, fPT, m2 f7 n26, notaio camillo lanzi, atto 15 agosto 1621.
(50) BcAfe, Archivio Pasi, strade: via Borgonuovo. Asfe, AnAfe, notaio Giuliano zoia, matr. 865, pacco 3, atto 6 ottobre 1621.
(51) Asdfe, fPT, m3 f14 n5; Asdfe, fPT, m3 f14 n3.
(52) Asdfe, fPT, m3 f11 n34.
(53) Asdfe, fPT, m2 f7 n22, notaio camillo lanzi, atto 24 febbraio 1628.
(54)Asdfe, fPT, m2 f7 n22, notaio camillo lanzi, atto 10 dicembre 1625.Asfe,AnAfe, notaio camillo lanzi, matr. 819, pacco 23, atto 10 aprile 1625.
(55) Asdfe, fPT, m2 f7 n23, notaio camillo lanzi, atto 15 dicembre 1625.
(56) Ascfe, Ascofe, libro 87, fascicolo 109: registro fG dei memoriali, c. 147, 11 set-tembre 1626.
(57) Asdfe, fPT, m2 f7 n23, notaio camillo lanzi, atto 14 settembre 1626.
(58) Asdfe, fPT, m2 f7 n24, notaio camillo lanzi, atto 30 agosto 1627. Asfe, AnAfe, notaio camillo lanzi, matr. 819, pacco 25, atto 30 agosto 1627.
(59) Asdfe, fPT, m2 f7 n29, notaio camillo lanzi, atto 14 giugno 1627.
(60) Asdfe, fPT, m2 f7 n24, notaio camillo lanzi, atto 30 agosto 1627.
(61) Asdfe, fPT, m3 f 11 n11, 3 dicembre 1631.
(62) BcAfe, Archivio Pasi, strade: via Borgonuovo. Asfe, AnAfe, notaio camillo lanzi, matr. 819, pacco 26, atto 4 dicembre 1628.
(63) BcAfe, Archivio Pasi, strade: via Borgonuovo. Asfe, AnAfe, notaio mainardo Gua-rini, matr. 582, pacco 21, atto 31 agosto 1629.
(64) BcAfe, Archivio Pasi, strade: via Borgonuovo. Asfe, AnAfe, notaio mainardo Gua-rini, matr. 582, pacco 23, atto 27 ottobre 1629.
(65) Asdfe, fPT, m3 f 11 n54. Perizia estimativa eseguita da Girolamo ferri della piccola stalla prospiciente via Borgonuovo di proprietà di Alfonso Isinardi, senza data.
(66) Asdfe, fPT, m3 f14 n2, Partito preso dai Teatini, senza data.
54
Laura Graziani Secchieri
(67) BcAfe, Archivio Pasi, strade: via Borgonuovo. Asfe, AnAfe, notaio mainardo Gua-rini, matr. 582, pacco 23, atto 15 aprile 1631.
(68) G. marcolInI, Restaurato un dipinto, pp. 37-64.
(69) Asdfe, fPT, m6 f5 n21.
(70) Asdfe, fPT, m3 f 11 n15, 3 dicembre 1631.
(71) Asdfe, fPT, m3 f 11 n33, senza data.
(72) Ascfe, Ascofe, libro 91, fascicolo 62: 11 luglio 1626.
(73) BcAfe, Archivio Pasi, strade: via Borgonuovo. Asfe, AnAfe, notaio francesco Bo-naccioli, matr. 934, pacco 3, atto 5 dicembre 1634.
(74) Asdfe, fPT, m 3 f11 n 33 e 32: stima di Giamo Toselli, senza data; m3 f 11 n 16: stima di Girolamo ferri, 10 marzo 1632.
(75 Asdfe, fPT, m3 f11 n39, Stime de siti parte comprati e parte da comprarsi da padri Teatini per la loro fabrica come dalle autentiche si può vedere, senza data.
(76) P. massarentI, Luca Danese e l’architettura ecclesiastica, p. 125.
(77) La basilica di Santa Maria in Vado a Ferrara, a cura di carla dI Francesco, ferrara 2001. P. massarentI, Luca Danese e l’architettura ecclesiastica, fig. 1, p. 136: «luca danese (?): disegno di una cappella di santa maria in Vado a ferrara».
(78) Asdfe, fPT, 73, m3 f11 n23, stima del 20 gennaio 1668.
(79) s. PasolInI, Lustri ravennati, IV forlì 1684, p. 96. P. P. GInannI, Memorie storico-critiche degli scrittori ravennati, I, faenza 1769, pp. 169-173. V. Fontana, Luca Danesi (1598- 1672), un galileiano a Ravenna, in Studi Romagnoli, XXXI, faenza 1960. T. scalesse, Un “parere” di Luca Danese sulle fortificazioni nel ferrarese, in Saggi in onore di G. De Angelis d’Ossat, roma 1987. Ristrutturazione urbanistica e architettonica di Comacchio 1598-1659. L’età di Luca Da-nese, convegno di studi – comacchio 1992, supplemento al vol. 69 degli Atti dell’Accademia delle scienze di ferrara, 169° ano accademico 1991-92, ferrara 1994.
(80) P. massarentI, Luca Danese e l’architettura ecclesiastica, p. 137, fig. 2: «luca danese (?): Pianta di san romualdo di ravenna».
(81) lo stesso luca danese dichiarava: «Quest’invenzione non è mia, ma l’ho cavata dal dot-tissimo leone BattistaAlberti al 3° libro et 5 capitolo et anco dal reverendissimo daniel Barbaro sopra i “comenti di Vitruvio” al libro 3° capitolo 3°».
(82) Asdfe, fPT, 73, m5 f09 n21.
(83) P. massarentI, Luca Danese e l’architettura ecclesiastica, p. 146, fig. 11: «luca danese (?): Pianta della chiesa dei Teatini (1630)»; p. 147, fig. 12: «francesco Vacchi (?): Pianta della chiesa dei Teatini.»
55
Una chiesa incompiuta e una casa irriconoscibile: le vicende infauste del complesso dei Teatini a Ferrara
(84) P. massarentI, Luca Danese e l’architettura ecclesiastica, p. 129.
(85) Asdfe, fPT, disegni, m6 f4 n4, m6 f5 n5, m6 f6 n6, m6 f7 n7, m6 f8 n8.
(86) P. massarentI, Luca Danese e l’architettura ecclesiastica, p. 141, fig. 6: «Prima pianta del complesso conventuale dei Teatini di ferrara».
(87) Ivi, p. 142, fig. 7: «seconda pianta del complesso conventuale dei Teatini di ferrara».
(88) sic.
(89) sul lato della strada dei naranci.
(90) P. massarentI, Luca Danese e l’architettura ecclesiastica, p. 143, fig. 8: «Terza pianta del complesso conventuale dei Teatini di ferrara».
(91) Ivi, p. 144, fig. 9: «Quarta pianta del complesso conventuale dei Teatini di ferrara».
(92) Ivi, p. 145, fig. 10: «Quinta pianta del complesso conventuale dei Teatini di ferrara».
(93) Asdfe, fPT, disegni, senza data.
(94) Asdfe, fPT, vol. 73 di antica segnatura: mV f IX.
(95) Asdfe, fPT, all. 30: m5 f09 n34; all. 31: m5 f09 n33.
(96) Asdfe, fPT, disegni, senza data; fig. 5.
(97) Archivio segreto Vaticano, congregazione stato regolari I, relationes, 46 (Teatini – Trinitari), cc. 70r-71v, in lorenzo PalIotto, Ferrara nel Seicento, Parte seconda, pp. 240-241.
(98) Asdfe, fPT, m3 f11 n19, 19 gennaio 1662; m3 f 11 n29, 11 giugno 1686
(99) Asdfe, fde, 1695. Libro de Congregationi, cc. 13v-14r, in l. PalIotto, Ferrara nel Seicento, Parte seconda, p. 271.
(100) Asdfe, fPT, disegni, senza data.
(101) Architetture e magisteri murari nel ‘700 padano. L’attività dei “maestri” Santini tra Ferrarese e Polesine, a cura di U. soragni, rovigo 2002, e in particolare A. FarInellI tosellI, La famiglia Santini e l’urbanistica barocca ferrarese, pp. 45-62.
Peccato che in quella sede, che poteva essere uno studio ‘definitivo’ sui santini progettisti ed imprenditori, non siano state attribuite loro, studiate e pubblicate né le piante del fondo Padri Teatini, né il progetto sotteso all’ampliamento della casa o la speculazione immobiliare che vado a descrivere.
(102)Asfe, AnAfe, notaio Giuseppemelotti, matr. 1299, pacco 1, atto del 28 gennaio 1739.
(103) raFFaella montanarI, L’edificio teatrale, in I teatri di Ferrara. Il Comunale, a cura di P. fabbri – m. c. Bertieri, libreria musicale Italiana, lucca 2001, vol. I, pp. 3-49.
(104) «corriere padano», 24 ottobre 1950: Dopo oltre trecento anni di vana attesa la Chiesa dei Teatini avrà la ‘sua’ facciata. ringrazio Giorgio mantovani per questa utile indicazione.
56
Laura Graziani Secchieri
(105) Infatti nomina la sola consacrazione del 1618, e quindi relativa alla prima, piccola chiesa, cui però attribuisce la facciata incompleta a «luca danesi che la chiesa edificò», con evidente confusione cronologica.
(106) riguardo ad Antonio foschini: antonIo FrIzzI, Memorie per la storia di Ferrara, V, ferrara 1809, pp. 227-231; leoPoldo cIcoGnara, In morte dell’architetto Antonio Foschini, ferrara 1814; GIorGIo PadovanI, Architetti ferraresi, rovigo 1955, pp. 139-145; A.m. mat-teuccI - d. lenzI, C. Morelli e l’architettura delle legazioni pontificie, Bologna 1977, pp. 294-299; FaBrIzIo FIocchI, Antonio Foschini architetto e pubblico professore di architettura, tesi di laurea, Venezia, Istituto universitario di architettura, a.a. 1981-82; Idem, L’Accademia del disegno di Ferrara, in «Musei ferraresi», 1983-84, 13-14, pp. 237, 240, 243.; Idem, Contributi alla conoscenza della didattica architettonica…, in Ferrara disegnata, a cura di m. Peron - G. savioli, ferrara 1986, pp. 62-67; f. mancInI - m.t. muraro - e. Povoledo, I teatri del Veneto, III, Venezia 1988, pp. 419-425; F. FIocchI, L’insegnamento dell’architettura e la formazione del “tecnico” a Ferrara. Dall’Accademia del disegno alla libera università (1736-1860), in L’architettura nelle accademie riformate, a cura di G. ricci, milano 1992, pp. 139, 147; u. thI-eme - F. Becker, Künstlerlexikon, XII, p. 236; F. FIocchI, Antonio Foschini, voce in «Dizionario Biografico degli Italiani», volume 49 (1997), url http://www.treccani.it/ enciclopedia/antonio-foschini_(Dizionario-Biografico)/.
(107) Il Resto del Carlino, 3 novembre 1934. Il Corriere Padano, 3 novembre 1934.
(108) Ascfe, secolo XIX, serie strade e fabbricati: ornato, busta 97, numerazione civica stradale, fogli 1 e 32.
(109) Ascfe, secolo XIX, Poste, busta 65, fascicolo 1: 1802 – Traslocazione dell’Ufficio Postale delle Lettere nell’Oratorio dei Teatini.
(110) Asfe, AnAfe, notaio filippo francesco carli, matr. 1766, pacco 7, atto del 16 maggio 1799.
(111) Ivi, pacco 7, atto del 17 maggio 1799.
(112) Ivi, pacco 7, atto del 21 maggio 1799.
(113) Asfe, APA, Vincenzo Bertoni, busta 34, fascicolo 238, perizia del 6 novembre 1806.
(114) Asfe, APA, luigi casoni, busta 145, fascicolo 164, perizia dell’8 ottobre 1807.
(115) sono presso l’Asfe i Brogliardi, i catastini dei Proprietari Primitivi, i registri delle mutazioni ed i registri delle Partite.
(116) Ascfe, secolo XIX, serie strade e fabbricati, cartella 5: via del Commercio, richiesta dell’11 marzo 1822.
(117) Ivi, richiesta del 16 aprile 1825.
(118) Ivi, richiesta del 4 agosto 1829.
57
Una chiesa incompiuta e una casa irriconoscibile: le vicende infauste del complesso dei Teatini a Ferrara
(119) Ascfe, secolo XIX, serie strade e fabbricati, cartella 10: via Cairoli già Borgonuovo, fasc. 1, richiesta del 24 agosto 1833.
(120) Ivi, richiesta del 27 settembre 1833.
(121) Francesco avventI, Il servitore di Piazza. Guida per Ferrara, ferrara 1838, p. 97.
(122) Ascfe, secolo XIX, serie strade e fabbricati, cartella 5: via Bersaglieri del Po già Commercio, fasc. 1, richiesta del 21 maggio 1839.
(123) Ascfe, secolo XIX, serie strade e fabbricati, cartella 30: corso Giovecca, richiesta del 14 ottobre 1854.
(124) Ascfe, secolo XIX, serie strade e fabbricati, cartella 10: via Cairoli già Borgonuovo, fasc. 1, richiesta del 29 novembre 1859.
(125) Ivi, cartella 10: via Cairoli già Borgonuovo, fasc. 2, richiesta del 4 giugno 1862.
(126) Ascfe, secolo XIX, serie strade e fabbricati, cartella 30: corso Giovecca, richiesta del giorno 11 giugno 1864.
(127) Asfe, APA, Antonio maestri, busta 391, fascicolo 8, perizia del 31 gennaio 1846.
(128) Ascfe, secolo XIX, serie strade e fabbricati, cartella 5: via del Commercio, richiesta del giorno 11 aprile 1871.
(129) Ivi, richiesta del 2 luglio 1871.
(130) Ivi, richiesta del 10 ottobre 1873.
(131) Ivi, richiesta del 9 giugno 1873.
(132)Ascfe, secolo XIX, serie strade e fabbricati, cartella 10: via Cairoli già Borgonuovo, fasc. 1, richiesta del 12 luglio 1875.
(133) Ivi, richiesta del 26 aprile 1879.
(134) Asfe, rsBV, busta 11, fascicolo 16, Ferrara: Chiesa di San Gaetano detta dei Teatini succursale della Cattedrale di Ferrara.
(135) Asfe, cessato catasto di ferrara, Tipo di frazionamento e voltura n. 623 del novembre 1884.
(136) Ascfe, secolo XIX, serie Patrimonio comunale, cartella 42: Ex convento dei Teatini. Costruzione del Palazzo Postale; 28 giugno 1885.
le vicende del trasferimento (preceduto da una campagna stampa che aveva preso avvio da lamentele per la mancanza d’igiene e per l’inadeguatezza dello stabile) della sede dell’Ufficio delle Poste da corso Giovecca al nuovo palazzo in viale cavour, inaugurato il 1° maggio 1930, sono state tratteggiate da l. maraGna, La storia del palazzo delle Poste di Ferrara, ferrara 2007. Anche: lucIo scardIno, Famigerato e dispettoso. Appunti sul palazzo delle Poste di Ferrara e
58
Laura Graziani Secchieri
su Angiolo Mazzoni, in Angiolo Mazzoni (1894-1979), Architetto Ingegnere del Ministero delle Telecomunicazioni, milano, sitira 2003, pp. 205-214.
(137) Ascfe, secolo XIX, serie strade e fabbricati, cartella 30: corso Giovecca, richiesta del giorno 11 marzo 1894.
(138) Asfe, cessato catasto di ferrara, Tipo di frazionamento e voltura n. 523 del 29 luglio 1902.
(139) Asfe, rsBV, busta 3, fascicolo 9, Ferrara: Chiesa di San Gaetano detta dei Teatini succursale della Cattedrale di Ferrara.
(140) GualtIero medrI, Ferrara brevemente illustrata nei suoi principali monumenti, fer-rara 1933, pp. 155-158; identico il passo nella II edizione a cura dell’ente Provinciale per il turismo di ferrara, 1953, pp. 155-158.
(141) In giro per Ferrara. Guida storico-artistica della città, a cura di alFonso sautto, «supplemento alla rivista ferrara della camera di commercio Industria Agricoltura di ferrara», 1959, p. 66.
(142) Ferrara – Danni di guerra, a cura di FerrarIae decus, ferrara 1995, foto 14.
(143) «corriere Padano», 24 ottobre 1950: Dopo oltre trecento anni di vana attesa la Chiesa dei Teatini avrà la ‘sua’ facciata.
(144) dipendente comunale, enrico Alessandri è stato collaboratore di carlo savonuzzi in diverse circostanze progettuali, dal serbatoio monumentale dell’acquedotto comunale (1930-32) allo studio del piano regolatore generale di ferrara (1946), dai Piani e progetti per il risanamento della zona di san romano di ferrara (1949) ai Piani di ricostruzione di Pontelagoscuro e della città di ferrara (entrambi del 1949) fino a quello del quartiere Arianuova (1951): enrico Alessan-dri vi compare come progettista, e non come disegnatore come affermato da alcuni.
Inoltre, ricordiamo che, il 17 novembre del 1960, nel corso delle celebrazioni del trentennale di affidamento della parrocchia di san Benedetto ai salesiani, l’arcivescovo di ferrara monsi-gnor natale mosconi ha consacrato l’altare dedicato a san Giovanni Bosco, disegnato dall’ar-chitetto enrico Alessandri.
(145) Ferrariae Decus, Archivio, fasc. 0149: Teatini, Santa Maria della Pietà.