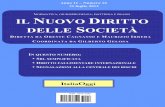Lo scioglimento delle unioni di fatto e degli accordi di convivenza nel diritto internazionale...
Transcript of Lo scioglimento delle unioni di fatto e degli accordi di convivenza nel diritto internazionale...
Giuffre
’ Edit
ore
VOLUME LXXXVIII 2005 FASC. 4PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in a.p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46)
art. 1, comma 1, DCB (VARESE)
ISSN 0035-6158
R I V I S T AD I
D I R I T T O I N T E R N A Z I O N A L E
G I U F F R È • E D I T O R ERIV
IST
A D
I D
IRIT
TO
IN
TE
RN
AZ
ION
ALE
V
olu
me
LX
XX
VII
I -
20
05
- F
asc.
4
GIUFFRÈ EDITOREVia Busto Arsizio, 40 - 20151 MILANOTel. 02/38.089.1 - Fax 02/38.009.582http://www.giuffre.it - E-mail: [email protected]
74
REPERTORIO GENERALE ANNUALE - 2004di legislazione - bibliografia - giurisprudenza
a cura di RENATO BORRUSOcon la collaborazione diGiuseppe Maria Berruti - Stefania Di Tomassi - Lorenzo Grisostomi Travaglini - Maria Raffaella Jannuzzi - Paola Jannuzzi - Giorgio Stella Richter - Paolo Zappanico
Responsabile gestione input: Paolo PistoneIl Repertorio comprende:a) la legislazione vigente emanata fino al 31 dicembre 2004,
con l’indicazione delle circolari e delle disposizioni dichiarate incostituzionali;
b) le notizie bibliografiche relative allo stesso anno (articoli didottrina, note a sentenze, principali note redazionali);
c) tutte le massime – in materia costituzionale, civile, penale,processuale, amministrativa, tributaria – estratte dalle decisioni pronunciate nell’anno 2004 dalla Corte costituzionale, dalla Corte di cassazione e dal Consiglio di Stato, nonché tutte le massime delle decisioni di altre autorità tratte dalle varie riviste pubblicate nello stesso anno. Sono riportate altresì le massime relative a decisioni degli anni precedenti, se pubblicate nel 2004.
L’intera materia – legislazione, bibliografia e giurisprudenza – è suddivisa in voci, sottovoci e, per le voci più complesse, in seconde e terze sottovoci, per consentire di identificare subito, per ogni argomento, la normativa vigente e quanto si è scritto ed è stato deciso in giurisprudenza nel corso dell’anno.Le riviste Giurisprudenza costituzionale, Giustizia civile, Giustizia civile - Massimario, Cassazione penale, Foro amministrativo C.d.S., Foro amministrativo T.A.R. e Giurisprudenza di merito – edite dalla Giuffrè – codificano la giurisprudenza pubblicata con lo stesso sistema di classificazione del Repertorio. L’utilizzazione dell’indice di riferimento a tale schema di classificazione, presente in queste riviste, unitamente al Repertorio stesso, permette ai consultatori un costante aggiornamento in attesa della pubblicazione dell’anno successivo.
Tre tomi rilegati di complessive p. XXXIX-6762,E 340,00
© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore
Giuffre
’ Edit
ore
SOMMARIO
pag.
P. PICONE, prof. ord. Univ. Roma « La Sapienza ». — Obblighi erga omnese codificazione della responsabilita degli Stati . . . . . . . . . . . . . . 893
I. VIARENGO, prof. ord. Univ. Milano. — Deroghe e restrizioni alla tuteladei diritti umani nei sistemi internazionali di garanzia . . . . . . . . . 955
S. TONOLO, prof. ass. Univ. Insubria. — Lo scioglimento delle unioni difatto e degli accordi di convivenza nel diritto internazionale privatoe processuale italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 997
Note e commenti
M. PISANI, prof. ord. Univ. Milano. — Franco Carrara e il ne bis in ideminternazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1022
A. ROTTOLA, prof. ord. Univ. Bari. — La violazione dell’obbligo di corre-sponsione dell’assegno di mantenimento stabilito da una sentenzastraniera di divorzio: solo illecito civile o anche reato?. . . . . . . . . 1033
G. MAROTTA, dott. giur. — Innovazioni tecnologiche e diritto al rispettodel domicilio nella Convenzione europea. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1044
Panorama
Il progetto di accordo interistituzionale sulle agenzie europee di regolazione:una soluzione adeguata? (V. Randazzo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1062
Giurisprudenza
GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE
Corte internazionale di giustizia - Competenza in materia contenziosa -Controversia di frontiera - Compromesso - Clausola sul diritto appli-cabile - Principio uti possidetis iuris - Portata ed effetti - Rapportotra titoli giuridici ed effettivita - Situazione territoriale al momentodell’accesso all’indipendenza e a quello attuale - Documenti carto-grafici - Valore - Instantane territorial - Effettivita post-coloniali -Diritto coloniale - Delimitazione della frontiera nel fiume Niger -
© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore
Giuffre
’ Edit
ore
LO SCIOGLIMENTO DELLE UNIONI DI FATTOE DEGLI ACCORDI DI CONVIVENZA NEL DIRITTO
INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE ITALIANO
SOMMARIO: 1. Osservazioni introduttive. — 2. Azioni proponibili al giudice italianoe criteri di giurisdizione. — 3. Questioni preliminari. Rilevanza di unioni difatto e accordi di convivenza quali presupposti per la definizione di uno sta-tus. — 4. Qualificazioni di unioni di fatto e accordi di convivenza. — 5. In-dividuazione dei criteri di collegamento rilevanti. — 6. Applicabilita del rin-vio. — 7. Problemi di qualificazione. — 8. Segue. Problemi connessi alla qua-lificazione di unioni di fatto e accordi di convivenza come istituti ignoti. — 9.Riconoscimento delle decisioni relative allo scioglimento di unioni di fatto eaccordi di convivenza.
1. La possibilita che il giudice italiano si trovi a dover ricer-care la disciplina applicabile allo scioglimento di accordi di convi-venza e unioni di fatto non e esclusa dall’assenza di norme specifi-camente rivolte a regolare tali fattispecie all’interno della l. n. 218del 31 maggio 1995 (1). In considerazione della diffusione di tali isti-tuti in molti paesi di civil law e di common law, puo accadere infattiche cittadini italiani concludano all’estero, tra di loro o con un cit-tadino straniero, un patto di convivenza e che le questioni collegatealla dissoluzione dello stesso si pongano nel nostro paese, o che cit-tadini stranieri domiciliati o residenti in Italia si rivolgano ai nostrigiudici per far valere i diritti derivanti da accordi di convivenza sti-pulati all’estero e in seguito dissolti, oppure ancora puo darsi il casoche si richieda nell’ordinamento italiano il riconoscimento e l’esecu-zione delle decisioni connesse all’interruzione del partenariato.
L’ampiezza con cui e definita la giurisdizione italiana, in ordinealle controversie che presentano elementi di estraneita, puo infattiporre il giudice italiano nella condizione di dover determinare lalegge applicabile alle questioni conseguenti allo scioglimento diunioni di fatto e di accordi di convivenza. In maniera analoga, laprevisione del riconoscimento automatico delle sentenze entro il si-
Rivista di diritto internazionale - 4/2005
(1) G.U. 3 giugno 1995 n. 128 suppl. n. 68.
© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore
Giuffre
’ Edit
ore
stema di diritto internazionale privato italiano puo consentire di ren-dere piu facilmente efficaci le decisioni estere pronunciate in questamateria.
Si tratta tuttavia di una materia alquanto problematica, dal mo-mento che tali fattispecie, regolate da discipline materiali diverse ne-gli ordinamenti coinvolti (2), danno anche luogo a differenti approcciinternazionalprivatistici (3), a causa dei contenuti che vengono ad as-
998 SCIOGLIMENTO DELLE UNIONI DI FATTO
(2) L’evoluzione, a seguito della quale gli ordinamenti nazionali hanno fissatoalcune norme per regolare le fattispecie esaminate nel testo evidenzia, in linea gene-rale, due procedimenti. Il primo consiste nell’estensione ai conviventi, tramite prov-vedimenti legislativi, amministrativi o giurisprudenziali, di alcuni benefici usualmenteriservati ai coniugi. Il secondo modello si realizza, invece, nella formalizzazione gene-rale della relazione con peculiarita diverse all’interno dei singoli ordinamenti e, al ri-guardo, gli schemi giuridici possono essere vari: con la domestic partnership si realizzail riconoscimento di alcuni diritti tradizionalmente derivanti dal matrimonio a seguitodi una convivenza rispetto alla quale i partners hanno l’onere della prova (v. ad es.:art. 3, 1o comma, l. aragonese 26 marzo 1999, Ley 6/1999 relativa a Parejas establesno casadas, in Boletın Oficial de Aragon, 6 aprile 1999 n. 39, consultabile anche all’in-dirizzo http://www.aragob.es; art. 1 l. portoghese dell’11 maggio 2001 n. 7, Adoptamedidas de proteccao das unioes de facto); la registered partnership configura inveceun istituto giuridico, di norma previsto per le coppie omosessuali, che tende a ripro-porre lo schema del matrimonio. La registrazione avviene generalmente tramite attopubblico e produce effetti giuridici personali e patrimoniali. Tale modello ricorre ades.: nei paesi scandinavi, che, seguendo l’esempio della Danimarca, primo paese adadottare una legge sulle convivenze registrate, hanno regolato tale materia con disci-pline simili e rivolte ad equiparare il piu possibile la posizione dei conviventi a quelladei coniugi (v. l. danese 7 giugno 1989, n. 372, d/341 — H — ML, Lov om registeretpartnerskab, successivamente modificata dalle leggi 19 dicembre 1989 n. 821, Data-sammenskriving af Lov om registeret partnerskab, 14 giugno 1995 n. 387, Lov om fo-raeldremyndighed og samvaer e 2 giugno 1999 n. 360, Lov om aendring af om registe-ret partnerskab: la versione inglese della legge e consultabile all’indirizzo http://www.denmarkemb.org/regipart2.html; l. norvegese 30 aprile 1993, Bill on RegisteredPartnerships n. 40 1992/1993, sull’unione registrata: la versione inglese della legge econsultabile all’indirizzo http://www.ub.uio.no/ulovdata/lov-19930430-040-eng.pdf;l. svedese 23 giugno 1994, emendata nel 2000, in Svensk Forlatt ningssamling1994:1117, e in Svensk Forlatt ningssamling 2000:374; l. islandese 12 giugno 1996:il testo inglese di questa legge e consultabile all’indirizzo http://government.is/inter-pro/dkm/dkm.nsf/pages/eng_partnership; l. finlandese 9 novembre 2001, Act on Re-gistered Partnerships 950/2001, consultabile, nella versione inglese, all’indirizzohttp://www.finlex.fi/english/index.html); in Germania, ove la l. 16 febbraio 2001,Gesetz uber die eingetragene Lebenspartnerschaft, in Bundesgesetzblatt, 2001, I,p. 266, disciplina le convivenze registrate tra coppie omosessuali attribuendo ai mem-bri delle stesse diritti simili a quelli riconosciuti ai coniugi, a far data dalla dichiara-zione resa dinanzi alla pubblica autorita competente; in Francia, Belgio e Olanda ovela formalizzazione della convivenza, tra coppie eterosessuali ed omosessuali, avvienetramite un atto di natura contrattuale: v. al riguardo l. olandese 5 luglio 1997, inStaatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1997, n. 324; l. belga 23 novembre1998, Loi instaurant la cohabitation legale; l. francese 15 novembre 1999 n. 99-944,Loi relative au Pacte Civil de Solidarite, in Journal Officiel, 16 novembre 1999n. 265, p. 16959, consultabile anche all’indirizzo http://www.legifrance.gouv.fr.
(3) Sui quali si veda in generale SARCEVIC, Private International Law Aspects of
© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore
Giuffre
’ Edit
ore
sumere in funzione della molteplicita delle situazioni ad esse colle-gate, non riconducibili ad un unico modello.
Infatti, accanto alle convivenze fra persone legate da un rap-porto sentimentale, e determinate dall’impossibilita giuridica di spo-sarsi, temporalmente limitata per i soggetti in attesa di divorzio, edindeterminata per le coppie omosessuali, se non sottoposte ad ordi-namenti che consentano loro il matrimonio (quale ad es. quelli deiPaesi Bassi e del Belgio, che hanno, previsto tale opzione rispettiva-mente con l. 21 dicembre 2000 (4), e con l. 13 febbraio 2003 (5),nonche della Spagna che ha recentemente modificato le disposizionidel Codigo civil concernenti il matrimonio con l. 1o luglio 2005n. 13), si pongono le convivenze volontarie ispirate da ragioni nonsentimentali (economiche, ideologiche, di studio, ecc.), e le convi-venze fra soggetti legati da vincoli di consanguineita (6).
Le ipotesi di definizione dei problemi di diritto internazionaleprivato, connesse agli accordi di convivenza sono sostanzialmentequattro: assenza di regole di conflitto normativamente definite e ri-cerca interpretativa delle stesse, come nell’ordinamento italiano o neisistemi di common law; previsione di disposizioni di diritto interna-zionale privato specificamente rivolte a regolare alcuni aspetti con-nessi agli accordi di convivenza, come in considerazione nel sistema
999E DEGLI ACCORDI DI CONVIVENZA
Legally Regulated Forms of Non-Marital Cohabitation and Registered Partnerships, inYearbook of Private Int. Law, 1999, p. 44 ss.; JESSURUN D’OLIVEIRA, Registered Part-nerships, Pacses and Private International Law. Some Reflections, in Riv. dir. int. priv.proc., 2000, p. 297 ss.
(4) In Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 2001, n. 9. La versioneinglese della legge e consultabile all’indirizzo: http://ruljis.leidenuniv.nl/user/cwaal-dij/www/NHR/transl-marr.html.
(5) Loi ouvrant le mariage a des personnes de meme sexe et modifiant certainesdispositions du Code civil, in Moniteur belge, 28 febbraio 2003, e consultabile all’in-dirizzo: http://www.just.fgov.be.
(6) Per la definizione delle varie tipologie di « famiglia naturale », con riferi-mento sia ai rapporti tra persone di sesso diverso, sia al rapporto di filiazione naturaleche ad essi si puo collegare, si veda, nella giurisprudenza della Corte europea dei di-ritti dell’uomo, sent. 13 giugno 1979, Marckx c. Belgio, Publications, Serie A, n. 31;sent. 26 maggio 1994, Keegan c. Irlanda, Serie A, n. 290; 27 ottobre 1994, Kroon c.Paesi Bassi, Serie A, n. 297-C. Per l’applicazione della nozione di « famiglia naturale »a un rapporto tra due donne, una delle quali aveva subito un cambiamento di sesso, eil figlio della prima concepito mediante fecondazione artificiale, si veda la sent. 22aprile 1997, X, Y e Z c. Regno Unito, in Recueil, 1997-II. Diverso e piu restrittivoe invece l’orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dellecoppie omosessuali. Si veda in tal senso: sent. 17 ottobre 1986, Rees c. Regno Unito,Serie A, n. 106; sent. 27 settembre 1990, Cossey c. Regno Unito, Serie A, n. 184. Siveda in generale sul punto COUSSIRAT-COUSTERE, Famille et Convention europeennedes Droits de l’Homme, in Protection des droits de l’homme: la perspective europeenne.Melanges a la memoire de Rolv Ryssdal, Koln/Berlin/Bonn/Munchen, 2000, p. 281 ss.
© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore
Giuffre
’ Edit
ore
olandese (7) e, seppure con diverse incertezze, nell’elaborazione delladottrina francese quanto ai PACS (8); codificazione di regole gene-rali, relative all’individuazione della legge applicabile agli accordidi convivenza, e al riconoscimento delle convivenze registrate all’e-stero, come recentemente avvenuto nel sistema di conflitto belga (9)e in quello tedesco (10); operativita delle regole di diritto internazio-
1000 SCIOGLIMENTO DELLE UNIONI DI FATTO
(7) Si vedano, a tale riguardo, le sezioni 1-35 della proposta del Comitato per-manente olandese di diritto internazionale privato del maggio 1998, consultabile al-l’indirizzo: http://www.minjust.nl:8080, ove si distingue tra convivenze registrateconcluse all’interno dei Paesi Bassi (cap. 2) e convivenze concluse all’estero (cap.3), stabilendo legge applicabile e giudice competente in ordine ai singoli aspetti (per-sonali, patrimoniali, estinzione del rapporto, ecc.), nonche il riconoscimento per laseconda categoria di convivenze. Al fine di evitare che alle unioni registrate in Olandavenga applicata da parte del giudice olandese una legge straniera che non conosce l’i-stituto in questione, il progetto sottopone quasi integralmente la disciplina delle part-nerships registrate nei Paesi Bassi al diritto olandese, richiamandolo sia in ordine allaregolamentazione della capacita a concludere tali unioni, sia in ordine ai rapporti per-sonali tra i partners. Per i rapporti patrimoniali, il progetto stabilisce poi il funziona-mento dell’electio iuris, purche essa giunga ad individuare la legge di uno Stato cheprevede l’istituto dell’unione registrata. In caso contrario, come in assenza di electioiuris, si richiamera la legge olandese. Infine il progetto prevede che la legge olandesesi applichi anche allo scioglimento delle partnerships registrate in Olanda, in relazionealle quali i tribunali olandesi hanno sempre giurisdizione. Per le unioni registrate al-l’estero, si richiama invece il criterio di collegamento del locus celebrationis, facendoinfatti riferimento alla legge dello Stato di registrazione dell’unione per determinarela disciplina della medesima.
(8) Si veda in generale sul punto FULCHIRON, Reflexions sur les unions hors ma-riage en droit international prive, in Journal du droit int., 2000, p. 902 ss.
(9) La Loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international prive, in [email protected], 2004, 4, prevede infatti disposizioni specifiche in tema di legge appli-cabile alla relation de vie commune (articoli 58-60) e l’estensione della norma dell’art.42 sulla competenza in materia di relazioni matrimoniali.
(10) L’art. 17b dell’EGBGB, come modificato dalla l. 16 febbraio 2001 — ori-ginariamente art. 17a EGBGB — e dalla l. 11 dicembre 2001, dispone infatti la ge-nerale applicabilita del criterio del locus celebrationis per determinare la disciplina ditutte le partnerships, indipendentemente dal fatto che esse siano registrate in Germa-nia o all’estero; in particolare tale norma sottopone alla disciplina del luogo di regi-strazione la costituzione, gli effetti personali e patrimoniali e lo scioglimento dell’u-nione registrata. La legge del luogo di registrazione viene poi in rilievo, nell’ambitodell’art. 17b, 1o comma, II frase, EGBGB, qualora la disciplina individuata dallenorme di conflitto comuni non preveda alimenti o diritti successori in relazione alleunioni registrate. In tema di giurisdizione, si prevede inoltre una modifica dell’art.606 n. 4 della Zivilprozessordnung: accanto ai criteri generali in base ai quali i tribu-nali tedeschi sono sempre competenti in relazione alle partnerships registrate in Ger-mania e in ordine a quelle registrate all’estero, quando almeno uno dei due partnersabbia la residenza abituale in Germania, si dispone l’inapplicabilita alle unioni regi-strate della regola secondo la quale in materia di divorzio i tribunali tedeschi nonsono competenti se la sentenza da essi pronunciata non possa essere riconosciutadai tribunali dello Stato al quale almeno uno dei coniugi appartiene. Cio al fine dievitare che l’assenza di riconoscimento all’estero delle unioni registrate possa limitarein qualche modo la giurisdizione tedesca. Relativamente al riconoscimento degli ef-
© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore
Giuffre
’ Edit
ore
nale privato concernenti la disciplina del matrimonio, con alcune ec-cezioni rappresentate da norme unilaterali (11).
Al contrario, non pare possibile ricondurre alle ipotesi di defi-nizione di problematiche internazionalprivatistiche, appena esami-nate, i matrimoni tra omosessuali. Tali fattispecie non suscitanocerto i problemi di qualificazione posti dagli accordi di convi-venza (12), dal momento che negli ordinamenti entro i quali sonoprevisti (13) e chiara la qualificazione attribuita. Nell’ambito dei si-stemi giuridici che non regolano questo istituto, come ad es. quelloitaliano, si porra tuttavia il problema della riconoscibilita degli effettidi tali matrimoni, anche alla luce del rispetto dell’ordine pubblico,che potrebbe essere invocato da quanti ritengono la differenza disesso tra i coniugi elemento essenziale all’istituto matrimoniale (14).
1001E DEGLI ACCORDI DI CONVIVENZA
fetti delle unioni registrate, l’art. 17b, 3o comma, EGBGB dispone che se due personesono legate da piu unioni registrate in Stati differenti e quella registrata per ultima aprodurre effetti nell’ordinamento tedesco. Su tale disposizione, si veda WAGNER, Dasneue Internationale Privat- und Verfahrensrecht zur eingetragenen Lebenspartner-schaft, in IPRax, 2001, pp. 281-293; GEBAUER, STAUDINGER, Registrierte Lebenspart-nerschaften und die Kappungsregel des Art. 17b Abs. 4 EGBGB, in IPRax, 2002,pp. 275-282. In materia, si veda inoltre: ROTHEL, Registrierte Partnerschaften im inter-nationalen Privatrecht, in IPRax, 2000, pp. 74-79.
(11) Si tratta del modello di regolamentazione internazionalprivatistica seguitodai paesi scandinavi: nella l. danese 1o giugno 1989, infatti, la sez. 2 richiama in ge-nerale la legge sul matrimonio, prevedendo pero quale condizione per la registrazionedella convivenza la residenza o la nazionalita in Danimarca di una delle parti; nellasez. 9 della l. svedese del 23 giugno 1994 si fa espresso riferimento alle sezioni 4-9della legge sul matrimonio e la tutela, ad eccezione delle condizioni richieste ai finidella registrazione della convivenza (cittadinanza o domicilio in Svezia), secondoquanto dispone la sez. 2 della stessa legge; nella sez. 2 della l. norvegese 1992-1993si richiamano i capitoli 1 e 2 della legge sul matrimonio, stabilendo pero per la regi-strazione della convivenza le condizioni del domicilio e della cittadinanza norvegesi;infine, nelle sezioni 2-3 della l. islandese del 12 giugno 1996, si fa espresso rinvio allalegge sul matrimonio, ponendo pero le condizioni della cittadinanza o del domicilioislandesi per la registrazione della convivenza.
(12) Si veda tuttavia contra ROSSOLILLO, Registered partnerships e matrimoni trapersone dello stesso sesso: problemi di qualificazione ed effetti nell’ordinamento ita-liano, in Riv. dir. int. priv. proc., 2003, p. 363 ss.
(13) Il matrimonio tra persone dello stesso sesso e analogamente previsto, oltreche in Olanda, in Belgio e in Spagna, nelle province canadesi dell’Ontario, British Co-lumbia e Quebec e nello Stato del Massachusetts (Stati Uniti). Si veda sul punto: Hal-pern v. Canada (Attorney General) (2003), Ontario Reports (3d), vol. 65, p. 161 (Ct.App.); Egale Canada Inc. v. Canada (Attorney General) (2003), British Columbia LawReports (4th), vol. 15, p. 226 (Ct. App.); Hendricks v. Quebec (Attorney General)(2004) (Ct. App. Quebec, 19 marzo 2004). Si veda inoltre HILL KAY, Same-Sex Di-vorce in the Conflict of Laws, in The King’s College Law Journal, 2004, p. 63 ss.
(14) Si veda in tal senso ROSSOLILLO, Registered partnerships, cit., p. 382; MO-
SCONI, Le nuove tipologie di convivenza nel diritto europeo e comunitario, in Riv. dir.int. priv. proc., 2005, p. 305 ss., p. 306.
© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore
Giuffre
’ Edit
ore
Nell’ambito della complessa tematica delle unioni di fatto e de-gli accordi di convivenza, costituiscono oggetto di particolare inte-resse le questioni connesse allo scioglimento volontario di tali situa-zioni, sia secondo il profilo della determinazione del giudice compe-tente ad apprezzarne gli effetti, sia in ordine all’individuazione dellalegge applicabile, sia infine relativamente al riconoscimento e all’ese-cuzione delle relative decisioni.
2. La dissoluzione delle unioni di fatto e degli accordi di con-vivenza puo porre al giudice italiano la necessita di determinarne ladisciplina applicabile, una volta individuate le questioni allo stessosottoponibili e i criteri che, in relazione ad esse, ne definiscono lagiurisdizione.
A tale riguardo, occorre innanzitutto considerare che la sem-plice configurabilita di tali istituti, essenzialmente fondati sull’auto-nomia della volonta dei soggetti che li costituiscono, nasconde inrealta molti problemi da risolvere, in relazione ai molteplici casiche possono porsi in questa materia. Le questioni sottoponibili algiudice italiano, a seguito della cessazione delle unioni di fatto, si ri-collegano infatti — come si e detto — non tanto alla rottura dell’u-nione, che, in quanto liberamente posta in essere, puo allo stessomodo essere liberamente sciolta tramite una manifestazione di vo-lonta, bilaterale o unilaterale, quanto alle conseguenze derivanti datale rottura: responsabilita per i danni dalla stessa derivanti, che sipuo delineare come contrattuale o extracontrattuale, a seconda delfatto che l’unione sia stata formalizzata con un accordo oppureno; obbligazioni alimentari tra i conviventi separati; esercizio dellapotesta sui figli eventualmente nati nell’ambito dell’unione; assegna-zione dell’abitazione ove i partners convivevano.
Relativamente alle controversie originate da tali questioni, l’as-senza di regole di giurisdizione specificamente dettate in tema diunioni di fatto e accordi di convivenza pone la necessita di ricorrerealle norme disposte dalla legge italiana di diritto processuale civileinternazionale per definire la competenza del giudice italiano, distin-guendosi, entro di esse, tra quelle specialmente rivolte a determinatecategorie di controversie cui siano riconducibili le questioni azionatedai conviventi, e quelle generalmente poste per delimitare la giuri-sdizione italiana.
Ricade, infatti, nell’ambito delle regole speciali di giurisdizionel’eventuale domanda di alimenti proposta da un convivente nei con-fronti dell’altro. Viene a tale riguardo in rilievo, da un lato, la disci-plina di cui all’art. 5 n. 2 della Convenzione di Bruxelles del 27 set-
1002 SCIOGLIMENTO DELLE UNIONI DI FATTO
© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore
Giuffre
’ Edit
ore
tembre 1968, richiamata dall’art. 3, 2o comma, della l. 218/95 e, dal-l’altro, la regolamentazione dell’art. 5 n. 2 del regolamento (CE)n. 44/2001 (15), che ha sostituito la Convenzione di Bruxelles (16). Se-condo tali disposizioni, e sufficiente che il creditore di alimenti ab-bia il domicilio o la residenza abituale in Italia per fondare la com-petenza del giudice italiano, comunque competente qualora la do-manda di alimenti si configuri in maniera accessoria rispetto adun’azione relativa allo stato delle persone in base alla legge nazio-nale.
In maniera analoga, l’azione per far valere l’eventuale responsa-bilita extracontrattuale di uno dei conviventi puo essere sottopostaal giudice italiano ove siano localizzabili in Italia i criteri di cui agliarticoli 5 nn. 1 e 3 della Convenzione di Bruxelles del 1968 e delregolamento 44/2001: luogo di esecuzione dell’obbligazione, luogoin cui l’evento dannoso e avvenuto o puo avvenire (17).
Alle regole speciali di giurisdizione si puo inoltre ricondurre lanorma dell’art. 42 della l. 218/95, che richiama in ogni caso la Con-venzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autoritae sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resaesecutiva con la legge 24 ottobre 1980 n. 742 (18). Secondo l’art. 1di questa Convenzione, la competenza ad adottare le misure ten-denti alla protezione della persona o dei beni del minore si individuainnanzitutto in base al criterio della residenza abituale del minore,
1003E DEGLI ACCORDI DI CONVIVENZA
(15) Il regolamento (CE) 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale,il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(G.U.C.E. 16 gennaio 2001 L 12) e in vigore dal 1o marzo 2002. Esso tuttavia nonsi applica alla Danimarca.
(16) L’adozione di tale regolamento si inquadra nel piu ampio fenomeno di« comunitarizzazione » del diritto internazionale privato, di cui costituiscono esempiosignificativo le nuove fonti del diritto internazionale privato e processuale. Su di essesi veda in generale DE CESARI, Diritto internazionale privato e processuale comunitario,Torino, 2003, p. 41 ss.; CARBONE, FRIGO, FUMAGALLI, Diritto processuale civile e com-merciale comunitario, Milano, 2004; MANSI, Il giudice italiano e le controversie euro-pee, Milano, 2004.
(17) Cfr. sul punto DE CESARI, Diritto internazionale privato, cit., p. 66 ss.; CAR-
BONE, FRIGO, FUMAGALLI, Diritto processuale civile, cit., p. 16 ss.; MANSI, Il giudice ita-liano e le controversie europee, Milano, 2004, p. 98 ss.
(18) G.U. 12 novembre 1980 n. 310 suppl. Le norme di attuazione sono con-tenute nella l. 15 gennaio 1994 n. 64, G.U. 29 gennaio 1994 n. 23 suppl. Sulla disci-plina prevista dall’art. 42 l. 218/95, cfr. in generale: HONORATI, Art. 42, in Commen-tario del nuovo diritto internazionale privato (a cura di Pocar), Padova, 1996, p. 209ss.; FRANCHI, Art. 42, in Legge 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano didiritto internazionale privato (a cura di Bariatti), in Nuove leggi civ. comm., 1996,p. 1235 ss.; TONOLO, Art. 42, in CONETTI, TONOLO, VISMARA, Commento alla riformadel diritto internazionale privato italiano, Legge 11 maggio 1995, n. 218, Torino, 2001,p. 175 ss.
© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore
Giuffre
’ Edit
ore
fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 che prevedonol’operativita residuale di altri collegamenti, quale ad es. la cittadi-nanza del minore o la precedente residenza del minore in caso ditrasferimento di residenza. E pertanto evidente che, qualora la resi-denza del minore figlio di due conviventi si trovi in Italia, il giudiceitaliano potra ritenersi competente in ordine al richiesto affidamentodello stesso; in maniera analoga, la giurisdizione italiana potra affer-marsi relativamente all’affidamento di un minore italiano, figlio diuna coppia italo-francese. Nel caso di specie, non pare possano fon-dare la giurisdizione italiana i criteri previsti dal regolamento CEn. 2201/2003, c.d. « Bruxelles II bis », in tema di responsabilita ge-nitoriale; anche se unioni di fatto e accordi di convivenza non sem-brano in linea di principio sottratti all’ambito d’applicazione del re-golamento in esame, che all’art. 46 equipara le condizioni per il ri-conoscimento degli atti pubblici formati e aventi efficacia esecutivain uno Stato membro a quelle previste per il riconoscimento delledecisioni, essi non risultano tuttavia rilevanti relativamente alle que-stioni di responsabilita genitoriale, per la stretta connessione che ilregolamento pone tra le domande relative alla responsabilita genito-riale e le domande di divorzio, separazione personale dei coniugi eannullamento del matrimonio (v., ad es., art. 12).
Infine le questioni derivanti dallo scioglimento di unioni di fattoe accordi di convivenza possono essere sottoposte alla giurisdizioneitaliana in forza dei criteri generali di giurisdizione, previsti dall’art.3 l. 218/95 (19), o in base all’accettazione della giurisdizione (art.4) (20), fatto salvo in ogni caso il limite delle azioni reali concernentibeni immobili siti all’estero di cui all’art. 5 l. 218/95.
3. In relazione alle questioni derivanti dallo scioglimento delleunioni di fatto e degli accordi di convivenza, viene poi in rilievo lapossibilita che il giudice italiano, investito della giurisdizione a deci-dere una controversia di questo tipo, si trovi a dover valutare la va-lida costituzione dell’unione da cui deriva l’obbligazione oggetto dicontroversia.
1004 SCIOGLIMENTO DELLE UNIONI DI FATTO
(19) Sull’art. 3 l. 218/95, cfr. in generale: LUZZATTO, Art. 3, in Commentario,cit., p. 19 ss.; BROGGINI, Art. 3, in Legge 31 maggio 1995, n. 218, cit., p. 905 ss.;DI BLASE, Art. 3, ibidem, p. 910 ss.; CONETTI, Art. 3, in CONETTI, TONOLO, VISMARA,Commento, cit., p. 11 ss.
(20) Sull’art. 4 l. 218/95, cfr. in generale: LUZZATTO, Art. 4, in Commentario,cit., p. 33 ss.; CARBONE, Art. 4, in Legge 31 maggio 1995, n. 218, cit., p. 918 ss.; CO-
NETTI, Art. 4, in CONETTI, TONOLO, VISMARA, Commento, cit., p. 16 ss.
© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore
Giuffre
’ Edit
ore
A tale riguardo, pare innanzitutto opportuno osservare che an-che se la lex fori non considera lo statuto dell’unione libera o del-l’accordo di convivenza e si rifiuta di assimilarla al matrimonio, ilgiudice dovra comunque confrontarsi con l’esistenza di tale fattispe-cie al fine di risolvere la questione oggetto della controversia propo-stagli. Si supponga ad es. che due conviventi portoghesi, residenti inItalia, pongano fine alla loro unione di fatto in Italia e che uno diessi si rivolga al giudice italiano per ottenere il risarcimento deldanno derivante dalla rottura per colpa dell’altro e che quest’ultimosi difenda argomentando che la convivenza non si era protratta per iltempo richiesto dalla normativa portoghese (due anni) (21) e pertantonon ricorre la fattispecie da quest’ultima prevista. Il giudice italianovalutera la durata della convivenza e lo status conseguentemente ri-conoscibile ai soggetti della medesima secondo la legge italiana inquanto lex loci delicti, oppure secondo la legge portoghese, leggepersonale, determinata dalla nazionalita comune di entrambi i convi-venti?
Tale alternativa, che ripropone chiaramente le soluzioni tradi-zionalmente avanzate per il complesso problema della questione pre-liminare, ovvero, da un lato, quella « congiunta », secondo la qualequest’ultima viene regolata dall’ordinamento competente a discipli-nare la questione principale, tenendo conto anche delle sue normedi conflitto oppure soltanto delle disposizioni materiali in esso vi-genti, e, dall’altro lato, quella « disgiunta », che individua la regola-mentazione della questione preliminare, tramite i criteri di collega-mento del foro ad essa applicabili (22), pare debba necessariamenterisolversi in questo caso con la preferenza per la legge personale, de-terminata dalla nazionalita comune dei conviventi (23). L’esistenzadell’unione libera, quale presupposto per l’acquisto dello status diconvivente, e per l’esercizio delle prerogative ad esso connessa,non puo in alcun modo riportarsi alle valutazioni della lex fori
1005E DEGLI ACCORDI DI CONVIVENZA
(21) Sul punto cfr. supra, nota 2.(22) Sulle questioni preliminari, cfr. in generale: WENGLER, Die Vorfrage im
Kollisionsrecht, in Zeitschrift fur auslandisches und internationales Privatrecht, 1934,pp. 148-251; LAGARDE, La regle de conflit applicable aux questions prealables, in Revuecritique de droit int. prive, 1960, pp. 459-484; RAAPE, Internationales Privatrecht, Ber-lin/Frankfurt, 1961, p. 119 ss.; PICONE, Saggio sulla struttura formale del problemadelle questioni preliminari nel diritto internazionale privato, Napoli, 1971, p. 18 ss.;ID., La riforma italiana del diritto internazionale privato, Padova, 1998, p. 271 ss.;SCHMIDT, The incidental question in private international law, in Recueil des cours,1992-II, pp. 307-415.
(23) Cio a differenza delle questioni concernenti gli aspetti formali dell’unioneche si possono ricondurre piuttosto alla disciplina della lex loci actus.
© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore
Giuffre
’ Edit
ore
(nel caso coincidente con la lex loci delicti), vista la stretta connes-sione tra tale questione e la condizione personale dei soggetti coin-volti. In questo caso, infatti, la necessita di verificare l’esistenza dellostatus di convivente richiede la ricostruzione della disciplina norma-tiva del sorgere di tale situazione; il rispetto del nesso tra il rapportoche ha dato origine alla condizione personale dei soggetti e la con-dizione stessa pone dunque un limite alle valutazioni che la lex foripotrebbe compiere in ordine al rapporto presupposto qualora ne ri-corressero le condizioni, ovvero quando la situazione dei conviventinon fosse stata contestata e dunque si ponesse come mero fenomenopregiudiziale rispetto alla valutazione del rapporto concreto (24).
Un suggerimento a favore dell’applicazione di tale soluzione nelsistema italiano di diritto internazionale privato si puo leggere nel-l’art. 6 l. 218/95, secondo il quale: « Il giudice italiano conosce, in-cidentalmente, le questioni che non rientrano nella giurisdizione ita-liana e la cui soluzione e necessaria per decidere sulla domanda pro-posta ». Cio, qualora si accolga l’interpretazione di questa disposi-zione come norma non meramente rivolta a fondare la giurisdizionedel giudice italiano, ma piuttosto diretta a suggerire che vi sia statada parte del nostro ordinamento l’assunzione di regolamentazionedella questione preliminare, attraverso i consueti strumenti di dirittointernazionale privato (25).
Alla luce di tali considerazioni, c’e da chiedersi peraltro se, an-ziche considerare le unioni di fatto e gli accordi di convivenza comeistituti sconosciuti (26), che tuttavia influiscono sulla soluzione di al-cune controversie, obbligando la giurisprudenza a confrontarsi congli stessi secondo un approccio casistico, condizionato, tra l’altrodalla mancanza di una disciplina uniforme, attualmente allo studiodella Conferenza di diritto internazionale privato dell’Aja (27), nonsia piu opportuno ripensare agli stessi in maniera globale, ovvero
1006 SCIOGLIMENTO DELLE UNIONI DI FATTO
(24) Sul punto si veda in generale LUZZATTO, Stati giuridici e diritti assoluti neldiritto internazionale privato, Milano, 1965, p. 145 ss.
(25) Cfr. in tal senso LUZZATTO, Art. 6, in Commentario, cit., p. 41 ss. Taleorientamento non e tuttavia generalmente condiviso; per la considerazione dell’art.6 come norma meramente giurisdizionale CONETTI, Art. 6, in CONETTI, TONOLO, VI-
SMARA, Commento, cit., p. 19; ed inoltre per la considerazione della norma in esamecome espressamente rivolta alle questioni pregiudiziali di merito di cui all’art. 34 cod.proc. civ. CONSOLO, Art. 6, in Legge 31 maggio 1995, n. 218, cit., p. 937 ss.
(26) Si veda tuttavia in tal senso ROSSOLILLO, Registered partnerships, cit.,p. 381 ss.
(27) Aspects de droit international prive de la cohabitation hors mariage et despartenariats enregistres, Note etablie par le Bureau Permanent, Conference de La Hayede droit international prive, doc. prel. n. 9, maggio 2000.
© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore
Giuffre
’ Edit
ore
a partire dalla qualificazione per trarne poi le conseguenze di dirittointernazionale privato.
4. La decisione di intraprendere una convivenza configurauna relazione che influisce sullo status dei soggetti che la pongonoin essere, indipendentemente dalle condizioni sessuali, religiose, so-ciali, ecc., in cui essi si vengano a trovare, dal momento che, comenoto, lo statuto personale riguarda lo « stato delle persone », ovveronon solo lo stato civile, ma anche le relazioni familiari degli indivi-dui (28).
Nell’ordinamento italiano, la classificazione giurisprudenzialedel diritto di costituire una famiglia, anche di fatto, nell’ambitodei diritti inviolabili dell’uomo, garantiti dall’art. 2 Cost., in quantoesplicazione della personalita individuale (29), non puo non ricon-durre la regolamentazione internazionalprivatistica dei presuppostidegli accordi di convivenza alla disciplina dei diritti della persona-lita.
Relativamente all’attuazione del diritto a porre in essere leunioni di fatto, spesso formalizzate tramite gli accordi di convivenza,si pongono pero alcune difficolta, in ragione della riconducibilita de-gli strumenti attraverso i quali tali diritto si esplica all’ampia catego-ria dell’autonomia negoziale.
Vi e, allora, il rischio che si faccia riferimento ad una genericaqualificazione contrattuale di tali accordi, come sostenuto dalla giu-risprudenza di altri paesi (30), seppure anteriormente all’entrata in vi-gore della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge ap-plicabile alle obbligazioni contrattuali (31), con il conseguente risul-tato di giungere all’applicazione dei criteri di collegamento previstiin materia contrattuale. Nell’ordinamento italiano, questa conse-guenza sarebbe teoricamente possibile, a seguito del richiamo ope-
1007E DEGLI ACCORDI DI CONVIVENZA
(28) Cfr. nello stesso senso GAUDEMET-TALLON, La desunion du couple en droitinternational prive, in Recueil des cours, 1991-I, p. 9 ss., p. 166.
(29) Per tale classificazione, seguita dalla giurisprudenza italiana, si veda App.Milano, 16 novembre 1993, in Foro it., 1994, 3212 ss.; Cass., 28 marzo 1994, in Giur.it., 1995, p. 1366 ss.; App. Milano, 4 dicembre 1995, in Famiglia e dir., 1996, p. 247;Trib. Milano, 23 gennaio 1997, ivi, 1997, p. 560 ss.; Trib. minorenni Perugia, 16 gen-naio 1998, ivi, 1998, p. 376; Trib. Palermo, 3 settembre 1999, ivi, 2000, p. 284 ss.
(30) Si veda ad es., in Austria, Oberster Gerichtshof, 18 dicembre 1982, in Fa-milienrechtZeitung, 1982, p. 1010 ss., relativo a un accordo di convivenza conclusotra un’austriaca e un polacco in Germania, in ordine al quale si e ritenuto applicabileil criterio del luogo di conclusione dell’accordo.
(31) Convenzione resa esecutiva in Italia con l. 18 dicembre 1984 n. 975, G.U.30 giugno 1985 n. 25 suppl.
© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore
Giuffre
’ Edit
ore
rato a tale Convenzione dall’art. 57 l. 218/95 « in ogni caso », e dun-que al di la dei limiti materiali che circoscrivono il suo ambito di ap-plicazione (32).
Tale soluzione non pare tuttavia concretamente realizzabile pervari motivi. Innanzitutto occorre osservare che la disciplina contrat-tuale, per quanto fondata sul rilievo attribuito alla volonta delle partinegli accordi di convivenza (33), non corrisponde pienamente alle fi-nalita dell’istituto, per le differenze evidenti tra l’intenzione di rego-lare una relazione economica e quella di instaurare una vita comune,cui corrispondono peraltro le difficolta di applicare le nozioni utiliz-zate in materia contrattuale agli accordi di convivenza (34). Tra esse,rileva in maniera particolare la dubbia operativita della scelta dilegge che, secondo quanto prevede l’art. 3 della Convenzione diRoma del 1980 potrebbe teoricamente comportare un frazionamentoo una modifica della regolamentazione degli accordi di convivenza,in maniera evidentemente contraria alla natura unitaria dell’istitutoin esame; anche l’individuazione del criterio del collegamento piustretto, richiamato in via sussidiaria dall’art. 4, non pare poi privadi problemi, in considerazione della difficolta di determinare tra icontraenti del patto il debitore della prestazione caratteristica (35).
Un aspetto connesso all’applicabilita della Convenzione diRoma del 1980 in materia di unioni di fatto e accordi di convivenzariguarda la possibile qualificazione societaria di tali istituti, suggeritadalla dottrina svizzera con riguardo proprio al fatto che tale qualifi-cazione determinerebbe il richiamo della disciplina convenzionale,secondo quanto prevede l’art. 150 della legge svizzera di diritto in-ternazionale privato del 18 dicembre 1987 (36) in ordine alle societa
1008 SCIOGLIMENTO DELLE UNIONI DI FATTO
(32) Sugli effetti del richiamo « in ogni caso » alla Convenzione di Roma daparte dell’art. 57 si veda in generale TREVES, Art. 57, in Commentario, cit., p. 272ss.; BENEDETTELLI, Art. 57, in Legge 31 maggio 1995, n. 218, cit., p. 1360 ss.; TONOLO,Art. 57, in CONETTI, TONOLO, VISMARA, Commento, cit., p. 289 ss.
(33) Si veda in generale sul punto: GAUTIER, Les couples internationaux de con-cubins, in Revue critique de droit int. prive, 1991, p. 525 ss., in particolare p. 534;GANNAGE, La penetration de l’autonomie de la volonte dans le droit international privede la famille, ivi, 1992, p. 425 ss.
(34) BUCHER, La famille en droit international prive, in Recueil des cours, vol.283, 2000, p. 9 ss., soprattutto p. 119.
(35) Su tali criteri di collegamento, si veda in generale: MAGAGNI, La presta-zione caratteristica nella Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, Milano, 1989; BA-
RATTA, Il collegamento piu stretto nel diritto internazionale privato dei contratti, Mi-lano, 1991. E, sulle difficolta di determinarli con particolare riguardo alla materiain esame, ROSSOLILLO, Registered partnerships, cit., p. 386 ss.
(36) Cfr. sul punto PATOCCHI, GEISINGER, Code de droit international privesuisse annote, Lausanne, 1995, p. 383 e ss.
© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore
Giuffre
’ Edit
ore
semplici che non si siano dotate di un’organizzazione (37). Si trattatuttavia di una classificazione legata alla peculiarita del sistema giu-ridico entro cui e stata elaborata, e difficilmente accoglibile, inquanto fondata su considerazioni poco rispondenti alle finalita degliistituti in esame.
Ancor piu problematica appare inoltre l’elaborazione di talequalificazione nell’ordinamento italiano, con la conseguenza di doverfare riferimento all’art. 25 l. 218/95 (38), oppure di suggerire unamodifica normativa della legge 218/95 allo scopo di introdurreuna norma ad hoc, che consideri unioni di fatto ed accordi di con-vivenza come « enti sui generis », ma consenta al contempo di supe-rare le difficolta testuali dell’art. 25, e soprattutto dei riferimenti inesso contenuti a nozioni quali la sede dell’amministrazione o l’og-getto principale delle « societa, associazioni, fondazioni ed ogni altroente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa » (39).
5. Il riconoscimento che l’ordinamento italiano puo attribuirealle unioni di fatto, nel quadro di istituti giuridici che spettera alParlamento definire, si fonda, come si e detto, sul presupposto delle« formazioni sociali » di cui all’art. 2 della Costituzione e sulla vo-lonta degli individui che le pongono in essere.
La qualificazione di queste fattispecie da parte del giudice ita-liano e attualmente molto dibattuta.
Sulla base della qualificazione c.d. familiare di unioni di fatto eaccordi di convivenza, configurabile in considerazione dell’oggettodelle medesime, potrebbero essere richiamati i criteri di collega-mento disposti dal capo IV della l. 218/95 per i rapporti di fami-glia (40), benche esso sia espressamente disposto, secondo le rigide
1009E DEGLI ACCORDI DI CONVIVENZA
(37) KREN KOSTKHEWICZ, Registrierte Partnerschaften gleichgeschechtlicher Per-sonen aus der Sicht des IPR (de lege lata), in Schweizerische Zeitschrift fur int. und eu-ropaisches Recht, 2001, p. 104 ss. In Svizzera e in preparazione una legge relativa alleunioni tra persone dello stesso sesso, a seguito dell’impulso lanciato dalla consulta-zione promossa dall’Ufficio federale della giustizia nel 1999, La situation juridiquedes couples homosexuels en droit suisse. Problemes et propositions de solution, sucui si veda SIEHR, Das Internationale Privatrecht der Schweiz, Zurich, 2001, p. 67 ss.
(38) Sull’art. 25 l. 218/95, si veda in generale SANTA MARIA, Art. 25, in Com-mentario, cit., p. 133 ss.; BENEDETTELLI, Art. 25, in Legge 31 maggio 1995, n. 218,cit., p. 1108 ss.; TONOLO, Art. 25, in CONETTI, TONOLO, VISMARA, Commento, cit.,p. 103 ss.
(39) Si veda tuttavia in tal senso ROSSOLILLO, Registered partnerships, cit.,p. 390.
(40) Per la posizione del medesimo problema entro diversi sistemi di conflitto,ove tuttavia le disposizioni concernenti i rapporti personali tra coniugi e la separa-zione e lo scioglimento del matrimonio non differiscono in maniera rilevante (ad
© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore
Giuffre
’ Edit
ore
concezioni dell’ordinamento italiano, per individuare la disciplina diconflitto della famiglia fondata sul matrimonio tra persone di sessodifferente (art. 29 Cost.; art. 107, 1o comma, e art. 108, 1o comma,cod. civ.). L’applicazione delle norme di conflitto, previste in temadi famiglia legittima e matrimonio, si estenderebbe agli accordi diconvivenza ed ai partenariati qualora si ritenesse attuabile il proce-dimento dell’adattamento, cui si ricorre, in linea generale, quandodevono essere richiamate nella lex fori norme ispirate a concezionigiuridiche differenti (41). L’adattamento potrebbe pertanto valeread ampliare le nozioni utilizzate dal capo IV della l. 218/95, qualead es. quella di coniuge (idonea a racchiudere in se anche quelladi partner), oppure quella di vita matrimoniale (ampliabile indubbia-mente alla vita familiare). Secondo questa prospettiva, lo sciogli-mento delle unioni di fatto potrebbe pertanto ricondursi all’art. 31in tema di separazione personale e scioglimento del matrimonio (42)o all’art. 29 in materia di rapporti personali tra coniugi (43). La qua-lificazione familiare di unioni di fatto e accordi di convivenza sugge-rirebbe infatti il richiamo della norma che regola la separazione per-sonale e lo scioglimento del matrimonio in ordine alla dissoluzionedi tali fattispecie. Tuttavia una fondamentale distinzione tra lo scio-glimento del matrimonio e la dissoluzione di unioni di fatto e ac-cordi di convivenza induce a far riferimento alla disciplina dell’art.29 per individuare la legge applicabile a questi ultimi. Mentre loscioglimento del matrimonio richiede l’intervento di un’autorita giu-risdizionale e dunque giustifica una norma di conflitto ad hoc, la dis-soluzione delle unioni di fatto e degli accordi di convivenza e gene-ralmente un atto volontario, relativamente al quale l’intervento diun’autorita giurisdizionale, ove previsto (come ad es. dall’art. 515-7 del Code civil in merito ai PACS), ha un valore meramente di pub-blicita. Pertanto qualora dovesse essere accolta la qualificazione fa-miliare delle unioni di fatto parrebbe piu opportuno ricondurre ladisciplina internazionalprivatistica dello scioglimento di esse alla
1010 SCIOGLIMENTO DELLE UNIONI DI FATTO
es.: articoli 48 e 61 della l. svizzera di diritto internazionale privato; articoli 14 e 17EGBGB), si veda GAUDEMET-TALLON, La desunion du couple, cit., p. 172 ss.
(41) Sul punto si veda in generale LEWALD, Regles generales des conflits de lois,in Recuil des cours, 1939-IV, p. 36 ss.
(42) Sull’art. 31 v. in generale CLERICI, Art. 31, in Commentario, cit., p. 167 ss.;CONETTI, Art. 31, in Legge 31 maggio 1995, n. 218, cit., p. 1179 ss.; ID., Art. 31, inCONETTI, TONOLO, VISMARA, Commento, cit., p. 136 ss.
(43) Sull’art. 29 v. in generale CLERICI, Art. 29, in Commentario, cit., p. 151 ss.;CONETTI, Art. 29, in Legge 31 maggio 1995, n. 218, cit., p. 1172 ss.; ID., Art. 29, inCONETTI, TONOLO, VISMARA, Commento, cit., p. 130 ss.
© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore
Giuffre
’ Edit
ore
norma dettata in tema di rapporti personali, individuando cosı, qualicriteri di collegamento applicabili, ove possibile (44), la cittadinanzacomune dei conviventi o la localizzazione della vita familiare.
La rilevanza della volontarieta dell’atto costitutivo delle unionidi fatto puo tuttavia giustificare una diversa qualificazione delle me-desime, quali relazioni derivanti da una scelta volontaria che ha adoggetto non solo i contenuti di tali relazioni ma anche la disciplinadi conflitto. Sulla base di tale qualificazione autonoma, la regola-mentazione internazionalprivatistica si definisce dunque, quanto aipresupposti di queste relazioni destinate ad incidere sullo statusdei soggetti che le pongono in essere, nell’ambito dei diritti dellapersonalita e dunque richiamando la legge nazionale dei partners(art. 24 l. 218/95), quanto invece al loro svolgimento e dunque an-che al loro scioglimento, tramite l’electio iuris. Poiche le unioni difatto si determinano a seguito dell’esercizio della volonta dei soggettiche le scelgono in alternativa al matrimonio, si e da tempo sottoli-neata l’opportunita di estendere la valenza di tale volonta anche aldiritto internazionale privato (45). Pertanto, anche relativamente alloscioglimento di accordi di convivenza ed unioni di fatto l’eventualeelectio iuris operata dai conviventi, nell’ambito degli accordi stessi,dovra avere un ruolo determinante, pur dovendo ritenersi circo-scritta agli ordinamenti competenti a disciplinare un istituto aventeconseguenze rilevanti in tema di statuto personale dei soggetti coin-volti, in quanto collegati alla fattispecie dalla cittadinanza, ovverodal domicilio o dalla residenza dei partners. Tale soluzione, eviden-temente fondata sulla qualificazione delle unioni di fatto come ine-renti allo statuto personale dei soggetti, offre, da un lato, il vantag-gio di realizzare una regolamentazione di conflitto uniforme in unamateria variamente disciplinata dai singoli ordinamenti (46) e, dall’al-
1011E DEGLI ACCORDI DI CONVIVENZA
(44) Non sempre, infatti, il procedimento dell’adattamento appare di facile at-tuazione, ai fini dell’applicabilita delle norme del capo IV della l. 218/95 agli accordidi convivenza, soprattutto nelle ipotesi in cui vengano coinvolti, in relazione agli stessisoggetti, istituti differenti, come ad es. qualora uno dei partners di un’unione regi-strata all’estero decida di sposarsi in Italia con un’altra persona. Nella valutazionedelle condizioni necessarie per la celebrazione del matrimonio, l’interprete dovrebbeavvicinare il partenariato al matrimonio, tramite il procedimento di adattamento, econsiderare dunque la dissoluzione del primo secondo la legge del luogo in cui e statoposto in essere quale condizione necessaria per la celebrazione del secondo.
(45) GAUDEMET-TALLON, La desunion du couple, cit., p. 173.(46) Per la considerazione dell’electio iuris quale collegamento idoneo a creare
una disciplina di conflitto uniforme, si veda il Libro verde della Commissione europeasulla giurisdizione e la legge applicabile in materia di divorzio (Bruxelles, 14 marzo2005, COM (2005) 82 def.).
© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore
Giuffre
’ Edit
ore
tro, quello di differenziare tali fattispecie rispetto ai rapporti di fa-miglia, la cui disciplina di conflitto nell’ordinamento italiano e peral-tro sottratta alla libera disponibilita delle parti, se non per la limitatarilevanza dell’autonomia della volonta in tema di rapporti patrimo-niali tra coniugi.
In assenza di electio iuris che indichi la regolamentazione con-cernente lo scioglimento delle unioni di fatto, la qualificazione dellemedesime entro l’ambito dei diritti della personalita consente di fareriferimento alla legge nazionale dei soggetti che le pongono in es-sere, secondo quanto prevede in materia l’art. 24 l. 218/95. Cio de-terminera poi la necessita di superare i problemi connessi all’opera-tivita del collegamento della cittadinanza, in presenza di diverse cit-tadinanze dei partners. Infatti la previsione alternativa della legge in-dividuata dalle differenti cittadinanze dei conviventi condurrebbe arisultati complessi, soprattutto in ragione del fatto che si tratta di re-golare una fattispecie in cui due soggetti sono uniti da una relazioneunitaria. In maniera analoga, l’applicazione cumulativa delle leggidei partners determinerebbe il rischio di una disciplina troppo rigo-rosa, con effetti negativi anche in caso di dissoluzione. C’e poi dachiedersi se nel caso in cui i conviventi abbiano diverse cittadinanzedelle quali una comune, ipotesi non espressamente regolata dallanorma in esame, si debba fare riferimento all’art. 19, 2o comma,della l. 218/95 (47), che regola in generale le situazioni concernentile persone con piu cittadinanze. Pare tuttavia poco opportuno il ri-chiamo di questa disposizione, dal momento che la stessa non risultapienamente soddisfacente; stabilendo che « se la persona ha piu cit-tadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenzacon il quale essa ha il collegamento piu stretto », e che « se tra lecittadinanze vi e quella italiana, questa prevale », la norma in esamegiungerebbe a sottoporre lo scioglimento della convivenza o diunioni di fatto, di individui italiani che abbiano anche un’altra citta-dinanza comune, alla legge italiana (48). Non sempre, tuttavia, talesoluzione risulta corrispondente alla cittadinanza effettiva (49), edinoltre essa pare porsi in contrasto con il principio di non discrimi-
1012 SCIOGLIMENTO DELLE UNIONI DI FATTO
(47) Sull’art. 19 si veda in generale: CLERICI, Art. 19, in Commentario, cit.,pp. 95-105; BAREL, Art. 19, in Legge 31 maggio 1995, n. 218, cit., pp. 1075-1085; CO-
NETTI, Art. 19, in CONETTI, TONOLO, VISMARA, Commento, cit., pp. 59-62.(48) CLERICI, Art. 31, cit., p. 170; CONETTI, Art. 31, in CONETTI, TONOLO, VI-
SMARA, cit., p. 136.(49) Per le origini di tale concetto, nel diritto internazionale, cfr. la sentenza
pronunciata dalla Corte internazionale di giustizia nel noto caso Nottebohm, inI.C.J. Reports, 1955, p. 4 ss.
© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore
Giuffre
’ Edit
ore
nazione in base alla nazionalita, sancito dall’art. 12 del Trattato CE erecentemente richiamato dalla Corte di giustizia delle Comunita eu-ropee al fine di consentire la derogabilita delle norme di conflittonazionali (50).
6. La disciplina di conflitto relativa allo scioglimento diunioni di fatto e accordi di convivenza e completata dalla previsionegenerale in tema di rinvio, di cui all’art. 13, che pone la possibilita dideterminare la legge applicabile non solo in base ai collegamenti in-dicati dal sistema italiano di diritto internazionale privato, ma anchedai criteri contenuti nelle norme di conflitto dell’ordinamento richia-mato.
Diversa e tuttavia l’operabilita di tale procedimento con ri-guardo ai criteri di collegamento applicabili in tema di scioglimentodi unioni di fatto e accordi di convivenza, dal momento che l’art. 13l. 218/95 stabilisce limiti e condizioni al funzionamento del rinvio.
L’art. 13, 2o comma, lett. a), della l. 218/95, dispone innanzi-tutto che l’operativita del rinvio e esclusa « nei casi in cui le dispo-sizioni della presente legge rendono applicabile la legge stranierasulla base della scelta effettuata in tal senso dalle parti interessate ».Dunque e evidente che il rinvio non potra operare qualora i convi-venti abbiano individuato volontariamente la disciplina applicabileallo scioglimento della loro unione. La scelta di legge svolge infattiun ruolo assorbente e primario quanto alla definizione spaziale dellafattispecie, e dunque non potrebbe essere derogata per effetto dellapresenza di un diverso criterio entro il sistema giuridico richiamato.E solo tramite l’espressa negazione del rinvio che si riesce ad assicu-rare alle parti l’effettivita della loro scelta (51).
1013E DEGLI ACCORDI DI CONVIVENZA
(50) Corte di giustizia, 2 ottobre 2003, causa C-148/02, Garcıa Avello c. Statobelga, in Riv. dir. int. priv. proc., 2003, pp. 1088-1095. Nel caso, la Corte ha affermatoinfatti che il principio di non discriminazione si pone in contrasto con l’applicazionedella disciplina di conflitto belga che faceva prevalere la cittadinanza belga, nel casorilevante nell’individuazione della disciplina del diritto al nome, impedendo cosı aifigli di una coppia belga-spagnola di poter essere registrati con il doppio cognomecome avrebbe consentito la sottoposizione del diritto al nome alla legge spagnola, in-dividuata sulla base di una delle cittadinanze di cui erano titolari.
(51) Nell’ordinamento italiano sono diverse le disposizioni in relazione allequali il rinvio non puo operare per la previsione dell’electio iuris. Anche in altri si-stemi di diritto internazionale privato, il rinvio e escluso nelle materie sottoposte al-l’autonomia delle parti: si veda ad esempio l’art. 4, 2o comma, dell’EGBGB e l’art. 11della legge federale austriaca. Si veda sul punto VON OVERBECK, Les questions genera-les du droit international prive a la lumiere des codifications et projets recents, in Re-cueil des cours, vol. 176, 1982-III, p. 9 ss., p. 146 ss.; DROZ, Regards sur le droit inter-national prive compare, in Recueil des cours, vol. 229, 1991-IV, p. 9 ss., p. 316 ss.
© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore
Giuffre
’ Edit
ore
Quanto alla nazionalita comune dei conviventi, operante, in as-senza di electio iuris, seguendo la qualificazione delle unioni di fattoin termini di fattispecie rilevanti ai fini dello status personale, e qualecriterio principale secondo la qualificazione familiare delle stesse,non vi e alcun dubbio che il rinvio possa applicarsi, con la conse-guenza che se il sistema di conflitto dell’ordinamento cosı richiamatoattribuisce la competenza a regolare la materia alla legge dello Statodi residenza abituale o di domicilio comune dei conviventi, potrarendersi necessario far riferimento o alla legge italiana (rinvio indie-tro) o alla legge di un terzo paese (rinvio oltre), a seconda della lo-calizzazione di tali collegamenti (52).
Relativamente alla prevalente localizzazione della vita matrimo-niale, applicabile, come si e detto, solo a seguito della qualificazionefamiliare di tali fattispecie, non e invece sicuro che il rinvio possaoperare per varie considerazioni: l’art. 13 della l. 218/95, pur preve-dendo dei casi in cui il rinvio e escluso, non ne sancisce la tassativitae dunque non esclude che il rinvio possa essere ritenuto inoperanteanche in altre ipotesi non specificamente previste (53). Tale ragiona-mento puo riguardare anche la prevalente localizzazione della vitafamiliare in un determinato Stato, relativamente alla quale si e, in-fatti, avanzata la tesi che il rinvio funzioni in ordine a ciascuna dellecircostanze rilevanti per l’individuazione della stessa, analogamenteal modo in cui i vari elementi di collegamento spaziale e personaledella vita familiare accrescono le finalita di coordinamento perse-guite dal rinvio (54). Si tratta tuttavia di un orientamento di difficileapplicazione, in ragione della determinazione specifica e diretta delladisciplina operante nel caso (55). Sarebbe infatti contrario alla ratio
1014 SCIOGLIMENTO DELLE UNIONI DI FATTO
(52) Cfr. sul punto PICONE, Modalita di designazione della legge applicabile neldiritto internazionale privato della famiglia, in Studi di diritto internazionale privato,Napoli, 2003, p. 681.
(53) MUNARI, Art. 13, in Legge 31 maggio 1995, n. 218, cit., p. 1018 ss.,p. 1028 ss.; VIARENGO, Autonomia della volonta e rapporti patrimoniali tra coniuginel diritto internazionale privato, Padova, 1996, p. 254; PICONE, La riforma italianadel diritto internazionale privato, Padova, 1998, p. 126.
(54) Cfr. in tal senso BARATTA, Scioglimento e invalidita del matrimonio nel di-ritto internazionale privato, Milano, 2004, p. 13 ss.; VIARENGO, Autonomia della vo-lonta, cit., pp. 254-256. Quest’ultima, pur ritenendo non tassative le esclusioni delrinvio di cui all’art. 13 l. 218/95, ritiene possibile dedurre dalla ratio del rinvio, intesacome volonta di non rendere applicabile un ordinamento che non si reputi compe-tente in base alle proprie norme, l’ammissibilita del rinvio qualora l’ordinamento ri-tenuto dal giudice come quello maggiormente connesso alla fattispecie non accetti lapropria applicabilita e rinvii ad altro che la ammetta.
(55) Cfr. in tal senso: BOSCHIERO, Appunti sulla riforma del sistema italiano didiritto internazionale privato, Torino, 1996, p. 195; CONETTI, Art. 29, in Legge 31
© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore
Giuffre
’ Edit
ore
della norma rivolta a richiamare l’ordinamento in cui si considera lo-calizzata la vita matrimoniale, in base agli indizi del caso di specie,accettare il rinvio, e quindi vanificare l’esigenza di localizzazioneperseguita dall’art. 29.
7. Tramite i criteri di collegamento individuati all’esito dellaqualificazione degli accordi di convivenza appena esaminati, si deter-minano le disposizioni, in base alle quali si puo compiere la defini-tiva valutazione della dissoluzione di unioni di fatto e accordi diconvivenza.
Tali norme devono essere applicate seguendo i principi propridell’ordinamento cui esse appartengono, secondo le indicazioni del-l’art. 15 della legge italiana di diritto internazionale privato (56). Inquesto modo si rispetta, infatti, la funzione di coordinamento coni valori giuridici esterni all’ordinamento del foro che il legislatore ge-neralmente assegna alle norme di diritto internazionale privato, rite-nendo che se il diritto straniero e considerato competente a regolareuna fattispecie, allora esso deve essere applicato nel suo complesso,indipendentemente dal fatto che contenga qualificazioni differentida quelle della lex fori.
La diversa classificazione delle questioni concernenti lo sciogli-mento di unioni di fatto e accordi di convivenza nell’ambito dell’or-dinamento straniero chiamato a disciplinarli rileva sia al fine dell’in-dividuazione delle disposizioni materiali applicabili, sia per il funzio-namento delle norme di diritto internazionale privato. Se la primaconseguenza di tale seconda qualificazione (determinazione della di-sciplina materiale degli accordi di convivenza) non pone particolaridifficolta all’interprete, piu complessa pare invece la seconda conse-guenza, ovvero, in caso di operativita del rinvio, l’incidenza dellaqualificazione straniera sul funzionamento delle norme di diritto in-ternazionale privato dell’ordinamento in cui essa viene effettuata.
Significativo e, a tale riguardo, l’orientamento della giurispru-denza francese, secondo la quale, nell’impossibilita di tratteggiareuna disciplina unitaria della materia delle unioni di fatto, e preferi-bile sottoporre tali fattispecie alle norme previste per la situazionecui si ricollegano in relazione alle circostanze del singolo caso di spe-
1015E DEGLI ACCORDI DI CONVIVENZA
maggio 1995, n. 218, cit., p. 1175; DISTEFANO, Il matrimonio nel nuovo diritto inter-nazionale privato italiano, in Riv. dir. int. priv. proc., 2001, p. 328.
(56) Sull’art. 15 si veda in generale CARBONE, Art. 15, in Commentario, cit.,p. 72 ss.; BOSCHIERO, Art. 15, in Legge 31 maggio 1995, n. 218, cit., p. 1043 ss.; CO-
NETTI, Art. 15, in CONETTI, TONOLO, VISMARA, Commento, cit., p. 49 ss.
© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore
Giuffre
’ Edit
ore
cie: ad es. norme in tema di responsabilita non contrattuale per l’in-terruzione della convivenza, disposizioni contrattuali per la disci-plina degli interessi comuni (57).
Si pensi ad es. al caso in cui due cittadini della Florida, convi-venti in Italia, concludano, nel loro paese d’origine, un accordo diconvivenza in cui si prevede che in caso di cessazione del rapportol’uomo versera alla donna la somma di $ 1000 al mese, in conside-razione della diversa capacita economica dei conviventi. Alla cessa-zione del rapporto, la donna si rivolge ai giudici italiani per vederattuata la propria pretesa, in base al titolo di giurisdizione del domi-cilio del convenuto (art. 3, 1o comma, della l. 218/95). Qualora ilgiudice italiano, qualificando l’accordo in questione come inerenteallo status dei partners faccia riferimento, in assenza di electio iuris,alla legge nazionale comune, verra in rilievo la qualificazione seguitanello Stato della Florida per gli accordi di convivenza. In assenza diuno statute specificamente previsto per questi nuptial-like agree-ments (58), si e infatti prevista l’estensione analogica della disciplinaprevista dagli statutes of frauds per gli accordi pre-nuziali (59).
Una soluzione di tale conflitto di qualificazioni puo tuttavia es-sere trovata nel rinvio di qualificazione, ovvero nel procedimento dicoordinamento tra differenti sistemi di conflitto, che, in applicazionedelle norme degli articoli 13 e 15 della l. 218/95, pone la possibilitache la legge applicabile venga determinata, in base alle qualificazionicontenute nell’ordinamento richiamato dalle norme di conflitto dellalex fori, ove si verifichi la compatibilita delle prime con i valori fon-damentali propri della seconda (60). Per quanto attiene all’obbligo dimantenimento della convivente, nel caso di specie, potra allora de-terminarsi un rinvio di qualificazione alla lex fori, in base alla tradi-zionale qualificazione processuale degli statutes of frauds.
Un’altra ipotesi di contrasto tra le qualificazioni concernenti gliaccordi di convivenza puo accadere nel caso in cui una cittadinafrancese, convivente con un cittadino italiano, si rivolga al giudice
1016 SCIOGLIMENTO DELLE UNIONI DI FATTO
(57) Si veda in tal senso Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre1983, in Revue critique de droit int. prive, 1984, p. 628 ss., con nota di LAGARDE.
(58) GORDON, The Necessity and Enforcement of Cohabitation Agreements:when Strings Will Attach and how to Prevent Them — a State Survey, in BrandeisLaw Journal, 1998-1999, p. 256.
(59) Per un’ampia analisi dell’evoluzione relativa alla qualificazione degli statu-tes of frauds nei paesi di civil law e di common law, si veda DONATH, Die Statutes ofFrauds der US-amerikanischen Bundestaaten aus der Perspektive des deutschen Kolli-sionsrechts, in IPRax, 1994, pp. 333-340.
(60) Si veda sul punto TONOLO, Il rinvio di qualificazione nei conflitti di leggi,Milano, 2003.
© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore
Giuffre
’ Edit
ore
italiano per ottenere un assegno alimentare in seguito all’interru-zione della convivenza avvenuta in Italia. Le indicazioni tratte dallalegge italiana di diritto internazionale privato in tema di alimenti po-trebbero far ritenere che la legge applicabile alla controversia sia in-dividuabile in base alla disciplina prevista per tale materia dal si-stema di conflitto italiano (art. 45), che richiama « in ogni caso » (61)la Convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabilealle obbligazioni alimentari (62). Il riferimento alla legge della resi-denza abituale del creditore di alimenti (art. 4 della Convenzionedell’Aja), nel corso della prima qualificazione da parte del giudiceitaliano, determinera il rilievo della qualificazione seguita nell’ordi-namento francese, ove e localizzata la residenza dell’attrice. Secondotale sistema giuridico potrebbe rilevare la qualificazione in base allaquale l’interruzione dei rapporti di convivenza viene ricompresanella materia della responsabilita non contrattuale (63), rimettendocosı in discussione la competenza della legge richiamata dai criteriitaliani.
Nel caso in esame, infatti, il conflitto di qualificazioni si risolve-rebbe seguendo il rinvio operato dalla qualificazione francese. Tuttaviail trasferimento di competenza alla legge del luogo in cui e avvenuta talerottura non puo effettivamente realizzarsi, consentendo cosı di supe-rare il conflitto di qualificazioni e di raggiungere una soluzione uni-forme a quella che seguirebbero i giudici francesi qualora la controver-sia venisse sottoposta al loro esame, dal momento che la Convenzionedell’Aja del 1973 esclude il rinvio, riferendosi esclusivamente all’appli-cazione della legge interna del creditore di alimenti (art. 4).
8. Nella definizione della disciplina applicabile a unioni difatto e accordi di convivenza, la qualificazione degli stessi come isti-tuti ignoti all’ordinamento italiano puo porre la necessita di confron-tarsi con alcuni problemi di ordine pubblico.
A tale riguardo e evidente che, relativamente a questa condi-zione, sorgono vari problemi in tema di accordi di convivenza e diunioni di fatto, perche gli istituti ora in esame sono privi di disciplina,ma non del tutto privi di effetti nell’ordinamento italiano. La compa-
1017E DEGLI ACCORDI DI CONVIVENZA
(61) Sul richiamo « in ogni caso » operato dall’art. 45 alla Convenzione dell’Ajadel 1973, si veda in generale: HONORATI, Art. 45, in Commentario, cit., p. 223 ss.; BA-
RUFFI, Art. 45, in Legge 31 maggio 1995, n. 218, cit., p. 1273 ss.; TONOLO, Art. 45, inCONETTI, TONOLO, VISMARA, Commento, cit., p. 194 ss.
(62) Convenzione resa esecutiva in Italia con l. 24 ottobre 1980 n. 745, G.U.12 novembre 1980 n. 310 suppl.
(63) Si veda sul punto FULCHIRON, Reflexions sur les unions, cit., p. 903 ss.
© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore
Giuffre
’ Edit
ore
tibilita con l’ordinamento italiano andra allora accertata in relazionealle soluzioni elaborate dalla giurisprudenza in ordine alla regolamen-tazione degli aspetti in questione (diritto di proprieta e obbligo dimantenimento) (64).
Nell’indagine diretta a verificare la compatibilita di istituti sco-nosciuti con la lex fori, potra pertanto assumere rilievo l’ordine pub-blico, limite generale all’applicazione del diritto straniero, richiamatodalle norme di conflitto, qui considerato come strumento idoneo asuperare le difficolta derivanti dall’introduzione, nell’ordinamentodel foro, di tali istituti.
Nell’ordinamento italiano, occorrera considerare l’art. 16 della l.218/95, secondo cui l’applicabilita della legge straniera e esclusaqualora i suoi effetti siano contrari all’ordine pubblico (65). Il riferi-mento del limite in esame all’esclusione di effetti inaccettabili, deri-vanti dall’operativita di norme straniere, consente di ampliarne, invia ermeneutica, la portata fino ad incidere non tanto sul richiamodell’ordinamento straniero nel suo astratto contenuto generale,quanto sulle conseguenze che le disposizioni individuate all’internodi esso producono nel caso concreto. La conseguenza dell’accertatocontrasto con l’ordine pubblico degli effetti dell’applicazione dellalegge straniera risulta pertanto la completa disapplicazione di que-st’ultima, non essendo proponibili interpretazioni rivolte all’adatta-mento o alla depurazione (66) del diritto straniero, in base agli as-
1018 SCIOGLIMENTO DELLE UNIONI DI FATTO
(64) Si veda sul punto App. Milano, 16 novembre 1993, cit.; Cass., 28 marzo1994, cit.; App. Milano, 4 dicembre 1995, cit.; Trib. Milano, 23 gennaio 1997, cit.;Trib. minorenni Perugia, 16 gennaio 1998, cit.; Trib. Palermo, 3 settembre 1999, cit.
(65) Sull’art. 16, si veda, in generale, BOSCHIERO, Art. 16, in Legge 31 maggio1995, n. 218, cit., p. 1046 ss.; MOSCONI, Art. 16, in Commentario del nuovo dirittointernazionale privato, cit., p. 78 ss; CARBONE, IVALDI, Lezioni di diritto internazionaleprivato, Padova, 2000, p. 47 ss.; CONETTI, Art. 16, in CONETTI, TONOLO, VISMARA,Commento, cit., p. 50 ss.
(66) Tali interpretazioni vengono proposte dalla dottrina tedesca che si e occu-pata di giustificare la prassi — non solo tedesca — diretta ad applicare l’ordine pub-blico come strumento di depurazione del diritto straniero, a partire da alcuni casinoti: Reichsgericht, 19 dicembre 1922, in Revue de droit int. prive, 1926, pp. 278-281; Oberlandesgericht Munchen, 2 febbraio 1938, in Giurisprudenza comparata didir. int. priv., vol. VIII, Roma, 1942, pp. 75-76; Oberster Gerichtshof, 25 ottobre1955, in Juristische Blatter, 1956, p. 132, con nota di SCHWIND. Sono considerazionidi carattere generale a sostenere questa soluzione, quale ad esempio la circostanzache l’alternativa ad essa, e cioe l’operativita della lex fori in forza dell’ordine pub-blico, e spesso priva di legami con la questione controversa. In tale contesto apparedunque preferibile la sostituzione del diritto straniero con altre norme appartenentiallo stesso sistema giuridico, che vengono rese applicabili, in forza di un adattamentoalle circostanze del caso, una volte eliminate le regole contrarie all’ordine pubblicodel foro. Si veda in tal senso: LEWALD, Regles generales des conflits de lois, cit.,p. 142 ss.; NUSSBAUM, Deutsches internationales Privatrecht, Tubingen, 1932, p. 69;
© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore
Giuffre
’ Edit
ore
sunti propri del sistema italiano di diritto internazionale privato. Incaso di accertato contrasto con l’ordine pubblico della normativa in-dividuata per regolare lo scioglimento delle unioni di fatto, si effet-tuera dunque dapprima il richiamo di un altro ordinamento che pre-senti una connessione significativa con la fattispecie che presenti ele-menti di estraneita; in mancanza di altri collegamenti, si applichera,a titolo residuale, la lex fori.
Nelle ipotesi di scioglimento di unioni di fatto e di accordi diconvivenza, non e tuttavia sicuro che la valutazione degli effetti deri-vanti dalla disciplina ad essi applicabile possa escludere l’operativitadi quest’ultima, in considerazione del rilievo assunto dai valori di giu-stizia materiale sottesi a tali fattispecie (67). Se infatti puo risultare dif-ficile il riconoscimento di effetti matrimoniali ad unioni costituite al-l’estero (68), in quanto contrastanti con i valori che costituiscono iprincipi generali informatori del foro (69), non pare tuttavia esclusala possibilita di affermare l’idoneita delle stesse a costituire diritti eobblighi, quali ad es. i diritti successori o il diritto agli alimenti.
10. La molteplicita delle questioni derivanti dallo sciogli-mento di unioni di fatto e accordi di convivenza puo determinare
1019E DEGLI ACCORDI DI CONVIVENZA
WOLFF, Das internationale Privatrecht Deutschlands, Berlin, 1954, pp. 70-71; RAAPE,Internationales Privatrecht, cit., pp. 90-101; RAAPE, STURM, Internationales Priva-trecht, Munchen, 1977, p. 215 ss.; DOLLE, Der ordre public im internationalen Priva-trecht, in Beitrage zum burgerlichen Recht, Tubingen, 1950, p. 397 ss., e specialmentepp. 408-409; RABEL, The Conflict of Laws, vol. III, Chicago, 1950, pp. 515-516; VI-
SCHER, General Course on Private International Law, in Recueil des cours, 1992-I,p. 104. Tale metodo non era invece seguito dalla dottrina italiana anteriormente allariforma del diritto internazionale privato, dal momento che nel caso in cui l’applica-zione della legge straniera fosse esclusa per contrasto con l’ordine pubblico la solu-zione preferita consisteva nell’applicazione della lex fori. Si veda sul punto per tuttiMOSCONI, Exceptions to the Operation of Choice of Law Rules, in Recueil des cours,vol. 217, 1989-V, p. 109 ss.; ID., Qualche considerazione sugli effetti dell’eccezionedi ordine pubblico, in Riv. dir. int. priv. proc., 1994, p. 5 ss.
(67) Sull’influenza dei valori di giustizia materiale in ordine alle scelte operatedalle norme di conflitto, si veda in generale BUCHER, L’ordre public et le but social deslois en droit international prive, in Recueil des cours, vol. 239, 1993, p. 26 ss.; MO-
SCONI, Exceptions to the Operation, cit., p. 127.(68) Si veda sul punto la circolare del Ministero degli affari interni del 26
marzo 2001, relativa al regolamento per la revisione e semplificazione dell’ordina-mento dello stato civile, in Riv. dir. int. priv. proc., 2002, p. 283 ss.
(69) E infatti evidente il carattere internazionale del limite contenuto nell’art.16 l. 218/95, senza che occorra cosı qualificarlo. Si veda sul punto: DAVI, Le questionigenerali di diritto internazionale privato nel progetto di riforma, in La riforma del di-ritto internazionale privato e processuale, Raccolta in ricordo di E. Vitta (a cura diGaja), Milano, 1994, p. 132; BOSCHIERO, Appunti, cit., pp. 226-228; ID., Art. 16,cit., p. 1049 ss.; MOSCONI, Art. 16, cit., p. 80 ss.; CARBONE, IVALDI, Lezioni, cit.,p. 51 ss.; CONETTI, Art. 16, p. 51.
© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore
Giuffre
’ Edit
ore
variamente il contenuto delle decisioni ad esse relative; si puo trat-tare infatti di sentenze aventi ad oggetto obblighi pecuniari, alimen-tari, diritti reali su beni immobili, ecc.
Relativamente a tali decisioni, occorrera allora distinguere, aifini del riconoscimento, la disciplina applicabile in base alla tipologiae al contenuto delle stesse, dal momento che il riconoscimento e l’e-secuzione delle sentenze relative alla dissoluzione dei partenariati re-gistrati e degli accordi di convivenza puo avvenire secondo quantoprevedono la legge 218/1995 (articoli 64-67) o le convenzioni inter-nazionali di cui l’Italia e parte. Cio con minori difficolta rispetto alledecisioni concernenti gli effetti personali di unioni di fatto e accordidi convivenza (ad es., quelle in tema di nome dei conviventi), per laresistenza ad accettare nell’ordinamento italiano la qualificazionepersonale o familiare di tali fattispecie, sottesa a questa forma di ri-conoscimento (70).
Ad es., relativamente alle obbligazioni alimentari tra ex convi-venti, viene in rilievo la disciplina contenuta nella Convenzione del-l’Aja del 2 ottobre 1973 sul riconoscimento e l’esecuzione delle de-cisioni relative alle obbligazioni alimentari (71), a condizione che si ri-tenga possibile ricondurre i partenariati alle relations de famille, chedefiniscono l’ambito d’applicazione di tale Convenzione (art. 1).Tale pare essere la conclusione cui perviene l’orientamento favore-vole alla qualificazione autonoma delle nozioni convenzionali, rivoltoa considerare, nel caso, l’evoluzione del concetto di famiglia nel di-ritto comparato. Si e osservato infatti che quest’ultimo comprendesenza dubbio le differenti forme di coabitazione, anche se non deri-vanti dal matrimonio, purche rivolte a costituire una vita comune inmaniera analoga alle altre relazioni familiari (72).
Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in cui si accertala responsabilita non contrattuale o contrattuale di uno dei convi-venti in ordine alla rottura del partenariato o dell’accordo di convi-venza puo invece ritenersi regolato dagli articoli 25 ss. della Conven-zione di Bruxelles del 1968 e ora dagli articoli 32 ss. del regola-mento CE 44/2001.
1020 SCIOGLIMENTO DELLE UNIONI DI FATTO
(70) Sul punto cfr. TONOLO, Profili internazionalprivatistici degli accordi di con-vivenza, in I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale, III, Persone e famiglia (acura di Cendon), p. 1067 ss., p. 1091 ss.
(71) Convenzione resa esecutiva in Italia con l. 24 ottobre 1980 n. 745, G.U.12 novembre 1980 n. 310 suppl.
(72) BUCHER, La famille, cit., p. 120.
© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore
Giuffre
’ Edit
ore
Le decisioni concernenti l’affidamento dei figli a seguito dellarottura della convivenza tra i genitori ricadono invece nella disci-plina generalmente prevista dall’art. 65 l. 218/95 per i « provvedi-menti stranieri relativi alla capacita delle persone nonche all’esi-stenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalita » (73). Lasentenza straniera concernente l’affidamento dei figli minori di unacoppia di conviventi puo dunque essere riconosciuta in Italia qua-lora siano rispettate le condizioni previste dall’art. 65, ovvero qua-lora con riguardo alle circostanze del caso, tali provvedimenti sianostati posti in essere dalle autorita dello Stato la cui legge e richiamatadalle norme della legge italiana di diritto internazionale privato enon siano contrari all’ordine pubblico. Quanto al rispetto del primorequisito, il richiamo della Convenzione dell’Aja del 1961 ad operadell’art. 42 ne rende agevole il rispetto, in ragione della coincidenzatra forum e ius dalla stessa prevista. Relativamente al limite dell’or-dine pubblico, pare possibile affermare, seppure in attesa di con-ferme da parte della giurisprudenza italiana, che la decisione concer-nente l’affidamento dei figli dei conviventi non contrasta con tale li-mite, dal momento che e ormai generalmente nota l’estensione del-l’ambito d’applicazione del diritto al rispetto della vita familiare, inforza di principi di ordine pubblico positivo (74).
SARA TONOLO
1021E DEGLI ACCORDI DI CONVIVENZA
(73) Sull’art. 65 l. 218/95, cfr. in generale: BARIATTI, Art. 65, in Commentariodel nuovo diritto internazionale privato, cit., p. 328 ss.; MARESCA, Artt. 64-66, in Legge31 maggio 1995, n. 218, cit., p. 1461 ss.; VISMARA, Art. 65, in CONETTI, TONOLO, VI-
SMARA, Commento, cit., p. 353 ss.(74) BUCHER, L’ordre public, cit., p. 26 ss.; MOSCONI, Exceptions to the Opera-
tion, cit., p. 127; CARBONE, IVALDI, Lezioni, cit., p. 65.
© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore