Gramsci nel dibattito politico arabo
Transcript of Gramsci nel dibattito politico arabo
2
Sommario Introduzione. ..................................................................................................................... 3 La diffusione del pensiero gramsciano nel mondo arabo. ................................................. 5
1.1. Gramsci nel mondo. ................................................................................................... 5
1.2 Convegni gramsciani nei Paesi arabi. ......................................................................... 6
1.3 Nascita del Gramsci arabo. ........................................................................................ 7
1.4 Gramsci e gli intellettuali arabi negli anni settanta. .................................................... 9
1.5 Gramsci e Said. ......................................................................................................... 11
1.6 Studi gramsciani negli anni ottanta; tra società civile ed intellighenzia. .................. 13
I Paesi arabi e l’Islam negli scritti di Gramsci. ............................................................... 17
2.1 Lo sguardo di Gramsci all'estero. .............................................................................. 17
2.2 L'Oriente negli scritti precarcerari. ........................................................................... 18
2.3 Il mondo arabo nei Quaderni del carcere. ................................................................ 20
Le categorie gramsciane nel pensiero arabo ................................................................... 25
3.1 La fortuna di Gramsci nel mondo arabo. .................................................................. 25
3.2 Egemonia................................................................................................................... 26
3.3 Società civile. ............................................................................................................ 27
3.4 L'intellettuale organico e l'intellettuale tradizionale. ................................................ 28
3.5 Note conclusive. ........................................................................................................ 30
Bibliografia. .................................................................................................................... 31
Sitografia. ........................................................................................................................ 34
3
Introduzione
A 76 anni dalla morte, la figura di Gramsci continua ad essere una delle più dibattute a livello politico ed accademico. Gli studi riguardanti il pensatore, lungi dall’essere interrotti, sono stati protagonisti, durante gli scorsi anni, di una mediatizzazione senza precedenti. Nel corso del biennio 2011-2012 gli studi sulla vita di Antonio Gramsci sono ritornati prepotentemente nelle librerie italiane. Un Gramsci dalle mille facce; violento nel pamphlet "Gramsci e Turati. Le due sinistre"1, del sociologo Alessandro Orsini; tradito e vittima di complotti togliattiani ne "I due carceri di Gramsci"2 di Franco Lo Piparo. Il primo segretario del PCI è stato dunque tirato per la giacca e dibattuto tra varie interpretazioni, come ben delineato dal presidente dell'International Gramsci Society Italia, Guido Liguori, nel suo: "Gramsci conteso"3. Oltre i confini italici lo studioso sardo non è più oggetto di speculazioni o endorsement di tipo politico, non sente più pesantemente sulle spalle il peso della sua partigianeria: fuori dalla Penisola egli è riconosciuto come uno dei più grandi studiosi del XX secolo. La sua esperienza vitale, così come la sua militanza politica sono accettate come dati di fatto; parti di un corollario che ha dato vita ad alcune tra le più brillanti analisi sociali e politiche. Lo scopo della presente ricerca è appunto quello di comprendere ed approfondire gli studi incentrati sul pensatore in una specifica parte di mondo, ovvero i Paesi arabi. Nelle prossime pagine si tenterà di delineare l’entità degli studi gramsciani in questa area geografica; di situarli cronologicamente ed, in particolar modo, di comprenderne l’utilità ai fini dell’interpretazione della realtà araba, nonché di porsi importanti questioni: a cosa è dovuta la fortuna di Gramsci nei Paesi arabi? Quale utilizzo è stato fatto delle sue categorie concettuali? Quali sono stati gli intellettuali che, in maggior misura, hanno diffuso ed utilizzato gli studi gramsciani? Una volta trattati gli argomenti appena scritti, sarà necessario svolgere un ragionamento inverso, ovvero ricercare, nell’immensa letteratura dell’umanista sardo, l’idea che lui aveva dell’Islam, sapere ciò che conosceva dei Paesi arabi, data la sua condizione vitale e gli scarsi mezzi a sua disposizione. Il progetto per questo lavoro è nato grazie alla collaborazione con la O.N.L.U.S. Casa Museo di Antonio Gramsci a Ghilarza, iniziata nel 2010, che mi ha permesso di incontrare persone provenienti da ogni parallelo interessate alla figura dell’umanista sardo. Notare un tale interesse per la figura di un conterraneo, o nel mio caso specifico, di un compaesano, non può lasciare indifferenti: diviene d’obbligo comprendere il perché di tale coinvolgimento. L’approfondimento in tal senso nasce con la lettura di Gramsci in Asia e in Africa, curato da Annamaria Baldussi e Patrizia Manduchi ed edito dalla Aipsa Edizioni, considerabile il pilastro portante della ricerca svolta di seguito. Nella lettura del volume appena nominato, a destare in particolar modo il mio interesse, è stata la parte relativa al Vicino Oriente, con i saggi di Derek Boothman, Patrizia Manduchi, Elena Vezzadini e Mauro Pala; grazie ai riferimenti bibliografici qui espressi ho potuto approfondire il
1 ORSINI Alessandro, Gramsci e Turati: le due sinistre, Rubbettino, 2011 Soveria Mannelli. 2 LO PIPARO Franco, I due carceri di Gramsci: la prigione fascista e il labirinto comunista, Donzelli, 2012 Roma. 3 LIGUORI Guido, Gramsci conteso: interpretazioni, dibattiti e polemiche 1922-2012, Editori Riuniti, 2012 Roma.
4
discorso sulla diffusione degli studi gramsciani nel mondo islamico, in particolare grazie al preziosissimo (ma altrettanto raro) volume Gramsci dans le monde arabe, edito a Tunisi nel 1994 e curato da Michele Brondino e Tahar Labib. Proprio grazie all’approfondito saggio di quest’ultimo studioso, intitolato Gramsci dans le discours des intellectuels arabes, ho potuto chiarire con precisione gli ambiti di diffusione degli studi gramsciani nei Paesi arabi, situarli cronologicamente e rispondere, sebbene in parte, alle domande sulla fortuna di Gramsci nel mondo arabo. La comprensione della terminologia utilizzata e delle categorie concettuali gramsciane sarebbe stata, senza dubbio alcuno, più difficile senza il Dizionario gramsciano 1926-1937, un vero e proprio strumento di interpretazione del linguaggio, della filosofia e dei concetti di Antonio Gramsci, curato da Guido Liguori e Pasquale Voza, e contenente collaborazioni dei più grandi studiosi gramsciani viventi. Nel primo capitolo della presente tesi, intitolato La diffusione del pensiero gramsciano nel mondo arabo, viene trattato il tema della fortuna di Gramsci nell’area geo-politica araba: i convegni a lui dedicati, i centri di lavoro e di studio, le traduzioni e le sue interpretazioni nel corso dei quarant’anni che intercorrono tra gli anni ’70 ed oggi, nonché le sue affinità con alcuni intellettuali arabi. Nel secondo capitolo, I Paesi arabi negli scritti di Gramsci, si fa una cernita dei cenni negli scritti di Antonio Gramsci riguardanti l’Islam e il mondo arabo: dalle semplici note alle vere e proprie analisi, nell’arco di tutti i suoi scritti, da quelli precarcerari fino ai Quaderni del carcere. Nel terzo capitolo, Le categorie gramsciane nel pensiero arabo, si cerca di comprendere l’utilizzo fatto delle principali categorie concettuali gramsciane nel mondo arabo: vengono trattate egemonia culturale e politica, il ruolo della società civile, dell’intellighenzia e degli intellettuali, con le definizioni di intellettuale organico e tradizionale.
5
La diffusione del pensiero gramsciano nel mondo arabo
1.1. Gramsci nel mondo L’ampiezza dell'interesse mosso dal pensiero e dagli scritti di Antonio Gramsci è facilmente deducibile dalle dimensioni della sua bibliografia. La letteratura dedicata al pensatore, consultabile on-line, conta ben 19.109 documenti, ed è la più vasta dedicata ad un singolo autore4. Ciò che colpisce della Bibliografia Gramsciana, ancor più della sua grandezza in termini numerici, è la sua spiccata internazionalità: i testi elencati sono scritti, infatti, in quarantuno lingue differenti5. La fortuna di Gramsci al di fuori dei confini italiani è da tempo cosa nota, sicuramente dovuta alle sue brillanti analisi in campi diversi: nella filosofia politica come nella linguistica, nella critica culturale quanto nell'antropologia. L'espansione del pensiero gramsciano è stata disomogenea sia dal punto di vista geografico, sia dal punto di vista temporale. Il primato per la scoperta di Antonio Gramsci all'estero, spetta, senza dubbio, al mondo anglosassone. Gli storici americani ed inglesi conobbero il pensatore sardo poco dopo la fine del secondo conflitto mondiale; le prime pubblicazioni in lingua inglese nacquero tra la fine degli anni cinquanta ed i primi anni sessanta. Proprio nel 1960, John M. Cammett, storico americano, completò la sua tesi di dottorato: Antonio Gramsci and the origins of Italian Communism, divenuta poi, pochi anni dopo, il primo libro su Gramsci scritto al di fuori dall'Italia ed in una lingua diversa dall'italiano6. Gli studi e le pubblicazioni gramsciane iniziarono allora a fiorire in Europa, così come nel continente americano, nell'estremo oriente asiatico e nel sub-continente indiano, fino ad arrivare ai Paesi arabi. I paesi e le popolazioni del mondo hanno conosciuto Gramsci nel momento in cui il suo pensiero, le sue riflessioni, ed, in particolar modo, le sue categorie concettuali, risultavano essere utili per meglio comprendere i cambiamenti ed i momenti storici che proprio quei paesi e quelle popolazioni stavano affrontando. Negli anni settanta, l'interesse per la figura di Antonio Gramsci valicò definitivamente i confini del mondo occidentale, od occidentalizzato, sviluppandosi in Asia ed in Africa, grazie, soprattutto, agli spunti maturati nei Quaderni del carcere e nel saggio Alcuni temi sulla quistione meridionale, che bene si sono adattati come strumento d'analisi dei cambiamenti negli scenari post-coloniali7. La mole di pubblicazioni e studi crebbe ancor di più con l'approssimarsi della fine del socialismo reale, portando, nel 1989, alla fondazione dell'International Gramsci Society, organizzazione no-profit creata per facilitare lo scambio di informazioni tra gli studiosi interessati alla figura ed ai lavori del pensatore sardo8 e, sempre nel 1989, al convegno della Fondazione Istituto Gramsci
4 Bibliografia Gramsciana on line,
http://www.fondazionegramsci.org/5_gramsci/ag_bibliogramsci.htm. 5 Idem. 6 CAMMETT M. John, Antonio Gramsci and the Origins of Italian Communism, Stanford University
Press, 1967 Stanford, in HOBSBAWM Eric J., Come cambiare il mondo. Perché riscoprire l'eredità del marxismo, RCS Libri Spa, 2011 Milano, pag. 135.
7 BALDUSSI Annamaria / MANDUCHI Patrizia, Gramsci in Asia e in Africa, in BALDUSSI Annamaria / MANDUCHI Patrizia (a cura di), Gramsci in Asia e in Africa, Aipsa Edizioni, 2010 Cagliari, pag. 15.
8 International Gramsci Society, http://www.internationalgramscisociety.org/.
6
svoltosi a Formia ed intitolato Gramsci nel mondo, con lo scopo di fornire una nitida visione d'insieme sull'interesse relativo ad Antonio Gramsci in campo internazionale9. Proprio questo convegno, al quale parteciparono ventisei studiosi provenienti da ogni continente ed il direttore della Columbia University Press10, mostrò, ineditamente, la mole d'interesse cresciuta attorno a Gramsci negli anni settanta ed ottanta. Il convegno Gramsci nel mondo confermò che il Gramsci ignorato in Italia negli anni ottanta11, stava divenendo, al contempo, protagonista negli studi antropologici, politici e sociali a livello internazionale, spesso attraverso canali non convenzionali rispetto a quelli utilizzati negli studi italiani ed occidentali. Analizzeremo, nelle pagine che seguiranno, gli influssi, la fortuna e gli studi gramsciani svoltisi nei Paesi arabi.
1.2 Convegni gramsciani nei Paesi arabi Nella varietà dei paesi facenti parte del Nord africa e del Vicino Oriente, la diffusione del pensiero dell'umanista sardo fu disordinata, disomogenea. A far chiarezza sulla fortuna del pensatore comunista nei Paesi musulmani fu una serie di convegni, organizzati nel Nord africa: il primo di questi fu Gramsci et le monde arabe tenutosi a Tunisi dal 24 al 26 febbraio del 1989, promosso dall'Istituto superiore di animazione culturale (ISAC) e dall'Istituto culturale italiano (ICI), con il patrocinio della Facoltà delle scienze umane e sociali dell'università di Tunisi e dell'Istituto Gramsci di Roma12. Per il centenario della nascita di Gramsci, nel 1990 (sebbene il centenario ricorresse nel 199113), si svolse a Il Cairo il più grande convegno sulla figura del politico sardo nel mondo arabo. Organizzato dal Markaz al-buhūth al- 'arabiyya, ovvero Center for Arabic Studies, e dal tunisino Arab Group for Sociology, ebbe una vasta partecipazione da tutti i Paesi islamici, con l'adesione di studiosi provenienti anche dall'Italia e dagli Stati Uniti14. Gli atti del congresso furono pubblicati due anni dopo, in arabo, curati dalla studiosa egiziana Amina Rashid, intitolati La questione della società civile araba alla luce delle tesi di Gramsci15. Nel 1991, nuovamente a Tunisi, il Centro culturale Tahar Haddad organizzò un nuovo dibattito sullo stesso tema16, cui seguì, nel 1994, la pubblicazione degli atti17, ovvero del prezioso volume Gramsci dans le monde arabe. L'ultimo meeting, dal punto di vista cronologico, è avvenuto nel 2008, organizzato da la Casa della Cultura ibn Khaldun, sempre nella capitale della Tunisia, intitolato Gramsci, la cultura e gli intellettuali, con la partecipazione di Silvia Finzi (Gramsci: l’uomo), Bakkar Gharib (Verso le fonti dell’eterodossia gramsciana), Rida al-Tillili (Le influenze di Gramsci nell’America Latina), Zuhayr al-Khuwailidi (Il filosofo democratico tra critica e prassi), Ibrahim al- ‘Umayri (La dimensione politica dell’intellettuale), Ahmad Ibrahim (Gramsci e la questione linguistica) e Salin al-Hajji (Gramsci e la questione educativa)18.
9 BALDUSSI Annamaria / MANDUCHI Patrizia, Op. Cit. pag. 15. 10 VACCA Giuseppe, Prefazione in SCHIRRU Giancarlo (a cura di) Gramsci, le culture e il mondo,
Viella libreria editrice, 2009 Città di Castello (PG), pag. 9. 11 Idem. 12 BRONDINO Michele / LABIB Tahar, Introduction, in BRONDINO Michele / LABIB Tahar (a cura
di), Gramsci dans le monde Arabe, Alif Éditions, 1994 Tunisi, pag. 7. 13 FIORI Giuseppe, Vita di Antonio Gramsci, Edizioni Laterza, 1966 Bari, pag. 11. 14 MANDUCHI Patrizia, Antonio Gramsci e il dibattito intellettuale nel mondo arabo contemporaneo in
BALDUSSI Annamaria / MANDUCHI Patrizia (a cura di), Gramsci in Asia e in Africa, Aipsa Edizioni, 2010 Cagliari, pag. 139.
15 Idem. 16 Idem. 17 BRONDINO Michele / LABIB Tahar, Op. cit., pag. 9. 18 MANDUCHI Patrizia, Antonio Gramsci e il dibattito intellettuale..., Op. cit., pag. 149.
7
Al di fuori del circuito dei convegni svoltisi nei Paesi nordafricani è d'uopo ricordare il compiuto intervento, al sopracitato convegno di Formia del 1989, di Tahar Labib, da cui nasce il saggio "Gramsci nel mondo arabo", contenuto nel volume "Gramsci nel mondo"19.
1.3 Nascita del Gramsci arabo Il lavoro del sociologo Tahar Labib, contenuto all'interno del sopracitato volume Gramsci dans le monde arabe, ci permette una precisa collocazione storica della nascita del Gramsci arabo20. Labib, oggi presidente dell'Associazione Araba di Sociologia, apre la sua dissertazione, intitolata "Gramsci dans le discours des intellectuels arabes", con una frase che è al contempo giudizio e dato cronologico: "Il Gramsci degli Arabi ha l'età del loro disfattismo"21. Si riferisce al breve ed intenso spazio temporale a cavallo tra gli anni sessanta e settanta, scandito dal conflitto arabo-israeliano del 1967, noto come guerra dei sei giorni, e dalla guerra dello Yom Kippur o del Ramadan, avvenuta nel 197322. Le riflessioni riguardanti il pensatore sardo nel mondo arabo, nacquero in seno ad una vera e propria rivoluzione culturale nei Paesi arabi: è il momento storico dell'abbandono delle ideologie importate, spesso grossolanamente, dall'Occidente, e della nascita dell'islamismo23, ovvero dell'Islam politico24. La scoperta di Gramsci da parte dell'intellighenzia araba fu graduale e disomogenea. Una buona cartina di tornasole per stabilire il principio degli studi gramsciani nel mondo arabo è una ricerca bibliografica relativa alle prime pubblicazioni in arabo riguardanti Gramsci. Come è facile intuire si tratta, anzitutto, di traduzioni dei lavori del pensatore: la prima pubblicazione, in ordine cronologico, è Al-amīr al-hadīth, ovvero il Principe moderno, tradotto dal francese da Zahi Charfan e Anis Chami, pubblicato a Beirut, in Libano, nel 197025. Seguirono, nel corso degli anni settanta, altre traduzioni, divulgate soprattutto in Libano: ricordiamo Qadāyā al-māddiya al-tārīkhiyya, traduzione di Questioni di materialismo storico; Ghārāmshī: dirāsāt mukhtāra, ovvero una traduzione di scritti scelti di Gramsci già pubblicati in Francia da Texier26. Alcuni estratti degli scritti gramsciani sono stati tradotti, negli anni seguenti, per essere pubblicati in alcune riviste di sinistra palestinesi, come al-Karmal, o egiziane, come Qadaya fikriyya. I temi del politico sardo, trattati e tradotti nelle sopracitate riviste partigiane, sono sicuramente tra i più noti anche nel mondo occidentale; a tal proposito possiamo citare: le questioni di partito, il concetto di egemonia, la discussione sugli intellettuali, così come la questione meridionale ed i temi sulla letteratura ed il nazionalismo italiano, fino ad arrivare alla critica su Pirandello27.
19 RIGHI Maria Luisa (a cura di), Gramsci nel mondo, Atti del convegno internazionale di studi
gramsciani Formia, 25-28 ottobre 1989, Fondazione Istituto Gramsci, 1995 Roma, pag. 207. 20 LABIB Tahar, Gramsci dans le discours des intellectuels arabes, in BRONDINO Michele / LABIB
Tahar (a cura di), Gramsci dans le monde Arabe, Alif Éditions, 1994 Tunisi, pag. 13. 21 Idem. 22 MANDUCHI Patrizia, Antonio Gramsci e il dibattito intellettuale..., Op. cit., pag. 128 23 Ibidem, pagg. 128-129. 24 TREVOR Stanley, Definition: Islamism, Islamist, Islamiste, Islamicist, Perspectives on World History and Current Events, 2005. URL: http://www.pwhce.org/islamism.html. 25 MANDUCHI Patrizia, Antonio Gramsci e il dibattito intellettuale…, Op. cit., pag. 137 26 Idem. 27 LABIB Tahar, Gramsci dans le discours des intellectuels…, Op. cit., pag. 15-16.
8
Le versioni di Gramsci in lingua araba ebbero spesso come filtro una doppia traduzione: dall'italiano al francese e dal francese all'arabo. I testi gramsciani vennero studiati nei Paesi musulmani così come erano stati selezionati dagli occidentali28. Nel decennio che intercorre tra il 1975 ed il 1984, furono tradotte in arabo tre opere di interpretazione gramsciana provenienti dall'Europa: La pensée politique de Gramsci del francese Jean-Marc Piotte, Gramsci di Pier Paolo Pasolini29 ed il già citato Gramsci and the origins of italian Communism dello statunitense John M. Cammett30. Tuttavia, queste prime interpretazioni tradotte non ebbero gran successo, furono scarsamente utilizzate, finanche scordate31. Il tomo gramsciano di maggior successo nel mondo arabo e, peculiarmente, nel Maghreb, fu Gramsci dans le texte32, volume francese non tradotto, redatto da François Ricci e Jean Bramant nel 1975, contenente una selezione dei testi di Gramsci dal 1916 al 193533. Le 798 pagine del volume danno una visione d'insieme del lavoro di Antonio Gramsci nei Quaderni del carcere. La selezione di testi ivi presente fa ben comprendere l'utilità che questo libro ha avuto, e continua ad avere, per l'interpretazione delle realtà sociali e politiche dei paesi arabi. I temi affrontati sono generalmente tra i più popolari tra quelli trattati dal pensatore sardo: i discorsi sugli intellettuali, la disamina sul Principe moderno ed il saggio sulla questione meridionale34. Le sopracitate versioni in lingua araba, così come i primi studi specifici in francese, inglese ed arabo35 nacquero in seno al mondo accademico, per volontà e bisogni collegati al mondo degli atenei: tale particolare attenzione si sviluppò soprattutto nei centri universitari di Tunisi, Il Cairo, Damasco e Beirut36. Senza le università, la fortuna dell'umanista sardo nei paesi arabi sarebbe praticamente nulla. Il mondo accademico dimostrò d'essere avanti di un decennio rispetto alla politica ed alla società araba: i docenti cominciarono a parlare di Gramsci ai propri studenti: Pour Gramsci di Maria Antonietta Macciocchi37, pubblicato nel '71 a Parigi, divenne parte delle bibliografie consigliate38. Nello scenario politico, al contrario, la sua presenza è evanescente, quasi inesistente. I partiti comunisti arabi, formati presto, poco dopo quello italiano, non ebbero una grande diffusione nella società e, privi di radicamento territoriale, non incisero mai in maniera consistente negli scenari sociali e politici statali39; anche all'interno dei partiti di chiara ispirazione marxista, la figura del pensatore sardo restava una materia oscura. Fino agli
28 LABIB Tahar, Gramsci dans le discours des intellectuels…, Op. cit., pag. 15-16. 26 Tahar Labib nella sua notazione a pag. 15 di Gramsci dans le discours des intellectuels…, Op. cit. sostiene che non vi sia corrispondenza del titolo Gramsci della versione araba con alcuna opera scritta da Pasolini. Tuttavia si potrebbe supporre che si tratti dell’unica opera che quest’ultimo ha dedicato ad Antonio Gramsci, ovvero il componimento Le ceneri di Gramsci, Ed. Garzanti, 1957 Milano. 30 LABIB Tahar, Gramsci dans le discours des intellectuels…, Op. cit., pag. 15-16. 31 Idem. 32 Idem. 33 GRAMSCI Antonio / RICCI François / BRAMANT Jean (a cura di), Gramsci dans le texte, Éditions
sociales, 1975 Parigi, pagg. 4-5. 34 Idem. 35 MANDUCHI Patrizia, Antonio Gramsci e il dibattito intellettuale…, Op. cit., pag. 137. 36 Idem. 34 MACIOCCHI Maria Antonietta, Pour Gramsci, Éditions du Seuil, 1971 Parigi. 38 LABIB Tahar, Gramsci nel mondo arabo in RIGHI Maria Luisa (a cura di), Gramsci nel mondo, Atti
del convegno internazionale di studi gramsciani Formia, 25-28 ottobre 1989, Fondazione Istituto Gramsci, 1995 Roma, pag. 210.
39 MANDUCHI Patrizia, Antonio Gramsci e il dibattito intellettuale…, Op. cit., pag. 135.
9
anni settanta, non troviamo alcuna disamina del suo pensiero da parte dei politici e dei teorici marxisti arabi40, il cono d'ombra coinvolge i lavori più noti della critica marxista araba, come quelli di Hassin Muruwwa, Tayyib Tayzini, Sadiq Jalal al-Azm, Ilyas Murqus e Mahmud Amin Al-Alim41. I partiti comunisti arabi furono filo-sovietici ed estremamente vicini al Partito comunista francese, fortemente dogmatici e poco flessibili, distanti in maniera del tutto evidente dal gramscismo42. In riferimento a ciò, il critico letterario egiziano Ghali Shukri affermò in maniera molto eloquente che: "Gramsci si indirizzava principalmente alla sinistra, ma l'incoscienza della sinistra araba portava ad osservarlo con sospetto: precisamente a causa della sua italianità. Da Togliatti a Berlinguer il PCI non godeva di una buona reputazione presso gli stalinisti arabi."43 Tuttavia, Gramsci emerse nell'ambiente comunista dopo la disfatta araba della guerra dei sei giorni, come elemento di rottura, come strappo dal dogmatismo stalinista: riconosciuto come portatore d'un pensiero marxista indipendente44. I riferimenti all'umanista sardo rimasero comunque evanescenti nel comunismo arabo fino alla metà degli anni settanta; quella di Gramsci fu, secondo Tahar Labib, una "presenza nell'assenza"45, fatta di citazioni ed evocazioni lontane46, di analisi politiche non tanto sul personaggio, quanto, piuttosto, sulla sua mancanza o non conoscenza. Possiamo affermare che il Gramsci degli arabi non sia figlio del marxismo.
1.4 Gramsci e gli intellettuali arabi negli anni settanta A riprova di quanto appena detto, è utile render noto che il primo autore arabo a citare Gramsci in una sua opera non sia un marxista in un documento di stampo politico, bensì uno storico. Abdallah Laroui, noto accademico marocchino, che citò il pensatore sardo nel 1967 all'interno della sua opera Idéologie arabe contemporaine, per attribuirgli, in una nota, la paternità della locuzione "storicismo assoluto"47. Una citazione timida, certo, ma al contempo una testimonianza di conoscenza, da parte dello storico marocchino Laroui, dei concetti e della figura dell'umanista sardo; un primo tentativo di utilizzare Gramsci come strumento di studio. In un secondo momento, precisamente nel 1970, Gramsci verrà citato da Anouar Abdelmalek nel suo fortunato La pensée politique arabe contemporaine, tradotto anche in italiano ed edito nel 1973 in Italia con il titolo Il pensiero politico arabo. In questa occasmione, lo studioso di origini egiziane evoca esplicitamente Gramsci in riferimento alla crisi degli intellettuali nel mondo arabo, con la frase: "mai, forse, le tesi di Gramsci sugli intellettuali hanno ricevuto una conferma più eclatante come nel mondo arabo di oggi"48. Abdelmalek si spinge oltre la semplice citazione, aprendo una discussione sulle problematiche legate alla formazione dell'intellighenzia araba49.
40 MANDUCHI Patrizia, Antonio Gramsci e il dibattito intellettuale…, Op. cit., pag. 135. 41 LABIB Tahar, Gramsci nel mondo arabo, Op. cit, pag. 208. 42 Idem. 43 Citato in BROWERS M.L. Il concetto di società civile nel mondo arabo, in VACCA Giuseppe,
SCHIRRU Giuseppe (a cura di), Studi gramsciani nel mondo. 2000-2005, Fondazione Istituto Gramsci, il Mulino, Bologna 2007, pagg. 79-117.
44 LABIB Tahar, Gramsci nel mondo arabo, Op. cit., pag. 208. 45 MANDUCHI Patrizia, Antonio Gramsci e il dibattito intellettuale…, Op. cit., pag. 135. 46 LABIB Tahar, Gramsci nel mondo arabo, Op. cit., pag. 208. 47 Idem. 48 ABDEL-MALEK Anouar, La pensée politique arabe contemporaine, Editions du Seuil, 1970 Parigi,
pag. 26. 49 MANDUCHI Patrizia, Antonio Gramsci e il dibattito intellettuale…, Op. cit., pag. 131.
10
Sempre nel 1970, Hichem Charabi, nel suo volume Arab intellectuals and the West, pone una questione espressa tempo prima da Gramsci, ovvero: "Gli intellettuali costituiscono una classe indipendente?"50. Charabi farà sue le tesi del pensatore comunista, sottolineando l'importanza di un dialogo diretto, orizzontale tra gli intellettuali e la società51. I primi incontri degli intellettuali arabi con Gramsci, appena enucleati, dimostrano una conoscenza ed uno studio del pensiero gramsciano in una fase embrionale. Sono legati tra loro da un filo conduttore evidente alla sola lettura dei titoli delle opere; nessuna di queste è stata scritta in lingua araba, o edita in un Paese arabo52: il risultato fu che i volumi succitati furono maggiormente rilevanti nei Paesi di pubblicazione rispetto ai Paesi arabi, contribuendo alla non referenzialità dell'umanista sardo in lingua araba, e ad una sorta di esilio linguistico per lo stesso. Il primo marxista53 arabo ad ispirarsi a Gramsci fu il libanese Hassen Hamdan, meglio conosciuto come Mahdi Amel, uno dei teorici e militanti maggiormente noti all'interno del partito comunista libanese. Egli menzionò per la prima volta Gramsci, come già fece Laroui, in una nota presente in un articolo-risposta pubblicato su La sinistra reale e la sinistra avventurista nel 197054. Mahdi Amel, pubblicò nel 1973 a Beirut la sua Introduzione teorica allo studio dell'impatto del pensiero socialista nel movimento di liberazione nazionale55 [titolo originale: Muqaddimat nadhariyya li-dirasat al-fikr al ichtiraki fi harakat al taharrur al-watani], opera di grande successo nel mondo arabo, che parve richiamare Gramsci senza citarlo nemmeno una volta56. In seguito all'assassinio di Mahdi Amel, avvenuto nel 1987 per mano di Hezbollah57, vi sarà il tentativo, da parte di alcuni intellettuali (uno su tutti Faysal Darraj) di accostare la sua figura a quella di Gramsci58: tale tesi non è da definirsi sconsiderata a prescindere, poiché, come vedremo in seguito, le analogie tra il pensiero gramsciano e l'opera del marxista libanese sono poche, ma di estremo rilievo. Innescando una riflessione sulla crisi dei movimenti rivoluzionari arabi, Mahdi Amel attribuisce all'intellettuale un'importanza del tutto nuova rispetto all'approccio marxista dogmatico dell'epoca: definisce il comunismo nei Paesi arabi come una filosofia morale del tutto inetta a produrre un programma politico di cambiamento59. A tal proposito, il comunista libanese sostiene: "Il campo del sapere è un campo molto importante nell'ambito della lotta di classe"60, rigettando così l'individualizzazione dell'intellettuale o la scoperta di una figura messianica capace di cambiare le sorti del mondo; a tal proposito, scrive: "È l'inclinazione individualista borghese che incita alcuni intellettuali a pensare che nelle nostre società coloniali, abbiamo bisogno di un altro Marx, di un altro Lenin, cioè di un individuo geniale che possa condurre il nostro movimento di
50 CHARABI ICHAM, Arab intellectuals and the West, the formative years 1875-1914, The Johns
Hopkins Press published in cooperation with The Middle East Institute, Baltimore 1970, in LABIB Tahar, Gramsci dans le discours des intellectuels…, Op. cit., pag. 19.
51 MANDUCHI Patrizia, Antonio Gramsci e il dibattito intellettuale…, Op. cit., pag. 131. 52 LABIB Tahar, Gramsci dans le discours des intellectuels…, Op. Cit., pag. 19. 53 Ibidem, pag. 23. 54 LABIB Tahar, Gramsci nel mondo arabo, Op. Cit., pag. 208. 55 LABIB Tahar, Gramsci nel mondo arabo, Op. cit., pag. 208. 56 Idem. 57 MANDUCHI Patrizia, Antonio Gramsci e il dibattito intellettuale…, Op. cit., pag. 135. 58 LABIB Tahar, Gramsci nel mondo arabo, Op. cit., pag. 208. 59 LABIB Tahar, Gramsci dans le discours des intellectuels, Op. cit., pag. 24. 60 MAHDI Amel, Muqaddimat Nadhariyya li-Dirasat ‘Athar al-Fikr al Ichitiraki fi Harakat al –
Taharrur al-Watani: fi al-Tanaqudh, éd. Dar al-Farabi, Beirut, 1973, citato in LABIB Tahar, Gramsci nel mondo arabo, Op. cit., pag. 209.
11
liberazione allo stadio del socialismo"61. L'accostamento di tali asserzioni con l'idea gramsciana di "intellettuale collettivo"62 è naturale, di palese verosimiglianza. A fronte di tale discussione, Faysal Darraj sosterrà che in Mahdi Amel si trovino "alcune idee di Gramsci sul partito rivoluzionario che stabiliscono un nuovo rapporto d'unione tra la teoria e la pratica."63. La presenza di Gramsci in Introduzione teorica allo studio dell'impatto del pensiero socialista nel movimento di liberazione nazionale non si ferma ai concetti già nominati, ma emerge costantemente tra le righe della dissertazione del marxista libanese. Concetti tipicamente gramsciani, spesso non nominati, ma comunque trattati dall'autore, sono presenti in tutta l'opera: egemonia, blocco storico, intellettuale collettivo, lavoro manuale ed intellettuale.64 Gramsci non è citato, ma la sua presenza è ben più profonda e marcata rispetto ai lavori precedenti di altri studiosi, in cui il pensatore sardo viene nominato per riconoscenza, come presenza eterea e superficiale65. Poche altre uscite bibliografiche caratterizzarono il decennio che va dal 1970 al 1980: un lavoro sulla sociologia della cultura di Tahar Labib, uscito nel 1978 al Cairo, utilizzò Gramsci come strumento di riflessione per un'analisi sugli intellettuali; nel 1979 Mohamed Barada utilizzò il concetto di "intellettuale organico" nel suo Mandur wa tandhir al-naqd al-adabi [Mandur e la teorizzazione della critica letteraria]; sempre nel 1979, ci troviamo dinanzi alla prima critica gramsciana: Samir Amin, economista marxista egiziano, trattò alcune tesi della "Quistione Meridionale" nel suo Classe et nation, edito a Parigi. Trattò l'iniquità del rapporto Nord-Sud, raffrontando, d'un tratto, le proprie tesi con quelle gramsciane; scrisse: "una analisi come la nostra non è incompatibile con la tesi di Gramsci. Ma la continua in una direzione che Gramsci non avrebbe potuto tracciare."66. Gramsci cominciò a guadagnare popolarità. Le poche citazioni, le esigue riflessioni degli anni settanta, ma soprattutto il lavoro dei cosiddetti fuoriusciti e lo studio all'interno degli atenei, delinearono un buon punto di partenza, segnarono un netto sentiero, per la definitiva compenetrazione gramsciana nel mondo arabo dei decenni successivi.
1.5 Gramsci e Said Al termine del paragrafo precedente, si parla di fuoriusciti: sinonimo di esiliati, distanti dalla patria: Abdelmalek, Charabi, Laroui, si formarono all'estero: scrissero in francese o, nel caso di Charabi, in inglese. Il loro esilio fisico non fu, d'altro canto, esilio ideologico. Proprio grazie alle loro analisi il pensiero gramsciano è penetrato nella società araba: grazie alla loro popolarità in patria, Gramsci divenne popolare. Non si può parlare di fuoriusciti dal mondo arabo senza citare il più celebre fra questi, ovvero Edward Said, autore di Orientalism67, professore alla Columbia University68.
61 MAHDI Amel, Op. cit. 62 GERRATANA Valentino (a cura di) GRAMSCI Antonio, Quaderni del carcere, 4 voll., Einaudi,
Torino 1975, pag. 1430. 63 DARRAJ Faysal, «al-hizb wa al-nadhariuua fi fikr Mahdi ‘Amil» in al-Nadhariyya wa al-Mumarasa
fi Fikr Mahdi ‘Amil, LABIB Tahar, Gramsci dans le discours des intellectuels..., Op. cit., pag. 25. 64 LABIB Tahar, Gramsci nel mondo arabo, Op. cit., pag. 209. 65 Idem. 66 Ibidem, pag. 210. 64 SAID W. Edward, Orientalism, Vintage Books, New York 1979.
12
Grazie alle possibilità dateci dalla Bibliografia gramsciana on-line possiamo verificare, semplicemente digitando il nome dello studioso palestinese, che ben ottantadue pubblicazioni collegano Said a Gramsci. Said è considerato un pensatore comparabile a Gramsci, tanto per la grandezza delle sue analisi, quanto per il semplice fatto di essere l'umanista di origine araba ad aver utilizzato in maniera più compassata e acuta le categorie gramsciane. A partire dai concetti del pensatore sardo, Said costruì ragionamenti fondamentali per lo sviluppo del suo pensiero, come "l'umanesimo critico e democratico"69, teorizzante una pacifica convivenza anticolonialista ed opposta allo scontro di civiltà. Said, nel suo capolavoro Orientalism, mostra quali significati prende la nozione di Oriente nel mondo occidentale. Secondo l'analisi di Said l'Oriente, dunque, non è visto dagli occidentali come entità geografica o culturale, ma come strumento utilizzato dalle culture di matrice eurocentrica per poter costruire un dualismo tra Occidente e Oriente. Said sottolinea la volontà della cultura europea di stereotipare le grandi differenze culturali ed i grandi fenomeni sociali e politici del continente asiatico in poche linee guida, quali: fanatismo, dispotismo e spiritualismo70. Nella stesura del suo saggio di maggior successo, pubblicato anche in Italia con il titolo Orientalismo71, Edward Said utilizza e rielabora il pensiero e le strutture concettuali create da Michel Foucault e da Antonio Gramsci. Said non nasconde di ispirarsi all'umanista sardo, esplicitando chiaramente nell'introduzione all'opera la sua ammirazione per Gramsci: "Gramsci ha proposto una preziosa distinzione teorica tra una società civile e politica, la prima essendo costituita da associazioni spontanee, razionali e non coercitive come la famiglia, il sistema scolastico, e i sindacati, la seconda da istituzioni i cui membri sono legati in modo non spontaneo e la cui funzione non è connessa con forme di dominio entro la società (esercito, polizia, magistratura etc.). La cultura opererebbe nell'ambito della società civile, e l'influenza di idee, istituzioni e singole persone dipenderebbe non dal dominio, ma da ciò che Gramsci chiama "consenso". Allora, in ogni società non totalitaria, alcune forme culturali saranno preponderanti rispetto ad altre, alcune concezioni saranno più seguite, si realizzerà cioè lo spontaneo prevalere di determinanti sistemi d'idee che Gramsci chiama "egemonia", concetto di fondamentale importanza per comprendere la vita culturale dell'Occidente industriale. È proprio l'egemonia, o più precisamente il risultato dell'egemonia culturale, a dare all'orientalismo la durata e la forza su cui abbiamo or ora richiamato l'attenzione [...] Nei Quaderni del carcere Gramsci afferma: "L'inizio dell'elaborazione critica è la coscienza di quello che è realmente, cioè un 'conosci te stesso' come prodotto del processo storico finora svoltosi, che ha lasciato in te stesso un'infinità di tracce accolte senza beneficio d'inventario." [...] Gramsci conclude aggiungendo "occorre inizialmente fare un tale inventario" [...] Da molti punti di vista questa ricerca sull'orientalismo rappresenta uno sforzo per redigere l'inventario delle tracce depositate in me, orientale, dalla cultura il cui predominio è stato un elemento così importante nella vita di tanti orientali. [...] Se ciò che ho realizzato sia un buon esempio dell''inventario' che Gramsci ci suggerisce di compilare non sta a me dirlo..."72. Già dalle poche righe appena accennate, è palese, in Said, un livello di comprensione,
68 MANDUCHI Patrizia, Antonio Gramsci e il dibattito intellettuale…, Op. cit., pag. 133. 69 Idem. 70 SAID W. Edward, Orientalismo, Feltrinelli, 1999 Milano. 71 Idem. 72 Ibidem, Op. cit., pagg. 9-29.
13
elaborazione e conoscenza del pensiero gramsciano, estremamente superiore rispetto a quello dei suoi colleghi arabi dell'epoca. Lavorare negli Stati Uniti, in humus culturale in quel periodo ricco di interpretazioni gramsciane (basti pensare a Noam Chomsky o a John M. Cammett), può aver agevolato il lavoro del pensatore di origini palestinesi. Tuttavia, la vicinanza di Said a Gramsci non è così facilmente riassumibile; la forza di Said sarà quella di utilizzare in maniera esperta gli strumenti fornitigli da Antonio Gramsci, analizzando criticamente la devastazione culturale e sociale subita dal mondo arabo colonizzato73. Said sarà affascinato, inoltre, dal territorialismo gramsciano, sostenendo che Gramsci "mette in evidenza il ruolo della geografia all'interno della realtà sociale."74 Le analisi dell'intellettuale Said saranno fondamentali per la divulgazione del pensiero gramsciano nei Paesi arabi: variegato e vasto, il discorso su Gramsci di Said portò, negli anni ottanta, gli studiosi e la società civile a chiedersi chi fosse Gramsci e quale potesse essere il suo ruolo nell'interpretazione della realtà araba.
1.6 Studi gramsciani negli anni ottanta; tra società civile ed intellighenzia Nel corso degli anni ottanta, l'interpretazione gramsciana nel mondo arabo prese nuove forme, più evolute e variegate. Il merito di questa crescita è dato, in particolar modo, da un nuovo rapporto tra politica ed intellettuali nel mondo arabo, senza dimenticare, tuttavia, l'importanza degli studi pionieristici svoltisi sin dal principio degli anni settanta. La necessità di discussioni relative al concetto di intellettuale ed il nascente dibattito sulla questione della società civile non poterono fare a meno di Gramsci, destinato a divenire il principale interlocutore per tali tematiche75, intrattabili senza il suo apporto. L'utilizzo di Gramsci nel corso degli anni ottanta venne giustificato dalla Rashid nel corso del secondo convegno gramsciano svoltosi nel mondo arabo, il già citato La questione della società civile araba alla luce delle tesi di Gramsci del 1990. La Rashid sostiene nella sua tesi che l'utilizzo di Gramsci sia giustificato dal bisogno di rendere i grandi pensatori mondiali parte del patrimonio militante arabo, Gramsci è per la studiosa egiziana "il modello di un militante che ha saputo esplicare la specificità dei problemi della rivoluzione nel suo paese rispettando l'universalità di tali concetti"76. Nel corso degli anni ottanta, alcuni testi pubblicati dal Centro di studi sull'Unità araba di Beirut ci mostrano il raggiungimento di un grado di consapevolezza sicuramente maggiore nell'utilizzo di Antonio Gramsci. In un simposio organizzato nel corso del 1983 su La crisi della democrazia nel mondo arabo, Gramsci viene collocato come uno dei pensatori fondamentali per comprendere l'evoluzione della società civile, ponendo il suo nome accanto a quelli di umanisti già molto conosciuti nel mondo arabo, quali Hobbes, Locke, Montesquieu e Rousseau. In particolare, Gramsci viene utilizzato come metro di comparazione, rispetto a dei noti riformatori arabi come Tahtawi, Kheireddine, Kawakibi ed Afghani, per argomentare l'esistenza, nella storia araba, di un'equivalente
73 MANDUCHI Patrizia, Antonio Gramsci e il dibattito intellettuale…, Op. cit., pag. 134. 74 LABIB Tahar, Gramsci dans le discours des intellectuels…, Op. cit., pag. 20. 75 Ibidem, pag. 29. 76 RACHID Amina, Qadaya al-Muhitama‘ al-Madani al-‘Arabi fi Dhaw’ Utruat Grahmchi, Markaz al-
Buhut al’Arabiyya, Il Cairo 1992, pagg. 9-10.
14
della società civile77. La rivista al-Mustaqbal al-Arabi, pubblicata dal Centro di studi sull'Unità araba, ha dedicato, negli anni ottanta, numerose pagine alla discussione sulla cultura e sugli intellettuali. Nel corso del decennio l'autore europeo più citato risulta essere proprio Gramsci; un risultato straordinario, se si pensa che quindici anni prima l'umanista sardo era praticamente sconosciuto nel mondo arabo. A seguire Gramsci, nella classifica dei più citati nella rivista, vi è un altro filosofo di chiara ispirazione marxista, ovvero Jean Paul Sartre. Il filosofo francese venne utilizzato, soprattutto, per essere comparato a Gramsci78. La tendenza a privilegiare Gramsci rispetto ad altri autori venne ribadita da un altro convegno libanese del Centro di studi sull’Unità araba di Beirut, organizzato nel 1990 su La società civile araba. Gramsci, marxista, viene utilizzato più dello stesso Marx. Il tentativo non è quello di rimpiazzare Marx con Gramsci, bensì di creare una catena di riferimenti per le interpretazioni della società civile. Nel simposio di Beirut è facilmente riscontrabile la combinazione delle interpretazioni di Gramsci-Marx-Hegel79a favore di un concetto articolato e chiaro di società civile. La fortuna del discorso gramsciano sulla società civile è dovuta alla sua vicinanza con gli interrogativi della società araba negli anni ottanta. Gramsci considera la società civile la sede storica delle ideologie. Qui ideologie e società civile divengono forze creatrici di storia futuribile, generatrici della formazione di un potere ancora da costituirsi, opposto ad un potere costituito. Gramsci si oppone a Marx privilegiando l'ideologia e giustapponendo il ruolo della sovrastruttura a quello della struttura, nel senso marxista del termine80. Il periodo storico arabo e la necessaria analisi dei rapidi cambiamenti sociali e politici, la velocità della cronaca che si trasforma in storia, rendono necessario l'utilizzo del concetto di società civile gramsciano sovrapposto a quello marxista. A rendere obbligatoria una lettura sociale e storica di questo periodo tramite occhiali gramsciani è la nascita di ideologie, quali l'islamismo, che in maniera preponderante assumono un ruolo egemonico, così come la ricerca delle forme dello Stato democratico, o meglio, le questioni riguardanti la sua assenza. A tener banco negli anni ottanta non fu solo il fortunatissimo discorso, prevalentemente libanese, sulla società civile. L'analisi sulla situazione degli intellettuali nel mondo arabo, proposta già negli anni settanta da Laroui, Abdelmalek e Mahdi Amel, fu l'argomento gramsciano di studi più affrontato nel Maghreb dalla metà degli anni ottanta, ma con un approccio differente rispetto al passato. Venne ripresa la questione sulla difficoltà d'essere un intellettuale arabo, censurando il termine stesso, e passando dalla nozione di intellettuale, troppo scarna e divenuta, secondo i sociologi arabi, quasi priva di significato, a quella di intellighenzia81. Il dibattito relativo alla nozione di intellighenzia diede luogo alla nascita di tre titoli nel corso degli anni '80: Intellighenzia nel Maghreb nel 1984, Intellighenzia o intellettuali, in Algeria? nel 1986 e L'intellighenzia araba nel 1989. Il risultato unanime delle discussioni presenti nelle soprascritte pubblicazioni è retorico, finanche ridondante: un'intellighenzia araba non esiste. Se non ci si affretta a saltare alle conclusioni, tuttavia,
77 LABIB Tahar, Gramsci dans le discours des intellectuels…, Op. cit., pag. 20. 78 Ibidem, pag. 29-30. 79 LABIB Tahar, Gramsci dans le discours des intellectuels…, Op. cit., pag. 29. 80 BOBBIO Norberto, Gramsci e la concezione della società civile, in BOBBIO Norberto, Etica e
politica. Scritti di impegno civile, Arnoldo Mondadori Editore, 2009 Milano, pagg. 1336-1350. 81 LABIB Tahar, Gramsci dans le discours des intellectuels…, Op. cit., pag. 30.
15
è possibile ritrovare in queste opere un approccio differente all'intellettuale: categoria sociale e non solo più creatore di discorso. Tahar Labib osserva che la nozione di intellighenzia è servita soprattutto ad orientare la concezione di intellettuale in questa direzione, "ove si cerca l'intellighenzia, si trovano solo gli intellettuali."82 Ammar Belhassan nel suo Intellighenzia o intellettuali, in Algeria? cita Gramsci poiché affascinato dal concetto di intellettuale organico, riformatore e tradizionale. Il discorso su Gramsci è, però, ancora scarno: il pensatore sardo viene toccato in maniera marginale tramite alcune citazioni commentate83. Abdelkader Jaghloul nel suo Intellighenzia nel Maghreb affronta Gramsci ed il suo concetto di intellettuale in maniera più compiuta. Dopo aver constatato l'inesistenza di una intellighenzia in Algeria, o meglio, di una sua esistenza in fase embrionale, Abdelkader Jaghloul propone una critica al concetto di intellettuale gramsciano: egli ritiene la distinzione tra intellettuale organico ed intellettuale tradizionale non applicabile alla realtà sociale algerina. L'intellettuale tradizionale gramsciano diviene per Jaghloul intellettuale tradizionalizzante, ovvero un intellettuale tradizionale che si muove dalle sue posizioni per affrontare la modernità, mentre la concezione di intellettuale organico risulta essere del tutto avulsa rispetto alla realtà storica algerina84. Il concetto di intellettuale tradizionalizzante di Jaghloul trova riscontro nella realtà dei Paesi arabi, e, sorprendentemente, anche nella stessa notorietà gramsciana nel mondo arabo: ovvero, senza voler essere troppo criptici, possiamo affermare che gli intellettuali tradizionali del mondo arabo si modernizzarono, arrivando a studiare e conoscere Gramsci. In Jaghloul si verificò un fenomeno di inversione dei concetti: l'intellettuale tradizionale o tradizionalizzante tese a mutare, divenendo intellettuale organico, mentre l'intellettuale organico bloccò il suo percorso, tradizionalizzandosi. Nel 1984, una rivista di tendenza islamista-progressista tunisina, Revue 15-21, fu il primo periodico del Maghreb a dedicare un titolo in copertina a Gramsci e ad affrontare il suo pensiero in alcune pagine al suo interno85. Negli ambienti della sinistra tunisina era altresì noto che i movimenti islamici avevano coscienza di chi fosse Antonio Gramsci, tanto da arrivare a sostenere che Rashid Ghannouchi, leader del movimento islamista in Tunisia, utilizzasse Gramsci nei suoi scritti e che avesse coscienza del concetto di egemonia culturale86. Nel 1988, in un incontro tra intellettuali di sinistra tunisini, vi fu per la prima volta la constatazione del fatto che i marxisti arabi avessero impiegato troppo tempo per scoprire Gramsci, che nel frattempo era già compenetrato nella società civile e nell'idea di conquista della società degli islamisti87. La questione relativa alla società civile fu trattata senza dubbio in maniera puntuale rispetto al discorso sugli intellettuali e l'intellighenzia. Nell'osservazione delle forme della società civile, la figura di Gramsci è necessaria, ma non sempre utile. Il pensatore sardo viene citato per essere discusso e criticato, definito utopista ed opportunista per la sua visione dell'intellettuale collettivo; viene sottoposto ad un confronto, teorico e mai empirico, con la realtà araba88. Nella critica, nei fraintendimenti e nelle prese di posizione, il Gramsci degli arabi nasce in maniera travagliata: è giusto parlare di incontro tardivo tra Gramsci ed il mondo
82 LABIB Tahar, Gramsci dans le discours des intellectuels…, Op. cit., pag.31. 83 Idem. 84 Ibidem, pag.32. 85 LABIB Tahar, Gramsci nel mondo arabo, Op. cit., pag. 210. 86 Idem. 87 LABIB Tahar, Gramsci dans le discours des intellectuels…, Op. cit., pag. 32. 88 Ibidem, pagg. 34-37.
16
arabo? Probabilmente sì. Tuttavia il ritardo non è eccessivo, se si pensa che l'epoca di diffusione del pensiero gramsciano al di fuori del mondo europeista, escludendo l'America latina, è la stessa dei Paesi arabi. Resta "un Gramsci senza gramscismo", come sostiene Tahar Labib, ma comunque oramai fortemente legato alla società civile araba, dove la fortuna di Gramsci va oltre la semplice necessità intellettuale ed accademica, arrivando sino ad una sorta di legame sentimentale89.
89 LABIB Tahar, Gramsci nel mondo arabo, Op. cit., pag. 210.
17
I Paesi arabi negli scritti di Gramsci
2.1 Lo sguardo di Gramsci all'estero Dopo aver osservato nelle pagine precedenti gli studi gramsciani svoltisi nei Paesi islamici, è interessante osservare come Gramsci stesso sia entrato in contatto con il mondo arabo nel corso della sua vita, nonostante le limitazioni date dalla brevità della sua esistenza, dai lunghi anni passati in carcere (Gramsci morirà quarantaseienne in clinica a Roma, sei giorni dopo aver finito di scontare la sua pena carceraria durata undici anni90), e la difficoltà di ottenere, in quel periodo storico, notizie ed informazioni sugli avvenimenti e sulle realtà storiche, sociali e politiche del Vicino Oriente e dei Paesi arabi in generale. La dimensione internazionale di Gramsci è dovuta ad una predisposizione umanista che si allontana dall'eurocentrismo. Già nel periodo degli studi, il pensatore sardo ebbe a che fare con l'estero: lo studio dei Balcani approfondito negli anni degli studi torinesi, per poi ritrovarsi, da dirigente del Partito Comunista d'Italia e del Comintern, a confrontarsi con intellettuali e realtà provenienti da ogni parte del mondo91. La sua permanenza a Mosca, tra il maggio del 1922 ed il dicembre del 1923, intervallata da un breve periodo di ricovero in un sanatorio nel '2292, accrebbe la sua predisposizione universalista e gli rese possibile comunicare con personalità provenienti da ogni parte del mondo. In questo periodo partecipò come delegato del PCd'I al IV Congresso del Comintern, svoltosi tra il novembre ed il dicembre del 1922; alla conferenza dei Balcani, avvenuta esattamente ad un anno di distanza, tra il novembre ed il dicembre del 1923; per poi essere nuovamente presente in terra russa nella primavera del 1925, come partecipante del V Esecutivo Allargato, sempre nell'ambito dell'Internazionale Comunista93. Negli articoli giornalistici scritti dal pensatore sardo, e sin dalla giovanissima età, spesso vi sono riferimenti (impliciti il più delle volte) a rapporti tra Stati e classi egemoni e subalterne, ai rapporti di potere ed alle mire colonialiste dell'Occidente. Tali analisi non possono certo precludere la conoscenza di realtà estere; conoscenza di seguito confermata dagli articoli di rivista menzionati dallo stesso Gramsci94. Nello studio dei Quaderni del carcere i concetti di egemone e subalterno sono spesso ripresi, ma è ancor più piacevole, per quanto concerne questo esercizio di ricerca, trovare nei Quaderni delle nozioni relative specificamente al mondo musulmano e su “Vicino Oriente” e “Prossimo Oriente”95, ovvero l'area dei Paesi arabi, ad oggi chiamata “Medio Oriente” per via della definizione anglofona “Middle East”.
90 FIORI Giuseppe, Vita di Antonio Gramsci, Edizioni Laterza, 1966 Bari., pagg. 236-366. 91 BOOTHMAN Derek, Gramsci e il Comintern sui mondi arabo, musulmano e palestinese-ebreo, in
BALDUSSI Annamaria / MANDUCHI Patrizia (a cura di), Gramsci in Asia e in Africa, Aipsa Edizioni, 2010 Cagliari pag. 109.
92 FIORI Giuseppe, Op. cit., pagg. 181-185. 93 Ibidem, pagg. 181-212. 94 BOOTHMAN Derek, Gramsci e il Comintern…, Op. cit., pag. 109. 95 Ibidem, pagg. 109-110.
18
2.2 L'Oriente negli scritti precarcerari Nel 1911, Gramsci è appena ventenne e studia al Liceo Classico Dettori di Cagliari, dove, grazie al suo professore di lettere, Raffaele Garzia, anche direttore de L'Unione Sarda, inizia a collaborare con il quotidiano isolano96. Proprio tra i banchi del Liceo Dettori, in un tema di italiano, il giovane Antonio scrive le sue prime righe sull'Oriente, in un compito sul colonialismo e sulle popolazioni oppresse: “ […] Un giorno si sparge la voce: uno studente ha ammazzato il governatore inglese delle Indie, oppure: gli italiani sono stati battuti a Dogali, oppure: i boxers hanno sterminato i missionari europei; e allora la vecchia Europa inorridita impreca contro i barbari, contro gli incivili, e una nuova crociata viene bandita contro quei popoli infelici […] Le guerre sono fatte per il commercio, non per la civiltà: gli Inglesi hanno bombardato chissà quante città della Cina per i Cinesi che non volevano sapere del loro oppio. Altro che civiltà! E Russi e Giapponesi si sono massacrati per avere il commercio della Corea e della Manciuria.”97 L'impressione è di un Gramsci a tratti acerbo, ma che nel suo sviluppo intellettuale e nel suo metodo di osservazione della realtà, ha già abbandonato in toto l'eurocentrismo. È ancora presto per introdurre il concetto di subalternità tipicamente gramsciano ma, ad ogni modo, è possibile osservare nel testo soprascritto una notevole sensibilità nei confronti delle popolazioni oppresse. Il tema si chiude con una chiosa che rende ben visibili delle influenze marxiste nel pensiero del giovane Gramsci: “[…] La Rivoluzione francese ha abbattuto molti privilegi, ha sollevato molti oppressi; ma non ha fatto che sostituire una classe all'altra nel dominio. Però ha lasciato un grande ammaestramento: che i privilegi e le differenze sociali, essendo prodotto della società e non della natura, possono essere sorpassate. L'umanità ha bisogno d'un altro lavacro di sangue per cancellare molte di queste ingiustizie: che i dominanti non si pentano allora di aver lasciato le folle in uno stato di ignoranza e di ferocia quali sono adesso!”98 L'analisi relativa al colonialismo, all'imperialismo ed alla subalternità, sarà senza dubbio il cuore pulsante dell'interesse di Gramsci rivolto all'Oriente. Si parla di imperialismo, nel settembre del 1925, a ben quattordici anni di distanza dalla stesura del tema sul colonialismo, quando Gramsci scrive nelle tesi per il III Congresso nazionale del Partito Comunista d'Italia (poi tenutosi all'estero, a Lione, nel gennaio del '26)99: “Coronamento di tutta la propaganda ideologica, dell'azione politica ed economica del fascismo è la tendenza di esso all' «imperialismo». Questa tendenza è l'espressione del bisogno sentito dalle classi dirigenti industriali-agrarie italiane di trovare fuori del campo nazionale gli elementi per la risoluzione della crisi della società italiana. Sono in essa i germi di una guerra che verrà combattuta, in apparenza, per l'espansione italiana ma nella quale in realtà l'Italia fascista sarà uno strumento nelle mani di uno 96 FIORI Giuseppe, Op. cit., pagg. 70-79. 97 Ibidem, pag. 78. 98 Idem. 99MANDUCHI Patrizia, La diffusione del pensiero di Gramsci nel mondo arabo: traduzioni, riletture,
prospettive in FIAMMA Lussana / PISSARELLO Giulia (a cura di), La lingua / le lingue di Gramsci e delle sue opere. Scrittura, riscritture, letture in Italia e nel mondo, Rubettino Editore, 2008 Sassari; 246-247.
19
dei gruppi imperialisti che si contendono il mondo.”100 Gramsci, che proprio grazie alle tesi per il Congresso di Lione divenne segretario del Partito Comunista d'Italia101, e che già da un anno e mezzo dirigeva il suo nuovo quotidiano L'Unità102, sfruttò nella stesura della discussione sull'imperialismo appena esposta, la sua recentissima esperienza internazionale. Era stato delegato del PCd'I al IV Congresso del Comintern e, nell'ambito dell'Internazionale Comunista, partecipò a tre congressi e conferenze dal grande respiro internazionale tra il 1922 ed il 1925103. Secondo Derek Boothman, professore ordinario di lingua inglese all'Università degli Studi di Bologna, attento alle questioni riguardanti il pensatore sardo, Gramsci fu fortemente influenzato, durante il IV Congresso del Comintern, dalla relazione sulla Questione Orientale, svolta da Willem Van Ravesteyn e pubblicata il 22 dicembre 1922 su Inprecorr, rivista del Comintern pubblicata a cadenza bisettimanale in quel periodo104. Van Ravesteyn, leader della sinistra comunista olandese, possedeva, grazie alla sua nazionalità, una approfondita conoscenza della realtà indonesiana e di alcuni movimenti islamici nazionalisti operanti nella colonia olandese, particolarmente di “Sarekat Islam”, movimento nazionalista di matrice islamica. Nella sua relazione, il comunista olandese presentò una ricostruzione della caduta dell'impero Ottomano, nonché una riflessione sul colpo di Stato dei “giovani Turchi” del 1913, capeggiati da Enver Pascià, che: “[…] offrì la possibilità di ribellarsi contro l'imperialismo europeo. L'azione di Enver e dei suoi complici fu una chiara manifestazione della crescente rabbia dell'intero mondo islamico contro la politica brutale di violenza dei capitalisti europei cristiani e già a quel tempo si sollevavano delle proteste in tutto il mondo islamico contro la politica di cacciare dall'Europa la Turchia.”105 Van Ravesteyn parlò apertamente dell'impossibilità di allontanare la Turchia dall'Europa, riferendosi ad Istanbul come un punto di contatto obbligato tra Occidente e Oriente, che “stende una mano tanto all'Occidente quanto all'Oriente.”106. Gramsci fece suo quest’approccio, con il suo atteggiamento relativo ai densi legami tra le civiltà, al mondo pensato come un tutt'uno, senza rinnegare le differenze tra le culture e le società. Gramsci venne arrestato dallo Stato fascista il 6 novembre del 1926107, e visse i suoi restanti undici anni da recluso. L'umanista sardo scrisse, nel periodo della prigionia, i suoi Quaderni del carcere, dove, da una cella di pochi metri, volse il suo sguardo verso il mondo esterno, analizzando gli avvenimenti e le culture, ed arrivando, sebbene con pochi cenni, a discutere dei Paesi arabi ed ad analizzare con cenni precisi alcune realtà legate alla religione islamica.
100 FIORI Giuseppe, Op. cit., pag. 233. 101 Idem. 102 Ibidem, pag. 198. 103 BOOTHMAN Derek, Gramsci e il Comintern…, Op. cit., pag. 109. 104 Ibidem, pag. 110. 105 VAN RAVESTEYN Willem, Eastern Question in Inprecorr, vol. 2, no. 116, pagg. 979-988 Citato in
BOOTHMAN Derek, Gramsci e il Comintern…, Op. cit., pagg. 109-110. 106 Idem. 107 FIORI Giuseppe, Op. cit., pag. 233.
20
2.3 Il mondo arabo nei Quaderni del carcere Ne I Quaderni del carcere Antoniot Gramsci tocca a più riprese l’Islam, realtà poco nota e parecchio distante da quella italiana, almeno nel periodo storico del pensatore. Il filo che più spesso lega il mondo arabo al pensiero di Gramsci è senza dubbio la sua riflessione sulla subalternità: “ […] È inutile provare a formulare una definizione precisa di «subalterno» o di gruppo subalterno o di gruppo-classe sociale subalterna in G., dato che, a suo avviso, non costituiscono una singola – e meno che mai omogenea – entità. La categoria di gruppi subalterni-classi sociali subalterne comprende molte altre componenti della società, oltre alla «classe operaia» o al «proletariato» G. non usa «subalterno» o «subalterni» come semplice sostituto di «proletariato» per aggirare la censura carceraria o per altre ragioni. […] L’elemento distintivo dei subalterni e dei gruppi subalterni è la loro disgregazione. Questi gruppi (o classi) sociali non sono molteplici, ma sono anche divisi e piuttosto differenti gli uni dagli altri.”108 Il mondo arabo è subalterno all’Occidente, in quanto colonizzato, le sue genti sono subalterne alle genti europee, in quanto dominate. I Paesi arabi sono presenti nei Quaderni soprattutto perché colonizzati. Tuttavia le analisi dell’umanista sardo sono ben più profonde di semplici constatazioni sulle condizioni politiche e sociali delle popolazioni: in brevi cenni, Gramsci riesce ad esser specifico e lungimirante. Al momento della stesura dei Quaderni il mondo arabo era quasi interamente sotto la dominazione europea; pochi Paesi, come ad esempio l’Egitto109, avevano da breve tempo ottenuto l’indipendenza, ma solo in maniera formale. Nel periodo storico dell’incarcerazione del pensatore sardo vi fu una rinascita delle volontà imperialistiche da parte del mondo europeo, nonché la nascita dei primi movimenti d’ispirazione islamica e dei movimenti fondamentalisti a matrice religiosa nei Paesi colonizzati, in risposta ai leader locali, legati da un rapporto di convenienza ed accondiscendenza con le potenze imperialiste europee110. L’analisi di Gramsci si snoda attorno alla tematica colonialista, mette a nudo le volontà imperialiste dell’occidente e dimostra di avere coscienza delle condizioni di vita arretrate delle masse arabe. Osserva i metodi di studio della realtà sociale ed antropologica araba da parte dei suoi contemporanei, denotandone la prospettiva convenientemente europeista111. L’abissale distanza tra Gramsci ed i suoi contemporanei eurocentrici si ritrova già nel Quaderno 4, al paragrafo 92112, dove, citando l’ispanista Ezio Levi, osserva le influenze della cultura araba nel mondo occidentale; il pensatore sardo, nel corso dei Quaderni nomina queste influenze, riguardanti la cultura a tutto tondo: dalla cucina alla chimica, fino alla scienza113, arrivando ad affermare, nel Quaderno 11, paragrafo 38, che “la
108 BUTTIGIEG Joseph A., subalterno, subalterni in LIGUORI Guido / VOZA Pasquale (a cura di),
Dizionario Gramsciano 1926-1937, Carocci Editore, 2009 Roma, pagg. 826-830. 109 MANDUCHI Patrizia, La diffusione del pensiero di Gramsci, Op. cit., pag. 246-247 110 Idem. 111 Idem. 112 GERRATANA Valentino, (a cura di) GRAMSCI Antonio, Quaderni…, Op. Cit., pagg. 625. 113 BOOTHMAN Derek, Islam e mondializzazione nei Quaderni del carcere in SCHIRRU Giancarlo (a
cura di), Gramsci le culture e il mondo, Viella libreria editrice, 2009 Città di Castello (PG), pag. 228.
21
scienza e la tecnica degli arabi apparivano ai cristiani pura stragoneria”114. Gramsci citò, nel Quaderno 5, al paragrafo 88115, in maniera breve, la fase di dominio arabo-islamico in Sicilia. Ritornando al discorso relativo al colonialismo, troviamo diverse osservazioni del pensatore sardo, dovute alla lettura di alcuni articoli. Nel Quaderno 2 troviamo le voci Asia Minore e Italia, Eritrea, Tripolitania116. Nel primo caso, annotando constatazioni a riguardo di un articolo di Roger Labonne nel Correspondant, analizza i rapporti internazionali tra l’Italia e la Turchia, citando il Patto di Londra117. Nelle pagine successive, la voce sull’Eritrea è derivata da un articolo di Roberto Cantalupo, intitolato La Nuova Eritrea, ed uscito su Nuova Antologia; l’articolo discute della situazione socio-politica del Paese del Corno d’Africa, i dati riportati sono considerati “invecchiati” da Gramsci e dunque non più validi118. Riguardo alla Tripolitania, Gramsci annota solo il nome di un articolo di E. De Cillis119. Sempre all’interno del Quaderno 2, il pensatore sardo svolge un lavoro più puntiglioso su altri Paesi, sottolineando condizioni sociali, politiche, economiche, storiche e culturali: nella voce Etiopia, Gramsci analizza un articolo intitolato L’Etiopia d’oggi, preso da Rivista d’Italia, qui osserva l’indipendenza del Paese in un continente totalmente dominato da potenze straniere, proiettandosi in una discussione sociale, politica, storica e persino geografica120. Il pensatore sardo esprime considerazioni sicuramente più personali sul colonialismo europeo nella voce Italia ed Egitto. Entrando più nello specifico, nel Quaderno 19, analizza la nascita della politica coloniale italiana: “Anche la politica coloniale di Crispi è legata alla sua ossessione unitaria e in ciò che seppe comprendere l’innocenza politica del Mezzogiorno; il contadino meridionale voleva la terra e Crispi, che non gliela voleva (o poteva) dare in Italia stessa, che non voleva fare del “giacobinismo economico” prospettò il miraggio delle terre coloniali da sfruttare. L’imperialismo di Crispi fu un imperialismo passionale, oratorio, senza alcuna base economico-finanziaria […]. Mancava dunque una spinta reale all’imperialismo italiano e ad essa fu sostituita la passione popolare dei rurali ciecamente tesi verso la proprietà della terra: si trattò di una necessità di politica interna da risolvere, deviandone la soluzione all’infinito.”121 Sempre sul tema del colonialismo, nel nono Quaderno, alla voce Intellettuali. Noterelle di cultura inglese, vi è un interessante commento ad un articolo di Guido Ferrando su Marzocco: in poche righe Gramsci si interroga sulla questione linguistica delle colonie e sull’importanza che il linguaggio ha per una cultura: “[…] Uno dei temi fondamentali del Congresso [Gramsci parla di un convegno sull’educazione e sulla cultura nel Commonwealth, N.D.A.] era quello dell’interracial understanding, del come promuovere e sviluppare una migliore intesa tra le diverse razze, specialmente tra gli europei colonizzatori e gli africani e gli asiatici colonizzati […] Tra i tanti temi discussi fu quello della lingua. Si trattava cioè di decidere se fosse opportuno insegnare anche alle popolazioni semiselvagge dell’Africa a leggere
114 GERRATANA Valentino, (a cura di) GRAMSCI Antonio, Quaderni…, Op. cit., pagg.1457-1458. 115 Ibidem, pagg. 618-620. 116 Ibidem, pagg. 174-224. 117 Ibidem, pagg. 174-175. 118 Ibidem, pagg. 204-205. 119 Ibidem, pag. 224. 120 Ibidem, pagg. 175-179. 121 Ibidem, pagg. 2018-2019.
22
prendendo per base l’inglese anziché il loro idioma nativo, se fosse meglio mantenere il bilinguismo o tendere, per mezzo dell’istruzione a far scomparire la lingua indigena. Ormsby Gore, ex sottosegretario alle colonie, sostenne che era un errore il tentare di snaturalizzare le tribù africane e si dichiarò favorevole ad una educazione tendente a dare agli africani il senso della propria dignità di popolo e la capacità di governarsi da sé.”122 Le analisi generali sul colonialismo portarono Gramsci ad analizzare e descrivere le peculiarità sociali e culturali dei Paesi presi in esame. Sicché dovette ricercare ed annotare anche i gruppi di pressione o i gruppi e movimenti religiosi presenti. Questo porta il pensatore sardo ad occuparsi più concretamente dell’Islam. Nella dissertazione sullo Yemen, nel Quaderno 2, alla voce Italia e Yemen nella nuova politica arabica, commentando un articolo de la Rivista d’Italia, Gramsci definisce in una nota i Wahhabiti e parte della storia a loro collegata: “Wahhabiti: setta musulmana fondata da Abd-el-Wahhab che cercò di allargarsi con le armi; ebbe molte vittorie ma fu ricacciata nel deserto dal famoso Mehemet Alì e da suo figlio Ibrahim pascià. Il sultano Abdallah, catturato, fu giustiziato a Costantinopoli (dicembre 1818) e suo figlio Turki a stento riuscì a mantenere uno staterello nel Negged. I Wahhabiti vogliono tornare alla pura lettera del Corano, sfrondando tutte le superstrutture tradizionali (culto dei santi, ricche decorazioni delle moschee, pompe religiose). Appena conquistata la Mecca, hanno abbattuto cupole e minareti, distrutto i mausolei di santoni celebri, fra cui quello di Khadigia, la prima moglie di Maometto, ecc. Ibn Saud emanò ordinanze contro il vino e il fumo, per la soppressione del bacio della “pietra nera” e dell’invocazione a Maometto nella formula della professione di fede e nelle preghiere. Le iniziative puritane dei Wahhabiti sollevarono proteste nel mondo musulmano; i governi di Persia e dell’Egitto fecero rimostranze. Ibn Saud si moderò.”123 In questa analisi del tradizionalismo tipico dei Wahhabiti, Gramsci nomina il “culto dei santi”; nel Quaderno 5 affronterà in maniera più precisa l’argomento, commentando un articolo di Bruno Ducati nella rivista Nuova Antologia, intitolato I santi dell’Islam. “Assenza di un clero regolare che serva da trait-d’union tra l’Islam teorico e le credenze popolari. Bisognerebbe studiare bene il tipo di organizzazione ecclesiastica dell’Islam e l’importanza culturale delle Università teologiche (come quella del Cairo) e dei dottori. Il distacco tra intellettuali e popolo deve essere molto grande, specialmente in certe zone del mondo musulmano: così è spiegabile che le tendenze politeiste del folklore rinascano e cerchino di adattarsi al quadro generale del monoteismo maomettano […] Il fenomeno dei santi è specifico dell’Africa settentrionale, ma ha una certa diffusione anche in altre zone. Esso ha la sua ragion d’essere nel bisogno (esistente anche nel Cristianesimo) popolare di trovare intermediari tra sé e la divinità. Maometto, come Cristo, fu proclamato, - si proclamò – l’ultimo dei profeti, cioè l’ultimo legame vivente tra la divinità e gli uomini; gli intellettuali (sacerdoti o dottori) avrebbero dovuto mantenere questo legame attraverso i libri sacri; ma a una tal forma di organizzazione religiosa tende a diventare razionalistica e intellettualistica […] mentre il popolo primitivo tende a un misticismo proprio, rappresentato dall’unione con la divinità con la mediazione dei santi […] Questo movimento nuovo dell’Islam è il sufismo. I Santi musulmani sono uomini
122 GERRATANA Valentino, (a cura di) GRAMSCI Antonio, Quaderni…, Op. cit., pagg. 2018-2019. 123 Ibidem, pagg. 186-188.
23
privilegiati che possono, per speciale favore, entrare in contatto con Dio, acquistando una perenne virtù miracolosa e la capacità di risolvere i problemi e i dubbi teologici della ragione e della coscienza. Il sufismo, organizzatosi a sistema ed esternatosi nelle scuole sufiche e nelle confraternite religiose, sviluppò una vera teoria della santità e fissò una vera gerarchia dei santi. L’agiografia popolare è più semplice di quella sufica. Sono santi per il popolo i più celebri fondatori o capi di confraternite religiose; ma anche uno sconosciuto, un viandante che si fermi in una località a compiere opere di ascetismo e benefici portentosi a favore delle popolazioni circostanti, può essere proclamato santo dalla pubblica opinione. Molti santi ricordano i vecchi iddii delle religioni vinte dall’Islam. Il Marabutismo dipende da una fonte della santità musulmana diversa dal sufismo: Murābit (marabutto) vuol dire che è nel ribāt, cioè nel luogo fortificato della frontiera dal quale irrompere, nella guerra santa, contro gli infedeli. Nel ribāt il culto doveva essere più austero, per la funzione di quei [soldati] presidiari, più fanatici e costituiti spesso di volontari (arditi dell’Islam): quando lo scopo militare perdé d’importanza, rimase un particolare abito religioso e i “santi” più popolari ancora di quelli sufici.”124 La puntualità dell’analisi, dato il periodo storico e date le poche informazioni a cui Gramsci aveva accesso, per via della sua condizione di detenuto, è stupefacente. In questa nota, l’umanista sardo attua un parallelismo tra Islam e Cristianesimo: paragone presente anche nel Quaderno 2, al paragrafo La nuova evoluzione dell’Islam, analisi di un articolo del diplomatico afghano Iqbāl ‘Ali Shāh, con un’introduzione di Michelangelo Guidi, noto islamista, uscito su Nuova Antologia: “Mi pare che il problema sia più semplice di quanto lo si voglia far apparire, per il fatto che implicitamente si considera il “cristianesimo” come inerente alla civiltà moderna, o almeno non si ha il coraggio di porre la quistione dei rapporti fra cristianesimo e civiltà moderna. Perché l’Islam non potrebbe fare ciò che ha fatto il cristianesimo? Mi pare anzi che l’assenza di una massiccia organizzazione ecclesiastica del tipo cristiano-cattolico dovrebbe rendere più facile l’adattamento. Se si ammette che la civiltà moderna nella sua manifestazione industriale-economico-politica finirà col trionfare in Oriente (e tutto prova che ciò avviene e che anzi queste discussioni sull’Islam avvengono perché c’è una crisi determinata appunto da questa diffusione di elementi moderni), perché non bisogna concludere che necessariamente l’Islam si evolverà? Potrà rimanere tale quale? No: già non è più quello di prima della guerra. Potrà cadere d’un colpo? Assurdo. Potrà essere sostituito da una religione cristiana? Assurdo pensarlo per le grandi masse […] In realtà la difficoltà più tragica per l’Islam è data dal fatto che una società intorpidita da secoli di isolamento e da un regime feudale imputridito […] è troppo bruscamente messa a contatto con una civiltà frenetica che è già nella sua fase di dissoluzione. Il Cristianesimo ha impiegato nove secoli a evolversi e ad adattarsi, lo ha fatto a piccole tappe, ecc.: l’Islam è costretto a correre vertiginosamente, ma esso in realtà reagisce proprio come il Cristianesimo: la grande eresia su cui si fonderanno le eresie propriamente dette è il “sentimento nazionale” contro il cosmopolitismo teocratico. Appare poi il motivo del ritorno alle “origini” tale e quale come nel cristianesimo; alla purezza dei primi testi religiosi contrapposta alla corruzione della gerarchia ufficiale: i Wahhabiti rappresentano proprio questo e il Sirdar Ikbal Ali Shah spega con questo principio le riforme di Kemal Pascià in Turchia: non si tratta di una “novità” ma di un ritorno all’antico, al puro, ecc. ecc.”125
124 GERRATANA Valentino, (a cura di) GRAMSCI Antonio, Quaderni…, Op. cit., pagg. 621-623 125 Ibidem, pagg. 246-248.
24
Gramsci allude, in questa analisi, ad un tema ancora oggi molto attuale: ovvero lo scontro e la possibilità di convivenza tra l’Islam e la modernità. Il parallelismo tra la realtà islamica e quella cristiano-cattolica è molto stretto, poiché, come ci suggerisce Derek Boothman126, Gramsci si approccia all’Islam così come si approccia al Cristianesimo. L’analisi sull’Islam di Gramsci nei Quaderni si limita a queste poche note. Lo scarso numero di trattazioni sul mondo arabo in Gramsci viene ripagato dalla qualità delle sue discussioni: attuali e sorprendentemente precise nonostante il periodo storico.
126 BOOTHMAN Derek, Gramsci e l’Islam negli articoli giornalistici e nei Quaderni del carcere, in
www.mercantedivenezia.org, pag. 10.
25
Le categorie gramsciane nel pensiero arabo
3.1 La fortuna di Gramsci nel mondo arabo Discutere sulla fortuna di Gramsci nel mondo arabo non è semplice come si potrebbe pensare: fare la conta delle pubblicazioni in lingua araba, utilizzando la Bibliografia gramsciana on-line, darebbe un risultato non rappresentativo e piuttosto deludente. Se è vero che la produzione in lingua araba riguardante il filosofo è piuttosto esigua, all'incirca una quarantina di volumi127, è anche vero che, come già detto, Gramsci è stato studiato nei Paesi islamici con testi anzitutto scritti in lingua francese ed inglese, e solo in terzo luogo in arabo. L'umanista sardo penetra diventando al contempo oggetto e strumento di studio: gli intellettuali arabi attingono i propri meccanismi di interpretazione dalle categorie concettuali gramsciane, in ogni ambiente del sapere ideologico e politico128. Il consenso ricevuto dal pensiero di Gramsci è da ricercarsi nella sua straordinaria duttilità: il marxismo gramsciano è un marxismo aperto, antidogmatico. Rende possibile porre delle questioni, Gramsci rende fruibile e più leggero Marx129, con un metodo di studio “alla portata di ogni uomo libero”130. Il merito del pensatore sardo è quello di non turbare la specificità araba: Gramsci si tira fuori dalla polemica degli anni settanta relativamente alle ideologie importate, non si impone come un pensatore onnisciente ed onnipresente, è fortemente italiano, legato al meridione ed alla Sardegna. Il suo pensiero è universale proprio perché particolare e specifico131, dedicato all'analisi di situazioni peculiari, non inteso per esser valido in qualsiasi luogo o istante storico. Il legame affettivo che stringe gli arabi a Gramsci si può ritrovare già in quanto appena scritto: un pensatore legato alle particolarità della sua cultura. È certo che, a contribuire ad un legame di tipo sentimentale, vi sia anche la peculiarità della vita del pensatore sardo: Gramsci fu un grande militante politico, di grande ispirazione per via della sensibilità araba per la cultura, per via del tentativo di questi popoli di identificarsi e lottare attraverso la propria cultura132. Gramsci è visto come un compagno di lotta dei perseguitati politici, soprattutto di coloro i quali, senza distinzioni politiche particolari, si ritrovano a dover affrontare la realtà carceraria; questi lessero e continuano a leggere Gramsci, affiancandosi a lui non solo dal punto di vista culturale, ed in alcuni casi politico, ma anche e soprattutto per la familiarità con la sua condizione umana133. Analizzata la vicinanza di Gramsci agli intellettuali arabi, sarà scopo di questo capitolo passare in rassegna le categorie concettuali gramsciane che hanno avuto maggiore successo nel mondo arabo, dando adito ad affascinanti analisi della società e della cultura dei Paesi arabi.
127 MANDUCHI Patrizia, Antonio Gramsci e il dibattito intellettuale…, Op. cit., pag. 138. 128 Idem. 129 LABIB Tahar, Gramsci nel mondo, Op. cit., pag. 212. 130 MANDUCHI Patrizia, Antonio Gramsci e il dibattito intellettuale…, Op. cit., pag. 141. 131 LABIB Tahar, Gramsci nel mondo arabo, Op. cit., pag. 212. 132 Idem. 133 MANDUCHI Patrizia, Antonio Gramsci e il dibattito intellettuale…, Op. cit., pagg. 141-142.
26
3.2 Egemonia Il concetto di egemonia risulta essere uno dei temi gramsciani più dibattuti nel mondo arabo. Per egemonia si intende il potere politico esercitato con il consenso e non solo come dominio134; per una migliore interpretazione del termine, ci affidiamo alla definizione data dal Dizionario Gramsciano, opera edita nel 2009 dalla International Gramsci Society, avente lo scopo di catalogare ed esplicare le categorie concettuali gramsciane, rendendo così maggiormente fruibili al pubblico i Quaderni: “La prima occorrenza del lemma «egemonia» è in Q 1, 44, 41, in cui incontriamo l'espressione «egemonia politica», espressione introdotta da G. tra virgolette, a indicare la sua particolare valenza rispetto all'accezione generica di “preminenza”, “supremazia”, che si ritrova a partire dal prosieguo dello stesso appunto, finendo per costruire uno spettro estremamente ampio di significati in un ambito di contesti che va dall'economia alla letteratura, dalla religione all'antropologia, dalla psicologia alla linguistica. […] Egemonia culturale che a sua volta non va contrapposta a quella politica, come testimonia l'uso di espressioni quali «egemonia politico-culturale», «politico-intellettuale». «intellettuale, morale e politica» e simili […] Per quanto riguarda il significato da attribuire al termine «egemonia», fin dall'inizio (Q 1, 44, 41) G. oscilla tra un senso più ristretto di «direzione», contrapposto a «dominio», e uno più ampio comprensivo di entrambi (direzione più dominio), Egli infatti scrive che «una classe è dominante in due modi, è cioè “dirigente” e “dominante”. È dirigente delle classi alleate, è dominante delle classi avversarie. Perciò una classe già prima di andare al potere può essere “dirigente” (e deve esserlo): quando è al potere diventa dominante ma continua ad essere anche “dirigente”.”135 Faysal Darraj in Omaggio a Gramsci, utilizza il concetto di egemonia discutendo la mancanza di democrazia nei Paesi islamici. Darraj ricerca le radici del problema, spesso trattato in maniera semplicistica dal mondo occidentale, che tende a scaricare tutte le responsabilità sulla religione islamica. Nell'analisi dell'intellettuale arabo, vi è una chiara correlazione tra colonialismo e dispotismo136: “[...] l'egemonia, come la definisce Gramsci, non esiste nei nostri Paesi. Lo stato locale conta sulla repressione, e il sistema capitalista delle metropoli approva e sostiene solo i governi repressivi capaci di mantenere una certa forma di divisione del lavoro. Tale forma di coercizione a doppio taglio rende la lotta nazionale di liberazione una lotta di classe e la lotta di classe una lotta nazionale.”137 Si nota, nell'immediato, il riconoscimento da parte di Darraj dell'egemonia intesa come potere assecondato dalla società civile e della sua assenza dovuta ai rapporti di potere tra élite locali e potenti gruppi di pressione stranieri. Nella frase finale del testo riportato, Darraj esprime la necessità di un impegno collettivo138 per il raggiungimento di uno Stato non dispotico, o quantomeno legittimato dal consenso. Il concetto di egemonia viene utilizzato in ottica moderna anche da Edward Said nei suoi lavori. In Covering Islam del 1981, Gramsci è presente, pur non essendo nominato.
134 COSPITO Giuseppe, egemonia in LIGUORI Guido / VOZA Pasquale (a cura di), Dizionario
Gramsciano 1926-1937, Carocci Editore, 2009 Roma, pagg. 266-269. 135 Idem. 136 MANDUCHI Patrizia, Antonio Gramsci e il dibattito intellettuale…, Op. cit, pag. 143. 137 DARRAJ Faysal, in AA.VV., Omaggio a Gramsci, Tema, 1994 Cagliari, pag. 48. 138 Idem.
27
In quest'opera il celebre autore palestinese si interroga sul modo in cui i mass-media e gli esperti forgiano l'opinione pubblica attraverso il controllo dell'informazione. Said analizza il linguaggio dei media: il suo concetto di opinione pubblica risulta simmetrico a quello di “libertà organica” in Gramsci, usato per collegare il comune pensare all'egemonia politica. La libertà organica dell'umanista sardo e l'opinione pubblica di Said sono da intendersi come punto di forza del consenso politico139.
3.3 Società civile Il concetto gramsciano di società civile è forse il meglio elaborato dagli studiosi arabi: come scritto in precedenza (§1.6), negli anni ottanta in Libano l'esercizio sulla società civile fu il fulcro degli studi gramsciani del Centro di studi sull’Unità araba di Beirut. Il concetto di società civile si intrinseca con quello di egemonia negli scritti di Gramsci; è una locuzione molto duttile ed al contempo piuttosto complessa, come si vedrà dalla definizione datane dal Dizionario Gramsciano: “Scrive G. nel paragrafo intitolato “Nozioni enciclopediche. La società civile”: «Occorre distinguere la società civile come è intesa dallo Hegel e nel senso in cui è spesso adoperata in queste note (cioè nel senso di egemonia politica e culturale di un gruppo sociale sulla intera società, come contenuto etico dello Stato) dal senso che le danno i cattolici, per i quali la società civile è invece la società politica o lo Stato, in confronto della società famigliare e della Chiesa» (Q 6, 24, 703) [...] la nozione di società civile è la risultante dell'indagine sull'egemonia e questa è legata a doppio filo alla questione degli intellettuali. Siamo all'interno di quello che G. definisce lo «Stato integrale», insieme di società civile e società politica. […] La società civile in senso gramsciano è la sfera dell'attività politica per eccellenza, in quanto luogo in cui compaiono sulla scena le organizzazioni cosiddette private (sindacati, partiti, organizzazioni di ogni tipo) che hanno come loro obiettivo la trasformazione del modo di pensare degli uomini. Per quel che concerne la società politica in senso stretto, che predispone gli interventi coercitivi della legge e del diritto, è anch'essa un'istanza della trasformazione sociale.”140 Il concetto fu ampiamente elaborato con la nascita delle nuove categorie sociali: il sociologo algerino Ali el-Kenz afferma che nei Paesi arabi l'accostamento a Gramsci sia nato grazie ad un allontanamento dalla concezione teorica dello Stato, con una attenzione più forte verso le “organizzazioni private” descritte da Gramsci, ovvero i giornalisti, gli attivisti ed i partiti politici, i sindacati, le associazioni per i diritti umani e femministe141. Ad associarsi all'analisi del sociologo nordafricano, vi è anche l'iracheno F. Jabburi Ghazul, che osserva l'attualità delle tematica gramsciana di società civile, aprendo un dialogo con i testi del pensatore sardo, lontani geograficamente e cronologicamente, ma al contempo vicini intellettualmente alla realtà araba142. In F. Jabburi Ghazul ritorna la tematica del Gramsci universale perché provinciale, eterno perché specifico.
139 PALA Mauro, Said e Gramsci: dall'egemonia alla mondanità del contrappunto in FIAMMA Lussana
/ PISSARELLO Giulia (a cura di), La lingua / le lingue di Gramsci e delle sue opere. Scrittura, riscritture, letture in Italia e nel mondo, Rubettino Editore, 2008 Sassari, pagg. 265-266.
140 TEXIER Jacques, società civile in LIGUORI Guido / VOZA Pasquale (a cura di), Dizionario Gramsciano 1926-1937, Carocci Editore, 2009 Roma, pagg. 266-269.
141 MANDUCHI Patrizia, Antonio Gramsci e il dibattito intellettuale…, Op. cit, pag. 143. 142 Idem.
28
Il concetto di società civile risulta essere utile poiché moderno, vincente poiché capace di mostrare chiaramente, in una società in rapido mutamento, le categorie d'interesse per la costruzione di uno Stato nuovo; non monolitico, non dipendente, nella sua interezza, da un'ideologia unica, figlia di un partito unico, con a sostegno associazioni direttamente collegate alle strutture di potere. La società civile di Antonio Gramsci è estremamente composita e complessa; pur non avendo la pretesa di rappresentare le sfaccettature della realtà attraverso modelli semplicistici, resta un solido appiglio in momenti di incertezza intellettuale e di crisi politica.
3.4 L'intellettuale organico e l'intellettuale tradizionale Il primo tema fortemente gramsciano a coinvolgere gli studiosi dei Paesi arabi fu il concetto di intellettuale; trattato sin dai primi lavori citanti il pensatore sardo, incuriosì tanti studiosi legati ai Paesi islamici: Abdelmalek, Charabi, Laroui, Said, Belhassan, Jaghloul e tanti altri che si occuparono dell'intellighenzia e degli intellettuali nei loro Paesi d'origine, in modalità e con approcci differenti, ma servendosi, comunque, delle analisi fatte da Gramsci sul tema. Vediamo, a tal proposito, cosa intendesse il pensatore sardo quando si riferiva agli intellettuali organici: “L'ampia trattazione della questione degli intellettuali, presente nel Q 4, è dichiaratamente suscitata e attraversata da due interrogativi di fondo, strettamente intrecciati. Il primo concerne il problema se gli intellettuali siano un gruppo sociale autonomo o se invece ogni gruppo sociale abbia una propria categoria di intellettuali; il secondo chiama in causa un altro problema: come individuare e definire i «i limiti massimi dell'accezione di “intellettuale”» (Q 4, 49, 475). In relazione al primo punto, G. segnala una delle forme più importanti che sino ad allora, a suo avviso, ha assunto «il processo storico di formazione delle categorie intellettuali» affermando che ogni gruppo sociale, «nascendo sulla base originaria di una funzione essenziale nel mondo della produzione economica, crea insieme, organicamente, un ceto o più ceti di intellettuali che gli danno omogeneità e consapevolezza della propria funzione nel campo economico», sicché l'imprenditore capitalista crea con sé l'economista, lo scienziato dell'economia politica» (ivi, 474-5). Questo nucleo di riflessione può chiarirsi fino in fondo solo in connessione con la risposta che G. si adopera a fornire al secondo interrogativo «quali sono i limiti massimi nell'accezione di “intellettuale”?». […] egli in promo luogo pone l'accento su quello che gli pare «l'errore metodico» più diffuso: vale a dire che l'errore di cercare il carattere dell'attività intellettuale della natura, nell'intrinseco di essa e non invece nel sistema di rapporti in cui tale attività […] viene a trovarsi «nel complesso generale dei rapporti sociali» (ivi, 475-6). Per G. questo è un punto fondamentale: evitare quell'errore metodico significa saper guardare alle funzioni “organizzative” e “connettive” degli intellettuali, vale a dire alle funzioni che essi svolgono, in forme di volta in volta peculiari e storicamente determinate, nei processi di formazione dell'egemonia. […] Sulla base di queste analisi e considerazioni si può comprendere quanto la nozione di intellettuale organico sia stata, tra le nozioni gramsciane, quella più soggetta (forse ancor più della nozione di egemonia) a equivoci interpretativi e a una varietà di semplificazioni e “riduzioni”.”143
143 VOZA Pasquale, intellettuali organici in LIGUORI Guido / VOZA Pasquale (a cura di), Dizionario
29
E quale fosse per Gramsci il significato di intellettuale tradizionale: “[…] Egli […] definisce con nettezza la «formazione degli intellettuali tradizionali» come «il problema storico più interessante» (Q 1, 49, 477) […] G. argomenta la sua distinzione tra gli intellettuali come categoria organica e gli intellettuali come categoria tradizionale. Egli osserva che ogni gruppo sociale, «nascendo sulla base originaria di una funzione essenziale nel mondo della produzione economica, crea insieme, organicamente, un ceto o più ceti di intellettuali che gli danno omogeneità e consapevolezza della propria funzione nel campo economico». […] Ma ogni gruppo sociale, emergendo alla storia dalla struttura economica, trova o ha trovato (almeno nella storia finora svoltasi) delle «categorie intellettuali preesistenti», le quali si presentano come figure di una continuità storica ininterrotta, non messa in discussione nemmeno dai più complessi mutamenti sociali e politici. Dagli ecclesiastici («monopolizzatori per lungo tempo di alcuni dei servizi essenziali») a Croce (che si sente «legato ad Aristotele più che ad Agnelli», ivi, 475), essi che costituiscono la «categoria tradizionale» (ivi, 477), avvertono «con “spirito di corpo”» la continuità della loro condizione e qualifica intellettuale, al punto di determinare l'“apparenza” di sé come un gruppo sociale indipendente, con i suoi propri caratteri, con una certa autonomia dal gruppo sociale dominante (ivi, 475).”144 La distinzione, o meglio, la contrapposizione tra le due categorie concettuali risulta essere necessaria per comprenderne l'utilità nello studio sociale della realtà araba. Se l'intellettuale tradizionale è stabile, secolare, invariato nei momenti di cambiamento, l'intellettuale organico risulta mutevole, rinnovato, figlio delle necessità economiche. Come già accennato in precedenza, il principale momento di rottura storica del Novecento arabo fu quello del disfattismo, tra il '67 ed il '73, con lo smarrimento iniziale e la nascita dell'islamismo. Momento che coincide con l'ingresso di Gramsci nella società araba, proprio per la nascita di nuove forme sociali, politiche e culturali, per la nascita di nuove forme tese alla costruzione di una società civile, nonché per la pressante necessità di contrapposizione tra intellettuale tradizionale ed intellettuale organico. Il concetto di intellettuale gramsciano è utilizzato in una realtà diametralmente opposta rispetto a quella immaginata dall'umanista sardo: nel pensiero radicale islamico i lemmi intellettuale organico, tradizionale e collettivo sono concetti d'enorme importanza, poiché l'islamismo è, in questo momento storico, mutazione e rinnovamento145. I partiti d'ispirazione marxista, comunista, socialista non riuscirono a fare altrettanto, per la loro scarsa diffusione ed, al contempo, per il loro monolitismo filo-sovietico prima, ed in seguito per le conseguenze del crollo del muro di Berlino e la successiva dissoluzione dell'ideologia. I movimenti di sinistra non riuscirono ad elaborare una sintesi unitaria attorno al cambiamento storico, culturale e sociale, spaccandosi tra anti-islamisti, difensori della laicità dello Stato e filo-islamisti146. Il rapporto di giunzione tra militanti islamici e militanti di sinistra è figlio, anzitutto, della necessità di fare fronte unico nei confronti del potere statale repressivo, dispotico ed autoritario nella gran parte dei Paesi arabi. Il distacco dalla forma di Stato dittatoriale e dalle repressioni avvicina gli intellettuali delle minoranze agli islamisti anche idealmente: unità di vedute sono
Gramsciano 1926-1937, Carocci Editore, 2009 Roma, pagg. 431-432.
144VOZA Pasquale, Op. cit., pagg. 432-433. 145MANDUCHI Patrizia, Antonio Gramsci e il dibattito intellettuale…, Op. cit., pag. 145. 146Idem.
30
riscontrabili su tematiche complesse ed importanti, quali il rapporto tra mondo arabo ed occidente, su democrazia e società civile, nonché sulla annosa questione palestinese147. Queste chiare prese di posizione da parte del militante islamico danno ragione all'analisi del già citato Abdelkader Jaghloul che, nella sua opera Intellighenzia nel Maghreb, personalizza la distinzione tra intellettuale organico ed intellettuale tradizionale. Egli opera infatti, come già detto, un'inversione tra intellettuale tradizionale ed intellettuale organico. L'intellettuale tradizionale per Jaghloul non è il militante religioso: quest'ultimo diviene organico, o, per usare il termine coniato dal sociologo algerino, tradizionalizzante, mentre l'intellettuale laico tende ad essere tradizionale148. Jaghloul arriva ad individuare come organici i militanti fondamentalisti salafiti, e tradizionali gli intellettuali occidentalizzati, definiti dal sociologo algerino conservatori, tradizionalisti e legati ad un pensiero europeo, anche se non eurocentrico149.
3.5 Note conclusive L’utilizzo di Gramsci nella società araba è uno studio in prospettiva. I mutamenti rapidi che le popolazioni arabe stanno incontrando in questo drammatico inizio di decennio possono esser visti, o potranno esser studiati, in futuro, sotto una prospettiva gramsciana. Basti pensare alla continua e costante ricerca dello stato democratico, ed alla questione riguardante la società civile: quali sono le prospettive per la costruzione di quest’ultima? Chi sono i protagonisti del mutamento e della nascita di una società nuova? Chi possiede le caratteristiche per risultare una forza egemonica? Il dibattito sugli intellettuali, da sempre vivace nella società araba, resta ancora acceso per le sfide poste da questo inizio di millennio: ci si domanda se l’inversione operata da Jaghloul tra intellettuali organici e tradizionali sia ancora valida, o se, nel frattempo, la realtà abbia assunto nuove sfaccettature e se vi sia stata la nascita di nuove classi intellettuali, grazie alle maggiori possibilità di formazione ed informazione date dalle nuove tecnologie. Le questioni qui poste restano aperte: un bilancio affrettato sarebbe erroneo ed un utilizzo forzato delle categorie concettuali gramsciane risulterebbe essere inutile o dannoso per la comprensione della realtà. Gramsci è presente nel dibattito politico e negli studi storici e sociali della realtà araba: il tempo e gli studi ci mostreranno quale sarà il suo ruolo in queste realtà mutevoli, variabili, in divenire.
147MANDUCHI Patrizia, Antonio Gramsci e il dibattito intellettuale…, Op. cit., pag. 146. 148LABIB Tahar, Gramsci dans le discours des intellectuels…, Op. cit., pag.32. 149Intervista sul mensile Algérie Actualités, n.846, gennaio 1982, citato in MANDUCHI Patrizia,
Antonio Gramsci e il dibattito intellettuale…, Op. cit., pag. 147
31
Bibliografia
ABDEL-MALEK Anouar, La pensée politique arabe contemporaine, Editions du Seuil, 1970 Parigi; BALDUSSI Annamaria / MANDUCHI Patrizia (a cura di), Gramsci in Asia e in Africa Aipsa Edizioni, 2010 Cagliari; BOBBIO Norberto, Gramsci e la concezione della società civile, in BOBBIO Norberto, Etica e politica. Scritti di impegno civile, Arnoldo Mondadori Editore, 2009 Milano; BOOTHMAN Derek, Islam e mondializzazione nei Quaderni del carcere in SCHIRRU Giancarlo (a cura di), Gramsci le culture e il mondo, Viella libreria editrice, 2009 Città di Castello (PG); BOOTHMAN Derek, Gramsci e il Comintern sui mondi arabo, musulmano e palestinese-ebreo, in BALDUSSI Annamaria / MANDUCHI Patrizia (a cura di), Gramsci in Asia e in Africa, Aipsa Edizioni, 2010 Cagliari; BRONDINO Michele / LABIB Tahar, Introduction, in BRONDINO Michele / LABIB Tahar (a cura di), Gramsci dans le monde Arabe, Alif Éditions, 1994 Tunisi; BUTTIGIEG Joseph A., subalterno, subalterni in LIGUORI Guido / VOZA Pasquale (a cura di), Dizionario Gramsciano 1926-1937, Carocci Editore, 2009 Roma, pagg. 826-830; CAMMETT M. John, Antonio Gramsci and the Origins of Italian Communism, Stanford University Press, 1967 Stanford;
CHARABI ICHAM, Arab intellectuals and the West, the formative years 1875-1914, The Johns Hopkins Press published in cooperation with The Middle East Institute, Baltimore 1970;
COSPITO Giuseppe, egemonia in LIGUORI Guido / VOZA Pasquale (a cura di), Dizionario Gramsciano 1926-1937, Carocci Editore, 2009 Roma, pagg. 266-269 FIORI Giuseppe, Vita di Antonio Gramsci, Edizioni Laterza, 1966 Bari; DARRAJ Faysal, in AA.VV., Omaggio a Gramsci, Tema, 1994 Cagliari; GERRATANA Valentino (a cura di) GRAMSCI Antonio, Quaderni del carcere, 4 voll., Einaudi, Torino 1975; HOBSBAWM Eric J., Come cambiare il mondo. Perché riscoprire l'eredità del marxismo, RCS Libri Spa, 2011 Milano; GRAMSCI Antonio / RICCI François / BRAMANT Jean (a cura di), Gramsci dans le texte, Éditions sociales, 1975 Parigi; LABIB Tahar, Gramsci dans le discours des intellectuels arabes, in BRONDINO
32
Michele / LABIB Tahar (a cura di), Gramsci dans le monde Arabe, Alif Éditions, 1994 Tunisi; LABIB Tahar, Gramsci nel mondo arabo in RIGHI Maria Luisa (a cura di), Gramsci nel mondo, Atti del convegno internazionale di studi gramsciani Formia, 25-28 ottobre 1989, Fondazione Istituto Gramsci, 1995 Roma; LIGUORI Guido, Gramsci conteso: interpretazioni, dibattiti e polemiche 1922-2012, Editori Riuniti, 2012 Roma. LO PIPARO Franco, I due carceri di Gramsci: la prigione fascista e il labirinto comunista, Donzelli, 2012 Roma. MACIOCCHI Maria Antonietta, Pour Gramsci, Éditions du Seuil, 1971 Parigi; MAHDI Amel, Muqaddimat Nadhariyya li-Dirasat ‘Athar al-Fikr al Ichitiraki fi Harakat al –Taharrur al-Watani: fi al-Tanaqudh, éd. Dar al-Farabi, Beirut, 1973; MANDUCHI Patrizia, Antonio Gramsci e il dibattito intellettuale nel mondo arabo contemporaneo in BALDUSSI Annamaria / MANDUCHI Patrizia (a cura di), Gramsci in Asia e in Africa, Aipsa Edizioni, 2010 Cagliari; MANDUCHI Patrizia, La diffusione del pensiero di Gramsci nel mondo arabo: traduzioni, riletture, prospettive in FIAMMA Lussana / PISSARELLO Giulia (a cura di), La lingua / le lingue di Gramsci e delle sue opere. Scrittura, riscritture, letture in Italia e nel mondo, Rubettino Editore, 2008 Sassari; ORSINI Alessandro, Gramsci e Turati: le due sinistre, Rubbettino, 2011 Soveria Mannelli. PALA Mauro, Said e Gramsci: dall'egemonia alla mondanità del contrappunto in FIAMMA Lussana / PISSARELLO Giulia (a cura di), La lingua / le lingue di Gramsci e delle sue opere. Scrittura, riscritture, letture in Italia e nel mondo, Rubettino Editore, 2008 Sassari;
RACHID Amina, Qadaya al-Muhitama‘ al-Madani al-‘Arabi fi Dhaw’ Utruat Grahmchi, Markaz al-Buhut al’Arabiyya, Il Cairo 1995;
RIGHI Maria Luisa (a cura di), Gramsci nel mondo, Atti del convegno internazionale di studi gramsciani Formia, 25-28 ottobre 1989, Fondazione Istituto Gramsci, 1995 Roma;
SAID W. Edward, Orientalism, Vintage Books, New York 1979;
SAID Edward, Orientalismo, Feltrinelli, 1999 Milano; TEXIER Jacques, società civile in LIGUORI Guido / VOZA Pasquale (a cura di), Dizionario Gramsciano 1926-1937, Carocci Editore, 2009 Roma; VACCA Giuseppe, SCHIRRU Giuseppe (a cura di), Studi gramsciani nel mondo. 2000-2005, Fondazione Istituto Gramsci, il Mulino, Bologna 2007, pagg. 79-117.
33
VACCA Giuseppe, Prefazione in SCHIRRU Giancarlo (a cura di) Gramsci, le culture e il mondo, Viella libreria editrice, 2009 Città di Castello (PG); VAN RAVESTEYN Willem, Eastern Question in Inprecorr, vol. 2, no. 116; VOZA Pasquale, intellettuali tradizionali in LIGUORI Guido / VOZA Pasquale (a cura di), Dizionario Gramsciano 1926-1937, Carocci Editore, 2009 Roma, pagg. 431-433;
34
Sitografia
Bibliografia Gramsciana on line, http://www.fondazionegramsci.org/5_gramsci/ag_bibliogramsci.htm; BOOTHMAN Derek, Gramsci e l’Islam negli articoli giornalistici e nei Quaderni del carcere, in www.mercantedivenezia.org; International Gramsci Society, http://www.internationalgramscisociety.org/; TREVOR Stanley, Definition: Islamism, Islamist, Islamiste, Islamicist, Perspectives on World History and Current Events, 2005. URL: http://www.pwhce.org/islamism.html.


































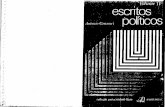













![La dominación cultural, un encuentro entre Gramsci y Bourdieu [traducción del inglés]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631a058efd704e1d3909f141/la-dominacion-cultural-un-encuentro-entre-gramsci-y-bourdieu-traduccion-del.jpg)






