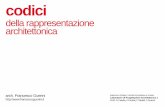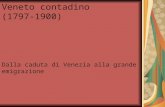Pensiero giuridico e riflessione politica in Antonio Pigliaru: dalla lezione di Capograssi...
Transcript of Pensiero giuridico e riflessione politica in Antonio Pigliaru: dalla lezione di Capograssi...
QUADERNI FIORENTINIper la storia del pensiero giuridico moderno
37(2008)
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
PAOLO CARTA
PENSIERO GIURIDICO E RIFLESSIONE POLITICAIN ANTONIO PIGLIARU: DALLA LEZIONE DI
CAPOGRASSI ALL’EREDITAv DI GRAMSCI
L’intensa esperienza di Antonio Pigliaru (Orune, 17 agosto1922 - Sassari, 27 marzo 1969), professore di Dottrina dello Stato aSassari e intellettuale tra i piu fecondi nella Sardegna del secondodopoguerra, occupa un posto particolarissimo nel panorama dellascienza giuridica italiana, innanzitutto per il contributo offerto allostudio del pluralismo. La sua riflessione sulla molteplicita degli or-dinamenti, in relazione alle concrete esperienze di vita delle realtaconsuetudinarie, maturo dapprima nel contesto degli studi scienti-fici, ma conobbe, in seguito, uno sviluppo ulteriore di carattere po-litico, che coinvolse integralmente il suo insegnamento accademico.Nella sua pur breve vita, Pigliaru ha lasciato numerose opere, chetestimoniano l’ampio spettro di interessi, cui dedico, senza riposo,la sua attivita scientifica e il suo impegno politico e civile. Tra glistudi di filosofia del diritto si ricordano Persona umana e ordina-mento giuridico (1953) e soprattutto La vendetta barbaricina comeordinamento giuridico (1959), che resta uno dei momenti apicalidella riflessione giuridica italiana intorno alla relazione tra legge econsuetudine. Accanto a queste opere stanno anche altri lavoricome le Meditazioni sul regime penitenziario italiano (1959), Lapiazza e lo Stato (1961), Struttura, soprastruttura e lotta per il diritto(1965), Promemoria sull’obiezione di coscienza (1968), L’eredita diGramsci e la cultura sarda (1969).
Testimone e partecipe delle vicende storiche di un’isola, carat-terizzate da bruschi arresti e repentine accelerazioni, Pigliaru de-dico ad esse, per un cospicuo periodo di tempo, l’intero suo impe-gno intellettuale, dando vita alla rivista « Ichnusa », pubblicata a
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
Sassari tra il 1949 e il 1964, in cui riverso le sue riflessioni intornoai problemi dell’autonomia regionale e della democrazia, intesacome « governo di tutti gli uomini insieme, ciascuno congiunta-mente agli altri » (1).
La sua statura internazionale si deve in ogni caso a La vendettabarbaricina come ordinamento giuridico, opera suggerita dalla rifles-sione filosofica di Giuseppe Capograssi e alla cui memoria fuespressamente dedicata (2). L’opera costituı l’occasione di indagare,in modo personalissimo, sulla pluralita degli ordinamenti nella lororelazione storica e istituzionale con lo Stato (3). Pigliaru considerole elaborazioni dottrinali di Santi Romano e di Giuseppe Capo-grassi, col proposito di indagare le realta e le consuetudini della co-munita pastorale dell’entroterra sardo (4), giungendo a conclusioni
(1) A. PIGLIARU, Le parole e le cose. Alfabeto della democrazia spiegato alla radio,prefazione di G. Melis e postfazione di G. Francioni, Sassari, Iniziative culturali, 2005,p. 57.
(2) Dopo l’edizione del 1959, uscı per i tipi di Giuffre una edizione accresciutaA. PIGLIARU, Il banditismo in Sardegna. La vendetta barbaricina come ordinamento giuri-dico, Milano, Giuffre, 1993. Ora si vedano l’edizione ID., Il banditismo in Sardegna. Lavendetta barbaricina come ordinamento giuridico, Nuoro, Il Maestrale, 2000 (con ulte-riori aggiunte e brani inediti), dalla quale cito, e la recente edizione ridotta ID., Il codicedella vendetta barbaricina, Nuoro, Il Maestrale, 2006 [nel presente contributo si fa rife-rimento all’edizione del 2000]. Su Antonio Pigliaru si veda in particolare M. PULIGA,Antonio Pigliaru. Cosa vuol dire essere uomini, Sassari-Pisa, Iniziative culturali-ETS,1996.
(3) Una nuova edizione comprendente la prima redazione dell’opera, arricchitada scritti inediti e testimonianze provenienti dall’« Archivio Antonio Pigliaru » sarapubblicata a cura di chi scrive nella Biblioteca del Centro Studi per lo storia del pen-siero giuridico moderno.
(4) I suoi riferimenti piu consueti sono naturalmente le opere classiche di S. RO-MANO, L’ordinamento giuridico, Pisa, Mariotti, 1917 (Firenze, Sansoni, 19452); ID., Di-ritto Costituzionale, Milano, Giuffre, 1945; ID., Frammenti di un dizionario giuridico,Milano, Giuffre, 1947 (si veda ora anche ID., Gli scritti del trattato Orlando, Milano,Giuffre, 2003); G. CAPOGRASSI, Note sulla molteplicita degli ordinamenti giuridici,« Studi Sassaresi », XIV (1936), pp. 77-90; quindi con modifiche in « Rivista Interna-zionale di Filosofia del diritto », 1939, I-II, pp. 9-44, poi in ID., Opere, IV, Milano,Giuffre, 1959, pp. 181-221; e gli studi di A. LEVI, Teoria generale del diritto, Padova,Cedam, 1967 (1934-35; 1937-19382; 19503).
QUADERNI FIORENTINI XXXVII (2008)350
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
particolarmente efficaci, tali da suscitare ancora oggi un ampio di-battito internazionale (5).
Recensendo la riedizione postuma dell’opera, nel 1971, VittorioFrosini, che fu legato a Pigliaru da uno personale vincolo di amici-zia, sottolineo l’importanza non solo giusfilosofica, ma anche poli-tica, di un lavoro animato dal proposito di considerare il fatto dellavendetta, « a prima vista cosı manifestamente antigiuridico, illecito,mosso da ragioni strettamente private », come « vero e proprio co-dice vigente non scritto, [...] con salde radici nel costume socia-le » (6). Il nesso diritto-politica, individuato da Frosini, era stato ac-colto anche da Alex Weingrod, il quale, scrivendo del volume perl’« American Anthropologist », ricordava che Pigliaru non era unantropologo, ma un giurista. Gli importanti risultati raggiunti dal-l’opera nell’ambito delle scienze sociali, non dovevano pertanto of-fuscare la prospettiva giuridico-istituzionale dell’opera: « Since, asPigliaru shows, the state’s laws have never fully permeated this in-terior region, the code of the vendetta provides a legal-like fra-mework for regulating certain relationships. Thus the traditionalantagonisms between the state and its agents on the one hand, and
(5) Si veda M. MASIA, A proposito della nota di Treves su Antonio Pigliaru e la ri-cerca empirica: spunti per una riflessione, in Diritto, cultura e societa, Atti del Convegnoin memoria di Renato Treves (Milano, 13, 14 e 15 ottobre 1994), a c. di V. Ferrari, M.L.Ghezzi e N. Gridelli Velicogna, Milano, Giuffre, 1997, pp. 347-367 e le note sul pro-cesso in Pigliaru e Satta di V. FERRARI, Diritto e societa. Elementi di sociologia del diritto,Laterza, Roma-Bari 2004. La bibliografia internazionale sull’opera di Pigliaru e amplis-sima e ancora da ricostruire, tra le opere piu recenti in cui si discute del suo lavoro in-torno alla vendetta si vedano The Subculture of Violence: Towards an Integrated Theoryin Criminology, ed. by M.E. Wolfgang and F. Ferracuti, London, Tavistock, 1967 (rist.New York, Routledge, 2001), in particolare p. 279; J.L. RUFFINI, Disputing Over Live-stock Sardinia, in Law and Anthropology: A Reader (Blackwell Anthologies in Social andCultural Anthropology), ed. by S. Falk Moore, Oxford, Blackwell, 2005, pp. 135-153;Risky Transactions: Trust, Kinship and Ethnicity, ed. by F.K. Salter, New York-Oxford,Bergham Books, 2002, ad indicem; What Is Justice? Classic and Contemporary Readings,ed. by Robert C. Solomon, Mark C. Murphy, Oxford-New York, Oxford UniversityPress, 1999, pp. 209-212 e piu in generale P. MARONGIU - G. NEWMAN, Vengeance: TheFight Against Injustice, Rowman & Littlefield, Lanham, 1987; A. BLOK, Honor and Vio-lence, Cambridge, Polity Press, 2001.
(6) V. FROSINI, Un codice per la vendetta, « Corriere della sera », 17 gennaio 1971,p. 13.
PAOLO CARTA 351
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
the villagers on the other, does not lead to anarchy, but instead thelocal code, the code of vendetta, provides a set of rules and ex-pectations that constrains behavior » (7). In questa chiave la inter-preto anche Eric J. Hobsbawm, che ad essa fece ricorso nei suoistudi sui Banditi (1969) e sui Rivoluzionari (1972) (8).
Della comunita barbaricina, nella quale era nato, Pigliaru tentodi individuare le consuetudini e le regole, le sue leggi fondamentali,che non potendo essere disattese, se non a patto di sovvertire l’in-tero ordine giuridico, in circostanze particolari erano destinate aentrare in conflitto con l’ordinamento statale. Nello specifico il si-stema penale, mediante il quale l’ordinamento particolare tutelavase stesso e perpetuava la propria vita, prevedendo il dovere « giuri-dico » della vendetta come riparazione « necessaria » all’offesa su-bita, riusciva determinante per la comprensione di quel che Salva-tore Satta aveva gia chiamato « il mistero del processo » (9). Era in-fatti nel momento processuale, che la consuetudine e la legge for-malizzavano il loro « incontro »; e solo in quel contesto la consue-tudine conosceva la legge (10). Nel riconoscimento della legittimitadel processo, la comunita determinava con maggiore incisivita ladifferenza tra il proprio ordinamento e la cosiddetta societa dei la-droni (11). Non si trattava dunque di comprendere l’ordinamento diuna societa criminale, che pure possiede e obbedisce a proprie re-
(7) A. WEINGROD, recensione di A. PIGLIARU, Il banditismo in Sardegna: la ven-detta barbaricina come ordinamento giuridico, Milano, Giuffre, 1970, « American An-thropologist », New Series, vol. 74, n. 4 (august, 1972), pp. 848-849: 848.
(8) E.J. HOBSBAWM, I banditi, Torino, Einaudi, 1971; ID., I rivoluzionari, Torino,Einaudi, 1975.
(9) A. PIGLIARU, Il banditismo in Sardegna, cit., p. 205: « [...]. Che nel processo cisia un’esigenza di giustizia, questo fatto non sfiora neppure la mente del pastore barba-ricino. Il pastore barbaricino vede il processo solo in termini di forza, che per contaredeve farsi valere in certe forme, con una determinata liturgia, di cui pare sı, intuire ilmistero — quel profondo mistero del processo di cui cosı acutamente ha discorso la scienzagiuridica italiana, specie forse in questi ultimi tempi — ma come fosse al postumo unmistero che non lo riguarda » [il corsivo e mio].
(10) Ivi, pp. 203-204.(11) Rievocando il suo primo incontro con Pigliaru, avvenuto grazie alla pubbli-
cazione del La vendetta barbaricina, Norberto Bobbio ha affermato: « L’importanza dellibro, che e sostanzialmente, come tutta l’opera di Pigliaru, un testo di teoria giuridica,e la straordinaria aderenza a processi storici e sociali carichi di pressanti domande per
QUADERNI FIORENTINI XXXVII (2008)352
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
gole; in quel caso l’ordinamento cessa infatti di essere un ordineumano che ha in se stesso il suo fine e che e fine a se stesso, dive-nendo piuttosto strumento integralmente destinato al persegui-mento di fini criminali (12). La comunita della quale intendeva oc-cuparsi era « semplicemente una comunita di vita, una comunitastorica, nel senso che il suo sistema di vita (il suo costume, la suacultura, o, se si vuole, la sua non-cultura) » erano « il suo stessoprocesso storico, la sua stessa vita » (13). Questo costume e questavita rivelavano l’essenza della comunita, arretrata, come anche am-metteva Gramsci nei suoi Quaderni del carcere, poiche sperimen-tava sulla propria concreta esistenza gli effetti dell’« arresto dell’ini-ziativa umana nella storia » (14). Si trattava dunque di considerareuna comunita che adottava la consuetudine come « costituzione »,tentando di comprenderla, indipendentemente dal giudizio che sudi essa, nella sola prospettiva di un ordinamento tipico, come loStato, fosse possibile esprimere (15).
La vendetta, intesa non come pratica individuale, ma comepropria di tutta la comunita, costituiva pero solo un momento del-l’ordine giuridico, che non poteva dunque dirsi esaurito in esso (16):
il presente. All’insieme di norme che regolano, o che regolavano, la vita delle comunitapastorali delle zone interne della Sardegna, Pigliaru applica la teoria della pluralita de-gli ordinamenti giuridici. Al codice che trova espressione nelle regole di comporta-mento garantite dall’azione di controllo e di repressione svolta dallo Stato attraverso lesue varie articolazioni, si sovrappone un sistema di valori che s’identifica con il nucleooriginale, fonte primaria d’identita individuale e collettiva. Dalla tensione tra questi dueschemi normativi nasce cio che dall’esterno si percepisce come puro fenomeno delin-quenziale, e che invece e aspro confronto tra diverse concezioni del vincolo che lega gliuomini in societa. Nella descrizione di un tale rapporto conflittuale sta la novita e l’ori-ginalita del lavoro di Antonio Pigliaru » (N. BOBBIO, Antonio Pigliaru, esempio di corag-gio e di rigore intellettuale, « La Nuova Sardegna », 23 marzo 1989, p. 21).
(12) A. PIGLIARU, Il banditismo in Sardegna, cit., p. 56.(13) Ivi, p. 57.(14) Ivi, p. 58.(15) Alludo in questo frangente al titolo del saggio di D. QUAGLIONI, La consue-
tudine come costituzione, in Dominii collettivi e autonomia, Atti della V Riunione Scien-tifica (Trento, 11-12 novembre 1999), a c. di P. Nervi, Padova, Cedam, 2000, pp. 21-40. Sul punto cfr. P. GROSSI, L’ordine giuridico medievale, Roma-Bari, Laterza, 1995,pp. 87-93.
(16) A. PIGLIARU, Il banditismo in Sardegna, cit., p. 61.
PAOLO CARTA 353
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
In realta qui abbiamo un conflitto di fatto tra due ordinamenti giuridici,uno d’origine riflessa, ed e l’ordinamento giuridico che si identifica con loStato, l’altro di formazione spontanea, tradizionale, caratteristico di una co-munita organizzata su basi proprie e refrattaria all’ulteriore esperienza dell’or-dinamento giuridico, almeno entro determinati limiti: entro i limiti, cioe, incui l’ordinamento giuridico dello Stato appare esprimersi in istituti non fun-zionali rispetto alle strutture fondamentali della comunita ed alle forme di vitaproprie della comunita originaria e quindi coerenti con quel sistema.
Tale atteggiamento, espresso dalla consuetudine, incideva nelprofondo del codice di norme che regolavano la pratica della ven-detta. Pigliaru tentava di trascrivere le regole « con massima doci-lita nei confronti delle cose », evitando accuratamente sia di co-stringere la consuetudine in un codice, sia il tranello indicato daSanti Romano circa la completezza dell’ordinamento. Riteneva, in-fatti, necessario liberarsi preliminarmente dalla fuorviante ed erro-nea opinione che considerava la completezza dell’ordinamento uni-camente in relazione al suo contemplare « tutti i rapporti della vitasociale, tutte le azioni umane, o per comandarle o per vietarle o perrenderle lecite » (17).
L’acquisizione di questo nucleo di idee fu pero tutt’altro chepacifica. L’incontro con il circolo capograssiano, propiziato dal piuanziano Opocher e dal coetaneo Piovani, fu possibile solo alla metadegli anni ’50. Rispetto al suo primo lavoro scientifico, Personaumana e ordinamento giuridico del ’53, in cui egli, partendo da pre-messe tipiche dell’attualismo gentiliano, criticava le teorie del plu-ralismo giuridico, pur dovendo ammettere l’esistenza di un plurali-smo « situazionale », con la Vendetta barbaricina compiva una com-pleta rivisitazione delle proprie posizioni. Era stato proprio Opo-cher in una lettera del 28 agosto 1954 a sollecitare una presa di co-scienza di Pigliaru su quelle premesse, che gli impedivano di com-piere il salto definitivo: « Ho avuto fiducia in Lei per la serieta,l’onesta e l’evidente tormento che lei mette nelle sue cose: in tuttele sue cose. Mi pare che questo sia il suo stile di vita. E ai nostritempi e molto, se non tutto. Cio non significa pero che Lei possa
(17) S. ROMANO, Osservazioni sulla completezza dell’ordinamento statale (1925),ora in ID., Scritti minori, Milano, Giuffre, 1950, I (rist. 1990), pp. 449-459: p. 450. Cfr.A. PIGLIARU, Il banditismo in Sardegna, cit., p. 62, nota 5.
QUADERNI FIORENTINI XXXVII (2008)354
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
‘camminare’ cosı come e. Solo i contatti umani, la discussione, [...]potranno sciogliere l’asprezza e l’angolosita del suo modo di lavo-rare. E poi e essenziale per Lei l’esperienza didattica. Ma potra maiuscire dal suo mondo? Questo sarebbe anzi indispensabile per Lei.E badi, non per rinnegarlo, ma per conquistarlo piu profondamentee inserirlo in una visione piu armonica [...] della vita. E poi bisognache Gentile, pur grandissimo pensatore, non leghi le sue ali » (18).
Nella Vendetta barbaricina, cinque anni piu tardi, sentı dunqueil « dovere » di aggiungere una lunga nota per « segnalare il valoreautocritico delle posizioni » espresse, rispetto a quanto sostenutonel secondo capitolo di Persona umana e ordinamento giuridico (19):
[...] nel quale per altro io stesso ho, come dire?, consumato in propriol’esperienza di questo dover ammettere un pluralismo situazionale, per negarela validita del pluralismo non pero ignorando una situazione, appunto, chia-ramente contraddittoria rispetto a quel concetto di unita come unicita dell’or-dinamento, sulla cui base per altro, ritenevo, allora, di dover criticare le po-sizioni pluralistiche per es., del Gurvitch e dello stesso Romano. C’era senzadubbio in quella logica un evidente equivoco, un fondamentale malinteso delquale in questa sede ho cercato di rendermi conto e del quale ho cercato, an-che, di render conto. E proprio per questo ora mi riesce tutt’altro che fati-coso ammettere quell’errore di prospettiva e, per cosı dire, prenderne attoesplicitamente, pur ritenendo di non dover andare oltre questo punto, ba-stando mi pare, al chiarimento necessario, aver richiamato l’attenzione sulfatto solo per quel tanto che cio era opportuno e obiettivamente dovuto alfine di assolvere ad un debito di coscienza, senza tuttavia aprire un caso per-sonale che sarebbe sicuramente fuor di luogo aprire, almeno in questa sede.
Prendere in considerazione l’ordinamento di una comunita sto-rica come era quella barbaricina, implicava rivedere interamente ipresupposti del proprio lavoro. L’occasione giunse dalla lezione diGiuseppe Capograssi, un « uomo suggestivo » e « incomprensibilea chi non gli abbia parlato », come gli scriveva Pietro Piovani (20).Da Capograssi, Pigliaru acquisı con acume critico la riflessione in-torno al principio di socialita del diritto e le efficaci note sulla mol-
(18) Sassari, Archivio Antonio Pigliaru, Enrico Opocher ad Antonio Pigliaru, 28agosto 1954. Parzialmente pubblicata in M. PULIGA, Cosa vuol dire essere uomini, cit.,p. 79.
(19) A. PIGLIARU, Il banditismo in Sardegna, cit., p. 82.(20) Sassari, Archivio Antonio Pigliaru, Pietro Piovani ad Antonio Pigliaru, 4
giugno 1951.
PAOLO CARTA 355
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
teplicita degli ordinamenti. In particolare fece propria l’idea per cui« posti vari ordinamenti, essi possono essere considerati da almenotre punti di vista: a) dal punto di vista del singolo ordinamento: ri-cercare cioe quello che il singolo ordinamento vuole siano per essogli altri ordinamenti [...]; b) dal punto di vista del singolo ordina-mento ma non piu per quello che il singolo ordinamento [...] postocome ordinamento tipico come avente valore tipico rispetto agli al-tri; c) dal punto di vista della esperienza totale cioe dal punto di vi-sta della pura molteplicita, della eguaglianza [...] di tutti gli ordina-menti puramente considerati come tali » (21). Pigliaru accolse in-nanzitutto l’idea di indagare « in se e prescindendo dal riferimentoa questo o quel determinato ordinamento » la realta giuridica delle« forme concrete dell’esperienza » (22).
La letteratura intorno all’unita-molteplicita degli ordinamentinon puo esimersi dal far capo all’indagine sulla societa dei ladroni,scriveva Pigliaru (23). Niente tuttavia era per lui piu distante dal-l’oggetto del suo studio. Se come ammetteva Capograssi, anche intali societa « si obbedisce a quel principio di verita e di ragione chetrasforma in ordinamento ogni fatto di vita associata » (24), e purvero che tale ordinamento « insieme si pone e si nega: si pone inbase ad un principio e ad un’esigenza che sono universali e si negaperche tuttavia sono trattati come un principio ed un’esigenza par-ticolari » (25). Da questa intima contraddizione interna, scaturiscequella caratteristica « ripugnanza, che in genere si avverte di frontealla necessita di conoscere la societa criminale come ordinamento »,poiche in essa si assiste a un fatto che nega radicalmente lo stessoprincipio che ha dato vita all’ordinamento (26). Come scriveva Ales-sandro Levi, anche chi accolga la tesi della socialita del diritto, nellasua piu ampia portata, non potra esimersi dal considerare queste
(21) G. CAPOGRASSI, Note sulla molteplicita degli ordinamenti giuridici, cit., p. 183.(22) Ivi, p. 185.(23) A. PIGLIARU, Il banditismo in Sardegna, cit., p. 54.(24) G. CAPOGRASSI, Note sulla molteplicita degli ordinamenti giuridici, cit., p. 203.(25) A. PIGLIARU, Il banditismo in Sardegna, cit., p. 55.(26) Ibidem.
QUADERNI FIORENTINI XXXVII (2008)356
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
societa come la patologia e non gia la fisiologia dell’esperienza giu-ridica (27).
Pur tipica delle societa criminali, la presenza della vendetta nel-l’ambito della comunita barbaricina implicava comunque una di-stinzione essenziale tra la diversa situazione di questa societa ri-spetto a quelle: « Questa comunita e semplicemente una comunitadi vita, una comunita storica », contemporanea unicamente a semedesima (28). Niente in essa porta a concepire una vera e propriastrumentalizzazione dell’ordinamento, come avviene nelle societacriminali. All’uomo barbaricino non e fatto altro dovere che quellodi essere uomo e anche in questo senso si scopre la differenza chesta tra « le norme che pongono la vendetta nel sistema della societacriminale e le norme che regolano la vendetta nella societa barbari-cina »: « Quelle presuppongono il ladrone (anche se dentro il la-drone pensano l’uomo); queste pensano l’uomo negli stessi terminiin cui l’uomo e pensato nell’ordinamento giuridico in quanto sem-plice ordine umano » (29).
Posta in tali termini la questione politica del cosiddetto « ban-ditismo » assumeva una connotazione del tutto nuova e particolar-mente complessa. Nello stretto rapporto tra vendetta e banditismo,Pigliaru scopriva, infatti, anche l’espressione dell’incontro-scontrotra l’ordinamento statale e l’ordinamento particolare. La praticadella vendetta, come si e detto, non appartiene a quella comunitacome pratica individuale, ma sociale, « non come pratica di alcuninella comunita », ma voluta da tutta la comunita per garantire lapropria sopravvivenza e dunque dar vita a un sistema di certezza.Essa si configura come una pratica, per cosı dire, di « tutela giuri-dica » e qui sta il suo aspetto piu rilevante ai fini di un’analisi cheguardi all’esperienza giuridica anche nella prospettiva dell’ordina-mento tipico, cioe dello Stato. Si tratta di un’azione « originaria-mente concepita come azione giuridica », che e tuttavia « cono-sciuta come contraddittoria, assolutamente parlando, con l’espe-rienza giuridica ulteriore, a sua volta conosciuta come inadeguata e
(27) A. LEVI, Teoria generale del diritto, cit., p. 16.(28) A. PIGLIARU, Il banditismo in Sardegna, cit., p. 58.(29) Ibidem.
PAOLO CARTA 357
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
cosı estranea e remota da non poter essere accettata ed accoltacome propria, anzi da dover essere negata » (30). Il che, va detto,non implica la negazione della natura di ordinamento dello Stato,ma piu semplicemente che lo Stato e riconosciuto come incapace digarantire alla comunita di essere semplicemente se stessa, di assicu-rare cioe la vita concreta nelle esperienze individuali all’internodella comunita (31).
In possesso di un suo sistema etico, che prescindendo dallaquestione penale, non confligge in alcun modo con lo Stato, la so-cieta barbaricina si configura per Pigliaru come vero e proprio or-dinamento giuridico, completo, nel significato proprio della formu-lazione di Santi Romano. Ogni ordinamento puo dirsi completoqualora lo si consideri nell’ambito della sua esperienza storica. Solofuori da quest’ambito, cioe osservandolo dalla prospettiva di un’al-tra cultura, o in termini comparatistici, nella sua relazione con altriordinamenti o con un ordinamento ideale, e possibile dichiararnel’incompletezza.
Ev evidente il capovolgimento completo del pensiero dell’autorerispetto al suo precedente lavoro, che si avverte soprattutto laddovePigliaru ammette, seguendo alla lettera le suggestioni capogras-siane, la possibilita di negare la natura di ordinamento della comu-nita barbaricina solamente alla luce delle « dottrine che comunqueidentificano l’ordinamento giuridico e il diritto con lo Stato e conla legge dello Stato, cioe portando ad estreme conseguenze scienti-fiche certo esclusivismo dello Stato medesimo, cosı spesso abba-gliato dalla sua naturale, essenziale vocazione all’universalita, da es-sere altrettanto spesso ridotto, pur da fondamentali esigenze dellasua stessa vita, a fraintendere la natura stessa della sua condizionedi Stato » (32).
Nella societa barbaricina c’e un ordinamento e pero non c’eStato, sottolineava Pigliaru, seguendo la teoria della socialita del di-ritto, espressa dalla proposizione ubi societas ibi jus, ubi jus ibi so-cietas, non trascurando comunque gli equivoci, individuati da Ales-
(30) Ivi, p. 61.(31) Ibidem.(32) A. PIGLIARU, Il banditismo in Sardegna, cit., p. 65.
QUADERNI FIORENTINI XXXVII (2008)358
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
sandro Levi, cui l’espressione poteva dar luogo. L’ordinamento giu-ridico e dunque tale per la sua essenziale ‘giuridicita’ e il suo finenaturale non e altro che quello di essere se stesso, cioe proprioquello di realizzare la sua giuridicita. Esso e da intendersi non inquanto prodotto, ma come attivita, azione; tale quindi da potersicogliere, come auspicava Capograssi, quale vita giuridica, pur nonessendo ancora vita giuridica « concettuale elaborata dalla scien-za » (33). L’analisi poneva in luce la necessita dell’ordinamento diobbedire all’esigenza dell’azione, sottraendo pero l’azione alla suaimmediatezza « e al rischio cui l’immediatezza la espone », inci-dendo nella sua « naturale, originaria, effettiva durata ». Lopez deOnate nel suo celebre studio su La certezza del diritto, scopriva nel-l’ordinamento giuridico la realizzazione di quella mediazione neces-saria al perpetuarsi di ogni vita associata e perfettamente rispon-dente alla natura stessa di quest’ultima. Il « codice » consuetudina-rio della comunita barbaricina, pur non essendo sorretto da alcunascienza, indicava in tal senso lo sforzo storico compiuto all’internodel suo « processo organizzativo » a realizzare « istituzionalmente »quella garanzia dell’azione, che da un lato « qualifica i comporta-menti possibili ‘in modo che gli uomini possano contare su quelloche verra’, e dall’altro fa sapere ad ogni soggetto cio che egli puo edeve volere » (34).
L’ordinamento giuridico che Pigliaru tentava indagare si pre-sentava dunque come un ordinamento perfettamente autonomo eoriginario: « I suoi limiti [...] sono i limiti che esso da a se mede-simo, con le sue stesse disposizioni e in forza dei suoi stessi prin-cipi; cioe quei limiti sui quali esso ordinamento si e costitui-to [...] » (35). Poiche costituendosi « non poteva evidentemente nonlimitarsi », l’ordinamento si e limitato per essere « la realta che e,se e vero che farsi e determinarsi oggettivamente, limitarsi » (36). Inquanto originario e non derivato, tale ordinamento era da conside-rarsi un’istituzione « perfetta, autonoma e quindi non subordi-
(33) Ivi, p. 69.(34) Ivi, p. 72.(35) Ivi, p. 73.(36) Ivi, p. 74.
PAOLO CARTA 359
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
nata », pur non essendo Stato. Queste considerazioni dovevano ne-cessariamente essere assunte prescindendo « dal territorio comeelemento essenziale dell’essere Stato dello Stato », cioe ripropo-nendo l’originaria definizione di sovranita, questione che torna oggidi grande attualita in seno al dibattito dottrinale. Come tale, l’ordi-namento barbaricino era un ordinamento a carattere universale,« con una pretesa all’universalita in tutto identica alla pretesa al-l’universalita propria di quegli ordinamenti che sono, in senso pro-prio, Stato » (37). Fuori dal suo impianto dottrinale, come avevacolto Frosini, quella di Pigliaru era pero un’interpretazione tutt’al-tro che pacificante della realta barbaricina. Ad essa continuo a pen-sare, senza mai perdere l’occasione di affiancare al suo studio, l’in-cessante appello per una concreta azione politica, finalizzata al ri-pristino dell’azione storica nella vita di quella comunita.
A definire meglio i contorni delle sue considerazioni politicheintorno alla vicenda storica della comunita barbaricina e piu estesa-mente della Sardegna, contribuı in modo significativo l’assidua fre-quentazione delle pagine gramsciane. A Gramsci dedico il suo ul-timo saggio, L’eredita di Gramsci e la cultura sarda contemporanea,pubblicato postumo nell’ottobre 1969 (38). Uno scritto penetrante edrammaticamente critico verso la cultura sarda, che non aveva sa-puto cogliere le opportunita di crescita garantite dall’autonomia re-gionale, intesa da lui come possibilita di un superamento democra-
(37) Ivi, p. 75.(38) ID., L’eredita di Gramsci e la cultura sarda, in Gramsci e la cultura contempo-
ranea, I, Atti del convegno internazionale di studi gramsciani tenuto a Cagliari il 23-27aprile 1967, a c. di P. Rossi, Roma, Editori Riuniti, 1969, pp. 487-533. Si trattava di untema particolarmente complesso, se solo si pensa che nel numero speciale dedicato allaSardegna della rivista « Il Ponte » (1951), Piero Calamandrei aveva domandato espres-samente a Palmiro Togliatti di scrivere sul Gramsci sardo. Cfr. P. TOGLIATTI, Gramscisardo, « Il Ponte », VII (1951), nn. 6-7, settembre-ottobre, pp. 1085-1090. Sul numerodella rivista mi permetto di rinviare ora a P. CARTA, Lo spirito ‘religioso’ del diritto. Sal-vatore Satta e Piero Calamandrei, « Annali dell’istituto storico italo-germanico inTrento », XXX (2005), pp. 93-118. Per uno studio piu ampio sulla storia de « IlPonte » cfr. A. COLOMBO, Alla testa del ‘Ponte’, in Piero Calamandrei. Ventidue saggi suun grande maestro, a c. di P. Barile, Milano, Giuffre, 1990 (Per la storia del pensierogiuridico moderno, 32), pp. 513-551 e L. POLESE REMAGGI, « Il Ponte » di Calamandrei.1945-1956, Firenze, Olschki, 2001.
QUADERNI FIORENTINI XXXVII (2008)360
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
tico della sovranita statale. Cio rende ancor piu profondo il ramma-rico per la brusca interruzione del suo percorso scientifico, avve-nuta proprio nel momento in cui l’acquisizione del pensiero diGramsci, pareva prospettare un nuovo orizzonte di studi. Restanosolo le esigue, ma essenziali, tracce, espresse nei suoi lavori piu ma-turi, tra i quali si segnalano l’importante contributo Struttura sopra-struttura e lotta per il diritto (1965) e l’incompiuto Studio sull’estin-zione dello Stato (39). In entrambi i saggi, e possibile scorgere unasottile linea che unisce la lezione di Giuseppe Capograssi, il suoprimo e sempre amato maestro, ai motivi elaborati con straordina-ria lucidita, mediante il ricorso al pensiero gramsciano: « Ogni se-ria meditazione sullo Stato e una meditazione sulla sua estinzio-ne » (40).
Fin dal 1963, dunque, manifestando la sua singolare acutezza,Pigliaru portava a compimento l’impegno, quasi autobiografico, dirivisitare se stesso e la sua opera, attraverso la reinterpretazionedelle tesi « culminanti » della filosofia di Antonio Gramsci (41).L’Intervista sul problema del banditismo in Sardegna, in seguito ri-pubblicata, per espressa volonta dell’autore, in appendice alla Ven-detta barbaricina, si apriva con una sequenza esplicita di citazionidei Quaderni del carcere, tra le quali spiccava una nota sul Machia-velli (42):
Non « puo esserci riforma culturale e cioe elevamento civile degli stratidepressi della societa, senza una precedente riforma economica e mutamentonella posizione sociale e nel mondo economico: percio una riforma intellet-
(39) I due studi sono stati raccolti in A. PIGLIARU, Scritti di scienza politica, Ca-gliari, Dattena, 1975, pp. 103-178; pp. 331-419.
(40) ID., Il banditismo in Sardegna, cit., p. 354. Si tratta di un’espressione ricor-rente negli scritti di Pigliaru, si veda ad esempio: l’Introduzione al corso di Dottrina delloStato in ID., Scritti di scienza politica, cit., p. 93. Ev appena il caso di ricordare il celebreluogo capograssiano: G. CAPOGRASSI, Saggio sullo Stato, Torino, Bocca, 1918, poi in ID.,Opere, I, cit., p. 17: « Ogni vera ricerca sullo Stato e una profonda meditazione dellasua fine ».
(41) A. PIGLIARU, Intervista sul problema del banditismo in Sardegna, « I problemidella pedagogia », IX (1963), pp. 237-285, ora in appendice a Il banditismo in Sarde-gna. La vendetta barbaricina, cit., pp. 325-371: p. 333.
(42) Ivi, p. 336; per la nota gramsciana: A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, a c. diV. Gerratana, III, Torino, Einaudi, 20012, Q. 13, § 1, p. 1561.
PAOLO CARTA 361
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
tuale e morale non puo non essere legata a un programma di riforma econo-mica, anzi il programma di riforma economica e appunto il modo concretocon cui si presenta ogni riforma morale e intellettuale ».
Il superamento delle contraddizioni, che imprigionavano e pa-ralizzavano la comunita di cui si era occupato, necessitava dunquedi uno sforzo di natura politica volto a favorire concretamente lapossibilita di una « scelta »: un « impegno di liberta », di libera-zione « dal bisogno, dall’ignoranza e da tutte quelle reali condizionidi miseria (in tutti i sensi in cui la parola puo essere usata) » (43). Inquesta direzione opero personalmente Pigliaru, incoraggiando, adesempio, una profonda riflessione sull’istruzione pubblica e sulleresponsabilita della scuola in un ambiente storico « arretrato » (44).Forte dell’esperienza gramsciana, egli agı nel contesto isolano, nonsolo in vista di una riforma della storia della comunita nella qualeera nato, ma piuttosto « in vista finalmente di una storia, in vistadella storia » (45).
Le pagine della Vendetta barbaricina, particolarmente sugge-stive, sono ancora oggi le piu citate. E tuttavia, come e stato scrittoanche di recente, l’eredita di Pigliaru non puo essere circoscritta« nei confini, pur importanti, del lavoro accademico ». Con la suaprematura scomparsa, egli ha lasciato di se « un ricordo indelebilecome ricercatore assiduo della verita, stimolatore incessante di co-scienze e intelligenze, organizzatore tenace di esperienze culturali.La passione dell’uomo in pienezza di umanita » (46). Norberto Bob-bio, rievocando il metodo di Pigliaru, lo ha sintetizzato tutto in unanaturale disposizione a considerare molto seriamente le cose e lepersone di cui si occupava: « Il suo mestiere di docente lo avevaconcepito non come insegnamento distaccato, dottrinario, ma comeun modo di comunicare [...] e di suscitare interessi seri [...]. La suaera una cattedra dalla quale si faceva un esperimento giornaliero di
(43) A. PIGLIARU, Intervista sul problema del banditismo in Sardegna, cit., p. 371.(44) Cfr. L. CAIMI, Motivi pedagogici e impegno educativo in Antonio Pigliaru, Mi-
lano, Vita e Pensiero, 2000.(45) A. PIGLIARU, Intervista sul problema del banditismo in Sardegna, cit., p. 366.(46) L. CAIMI, Motivi pedagogici e impegno educativo in Antonio Pigliaru, cit.,
p. 108.
QUADERNI FIORENTINI XXXVII (2008)362
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
educazione, nel senso piu alto della parola » (47). Fu insomma un« vero maestro », che, per usare una sua felice espressione, nacqueprofessore con la vocazione di chi concepisce l’universita, primaancora che come « strumento di ricerca scientifica », quale luogo incui la formazione diventa concreta riforma intellettuale e moraledella societa civile.
La sintesi tra attivita scientifica e riforma del metodo di inse-gnamento universitario trovo una concreta realizzazione negli ultimianni della sua vita. Durante quel periodo Pigliaru ricordo spesso aisuoi studenti, e a quanti riscoprivano nell’azione una gioia di granlunga superiore al semplice senso del dovere, quale patrimonio eracontenuto nell’ideale gramsciano di disciplina universitaria. Tentodunque di tradurlo nell’aula, presentandolo come opportunita daafferrare, in un momento in cui si faceva sempre piu forte anchel’esigenza di un cambiamento profondo nella didattica. Nell’annoaccademico 1968-1969 dedico il suo corso di Dottrina dello Stato auna revisione critica dell’insegnamento universitario, dando vita aun contraddittorio, talora aspro, ma mai sordo, con gli studentidella Facolta di Giurisprudenza di Sassari (48). Fu il suo ultimocorso. Scomparve il 27 marzo 1969, a soli 46 anni, senza poter por-tare a compimento il ‘piano’ delle lezioni. ‘Piano’ e naturalmentetermine usato a sproposito, poiche, come e possibile apprezzaredalle registrazioni, il dialogo serrato con gli studenti contribuiva inmodo considerevole a dirottare le lezioni lungo sentieri imprevi-sti (49). In quel corso la relazione tra filologia e politica che Gram-
(47) N. BOBBIO, Antonio Pigliaru, cit.(48) G. MELIS, Quel professore, nel Sessantotto, « Ichnusa », VIII (1989), n. 18/
19, Nuova Serie, pp. 48-52.(49) Le lezioni sono state pubblicate nel volume A. PIGLIARU, Il rispetto del-
l’uomo, introduzione di L. M. Lombardi Satriani e M. A. Cattaneo, testi inediti trascrittie annotati da T. Delogu e R. Turtas, Sassari, Iniziative Culturali, 1980. Dal gennaio 1968il bollettino bibliografico del corso di Dottrina dello Stato, che Pigliaru curava insiemea Mario A. Cattaneo, prese il titolo de « il Trasimaco ». Nel fascicolo del gennaio-marzo, insieme a colleghi e allievi, Pigliaru aveva gia iniziato una riflessione sulla crisidell’Universita e sul movimento studentesco. In particolare sul fascicolo apparvero icontributi di N. BOBBIO, Un dialogo difficile ma necessario (pp. 2-4) e di M.A. AIMO - A.MOTRONI - V.F. MURA, Per una bibliografia su: la crisi dell’Universita e sul movimento
PAOLO CARTA 363
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
sci auspicava di trasferire nella concreta realta politica, fu postacome preliminare questione metodologica.
Ev tuttavia necessario recuperare il valore delle lezioni di Pi-gliaru, accostandole sia ai suoi scritti di quegli anni, espressamenterievocati in aula, sia alle pagine gramsciane che in certo qual modole avevano ispirate, per comprendere l’autenticita del suo pensiero.
L’interesse per la questione della cultura e per la formazionedegli intellettuali si era in realta rivelato assai precocemente nel-l’opera di Pigliaru, in termini prossimi al pensiero di Gramsci. Sipensi, ad esempio, all’articolo apparso nel 1949 sul primo numerodi « Ichnusa », intitolato significativamente Il problema della cul-tura: primo sprovincializzare la provincia, nel quale si scopriva unduro atto d’accusa contro certo compiacimento per l’isolamentoculturale e contro un provincialismo inteso quale inevitabile ed in-superabile fatalita imposta dal destino (50). Questa acquisizione piuo meno consapevole, lo condusse a interpretare il lascito gram-sciano fuori da schemi ideologici. Di Gramsci accolse soprattuttol’aspirazione ideale per cui la comprensione della realta non puomai essere disgiunta dalla possibilita di modificarla, qualora essa lonecessiti. Tale aspirazione e interpretata e ricondotta nei termini diuna riflessione sulla democrazia, considerata pero fuori dal suo mi-to (51).
L’opportunita per discutere sistematicamente e coerentementedel « suo » Gramsci giunse comunque ben prima del corso accade-mico poc’anzi ricordato. Nel 1967 gli fu richiesto di partecipare alconvegno cagliaritano che celebrava il trentennale della scomparsadel politico di Ales (dalla relazione nacque il gia ricordato L’ereditadi Gramsci).
studentesco (pp. 4-28), con introduzione dello stesso Pigliaru. Sulle pagine del « Trasi-maco » stavano anche tutte le amare riflessioni sull’occupazione della Cecoslovacchia, eil tradimento di una speranza nella nuova storia, nel volto umano restituito al sociali-smo (« Il Trasimaco », 1968, 12, pp. 10-11). Cfr. L. CAIMI, Motivi pedagogici e impegnoeducativo in Antonio Pigliaru, cit., p. 102.
(50) A. PIGLIARU, Sprovincializzare la provincia: il problema della cultura, « Ich-nusa », I (1949), n. 1, pp. 67-71. Sulla rivista « Ichnusa » e sull’importanza che essaebbe nella Sardegna del dopoguerra cfr. S. TOLA, Gli anni di ‘Ichnusa’. La rivista di An-tonio Pigliaru nella Sardegna della rinascita, Sassari-Pisa, Iniziative culturali-ETS, 1994.
(51) Su questi aspetti si veda ora A. PIGLIARU, Le parole e le cose, cit.
QUADERNI FIORENTINI XXXVII (2008)364
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
Nella prima parte del suo discorso, Pigliaru ricordo il nesso tradisciplina universitaria e istituzioni — il rigore filologico auspicatocome modello politico — che Gramsci aveva individuato, commen-tando una pagina sull’Universita di John Henry Newman (52). Nelcarcere di Turi, Gramsci aveva potuto leggere una sintesi delleopere del Cardinale di Oxford, pubblicata in uno scialbo articoloapparso tra le Cronache del pensiero religioso nel numero di « Ge-rarchia » del marzo 1933 (53):
Anzitutto e in linea generalissima, la universita ha il compito umano dieducare i cervelli a pensare in modo chiaro, sicuro e personale, districandolidalle nebbie e dal caos in cui minacciava di sommergerli una cultura inorga-nica, pretenziosa e confusionaria, ad opera di letture male assortite, confe-renze piu brillanti che solide, conversazioni e discussioni senza costrutto: ‘Ungiovane d’intelletto acuto e vivace, sfornito di una solida preparazione, non hadi meglio da presentare che un acervo di idee, quando vere quando false, cheper lui hanno lo stesso valore. Possiede un certo numero di dottrine e di fattima scuciti e dispersi, non avendo principii attorno ai quali raccoglierli e si-tuarli. Dice, disdice e si contraddice, e quando lo si costringe a esprimerechiaramente il suo pensiero non si raccapezza piu. Scorge le obbiezioni, me-glio che le verita, propone mille quesiti ai quali nessuno saprebbe rispondere,ma intanto egli nutre la piu alta opinione di se e si adira con quelli che dis-sentono da lui’. Il metodo che la disciplina universitaria prescrive per ogniforma di ricerca e ben altro e ben altro e il risultato: e ‘la formazione dell’in-telletto, cioe un abito di ordine e di sistema, l’abito di riportare ogni cono-scenza nuova a quelle che possediamo, e di aggiustarle insieme, e, quel chepiu importa, l’accettazione e l’uso di certi principii, come centro di pensiero...La dove esiste una tale facolta critica, la storia non e piu un libro di novelle,
(52) J.H. NEWMAN, Lectures and Essays on University Subjects, London, Lognman,1859, pubblicato in seguito in ID., The Idea of a University Defined and Illustrated. I. inNine Discourses Addressed to the Catholics of Dublin. II, in Occasional Lectures Addres-sed to the Members of The Catholic University, London, Basil Montagu Pickering, 1873.Cfr. J.H. NEWMAN, Opere, a c. di A. Bosi, Torino, Utet, 1988 (rist. 1997). Sull’originedello scritto si veda J. MORALES MARIN, Newman (1801-1890), Madrid, Rialp, 1990, trad.it. di L. Dapelo, John Henry Newman (1801-1890), Milano, Jaca Book, 1998, in parti-colare pp. 263-282 e pp. 337-348.
(53) A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, III, p. 1806-1807 [il corsivo e mio]. Ilbrano e tratto interamente dall’articolo Il Cardinale di Oxford, firmato « Fermi » (« Ge-rarchia », 1933, pp. 245-250; 335-345: per la citazione gramsciana, pp. 339-340), nelquale in una prima parte si ripercorrevano le vicende della Chiesa anglicana, nella pro-spettiva di una storia delle idee, vagamente concepita e secondo gli stilemi di queglianni; nella seconda era possibile apprezzare una sintesi, condita con lunghe citazioni,dell’opera di Newman.
PAOLO CARTA 365
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
ne la biografia un romanzo; gli oratori e le pubblicazioni della giornata per-dono la infallibilita; l’eloquenza non vale piu il pensiero, ne le affermazioniaudaci o le descrizioni colorite tengono il posto di argomenti’. La disciplinauniversitaria deve essere considerata come un tipo di disciplina per la forma-zione intellettuale attuabile anche in istituzioni non ‘universitarie’ in senso uf-ficiale.
Questa pagina meditata in solitudine da Gramsci, e stata di re-cente definita come « una delle piu belle della nostra storia civilerecente, sull’universita e sull’idea di un ordine intellettuale e mora-le » (54). Fu scritta « nella primavera del 1933, l’anno che nell’Eu-ropa continentale segna l’avvento del progetto totalitario di distru-zione di un intiero ordine intellettuale e morale, proprio mentre inun’universita gia fascistizzata e nell’atmosfera trionfalistica e ubue-sque del regime si svolgevano le celebrazioni bolognesi e romaneper il XIV centenario delle Pandette di Giustiniano » (55).
Leggendola non ci si puo esimere dal domandarsi quanto inrealta si conosca l’esperienza di studio del Gramsci in carcere; inche modo egli lesse i volumi di cui poteva disporre; fino a chepunto citava, che cosa citava e quali furono le aggiunte che di suopugno scrisse accanto a brani escerpiti da riflessioni altrui (56). Al-cune di queste aggiunte, cosı come alcune sue glosse, sono tali dadonare a un testo non suo, un significato radicalmente nuovo.
Le due righe segnalate in corsivo, costituiscono, infatti, il solocommento autenticamente gramsciano; il resto e una citazione allalettera dell’articolo apparso sul numero di « Gerarchia ». Eppurequelle due sole righe sono sufficienti per regalare al lettore, tuttointiero, il significato piu profondo della riflessione morale e politicagramsciana. In quelle due righe si manifesta lo scarto tra l’idea didisciplina universitaria di Newman e il significato politico di cuiessa si riveste in Gramsci. La sua idea di filologia si prospetta come
(54) D. QUAGLIONI, Universita e « spirito pubblico », in L’Universita a Trento.1962-2002, a c. di F. Cambi, D. Quaglioni, E. Rutigliano, Trento, Universita di Trento,2004, pp. 5-47: p. 29.
(55) Ivi, pp. 29-30.(56) Un lavoro di questo tipo e stato avviato non molti anni fa da G. FRANCIONI,
L’officina gramsciana. Ipotesi sulla struttura dei « Quaderni del carcere », Napoli, Biblio-polis, 1984.
QUADERNI FIORENTINI XXXVII (2008)366
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
garanzia di verificabilita del dato, quale metodo necessario a unavera riforma democratica delle istituzioni politiche. A guardar bene,la riflessione gramsciana e in realta una riflessione sulla concretarelazione tra « verita e politica », comunque si vogliano intendere idue termini, e il primo nello specifico. La filologia, che nel suo uni-verso ideale e morale si presenta come l’esempio piu diretto delladisciplina universitaria, e in certo qual modo nient’altro che la ri-cerca della verita e della possibilita offerta a ciascuno di poter ve-rificare l’onesta di ogni affermazione; e insomma la nota a pie dipagina, nella quale, come ricordava il poeta, si ritrova e si perpetuala civilta di un popolo.
Ev stato altresı ricordato che la « questione universitaria ha inGramsci, lo stesso valore di una questione della ‘sprovincializza-zione’, o della costruzione di un ordine intellettuale e morale » —tale era appunto il proposito dei Quaderni fin dalle prime bozze —« come edificazione di una coscienza europea, e percio stesso comeriforma morale degli Italiani » (57). Fu questa esigenza di profondariforma morale che Pigliaru ritrovo nella riflessione gramsciana,particolarmente nelle due righe poste in calce al testo di Newman,con le quali si suggeriva il metodo e la via per realizzarla.
Interrogandosi sull’eredita di Gramsci, presento la questioneuniversitaria come il tratto piu rivoluzionario nella sua interpreta-zione del materialismo storico (58). Desiderava dunque compren-dere se e come la cultura era riuscita a far propria la lezione dell’in-tellettuale, quali elementi di arricchimento ne aveva tratto; in qualidirezioni ne aveva svolto le indicazioni, tenendo conto « non solodel significato totale che il nome e il pensiero di Gramsci hannoavuto ed hanno nel quadro della cultura contemporanea, la dove sifa piu fitto e intenso il discorso critico su marxismo e filosofie; mapiuttosto di quell’altro possibile significato che il nome e il pensierodi Gramsci possono assumere nei confronti dell’organizzazione‘culturale’ della Sardegna, cioe nei confronti di una intervenuta o
(57) D. QUAGLIONI, Universita e « spirito pubblico », cit., p. 31.(58) A. PIGLIARU, L’eredita di Gramsci e la cultura sarda, in Gramsci e la cultura
contemporanea, I, Atti del convegno internazionale di studi gramsciani tenuto a Cagliariil 23-27 aprile 1967, a c. di P. Rossi, Roma, Editori Riuniti, 1969, pp. 487-533.
PAOLO CARTA 367
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
mancata riforma dell’intellettuale sardo » (59). La biografia intellet-tuale di Gramsci diventava essa stessa un fatto particolarmente si-gnificativo per affrontare un bilancio della cultura sarda come cri-tica interna ed esterna. Quale uso questa cultura ha saputo o volutofare dell’esperienza gramsciana « se e vero che la critica e il supe-ramento che Gramsci fa della propria ‘formazione giovanile’ sonoinsieme critica e superamento di una condizione oggettiva e di unastoria identificabili con le condizioni e la storia della cultura sardagiunte ad un determinato grado di sviluppo, e comunque coinvolte,in lui, nella possibilita di un piu largo e approfondito esame di co-scienza » (60). Gramsci impersonificava la coscienza critica, e la suaesperienza andava considerata come momento della coscienza cri-tica nella storia dell’intellettuale italiano e sardo nello specifico.
Sulla scorta di quella mirabile pagina dei Quaderni intitolataStoricita della filosofia della prassi, che e appena il caso di ricordare,Pigliaru indicava nel carattere antidogmatico e storicistico le pecu-liarita della lezione gramsciana. In quel particolare frangente il ma-terialismo dialettico cedeva il passo a un piu rigoroso e criticamentevalido materialismo storico, per cui la filosofia della prassi potevaconcepire se stessa storicisticamente, cioe come un momento tran-sitorio del pensiero filosofico. Tutto cio emergeva in modo esplicitoanche nella tesi esposta da Engels nell’Antiduhring, secondo laquale lo sviluppo storico sarebbe stato caratterizzato « dal passag-gio dal regno della necessita al regno della liberta » (61). Se soloHegel, sia pure in forma di « romanzo filosofico », era stato capacedi incarnare in un unico sistema quella coscienza delle contraddi-zioni da cui la societa e stata lacerata, in quanto manifestazionedelle contraddizioni in atto tra i diversi sistemi filosofici in lotta traloro, la filosofia della prassi avrebbe dovuto farsi carico di rifor-mare e sviluppare lo hegelismo. In tal modo essa si presentava comefilosofia « liberata (o che cerca di liberarsi) da ogni elemento ideo-logico unilaterale e fanatico »; essa era « la coscienza piena dellecontraddizioni, di cui lo stesso filosofo, inteso individualmente o
(59) Ivi, p. 487.(60) Ivi, p. 488.(61) A. GRAMSCI, Quaderni del carcere (Q 11, § 62), II, cit., p. 1487.
QUADERNI FIORENTINI XXXVII (2008)368
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
inteso come gruppo sociale, non solo comprende le contraddizionima pone se stesso come elemento della contraddizione, eleva que-sto elemento a principio di conoscenza e quindi di azione » (62).
Dal riconoscimento del valore provvisorio di tutte le filosofie,della « storicita di ogni concezione del mondo », nasceva l’esigenzadi evitare la deformazione della riflessione filosofica in una ideolo-gia, intesa nel senso deteriore, cioe ridotta a « un sistema dogma-tico di verita assolute ed eterne » (63). La filologia, l’estremo rigoremetodologico, rappresentava la garanzia contro la riduzione dellafilosofia a ideologia e insieme il ripristino dell’autenticita in luogodella faziosita. Poiche erano note le critiche di Gramsci contro l’or-ganizzazione scolastica e la didattica universitaria italiana « quasisempre dogmatica e formalistica », la richiesta contenuta nelle duerighe di commento a Newman appariva a Pigliaru trasparente: nonsi trattava « di ridurre tutto ad accademia: ma di prendere atto delfatto che il rigore delle ‘stanze accademiche’ ha una validita ogget-tiva, e anzi che questa disciplina ‘per la formazione intellettuale’ euna forma di difesa necessaria contro dilettantismo e settari-smo » (64).
Il perseguimento di tale metodo, secondo Pigliaru, fu un atteg-giamento originario in Gramsci, non acquisito tardivamente e man-tenuto vivo anche durante la sua azione politica (65):
Lo stesso « rigore » del linguaggio « sperimentato » negli articoli dell’Or-dine Nuovo ne e una riprova, resa esplicita, del resto, come « tesi », da quelframmento intitolato Dilettantismo e disciplina, che denuncia « una tendenza
(62) Ibidem.(63) A. PIGLIARU, L’eredita di Gramsci e la cultura sarda, cit., p. 490.(64) Ivi, p. 491. Questo il brano di Gramsci: « Dilettantismo e disciplina. Neces-
sita di una critica interna severa e rigorosa, senza convenzionalismi e mezze misure.Esiste una tendenza del materialismo storico che sollecita [e favorisce] tutte le cattivetradizioni della media cultura italiana e sembra aderire ad alcuni tratti del carattere ita-liano: l’improvvisazione, il ‘talentismo’, la pigrizia fatalistica, il dilettantismo scervellato,la mancanza di disciplina intellettuale, l’irresponsabilita e la slealta morale e intellet-tuale. Il materialismo storico distrugge tutta una serie di pregiudizi e di convenziona-lita, di falsi doveri, di ipocrite obbligazioni: ma non percio giustifica che si cada nelloscetticismo e nel cinismo snobistico » [A. GRAMSCI, Quaderni del carcere (Q 6 § 79), cit.,p. 749].
(65) A. PIGLIARU, L’eredita di Gramsci, cit., p. 491.
PAOLO CARTA 369
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
del materialismo storico [a sollecitare e favorire] tutte le cattive tradizionidella cultura media italiana e [che] sembra aderire ad alcuni tratti del carat-tere italiano: l’improvvisazione, il ‘talentismo’, la pigrizia fatalistica, il dilettan-tismo scervellato, la mancanza di disciplina intellettuale, l’irresponsabilita e laslealta morale e intellettuale ». Cosı viene posta un’esigenza di fondo: la « ne-cessita di una critica interna severa e rigorosa, senza convenzionalismi e mezzemisure », dove pare opportuno sottolineare di proposito l’espressione: « ne-cessita di una critica », ma piu ancora gli aggettivi successivi: « interna severarigorosa ».
L’esercizio costante e permanente della critica verso gli altri esoprattutto verso se stessi, e il corollario necessario al metodo indi-cato da Gramsci nella pagina sull’Universita. La filosofia dellaprassi esige fedelta al rigore metodologico proprio delle « stanzeaccademiche », perche appartiene a quel metodo il compito di sor-reggere e incoraggiare incessantemente l’esercizio critico: « Fuori diquesta fedelta ci sono i rischi saputi [;] gli atteggiamenti olimpicialla Volfango Goethe; la ricaduta nella ideologia intesa nel sensodeteriore e dunque nel dogmatismo delle verita assolute ed eterne;la confusione della filosofia della prassi (come materialismo storico)col materialismo volgare, anzi ‘con la metafisica della materia chenon puo non essere eterna e assoluta; il ritorno insomma ad una fi-losofia contaminata ulteriormente da ‘ogni elemento ideologico efanatico’; la perdita della piena ‘coscienza delle contraddizioni’, contutto cio che l’espressione significa nei termini in cui Gramscistesso la usa nella ricordata pagina sulla storicita della filosofia dellaprassi » (66).
Rinunciare a tali contraddizioni e alla storicita, significava chiu-dere ogni esperienza, rigettandola direttamente in quel « provincia-lismo e in quel particolarismo integranti, a volte, i vizi d’origine di‘culture’ che non realizzano una trasfigurazione collettiva in sensonazionale-europeo, ma restano somma di ‘raids individuali’, ‘sortite’che in questo senso assumono forme per lo piu caricaturali, me-schine, ‘teatrali’, ridicole » (67). La riflessione di Pigliaru si ricon-giungeva in tal modo al momento della sua germinazione iniziale,con quell’espresso richiamo all’esigenza di sprovincializzare la pro-
(66) Ivi, p. 492.(67) Ibidem.
QUADERNI FIORENTINI XXXVII (2008)370
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
vincia, che costituı la cifra costante e piu autentica del suo pensiero.Di qui il riconoscimento dei tratti maggiormente significativi dellariflessione di Gramsci nell’antiprovincialismo, nell’antiregionalismo,nell’ampiezza nazionale e cosmopolita del suo lavoro. La consape-volezza di tali caratteri era il passo preliminare per la presa di co-scienza delle potenzialita, che essi avrebbero potuto garantire allaSardegna, e insieme all’isola anche ad altre realta, chiuse e retrive.Le ben note pagine gramsciane dedicate al folclore e rievocate daPigliaru, possono apparire oggi anacronistiche e tuttavia non per-dono il proprio valore. Proprio oggi la dilettantesca retorica poli-tica, che si esprime soprattutto nella dimensione localistica, paremoltiplicare l’uso di termini come « identita » e « territorio », in-consapevole del significato che tali vocaboli hanno avuto nella sto-ria democratica italiana (68):
La attivita formativa dello Stato che si esprime, oltre che nell’attivita po-litica generale, specialmente nella scuola, non si svolge sul niente e dal niente:in realta essa e in concorrenza e non in contradditorio con altre concezioniimplicite ed esplicite e tra queste non delle minori e meno tenaci e il folclore,che pertanto deve essere ‘superato’. Conoscere il folclore significa pertantoper l’insegnante conoscere quali altre concezioni del mondo e della vita lavo-rano di fatto alla formazione intellettuale e morale delle generazioni piu gio-vani, per estirparle e sostituirle con concezioni ritenute superiori. Dalle scuoleelementari alle cattedre d’agricoltura, in realta, il folclore era gia sistematica-mente battuto in breccia: l’insegnamento del folclore agli insegnanti dovrebberafforzare ancor piu questo lavoro.
Lo spirito antiprovincialistico, cosı come si rivela in questobrano, rappresenta uno dei tratti piu caratteristici del pensiero de-mocratico italiano. Pertanto, secondo Gramsci, un conto e pren-dere in considerazione il folclore, altro e l’« ismo », che da esso traela propria origine. Il « folclorismo », mito generato dal ripudiodella disciplina universitaria e del metodo filologico, e da intendere« come una delle forme in cui si esprime la negazione di ogni mo-bilita e di ogni fluttuazione che anche nel folclore possano essereregistrate » (69). Se il folclore puo comunque essere fatto oggetto discienza, il folclorismo e direttamente connesso alla dimensione pro-
(68) Ivi, pp. 496-497.(69) Ivi, p. 496.
PAOLO CARTA 371
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
vinciale della cultura e puo definirsi come l’abbandono deliberato« all’isolamento storico e ad una cultura arbitrariamente privata diogni residua mobilita, accettata anzi esclusivamente in quelle chesono le sue forme massimamente chiuse ed esaurite », hegeliana-mente incomprensibili, « perche private della loro stessa originariae spontanea obiettivita e storicita » (70). La bizzarria di tali formerisiede nel loro perpetuarsi ben oltre le condizioni che le hannoprodotte, dando vita a una classe di intellettuali, incapaci di com-prendere scientificamente il folclore e dunque di storicizzarlo, su-perandolo. Si tratta di un momento essenziale della eredita diGramsci, una delle sue cifre insostituibili.
Le riflessioni gramsciane sulla disciplina universitaria si innesta-vano comunque in un discorso piu complesso intorno alla parteci-pazione attiva del popolo alla vita politica, momento indispensabileper lo sviluppo della democrazia e per un’« estinzione democraticadello Stato ». Occorrera pertanto fare un passo indietro rievocandola ben nota pagina del 1930-31, intitolata Il « Saggio popolare » e lasociologia, per comprendere l’esatto significato che Gramsci attri-buiva al metodo filologico applicato alla politica. In quelle pagineegli manifestava la propria preoccupazione circa la riduzione delmaterialismo storico a una sociologia marxista. Il pericolo insito intale operazione si scopriva in modo limpido nell’incentivo alle « fa-cili improvvisazioni giornalistiche dei ‘genialoidi’ » (71):
La ‘filologia’ e l’espressione metodologica dell’importanza dei fatti parti-colari intesi come ‘individualita’ definite e precisate. A questo metodo si con-trappone quello dei ‘grandi numeri’ o della ‘statistica’, preso in prestito dallescienze naturali o almeno da alcune di esse. Ma non si e osservato abbastanzache la legge dei ‘grandi numeri’ puo essere applicata alla storia e alla politicasolo fino a quando le grandi masse della popolazione rimangono passive —
(70) Ibidem. Per le osservazioni sul folclore cfr. A. GRAMSCI, Quaderni del carcere(Q 27 § 1), III, cit., pp. 2311-2314.
(71) A. GRAMSCI, Quaderni del carcere (Q 7 § 6), II, cit., pp. 856-857. Si tratta diriflessioni elaborate sul testo di H. DE MAN, Il superamento del marxismo, trad. it. di A.Schiavi, Bari, Laterza, 1929. Secondo il curatore il riferimento esplicito a De Man po-trebbe anche riferirsi al volume La gioia del lavoro, Bari, Laterza, 1931 [ma fine 1930],che Gramsci avrebbe richiesto il 1o dicembre 1930 (A. GRAMSCI, Quaderni del carcere,cit., IV, pp. 2750-2751). Su questi temi si veda anche Q 11 § 25, Riduzione della filo-sofia della praxis a una sociologia, ivi, pp. 1428-1430.
QUADERNI FIORENTINI XXXVII (2008)372
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
per rispetto alle questioni che interessano lo storico o il politico — o si sup-pone che rimangano passive.
L’applicazione della ‘legge dei grandi numeri’, in luogo della fi-lologia, alle scienze storiche e alle scienze politiche, non era se-condo Gramsci priva di un significato politico, ne tanto meno sce-vra di conseguenze nefaste sia per la storia, sia per la politica. Il ri-pudio della filologia nell’ambito delle scienze storiche avrebbe po-tuto generare unicamente errori e spropositi scientifici, corretti inseguito dalla scoperta di documenti, che meglio avrebbero chiaritoe precisato cio che in origine era niente piu che una ipotesi. Nella« scienza », o « arte » della politica, tale avvicendamento del me-todo di analisi, scriveva Gramsci, avrebbe condotto a « catastrofi, icui danni ‘secchi’ » nessuno mai avrebbe potuto risarcire (72). L’ele-vazione della legge dei grandi numeri a legge politica, dunque, noncostituiva per Gramsci un errore scientifico, ma grave errore poli-tico in atto: « Ev incitamento alla pigrizia mentale e alla superficia-lita programmatica, e affermazione aprioristica di ‘inconoscibilita’del reale, molto piu grave che non sia nelle scienze naturali, in cuil’affermazione di ‘non conoscere’ e un criterio di prudenza meto-dica e non affermazione di carattere filosofico » (73).
Il suo ideale prevedeva che fosse proprio la politica, intesa nelsuo significato piu classico, a distruggere la legge dei grandi numeri,favorendo la fuoruscita delle « moltitudini » dalla passivita. In que-sto senso la ‘legge dei grandi numeri’ non potrebbe neppure ambireallo status di legge giacche essa intende negare la singolarita di ogniesperienza umana, cioe parte da un presupposto falso. La parteci-pazione attiva degli individui alla vita politica, in luogo di una pas-siva obbedienza al singolo, al capo individuale, era un passo neces-sario da compiere per il raggiungimento di una forma democraticadel potere. Discutendo di tutto cio Gramsci intuiva i confini di unsistema di partecipazione politica che dunque definiva « filologiavivente ». I sentimenti standardizzati delle grandi masse, che il sin-golo, il capo, conosce per espressione della legge dei grandi numeri,cioe « razionalmente, intellettualmente, e che egli — se e un grande
(72) A. GRAMSCI, Quaderni del carcere (Q 7 § 6), II, cit., p. 856.(73) Ivi, p. 857.
PAOLO CARTA 373
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
capo — traduce in idee-forza, in parole-forza », in una dimensionedemocratica del potere potrebbero essere conosciuti « per compar-tecipazione [...] per esperienza dei particolari immediati, con un si-stema di ‘filologia’ vivente, per cosı dire ». Tale era il compito delpartito politico, innestato in modo vitale nelle masse. Cio che quipero importa e sottolineare lo stretto nesso tra filologia e politicanel pensiero di Gramsci. Tale nesso appare in tutta evidenza nelladefinizione dell’idea di Stato senza Stato, che costituisce il risvoltogramsciano piu originale al problema marxiano dell’estinzione delloStato: insomma e proprio mediante questa « filologia vivente » chesi creano le condizioni per « definire la forma finale di una demo-crazia completa, che non sia semplicemente una forma di Stato po-litico, ma un suo vero e proprio superamento »; una democraziagovernante e non piu solo governata (74).
Alla traccia elaborata per il convegno gramsciano in cui questitemi erano appena sfiorati, Pigliaru fece seguire la sfida di tradurrein aula quel particolare metodo; meglio, di riportare quel metodonel suo luogo naturale, laddove Gramsci aveva potuto individuarloe proporlo come modello da imitare nell’azione politica. Il progettoebbe luogo nel mezzo della contestazione studentesca del ’68,quando la spinta di una forte e sentita esigenza di riforma dell’in-segnamento universitario, pareva chiudere piuttosto che riaprire icanali di comunicazione tra professori e studenti (75).
Il corso di Dottrina dello Stato ebbe inizio come riflessione piuo meno ordinata sulla necessita di « fondare una didattica anche alivello universitario come un fatto di autogoverno, cioe affermare lanecessita della didattica universitaria come didattica dell’autogo-verno ». Niente di nuovo in questa idea, giacche essa era andata af-fermandosi da quasi un secolo nella cultura pedagogica. L’autogo-verno in ogni caso richiedeva preliminarmente la giustificazione,per quanto possibile razionale, della presenza in classe di un pro-fessore. In tal senso Pigliaru intendeva la didattica dell’autogoverno« come didattica che presuppone un rapporto [...] maestro-scolaro
(74) A. PIGLIARU, L’eredita di Gramsci e la cultura sarda, cit., pp. 500-501.(75) Sulla particolare articolazione del corso si veda soprattutto M. PULIGA, An-
tonio Pigliaru. Cosa vuol dire essere uomini, cit., pp. 222-238.
QUADERNI FIORENTINI XXXVII (2008)374
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
in termini di rapporto dialettico, reciproco, unitario, non arbitrarioo autoritario » (76). Il discorso poteva essere dunque schematizzatoin quattro punti: fondazione generale della didattica dell’autogo-verno; giustificazione della presenza del professore nel rapporto di-dattico anche universitario; fondare quella didattica e giustificarequesta presenza con la stessa logica; fondare tutto cio sulla stessalogica con cui e possibile affermare il necessario passaggio dalla de-mocrazia governata alla democrazia governante.
Pigliaru proponeva in aula un’analisi filologica delle tesi diMarx su Feuerbach rilevando le erronee traduzioni che avevano ge-nerato pregiudizi e interpretazioni distorte. Cio accadeva soprat-tutto a proposito dell’idea di una filosofia della prassi intesa come« filosofia arrovesciante » e non gia come « prassi che semplice-mente rovescia », cosı come affermava Mondolfo, sulla scorta diuna prima fuorviante traduzione di Gentile. E proprio l’Umanismodi Marx di Rodolfo Mondolfo era il testo adottato per gli studen-ti (77). Nelle Tesi marxiane, Pigliaru individuava il punto di ap-prodo del pensiero contemporaneo « inteso come umanesimo ecome storicismo » (78).
Il tratto rivoluzionario di tale filosofia, che concepisce se stessanella sua dimensione storica, poteva essere compreso anche me-diante la teologia paolina e non solo con il ricorso alle tradizionalifonti politiche, quali ad esempio Rousseau, lettura piu consueta ebanale per spiriti solidali con un’esigenza di trasformazione dellarealta: « Quando san Paolo chiede ai cristiani ‘smettete l’uomo vec-chio, prendete l’uomo nuovo’, non fa altro che chiedere al cristianodi rovesciare il proprio atteggiamento nei confronti di se stesso einsieme nei confronti della realta. Il rivolgimento di se in se e percosı dire il presupposto alla edificazione del regno di Dio per quellaconsumazione delle cose, che comunque, a prescindere dal piano
(76) A. PIGLIARU, Il rispetto dell’uomo, cit., p. 39 (lezione 6 novembre 1968).(77) La riflessione di Mondolfo sul materialismo storico di Engels, come e noto,
rappresentava per Gramsci, contrariamente a quanto ritenuto da Sorel, « l’indicazionedi una via da seguire » (A. GRAMSCI, Quaderni del carcere (Q 4 § 1), I, cit., pp. 420-421).
(78) A. PIGLIARU, Il rispetto dell’uomo, cit., p. 53 (lezione 11 novembre 1968).
PAOLO CARTA 375
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
religioso in cui il discorso di san Paolo e posto, e un modo di tra-sformare la realta » (79).
Il movimento studentesco, indipendentemente dalla contesta-zione di una data societa, ma limitatamente alle sue critiche rivoltealla didattica, scopriva dunque un’esigenza oggettiva di riforma del-l’ordinamento universitario, divenuta ormai improcrastinabile. Essaportava « a livello universitario, con le sue contestazioni della didat-tica accademica e tradizionale, l’essenza stessa di tutta la pedagogiamoderna [intesa] in quanto sviluppo coerente e completo di unaconcezione dell’uomo interamente fondatesi come prassi » (80). Asuo giudizio esisteva un « blocco storico della filosofia moderna,dall’umanesimo allo storicismo », che si fondava sulla scoperta eprogressiva affermazione dell’uomo come prassi. Cio consentiva diripensare la relazione professore-allievo come mutuo rapporto disoggetti attivi, in cui lo stesso educatore, per cosı dire, poteva es-sere educato. Accanto a tale esigenza giungeva la denuncia di ognididattica che ha per presupposto un momento nel quale uno deidue termini « sia disumanizzato, cioe privato di quella soggettivitache e propria dell’uomo in rapporto all’attivita come attivita uma-na » (81). Proprio in quanto essa si concretizzava nella realizzazionedei soggetti, non era pensabile alcuna didattica che non fosse anchepluralistica; non era pensabile cioe una didattica che non facessepropria la liberta degli insegnamenti. Pigliaru ritrovava il fonda-mento del pluralismo e di questa liberta nella gia ricordata paginagramsciana dedicata alla filosofia della prassi: la consapevolezzadella provvisorieta, nell’esperienza storica, e di per se garanzia delpluralismo in ambito scientifico e culturale (82). Cio imponeva na-turalmente di prendere in considerazione il problema della scienzacome ricerca della verita. Liberta della scienza, cosı come libertadell’insegnamento, affermava Pigliaru, significa innanzitutto « de-terminazione a non anticipare, a verificare, a sottostare ai risultatidell’esperienza »; significa anche la negazione di scientificita a qua-
(79) Ivi, p. 42 (lezione 6 novembre 1968).(80) Ivi, p. 44.(81) Ivi, p. 50.(82) Ivi, p. 81 (lezione 17 novembre 1968).
QUADERNI FIORENTINI XXXVII (2008)376
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
lunque lavoro impostato su di una tesi preconcetta. In ambitoschiettamente politico il rapporto tra « verita e politica », come giasi e avuto modo di osservare in Gramsci, si presenta come il rifiutodi ridurre la verita ad altro: « La rivoluzione stessa », era l’ammo-nimento che faceva ai suoi studenti, « non e rivoluzione se non everita; [...] dire che si puo scegliere la rivoluzione contro la veritaquando la scelta [e] tra rivoluzione e verita, vuol dire che la rivolu-zione non e la rivoluzione. Una rivoluzione che ponga l’alternativacon la verita non e rivoluzione. Quindi anche in questo senso,liberta di insegnamento e rifiutarsi di ridurre la verita ad altro [...]anche la politica (se la politica e verita) e la stessa rivoluzione (se erivoluzione e verita), non puo temere la verita » (83).
L’autenticita dei risultati e la consapevolezza della loro provvi-sorieta comportava comunque che il modo migliore per presentareil proprio lavoro scientifico fosse, come affermava Giuseppe Capo-grassi, la scrittura di una « lettera »: « Io scrivo con la speranza cheun giorno o l’altro un giovane capiti in una bancarella, compri unacopia del mio libro, lo fiuti e lo porti a casa per leggerlo come silegge una lettera » (84). In tal senso egli parlava della lezione acca-demica come di « una proposta ». Questa impostazione era natural-mente da intendersi in riferimento all’intero corso, durante il qualele singole lezioni sarebbero dovute essere, almeno per una loroparte cospicua, necessariamente nozionistiche e tecniche. Cio per-che, cosı come Gramsci, Pigliaru intendeva la rivoluzione in ambitoaccademico come la conquista di una didattica capace di formare,anche nei contenuti, una vera coscienza storica. Le difficolta perraggiungere questo fine erano tali e tante, da richiedere tempi lun-ghi; non era ipotizzabile, per tutti, una magia come quella beneespressa dal verso di Montale: « ‘Buffalo’! e il nome agı » (85). Fuuna pagina tratta dal diario del suo amico Aldo Capitini, che lessee commento in classe, a mostrare quale pazienza fosse necessaria alraggiungimento del fine: « Dunque difficolta per gli ostacoli esterni,difficolta perche ci siano uomini degni e preparati. Queste difficolta
(83) Ivi, p. 85.(84) Ivi, p. 83.(85) Ivi, p. 100 (lezione 27 novembre 1968).
PAOLO CARTA 377
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
non si vincono in un lampo o con un colpo di mano. Sono tornatoal punto fondamentale: una nuova coscienza persuasa, se non vuolerompere facilmente, fara come il grano che per l’inverno e la nevespinge piu nel profondo le sue radici » (86). Questo era anchel’aspetto piu complesso da chiarire nell’aula.
Replicando a uno studente che gli rimproverava di esprimereunicamente una sua interpretazione del marxismo, una sua inter-pretazione della didattica, del pensiero contemporaneo, Pigliaru di-chiarava (87):
Cosa vuol dire una sua interpretazione? Deve avere, per aver significato,solo un senso: che nelle mie lezioni manca cio che neanche i Gentili fanno(anche i Gentili: il Vangelo ogni tanto dice questo: « non lo fanno neanche iGentili »): quello di esporre obiettivamente e in modo asettico le dottrine.Qui non lo fa perfino la procedura civile, bene attenta a non interpretarenulla per non compromettersi: « c’e questo istituto, questa scuola sostiene A,questa scuola sostiene B, questa scuola sostiene C, noi col Chiovenda conclu-diamo che... ». Non e lo schema logico della scuola accademica questa falsaobiettivita? Non e lo schema tradizionale della lezione cattedratica questafalsa e asettica obiettivita che consente alla gente di passare pulita, senza bru-ciarsi, attraverso tutti gli incendi e tutti i regimi? Non e proprio l’Universitache contestate questa? Bene, allora cosa vuol dire interpretazione? Debbodire da un punto di vista metodologico, che non esiste un discorso scientificoche non sia una interpretazione [...]. Se siamo d’accordo nello scartare comeobiettivita scientifica quella falsa obiettivita per cui anche i processualisti ci-vili possono sembrare obiettivi perche espongono puntualmente tutte le dot-trine, attenti a non compromettersi, debbo ricordarvi che l’obiettivita dellascienza non consiste nella compiutezza della esposizione. L’obiettivita di una
(86) Ivi, p. 97. I legami tra Pigliaru e Capitini, oltre che dal cospicuo numero dilettere, alcune delle quali rievocate nel volume di M. PULIGA, Antonio Pigliaru. Cosavuol dire essere uomini, cit., p. 105 e pp. 154-155; si possono apprezzare nel saggio diA. PIGLIARU, Promemoria sull’obiezione di coscienza, « Studi Sassaresi », 1, Giurispru-denza, XXXI, fasc. I-IV, 1967 (1968), pp. 9-75; poi in Scritti in memoria di Widar Ce-sarini Sforza, Milano, Giuffre, 1968, pp. 637-661 e quindi in A. PIGLIARU, Scritti discienza politica, cit., pp. 203-264. Sulla personalita e il pensiero di Aldo Capitini si rin-via a N. BOBBIO, La filosofia di Aldo Capitini e ID., Religione e politica in Aldo Capitini,in ID., Maestri e compagni, Firenze, Passigli, 1984, rispettivamente a pp. 239-260 e 261-299; P. POLITO, L’eresia di Aldo Capitini, prefazione di N. Bobbio, Aosta, Stylos, 2001;M. POMI, Al servizio dell’impossibile. Un profilo pedagogico di Aldo Capitini, Milano-Fi-renze, RCS-La Nuova Italia, 2005. Un’ampia bibliografia e reperibile nel sito www.al-docapitini.it, a cura dell’« Associazione Nazionale Amici di Aldo Capitini » con sede aPerugia.
(87) A. PIGLIARU, Il rispetto dell’uomo, cit., pp. 114-115 (28 novembre 1968).
QUADERNI FIORENTINI XXXVII (2008)378
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
proposizione, cioe la scientificita di una proposizione (perche la obiettivita esempre da verificare) e legata al protocollo di verifica e alla ripetibilita dellaesperienza [...]. Cioe una proposizione e scientifica solo quando nel momentostesso in cui si pronuncia, da, indica gli strumenti per la propria verifica.
In tal senso il modello suggerito da Gramsci trovava il suocompimento in un corso, che in quanto riflessione sul rovescia-mento di una prassi, si proponeva a suo modo come rivoluzionario.La lezione del 9 dicembre fu quella in cui il discorso della possibileapplicazione della disciplina universitaria alla realta politica e istitu-zionale emerse con maggiore efficacia, ritrovando nel contesto delcorso accademico il suo luogo naturale (88):
Il rapporto didattico si pone come rapporto di liberta tra uomo e uomoe quindi: 1) Riconosce senza scandalo il fondamentale pluralismo della cul-tura: i pluralismi della cultura cambiano a seconda della struttura della so-cieta; 2) Riconosce senza scandalo nel docente, in quanto uomo, un possibileportatore di ideologie; 3) Indica altresı nel rispetto didattico e morale dell’al-tro il limite stesso della propria liberta di ideologo; 4) Riconosce nell’altro ilportatore presente o futuro di un’altra ideologia, e intanto; 5) Lo costituiscecome una prospettiva immediatamente critica del proprio sapere ideologico(lo scolaro come prospettiva critica del sapere ideologico del maestro) e que-sto e un punto che segnalerei [...], perche anche questo e un modo di avvici-narsi al problema dell’Universita come Universita critica; 6) Pone cosı lo sco-laro come ipotesi di superamento e innanzitutto di verifica: ed ecco perche misono sempre riferito nelle lezioni al fondamento di questa didattica, alla filo-sofia della prassi come fondamento di questa didattica la quale non puo nonporre lo scolaro come ipotesi di verifica e innanzitutto come ipotesi di supe-ramento; 7) Responsabilizza negli stessi termini docente e scolaro; 8) Deter-mina quel salto qualitativo della scuola che si esprime nel passaggio inevita-bile dalla inevitabilita di una scuola ideologica, trasmissione passiva del sa-puto cioe del sistema, alla possibilita di una scuola metodologica, verifica cri-tica nel senso di verifica critica di tutto il sistema e revisione in atto di tuttoil saputo. Qui ho segnato un appunto molto breve che mi limito ad enunciare:la scuola metodologica come scuola democratica aperta e non dogmatica,esercizio attivo di un autentico rapporto di liberta. E, a questo punto, per unabreve rivendicazione di alcuni aspetti che sono spesso mistificati e che sonoanche mistificatori nella didattica universitaria tradizionale ma non perciofalsi (sono mistificatori perche sono mistificati). Avevo segnato nella pagina difronte due importanti pensieri di Gramsci circa la disciplina universitaria,pensieri, dovrei dire, rivoluzionari se non ci fosse in sospeso il discorso sullarivoluzione e su cio che e rivoluzionario. Due importanti pensieri rivoluzio-nari di Gramsci sulla disciplina universitaria, considerata in un suo momentopiu tradizionalista e meno rivoluzionario, cioe piu metodologico. Sono due
(88) Ivi, pp. 122-123 (lezione 9 dicembre 1968).
PAOLO CARTA 379
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
frammenti tratti dal volume su Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura.Il primo richiama l’attenzione sul fatto che la disciplina universitaria, di unauniversita come scuola di metodo con rigore filologico (chi di voi abbia stu-diato Gramsci non puo ignorare e non deve dimenticare l’estremo rigore fi-lologico con cui Gramsci ha sempre lavorato: da giovane, cioe da universita-rio, mentre era direttamente impegnato nella politica, mentre era costretto alsilenzio nel carcere e ripensava a tutti i termini del proprio pensiero), la di-sciplina universitaria deve essere considerata come un tipo di disciplina per laformazione intellettuale valida anche per le istituzioni non universitarie insenso ufficiale e direi abbastanza importante anche se e uno dei punti piu tra-scurati della cultura contemporanea.
Ai suoi studenti Pigliaru ricordava che la riforma universitariaavrebbe dovuto considerare il tesoro perduto della rivoluzione, nongia la sua superficie, e quel tesoro, per lui, andava recuperato in-nanzitutto nella lezione di Gramsci.
QUADERNI FIORENTINI XXXVII (2008)380
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano











































![lezione IVA 10-7.ppt [modalit\340 compatibilit\340] - My LIUC](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633614a362e2e08d490356f1/lezione-iva-10-7ppt-modalit340-compatibilit340-my-liuc.jpg)