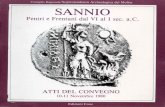Intorno alla regolamentazione dell'uso "giuridico" dell'argento nel mondo mesopotamico
Transcript of Intorno alla regolamentazione dell'uso "giuridico" dell'argento nel mondo mesopotamico
INTORNO ALLA REGOLAMENTAZIONEDELLUSO "GIURIDICO" DELLARGENTO
NEL MONDO MESOPOTAMICO
D a n i lo C e cca re lli -M o ro I li
SolntRnro: 1. Nota introduttiva - 2. I "Codici" mesopotamici e l'argento: esamedelle fonti - 3. Qualche considerazione conclusiva
7. Nota introduttiua
L'oggetto di questo modesto studio è quello di tentare di determi-nare le vaiazioni subite dall'argento (in accadico kaspum) nel corso deitre millenni di storia-vicino orient ale antica del mondo mesopotamicoattraverso l'analisi dei cd. "testi giuridici". Dunque si cercherà di notarel'impiego dell'argento usato in campo giuridico ed il suo relativo svilup-po in seno ad esso.
Pertanto, ci si occuperà solo del mondo mesopotamico tralascian-do volutamente l'area egiziana e quella anatolica, per or,wie ragioni di spa-zio e di tempo.
Dati i complessi problemi riguardanti il diritto nel Vicino OrienteAntico e la relativa interpretazione delle parole "legge" e "codice" -riguardo ai quali non si desidera qui entrare in merito - ci si baserà quale"fons iuris" sLll'opera del Saporettit; perciò tutte le "leggt" mesopotami-che saranno prese da tale autore.
Per quel che riguarda, invece l'aspetto ponderale dell'argento si ter-ranno presenti i dati riportati dal Caplice'z, che qui di seguito riproduciamor:
SE uttatum grano ca.I/20 gr.
CiN iiqlum siclo 180 5e = ca.8) gr.MA.NA nanùm mina 60 ciN = ca.500 gr.
GU/GUN biltum talento 60 ue.Na = 30 Kg.
I C. Saporctu, Le Leggi d.ellaMesopotafflia, Firenze 1984.2 R. Ceprrcr, Introduction to Akkadian, Rome 1988, p. 95. Si è ritenuto opportuno rifarsi a
Autore, poiché egli dà una tabella di pesi e misure completa.I In base allatabelTaabbiamo dunque la seguente equivalenza: 1 mina è data da 60 sicli.
<<ApoLLtNaruS>>, Anno LXXII, 2000, Fascicolo 1 -4
2. I'Codici' mesopotafiaici e I'argento: esarne delle fonti
Il materiale a nostra disposizione è dato dalle "leggi" mesopotami-
che, e quindi dagli"articoli" o "parugtafi" dei "codici"' Pertanto, ecco qui
di seguito, l'elenio del materiale scelto per i fini di questa piccola ricerca;
esso lostituisce la "fonte del diritto" relativamente allatematica prescelta'
(a) Dal Codice di I-Jr Narnrnu (=cuN)a sono attinenti per la nostra tema-
tica i seguenti parugrafr: §3, §8, §9, §10, §11, §14, §18, §20, §22,
s27.6) bal Codice di Lipit l§tar (=CLr)5, abbiamo i seguenti paragrafi: §14,
§15, §17, §18, §20, s22,s27.(c) bale Leggi di ana ittiiu (=I-AI)6, si hanno i seguenti patagrafi: 52 e
§3 dalla iarrolettu VII, e §§1 e 2 dal frammento YOS, I, 28'
(d) La le Leggi d.i Eìnurnma (=LE)1 , sono rilevanti i seguenti paragrafi:
§1, §1, §à;§7, §9, §11-A-I )6,5r2 A-1, §11, §14, §11-B II, §32-B
II, §42-A III, §4r-A III, §44-AIII, §45-A III, §r4-A IV §55-A IV§56-AV.
(e) b"l celeberrimo Codice di Harnmurapi (=cu)8, sono rilevanti i segg.
parugrafi: §4, §59, §90, §114, §115, §139, §140, §198, §201' §204'
§zoz] szos, s209, s211, ss2t2-217, ss22t-224, s228, s24t, s252,
§259, §260, SS2T-277.(0 b^ile Leggti Medio-Assire (=LMe)e, solo menzione genrica dell'ar-
g.r,to ,.1"§30 della ravoletta A-KAV.1 (riguardo ai doni nuziali).
(g) infine, ddleLeggi Neo-Babilonesz !=LNr)'.' è degno di nota solo il §6'
Alla luce del srladetto elenco di fonti, costituenti ciascuna un bloc-
co documentario per un dato periodo storico, si può procedere all'esame
dei medesimi seguendo un ordine cronologicoll, cioè partendo dai testi
più antichi fino I quelli più recenti. Quindi, si tenterà di rilevare le prin-
iipuirurorioni deil'argàto" e si cercherà di denotare l'uso fattone dallo
stesso; infine si pror"rà-u tracciare un diagramma dell'Ag rispetto al dirit-
414 Danilo Ceccarelli-Morollì
a cuN, in SaPorurrr, oP. cit.,iP.2l-25.5 cu, in SaponsrY oP. cb.,PP.27')4.6 rar, in Saponrrrt, op. cit.,pp.)5'19.7 rr, in Seponsrrt, op. cit., pp. 41-48.
8 cri, in SaPorurr\ oP. cit., PP' 49-92.
e rue,ln SaPonrm, oP. cit.,PP.91-116.10 tNa, in Seponrm, op. cit.,pp. ll7-120.1t Datalaproblematica della cronologia del mondo Vicino Orientale Antico, ci si è rifatti costan
*..*-ULi..a di M. LrvEnaNt,Antici Oiente. storia, Società, Economia, Roma-Bari 1988'
12 Per maggiore facilità esso si abbrevierà col simbolo chimico "Ag"'
Uso "giuridico" dell'argento ne| mondo mesopotarnico $5
to e quindi corcelazionandolo col tempo cronologico. Dunque vediamoora il ruolo dell'Ag all'interno dei singoli blocchi di fonti.
rk r'.- >k
(i) Il codice attribuito ad Ur Nammu (= CUN), che fu sovrano dellaterza dinastia di Ur, sviluppatasi nel cosiddetto periodo "neo-sumero"(21.20-2000 a.C. ca.), è la raccolta di leggi finora più antica esistente. Essocontiene ben trentadue parugrafi di leggi, dei quali sono rilevanti per lanostra tematica solo una diecina. Alf interno del cuN, osserviamo che ilpagamento di un tot di Ag è imposto come pena atta ad espiare precisireati, quali: il sequestrotr (punito con 15 sicli di Ag), la deflorazione diuna schiava verginela (5 sicli), lafalsa accusals (punita con j sicli) ed infi-ne la falsa testimonianzal6, punita con 15 sicli di Ag.
Inoltre, l'argento è dato come mezzo di risarcimento del danno fisicopersonale affecato; in questi si va dal pagamenro di soli 2 sicli per la rotruradi un dentelT ai I0 sicli per un piede18, infine ai 2/3 di una mina di Ag perl'amputazione del nasole. Casi a parte sono dati dalla quanrirà di Ag daconsegnare alla donna in caso di divorzio: dal/z ad 1 mina di argento20.
Il dato che emerge da cux è che la quantità ritenuta "giusta" periparure al danno o espiare il reato vaia da un minimo di Z sicli ad unmassimo di 1 mina d'Ag, dunque si va da una quantità di Z sicli pari a16,6 gr. ca. a 1. mina che pesa ca. 500 gr., secondo il seguente schema:
23101525sicli
IB dimina 2B dimina l mina= 20 sicli 40 sicli 60 sicli
(ii) Con il "codice" di Lipit I5tar (= CLI), ci roviamo nella mediaetà del bronzo e precisamente sotto la dinastia di Isin (ca.2017-1794a.C.). Lipit I§tar regnò dal L%4 al t9Z4 a.C. e fu autore di una raccolta dileggi pervenuta fino a noi e nota col nome di questo sovrano. Le leggi diLipit I§tar comprendono quarantadue paragrafi normativi con l'aggiuntadi altri sette provenienti da un ulteriore frammento. In realtà a noi inte-ressano solo circa sei articoli ffa tutto i corpus.
1r cux, §3.la cuN, §8.15 cux, §11.16 cur,, §27.17 cu.r, §22.Ì8 cox, §18ts cuN, s20.20 cuN, §§9-10
416 Danilo Ceccare lli-Morolli
Per quel che riguarda l'argento e la sua connessione col diritto non
notiamo cambiamenti significativi rispetto alle leggi mesopotamiche pre-
cedenti. Per un uomo che ruba in un frutteto2lla pena è di 10 sicli d'Ag,
mentre e di ben 1/z mina se taglia un albero"; a chi calunnia la verginità
di una vergine è imposta una ammenda di 10 sic1i23. Pene pecuniarie in
argento vengono inflitte a chi procuri aborto per mezzo di percosse; la
regola giuridica varia, nella ammenda, a seconda che si tratti di una
donna libera (1/zmina)2a oppure di una schiava (5 sicli)'?5. Infine, per
colui che si sia impossessato indebitamente di una schiava fuggiasca, la
pena è fissata a 10 sicli.Dunque, da quanto detto per tl cu, possiamo ffacciare per esso
una "linea di quantità"
sicli mlna
come appare chiaro non compare più sorto la dinastia di Isin laquantità parjaduna mina intera e soprattutto non vi sono più unità più pic-
cole, come t2 o i ) sicli, ma si parte direttamente dal quantitativo di 5 sicli.
(iii) Le Leggi di E§nunna (= LE) sono una raccolta legislativa redat-
ta in età neo-babilonese e probabilmente, a detta degli studiosi, di poco
anteriore al celeberrimo "codice" di Hammurapi. A differenza di altre
raccolte normative, le tE non traggono la propria denominazione dal
nome dell'artefice o del legislatore, bensì da quello della città - per l'ap-
punto E5nunna - a cui corrispondeva un potente stato.
Le ,,leggi,, o norme di questa collezione sono in tutto una sessanti-
na;traquestà;irca una diecina menzionano l'argento. È i.rt"t.ssunte nota-
re che pir la prima volta, nelle leggi mesopotamiche, compaia f istituto - o
forse dato il .uratt"re del diritto nel vicino Oriente Antico - la pratica del
noleggio nonché il lavoro salariato. Gli articoli delle Lr, in cui viene dato
,n .l*.o dettagliato dei beni che sono acquisibili mediante un solo siclo
di argento. Datò l'interesse di ciò, riportiamo l'elenco, riassumendolo: 1
gffi diorzo,) sila di olio ru§tum,l ban e2 sila di olio vegetal, I ban e5ilto di strutto, 4 ban di "olio di fiume", 6 mine dilana,2 gur di sale, I gur
di carbonato di sodio, 3 mine di rame ed infine 2 mine di rame lavotato'u.
21 cr-r, §14.zz at, Sl5.zt cu,s)8'2a cu, §4-II.25 cu, §6-IL26 crr in SaponETTt, op. cit., p.4l
a
Uso "giuridico" dell'argento ne| mondo rilesopotdrnico $7
come si può notare, salta subito all'occhio il fatto che con un solo siclodi Ag si potevano acquistare, secondo le leggi di Esnunna,ben3 mine (=1500 gr.) di rame lavoraro. La lista dei beni acquisibili con l'Ag, riportaranel primo paragrafo delle tr', appare importante al fine di ricostruire iltessuto economico-sociale del periodo paleo-babilonese; all'epoca, dun-que chi possedeva 1/zkg diAg deteneva un vero e proprio capiìale.
Ritornando all'argento nel diritto, osserviamo quanto segue. Il nologiornaliero di un caro di buoi, incluso il carrertiere, è fissato d alle rn ad1/3 di siclo di Ag27; mente il compenso di un mietitore per la durata dellemesse è fissato ad 1 siclo di Ag2s. Ma se ad un uomo si affidano 5 sicli diAg a)Joru bisognerà dargli 1 siclo di Ag quale ricompensa, mentre se gli siaffidano 10 sicli allon sarànecessario prowedere a dargliene duere. comesi può notare, nel periodo paleo-babilonese l'Ag è considerato non solocome metallo "nobile" atto a risarcire un danno o come dazione di unbene prezioso per espiare una pena; si inizia ad affermare nella realtàcome ricompensa del lavoro. Certamente questo processo è solo eviden-ziato dalle leggi di E§nunna e probabilmente ha precedenti molto antichi;le lr non sanciscono null'altro che la realtà esistente. Tuttavia, è interes-sante notare questo uso dell'Ag, che dalle raccolte giuridiche precedentisembra essere stato ignorato. Le LE non trascurano però l'aspetto, direm-mo noi oggi, penale. Infatti è ampia la casistica per i danni personali risar-cibili tramitela dazione di Ag: si va da una mina per il naso tagliato, idemper un occhio, fino alTa mezza mina per un dente o per l'orecchio, men-tre solo 10 sicli per aver dato uno schiafforo. In base al rapporto che esistetra argento e lavoro, si nota come il danno personale sia considerato sem-pre in modo estremamente grave; infatti se se un mietitore riceve per ilsuo lavoro 1 siclo di Ag, per un semplice schiaffo se ne debbono darè ben10: Si comprende bene che l'eventuale colpevole del danno personaledebba sborsare una considerevole quantità d'argento.
Anche per LE, possiamo dare una tabella quantitativa:
--1 siclo-------5--------10- ---------I2 sicli --------- --- 1/z mina 1 mina
Per la prima volta, nelle leggi mesopotamiche, compare la quantitàdi 1 siclo, mentre il massimo è sempre 1 mina.
" tu,53.
'u au, §9.2e ru, §14.jo
rc,,542.
438 Danilo Ceccarelli-Morolli
(iu) Il codice di Hammurapi (= cH) è senza dubbio la raccolta dinorme più nota al mondo giuridico occidentale, esso racchiude ben 282
articoli o parugrafi normativi; ciò fa sì che sia i-l "codice" più lungo e piùimponente che il mondo mesopotamico ci abbia 6asmesso. Hammurapi,
re di Babilonia, è passato alla storia non solo per le sue fortunate imprese
militari e per il codice, ma anche per l'importante riforma religiosa attua-
ta in Babilonia; infatti al dio Enlil egli sostituì nel culto ufficiale di stato ildio Marduk, conferendogli così una speciale preminenz*1. Infine, l'im-portanza di Hammurapi, risiede anche per i problemi relativi alla crono-
iogia storica del Vicino Oriente Antico. Infatti, a seconda di quale data-
ziòne si assegni al suo periodo di regno, si ottengono diverse cronologie
della storia mesopotamica e vicino orientale antica. La data di regno diHammurapi più utilizzata dagli orientalisti è quella che pone il suo regno
d^l1792 al tl5O a.C.; tale datazione fissa le coordinate cronologiche per
la cosiddetta "cronologia media" (che è, attualmente, quella maggior-
mente accettata ed usata).
Il celebre "codice" costituisce un punto di riferimento chiaro per
lo studio della società e dei costumi paleo-babilonesi, dato il cospicuo
numefo di norme trattanti praticamente tutte le attività umane. Dei282
articoli o pangralt normativi del "codice", per quanto riguarda l'uso
dell'Ag, sono rilevanti solo una tentinai2. Un dato particolarmente inte-
."rrurit" emerge dalla lettura dei paragrafi normativi del Codex
Hammurapi, alla lex talionis in senso sffetto si affianca sempre oiù l'uso
dell'argento come mezzo privilegiato atto alla ùparazione del danno
inferto. In sostanza per il danno fisico inizia vistosamente a prevalere ilmeccanismo del risaicimento "pecuniario", menle per i reati penali con-
tinua a sussistere la lex talionzs. Anche le raccolte precedenti usavano,
come si è visto, l'Ag come mezzo atto alla dparuzione del danno persona-
le subito, mu il CrJ sembra porre ulteriore attenzione alfatto, riducendo
ancor di più la pratica della legge del taglione. Anche per il CH, come per
le altre ràccolte giuridiche, possiamo costruire una tabella di valori mini-
mi e massimi dell'Ag, come segue:
1/6 di siclo --- 2 sicli -" 3 --' 5 --- 10 ----'-- 1'B di mina -" 1/z mina --- 1 mina
Da tali valori emergono due dati rilevanti: (a) il massimo quantita-
rivo resta fissato ad 1 mina, (b) il minimo invece è variato rispetto alle
r1 Cfr. LtvpRaNt , Antico Oriente..., op.cit., pp. 415-419.
)2perlalettura dei medesimi si preferisce rinviare direttamente al Saporetti, op.,cit, passim-. Gli
articoli in questione sono i segg.: §4; §59, §90, §114, §116, §1r9, §140, §198, §201, §204, §207' §208,
szòs, szri, ss21.2-2t7,s22t,s222,s224,5228,s24t,s252, §259, §260, s2D,s274'ss275-277'Ved. Saporur"n , op. cit., pp.49'89 (testo completo del ca).
Uso "giuridico" dell'argento nel mondo rnesopotakuico 439
precedenti raccohe: la quantità minima è posta a L/6 di siclo (pari a 20grani, equivalenti a ca. I)8 gr.). Dunque nel cH si ha una maggiore"varietà" di quantità di Ag usata.
(u) Le Leggi Medio-Assire (= LMA), sono costituite da varie tavolet-terr, dalle quali si ottengono ben 126 articoli di legge o parugrafinormati-vi. questa raccolta giuridica è ascrivibile al periodo medio-assiro (da cui,appunto, prende il nome), che è databile tra I 1424 ed i 1976 a.C. ca.come ha rilevato saporetti: <<a differenza di quelle sumere e babilonesi,le leggi medioassire non sono una "codifi cazione" così come è stata pro-mulgata, né sappiamo se ci sia stato dawero un "codice" di leggi fattoredigere da qualcuno dei predecessori di riglatpileser, o se piurtosto nonci fosse alla base una serie di leggi emanate in periodi diversi da sovranidiversi. Così come le possediamo, le leggi sono raccolte di articoli divisiper argomento, e ne è prova evidente la presenza di articoli uguali in duetavolette che non sono per nulla l'una il duplicato dell'altro>ra. Dunque leLMA non sembrano essere utili per la nostra tematica, fifitavia si è prèferi-to menzionarle al fine di non lasciare "lacune" cronologico-giuridiche.
_ - . ui) Analoghi problemi delle rut sussisrono per le Leggi Neo-Babilonesi,la quali consrano di soli 1.5 parugrafi, dei quali molti appaiononelle tavolette illeggibili. Solo il §6 menziona l'argenìo; in esso ii l.gg.,<<Se un uomo vende una schiava che viene poi prelevat a da ùtri.he ,À-tano dei diritti su di lei, deve restituire interamente all'acquirente lasomma ricevuta. se la schiavaha generuto figli, deve risarcire all'acqui-rente con - siclo di argento per ciascun figlio»r'. Dunque, avendo un cosìscarso materiale, non è necessario stilare il consueto schema.
*- *- -*
(uii) Infine, abbiamo le leggi di <<ana ittiiu>> (= LAt).Il nome di talecollezione giuridica trae origine dalle prime due parole del primo para-grafo della tavolerta IV delle leggi. Pur essendo state compilàte in epocaneo-assira (900-615 a.c.), gli studiosi ritengono che questa piccola raicol-ta debba essere d'età sumera. Pertanto, ne trattiamo oru, d^ ultimo, inquanto le tn costituiscono - unitamente al frammento yos 1,2g - unaulteriore testimonianza delle leggi sumere. Le tal sono il "risultato" del-I'unione di due tavolette (la IV e la VII) dando in toto 14 parugrafi nor-mativi.
rr Ved. Saponrrrt, op. cit., pp. % -ll414 lbtd., t4.It tur, in Saponprrr, op. cit., p. ll8.
440 D ani lo C e ccare I li -Mo ro I li
Per ciò che concerne l'argento, esso è citato solo al §6 (tav. 7a) ed
al §3 (tav. 7b). Al primo l'Ag è menzionato come quantità di t/z mina
qtale prczzo da dare alla donna per il divorzio, mentre al secondo para-
sìrfo ri parla dell'inreresse di 12 sicli d'Ag per ogni mina, completando il§l (ruu. iUt. p interessante in questo caso rilevare la "nozione" di "inte-
resse", in un periodo così antico. Forse le L,4I sono uno dei prodromi più
antichi del concetto di interesse sui beni. Comunque essendo tropposcarsi i frammenti di " ana ittiiu" non è possibile stilare il solito schema.
Il frammento YOS 1,28 è una piccola ruccolta di soli dieci articolir6;
tra questi solo in un paio vi è menzionato l'argento'}7.
Infine, abbiamo una serie di frammenti detti AS 16, III-IV i quali
però non sono rilevanti per la nostra tematicar8.
Aspetto comune a queste ultime tre raccolte del periodo sumero (o
meglio ,r.o-.r*"ro) è quello di riprendere, pur con qualche variante, le
temadche espresse dal "codice" di Ur Nammu o dal "codice" Lipit I§tar.
Si sono descritte da ultime queste raccolte, in quanto esse costituiscono
una sorta di epigone relativamente all'oggetto di questo breve studio.
Inoltre, si deve rimarcare che le L41 sono state scritte in epoca neo-assira,
con tutti i problemi che facilmente sono ascrivibili quando si stila un
testo di una età molto Più antica.
Fin qui si è espÀsto il materiale, in ordine cronologico e seguendo
l'esposizione datane dal Saporetti; pertanto ora, analizzando il tutto, ci
sia concessa qualche considerazione conclusiva.
3. Qualcb e considerazion e conclusiua
Per prima cosa si ritiene utile comparare gli schemi dei valori del-
l'argento esposti precedentemente e singolarmente, ragg-ruppandoli in
,rra rric, tabella iiepilogativa. Lutilità di ciò risiede nel fatto che in tal
modo sarà possibile stilare alcune considerazioni di tipo "statistico".
Tuttavia, o..orr" ricordare che non si è proceduto all'inserimento dei
dati fornitici dalle leggi medio-assire e dalle leggi neo-babilonesi per la
scarsezza dei dati inÉse presenti ed ugualmente si sono ffalasciate le
leggi dette di " ana ittiìu" ed il materiale proveniente dal frammento YOS
rt' Ved. Seponrrt , op. cit., pp. )6-)7 .
r7 euesti sono il §1 ed il §2, entrambi concernenti l'aborto procurato_ad una donna; in base a tali
,rti.il r..iÀ ^*i.r. ir, -odo'u.cidentale si dovrà corrispondere un rimborso di 10 sicli, mentre se è
intenzionale allora si dovrà sborsare 1 /z mina.
r8 Ved. Saponrrry op. cit.,pp37-)8.
Uso "giuridico" dell'argento nel mondo rnesopotamico
e dai restanti frammenti. Dunque si prenderanno in esame solo il cuN, lerr ed il ctl; infatti queste raccolte - come si è potuto osservare preceden-temente - rappresentano il materiale rilevante per la nostra tematic*e.Ecco dunque la tabella completa dei dati ponderali dell'Ag:
sicli mlnam- 1/z
- 1/z 1
CUN
CLI
LE
CH
1
1,/6
10
10
10
t5 252525
5
5
52 )
Dalla tabella si può osservare immediatamente che pur variando laquantità minima di Ag, nei "codici" resta fissata ad 1 mina la quantitàmassima. Ciò significa che nonostante le differenze cronologiche - si vadal periodo neo-sumero a quello neo-babilonese, dunque un arco tempo-rale così ampio - la quantità di 1 mina resta come maggior valore possibi-le in campo giuridico. Una mina (equivalente di 60 sicli, cioè corrispon-dente all'inckca a1/z kg) resta come quantità massima attraverso i secoliperché la quantità corrispondente ad una mina è rimasta elevata nelcorso del tempo, cioè non ha perso il suo "potere d'acquisto", oppurèperché il diritto mesopotamico cristallizzala quantità di 1 mina come ilquantitativo massimo che un uomo potesse dare? È difficile rispondere;forse in realtà potrebbe essere tutte e due le cose. La società vicino-orien-tùe antica, nell'arco dei suoi millenni di storia, pur avendo conosciutocambiamenti, sembra tuttavia essere contraddistinta da una certa e relati-va omogeneità economica all'interno del processo evolutivo storico.Ossia, i cambiamenti (per esempio la trasformazione della società e delpotere regio awenuta con l'età del bronzo) sono stati lenti e la società -entro certi limiti - è riuscita bene nell'assorbimento delle "novità" tecno-logiche e sociali. Dunque non è improbabile ritenere, che nonostante letrasformazioni, la quantità di 1 mina d'argento è rimasta pressoché inva-riata nel suo "potere di acquisto". Oggi, terzo millennio dopo Cristo,questo apparirebbe agli occhi degli economisti moderni per certi versiquasi sconcertante. Ciò poiché oggi si è avvezzi ad utilizzare la cafiamoneta, ma se al posto dell,a carta moneta si usasse l'oro, già si potrebbe
- a mio sommesso awiso - notare una certa omogeneità e quindi fissitànella capacità di acquisto di beni. Nel mondo mesopotamico, ed orientale
re Certamente, il l,uoto delle lua e delle LNB rappresenta una lacuna cronologica non indifferente,tuttavia riteniamo che egualmente si possano trarre delle considerazioni riguardo al ruolo dell'Ag incampo "giuridico".
442 D anilo Ceccarelli-Moro lli
antico, non esistendo la moneta (inventata in età persiana), eta l'argento a
costituire il bene di scambio per eccellenza.
A conferma di tale omogeneità sembrano risiedere proprio i datidella tabella riepilogativa; da essi emerge che statisticamente la quantitàdi Ag è praticamente costante. Ma, la tabella ci fornisce solo indicazioniquantitative e non qualitative. Per avere indfuizzi qualitativi è necessario
comparare tutto il blocco documentario (cuN, cLI, LE, Cn) e vedere se inesso vi siano norme che abbiano lo stesso oggetto ed a cui corrisponda lastessa quantità di argento. Da un'attenta analisi comparativa, non com-paiono articoli con medesimo senso a cui corrisponda una eguale sommadi Ag. Ad esempio, roviamo in ben tre raccolte (cuN, cLI, e rE) il valoredi 10 sicli di Ag, ma questa quantità è espressa in riferimento a fattispeciecompletamente differentiao.
Un'ulteriore domanda sorge spontanea: perché l'uso dell'argentoanziché dell'oro. Evidentemente perché l'Ag era di maggior reperimento,dunque molte persone potevano entrarne in possesso; mentre l'oro (sem-
pre più raro) era considerato maggiormente per scopi artistici o simbolici(si pensi ad esempio al dono del collare d'oro che il faraone egizio conferi-va a persone particolarmente meritorie) o come simbolo di potere o addi-
rittura come mezzo di scambio lnternazionale (specie nei matrimoni inter-dinastici), Il trionfo dell'oro, in ambito economico, si avrà con l'ImperoRomano d'Oriente, la cui coniazione aurea conferirà stabilità economica
per moltissimi secoli (almeno fino al sorgere delle Repubbliche Marinare).Sempre in merito all'argento in correlazione col "diritto", possia-
mo compiere un'altra considerazione. I-Ag non è considerato come unbene di scambio o un metallo prezioso a se stante; esso è intimamenteconnesso con il valore dell'orzo e del rame: I kurrunry di orzo equivale ad
1 siclo d'argentoar, dunque 1 kurrum di orzo equivale a8,3 gr. di Ag; cioè
con soli 8 gr. ca. di Ag si poteva acquistare una grande quantità di orzo(100 litri ca.). Tale eqtivalenza non si basa sul risultato di studi moderni(a parte le conversioni ra unità di misura mesopotamiche con le nosre),ma fu stabilito dagli stessi popoli della Mesopotamia. Infatti, proprionelle tavolette, ritrovate negli scavi archeologici, troviamo e leggiamo che
I ìiqlum (siclo) di Ag è uguale ad 1 kurrum (" kor" ,litro) di orzo. Il moti-vo di tale correlazione risiede nel fatto che 1'Ag, assai più conservabile
dell'orzo, gioca un ruolo di stabilità economica; esso è insomma una
{0 Lunico esempio di somiglianza è quello datoci da rr §42 con il cH §204 In entrambi i parugrah
si cita l'ammenda di 10 .icli per 1o schiaffeggiamento, ma le fa in riferimento all'uomo ltbero (auilum),
mentre cH tratta dello schiaffo allo schiavo (muskènum); dunque c'è una grande differenza.at lJn kurruru equivale a 100 iitri. Cfr. Capucs, op. cìt., p.96.
Uso "giuridico" dell'argento nel mondo mesopotamico 443
" cettezza" per le società mesopotamiche (come fu, per molti secoli, ilnornisma aureo per l'Impero Romano d'Oriente). Infatti, come ha osser-vato Liverani: <<I-lorzo è scelto semplicemente perché è il prodotto basedell'aliment azione ( . . . ). I- argento ed il rame sono invece adatti a finzio-nare da modelli di valore perché essendo metalli duri e pregiati - più pre-giato l'argento che vale 120 volte il rame - possono praticamente fungereda pesi. Perciò l'orzo rimane più legato al suo valore come merce, mentrel'argento pesato tenderà a diventare qualcosa di simile alla moneta>>a2.
Ecco, dunque, il ruolo svolto dall'Ag, in modo indiretto, nel campo giuri-dico: quello di garantire delle certezze. Se le "regole di giustizia" e lenorme del diritto conribuiscono a dare sicurezza di ciò che è lecito e giu-sto, non ci stupisce che I'Ag sia menzionato frequentemente all'internodei "codici" e delle leggi mespotamiche. fnoltre, osserviamo che nelcorso della plurimillenaria storia vicino-orientale antica,l'argento si è -proprio per i suddetti motivi - andato sempre più affermando; a taleaff.ermazione ha conmibuito non poco anche lo sviluppo dei traffici com-merciali a lunga distanza, nei quali era, or,wiamente, molto più agevoletrasportare Ag come mezzo di scambio anziché altri beniar.
Dunque, l'argento, pratico e prezioso, acquisisce sempre maggiorernpofianza nei rapporti economici e commerciali come pure nelle societàmesopotamiche e vicino orientali antiche. Ma,l'Ag diviene anche un modoper "capitalizzare"; ad esempio alla donna dalla quale si voglia divoruiare,il marito dovrà darle 1 mina (i.e. 500 gr. ca.) di Ag. Questa mina argenteasarà il "capitale" che la donna avrà come "indennizzo" dalla rottura delvincolo matrimoniale e servirà al suo mantenimento futuroaa.
Difficile è affermare se vi sia stato un progresso dell'argento rispet-to al diritto. Al riguardo si osservano due dati: il primo è che l'Ag è men-zionato, praticamente sempre (almeno nelle raccolte giuridiche pervenu-teci pressoché integre); il secondo dato è costiruito dal fatto che l'Ag è
citato in cifre precise fino al "codice" di Hammurapi (1792-1750 a.C.),quindi viene menzionato come quantità indefinita. Sul primo dato non visono molte considerazioni da compiere: è un dato di fatto, una sempliceconstatazione. Menffe sul secondo occorre spendere qualche parola diriflessione. Perché dopo Hammurapi l'Ag viene citato solo come quantitàindefinita? Probabilmente poiché le leggi medio-assire e quelle neo-babi-
a2 M. Ln'rntNt, Llorigine della città. Le prime conunità urbane nelVicino Oriente,Roma 1988, p. 118.ar In merito si veda C. ZaccacNtNt, La circolazione dei beni, n S. Moscar (a cura di), Ilalba della
Cioibà, vol II, Torino 191 6, pp. 425 -57 0.aa Riguardo alle problematiche matrimoniali, cfr D. Crccarcllt-Monorlt, Alcune note circa l'isti-
tilto ,ndtlil,iloniale nel Vicino Oriente Antico alla lace dei "testi giuridici', in Apollinaris LXVIII 1-2(t995), pp.265-292.
D an ilo Ceccare lli-Morolli
lonesi, ascrivibili all'età del tardo bronzo, riflettono un periodo di cam-
biamento della società. In quel periodo la società mesopotamica (ma
anche le altre vicino-orientali antiche), conobbero un intenso e notevolecambiamento sociale. Infatti a seguito delf impiego del carro da guerra, si
creano delle vere e proprie élites mlitari che producono forte accenffa-
mento del sistema palatino ed un conseguente cambiamento dell'atteg-giamento del re verso la società e quindi un mutamento della concezione
stessa del potere regale. Ora il sovrano non è più bisognoso del consenso
generale per mantenere il potere e gestire lo "stato"; egli vive nel palazzo
e nella corte, a cui deve "rendete conto" (oltre che alle divinità) del suo
operatoas. Quindi è forse proprio in questo periodo che le leggi vengono
scritte con un intento propagandistico e religioso ancor più forte che nelpassato. Ma, l'intento propagandistico è questa volta rivolto più all'inter-no del palazzo (corte e casta sacerdotale) che non all'esterno (popolo).
Forse è per tale ragione che la menzione della quantità di argento non èpiù precisata nei dettagli come nel passato, ma è "sufficiente" indicarnesolo e semplicemente un tot, poiché appunto le leggi diventano ora solo
un ffiire interno.
Quanto detto riguardo all'argento ed al suo rapporto col "diritto",ci offre lo spunto inevitabile per accennare al significato stesso dei "codi-
ci" giuridici mesopotamici. In merito ad essi, riteniamo che si possa affer-
mare che tali raccolte di leggi siano una realtà molto più complessa diquanto si possa immaginare; essi - comunque e più o meno inconsape-
volmente - rispecchiano la realtà sociale in cui sono stati redatti' Ossia
l'intento propagandistico e religioso, pur essendo certamente presente,
non è il solo ed unico ad essere presente (come sostiene gran parte della
storiografia). I "codici" anche quando sono un atto formale di dimostra-zione della giustizia del sovrano , tuttavia non sono "invenzioni" totttcourt daparte del re, ma senza dubbio - almeno è ragionevole supporlo -evidenziano la realtà storica del periodo. Del resto, anche se si ammette
la sola natua propagandistica delle leggi, negando loro qualsiasi intentopratico e giudiziario, non si può negare loro il fatto che quella data quan-
tità di Ag da corrispondere, ad esempio nel caso delle lesioni personali,
era quella ritenuta giusta dalla società dell'epoca. Dunque i "codici"mesopotamici (che giustamente noi occidentali, frutto della riflessione e
maturazione giuridica romana, poniamo oggitra virgolette) sono il rifles-
so pratico della società. I1 fatto che nei codici mesopotamici non si ritro-vino negli stralci processuali, non sta a significare, dunque, che essi non
avessero altro valore che quello letterario. I "codici" anche sotto questo
a5 Riguardo a tale complessa problematica, ved. LtvEnaNl, op. cit.' pruesertim pp.45)'461
Uso "giuridico" dell'argento ne| mondo mesopotamico 445
aspetto sembrerebbero disattendere la concezione storica dominate.Ecco, dunque che i "codici" mesopotamici ci appaiono come un qualco-sa di più articolato e complesso; essi sono i "registri" della società, ,oro -poiché scritti dal re - le regole di giustizia per eccellenza, quelle a cui ci sidovrebbe ispirare, ma non necessariamentà applicare.