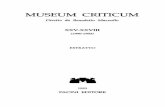Un contributo al dibattito sulla introduzione del quarto di dinar e sulla sua possibile derivazione...
Transcript of Un contributo al dibattito sulla introduzione del quarto di dinar e sulla sua possibile derivazione...
Un contributo al dibattito sull'introduzione del quarto
di drnàr e sulla sua possibile derivazione
da modelli bizantini*
Maria Amalia Dp Luce**
I\Tel 1991, nel corso del congresso < Oriental-Occidental Relations in1\Monetary Circulation, Money Trade and Coin Finds > organizzato
dall'Università di Tùbingen, Michael Bates prendeva la parola su un soggetto,per sua stessa ammissionc, immeritatamente << snobbato > dagli studiosi di numi-imatica islamica, ovverosia il quarto di dtndr alureo, che I'autorevole studioso
definiva con queste testuali parole:
But even though ìt is small and humble, the long life of this denomination,some four centuries, and its wide geographical dispersion aÌong both thenorthern and southern shores of the Mediterranean, and from Spain to Syria,suggest that it had an important role in thc economy of the Meditenaneanworld. It was a coinage that transcended religious frontiers, originating as a
Muslim adoption from Christians, and then later adopted by Christians fromMuslims |
.
Circa dieci anni dopo, l'intervento di Michael Bates veniva aggiornato e datoalle stampe nelTa Rivista Numismatica ltaliana2 ed è proprio da questa preziosapubblicazione che prende le mosse Ia mia presente ricerca, nel tentativo di offrireun ulteriore, modesto, contributo allo stimolante dibattito, iniziato a Túbingen'sulla data di introduzione e sui possibili modelli ispiratori di una minuscola, mastraordinaria, frazione aurea capace di conquistarsi, in poco tempo, un ruolo da
* Riccrca rcalizzata con il supporto deì fondi dcl MIUR (ex 607.). Ncl corso del presente sag
gio ho ritcnub opportuno non utjljzzarc la trascrìzione scientifica pcr alcuni tcmini a.abi di usopiar comune: es. sciita, aglabìtà etc.
** Università di Paleîmo.l. M. L. Bates, Tr? Introductíon of the Quarter-din!1r bl the Aghlahirls in264 H.(4.D.878)
and íts Derivatíon lrotu the Blzantine Tremissis, in Rivista ltaliana dí Numismatica ' lO3,2oo2'p. 115 I16.
2. M. L. Batcs. The Introduc tion... cÍ. n. I
LA SÍCII-E DE BYZANCE À L,ISLAM
lffr '#ili"::i':il:i.""i1';t*TI"#TAT:,;J,*;;:iìiti"i:T::î:ffi :spaz,/lo via Jal palcoscenit:o delfa \loria i primi o;";;,;i";:, ,,
Ma chi ne furono in 1s211"
Íli:JlmÌ*ff *.:í;ili' fiiil''i'?fi ijÌ'il'"';#n'iJ:,$"[1ij; ;'::?;
q,il'í ll;;:: i:;;"iT:[T::1"- ::'Ì:u" Michaer Bares.gri invenrori .der
f:::#f ?}i;]ffi [']'íq::ii**t [ ffi t *l ii:flf ;fr,re I q u r n,, a i .r,o", ii J ., ;i!! :Ll"rT i: E#l.J:il;T lú.JmHlíli;segurro all'espugnazione delta capít"1" o.ù,,il.tiì óìì""",ii",'si.".rra, caduÍrlil'11fl:#,*':?'"l"j.tl1Í;,î;,.,;,t*,"'i .i"f,"* "i"i'f inruttunir t""i,-
La conquista cli Siracusa avrebbe. infàtti consentito I,accesso alla millenaria egloriosa zecca greca, fbrnendo rn_ ral modo "i "i".i,"ìi gìì lì.iìnenti e le compe_
lljff fi :",,".i:r,:..::::i::J.,Ìii.ffi à::iìÍ.lff i.ilil1ru*:l;*;ossia l'equivalente ponderale clel tremissis ti^"ii". "fr."
p"ìòl trasf.erendosi edinc-ardinandosi nel ciiverso siscoforza nella lazi;";'àt;'qil;.T mone.taÍto islamico' si trasfbrmava gio-
Questa in sintesi è I'opinione
33ilil?5;;Hi.,-:#il['i;rt-;+tjri1*r#dtrji ncontrò ar' a v ven," i", É,úii,llÌ
l:ìru.1, ì, l!,i:"J,ll ;li ;U Tt1 X,,jgiíposo degli Aglrbiri al eomando..re .ririqilì èrì)1" ,ì .àr"r"..,". r Frtimiridrtlusero le loro monete nell.A
centralc; grazie alle ,,r-i. l" i,tttto nord occidentale' in Spasna e nell'Afiica
all'espandersi del toro dominio,ììli,ì:,i"t'il'"tf"t8 (nelee69 d' ) e, in seguito
'. - La vitalità del quarto di cltndr era destinata a protrarsi nelle regioni islamiche
::crdentatl fino alt,undicesimo . secoto (avventé d;i-Ni;;id; in Marocco eSpagna e degri zirtti in Ifrrqiya), mentre in Egitto la sua .ònil,on. sl prolun_
:,i:i,iliìiTir"lH[iÌ*Í.":ii:.,i1,fiil,,,*,*:ffi;:x*,i:fl,i:::1",i.Ì1,J,ffifl;;**j+-'.-rn:ilriln#;*ij,y*r*ir;ll1it:,,,ru'*ij:mnm:*:ff 1x:'J:TÚlfiil :ri,;rk:ii:;'tît+lilJ$Jr;;/t,:ll; n:"i"J:T:ffi ilr il"i
1. M.L. Bates,The Introduction... cit. n. I , p. i ló I 19.
UN CONTRIBUTO AL DIBATTITO SULL'INTRODUZIONE DEL OUARTO DI DINAR I I5
gava fino alla metà del dodicesimo; tuttavia la regione in cui, sol?rendente-mente, questa monetina iscritta in arabo, seppe più a lungo resistere - comerileva I'autore - fu la Sicilia dove essa rimase in circolazione. sotto i Nomannie gli Svevi, fìno alla prima metà del XIII sec.
All'inquadramento cronologico, segue una lucida ricognizione dei diversiappellativi che il quarto di dlrzar assunse a seconda del bacino linguistico diutenza e a seconda dell'epoca: dai termini più comunemente in uso in arabo,ruba't o ruh' dtnar (anche se sul tondello, nella hasmala,frgurava solo la deno-minazione di dtnar, con il signifìcato generico di <<moneta d'oro>, indipenden-temente dal peculiare valore ponderale) al termine <tarì> (dall'aggettivo arabo<< fresco >>, nel caso specifico ut:úizzato con il senso di << fresco di conio >) con ilquale esso venne comunemente designato dall'utente cristiano in Sicilia e
nell'Italia meridionale fin dal X secolo.
Fatte queste premesse, Michael Bates entra nel vivo della questione e, alloscopo di confemare la sua tesi, si accinge a determinare I'esatta data di iniziodella circolazione del quano di dtnar, prendendone in esame i più antichi esem-plari superstiti e 1a loro cronologia.
Sulla base dei dati forniti, nel 1982, da al-'Ui nel suo carpi.ls della moneta-zione aglabita5, risulta infatti che il primo quafio di dantir sia stato coniato addi-rittura all'epoca del secondo emiro aglabita, vale a dire'Abd Allah, primogenitodel fondatore della dinastia, IbrahÍm b. al-Aglab e suo diretto successore dal 196
E./8 l2 d.C.6.
'Abd Allah ricoprì la carica di emiro d'Africa per soli cinque anni, Iìno al 201
E./817 d.C. ed è dunque in tale lasso di tempo che si collocherebbe I'emissionedi questo esemplare, da al-'UÈ elencato sotto il numero 107 e conservato presso
I'American Numismatic Society (1923.150.30). In realtà, come precisaMichael Bates. ci troveremmo di fronte ad una erronea attribuzione, risalenteall'epoca in cui la moneta fece il suo ingresso nelìa collezione ANS e pedisse-quamente riprodotta da al-'UÈ (fig. l).
L'attribuzione della moneta in q[estione, dal momento che la data risultailleggibíle, fu fhtta, a suo tempo, esclusivamente in funzione del nome propriodell'autorità che in essa ricorre -'Abd Allah appunto senza tenere sufÎcienteconto del fatto che, alla fine del secolo, neÌ 289 E.l 902 d.C., un secondo 'AbdAllah, seppur per un tempo brevissimo, resse le sofii dell'emirato ed è a questosecondo 'Abd Allah che M. Bates attribuisce I'esemplare sulla base di alcuni
5. M. Abú I Faraj al'Ui, Monnaies aglabides étudiées cn relation avec l'histoire des dÈlabides. Damas,1982 (Publícatíons de I'lnstítut.fia caisde Damas. tlO).
6. Avverto il lettore che per la cronologja aglabjta mi sono basata su M. Talbi, I-'lmirot aghla-bide 184-2961800 909. Histoire politìque, Paris. 1966 (Pubti<tttions de la Facu[té des I'exres etStiencas humaines,S): questa scclta spiega alcune licvì discrepanzc rispctto ad altri testi cìlati' jvi
compreso M. L. Bates,The Introduction.. clf î. 1
7 . Ibid..D.62
I]6 LA SICILE DE BYZANCE À L'ISLAM
elementi stilistici (<<One clear indicator of relatìve chronology is the shape ofthe leîter waw in the worcl, rasnl on the reverse and another is the shaDe óf thelefteî ha'in Muhammad, which becomes quite vertical on later clinars as com-pared to thc oblique stroke oî early ones >8).
Acceftata questa fàlsa attribuzione, 1o stuclioso statunitense. procede col contestare anche i due quarti di dlnar cronologicrmente successivi, cioè, rispettiva-mente, i nn. l3 c 22 del corpas di al 'UÈ.
Al n. l3', appafienente al Museum of Archaeology and Anthropologydell'Università della Pcnnsylvania, ma attualmente in deposito presso 1'ANS(1002.1.371), tocca la stessa sorte del n. l0:anch'csso va postdatato per motivistilistici e quindi attribuito, non aÌ primo Ziyadat Allah (2Ol -223 E./817-838d.C.), bensì al terzo, al potere dal289 E.l9O2 d.C. al2968.1909 d.C. (fìg. 2)
In quanto al n.2210, esso non è affatto un quarto di dtnar bensì Lrn dinarintero, il cui effettivo peso, di g 4,24, espresso nel catalogo di Marsden dell823rrsecondo l'antico sistema ponderale inglese, sarebbe stato erroneamentetradotto in grammi da al 'U5.
Una volta eliminati questi tre esemplari di quafti di /tn.r antecedenti alladata di sbarco degli Arabo-musulmani in Sicilia (212 8.1827 d.C.), il primo con-siderevole ostacolo alla tesi del Bates viene senz'altro a cadere dal momentoche una influenza della monetazione bizantina di Sicilia su quella aglabita è,evidentemente, più difîcile da sostenere, anteriomente ad uno stabile insedia-mento arabo-musulmano neìl'isola.
A Michael Bates restano da esaminare i sette esemplari di quarto di dtnaranteriori alla caduta di Siracusa che ricordo avvennc nel 264 E./878 d.C. altempo dell'emiro lbrahim II (261-289 E./875-902 d.C.).
ll primo, riportato da al-'US al n. 4312, altro non è, ancora una volta che undlndr rl c:ui pesolr è stato erroneamente convertito da a1-'U5 in grammi ; ilsecondo, il terzo e il quano, rispettivamente i nn. 54b, 57 e 60ra meritano un po'più di attenzione.
Il n.54b, appafienente alla collezione Shamma, data I'assenza della data,viene da al-'UÈ ipoteticamente rj attribuito al quinto emiro della dinastia,Muhammad I (226-242 E./841-856 d.C.), sulla base del nome Muhammad da lui
8. M. L. Batcs. Ifte tutroduction... cit. n. I,p. 122.9. M. Abul Faraj d 'Uí, Monnuies aÈl(bides... cit. n. 5, p. 63.lO.Ihid.,p.66.I I . W. Marsden, Nlll/aismata OrientaLia l ustfttt|. The Oriental Coins, Ancienî and Modern ()f
his Collection, Described and Histrtricolly I lLustrated ,Londra, l 823, p. 186 n.CXCVll c T. XI.12. M. Abù-l-Faraj al 'U\, Monrníes aghbi.1".r... cir. n.5.p.71.I3. Vy'. Marsden, Ntmismata Orientalia I[Lusfrdta... cìt.n.l I, p. 188 n. CXCIX.I 4. M. Abu-l-Farai al' Ui. M onnaie s aÉlubider... cit. n. 5. p. 74, p. 75 e p. 60.15. Ibid., p.'74 nota 2.
UN CONTRIBUTO AL DIBATTITO SULL'INTRODUZIOND DEL QUARTO DI DÌNAR I I7
letto sia sul D che sul R16; il n. 57, afferente alla collezione di Henry Amln'Awad, dove aì-'U5 legge il nome Ahmad è da lui accomunato al n.60 e, conse-guentemente, sulla base della datazione di quest'ultimo, fornita dal Laguminanel 1892r?, attribuito aìl'emiro Abu Ibrahim Ahmad (242-249 E.1856-863 d.C.).
La caratteristica più sorprendente, che accomuna itre esemplari, è data dalfatto che sul loro R non compare il consueto motto aglabita GaLabat\ bensì I'e-spressione li-llah.In realtà l'assenza deÌ motto aglabita in queste tre monete è
dovuta ad un'ottima ragione: come ricorda Bates, infatti, le tre monete non sonoaff'atto aglabite. Ad accorgersene per primo 1ì proprio lo stesso Lagumina che,in un articolo del 1896r'q, ritrattò I'erronea attribuzione da lui proposta prece-dentemente (1892), per fornire, in suo luogo, I'esatta spìegazione. L'Ahmadcitato nelle monete non è il sesto emiro della dinastia aglabita, bensì Ahmad b.
Qurhub, il portabandiera della effimera autonomia realizzatasi nelÌa coìonia sici-liana dal 300 E./913 d.C. al 304 8.1916 d.C., durante la breve stagione di tra-passo che, dopo la caduta aglabita, precedette il trionfo fatimita.
Eliminari i ruba't dr Ahmad b. Qurhub, restano ancora tre ruba', ànterrori al
878, anzi, per I'esattezza, due, poiché il n. 78 di al-'U5r0, per I'ennesima volta'si rivela essere trn dîndr intero di g 4,21 erroneamente catalogato da al-'US
come frazione di un quafo.
Per quanto concerne, dunque, questi due uÌtimi rubd'a anfer.ori aìl'878 d.C.'resistrati da al-'U! al n. 88 21. abbiamo a che fare con due monete, battute incon-testabilmente dal nono emiro lbrahim II (26l-289 8.1815-902 d.C.), appane-nenti alla Biblioteca Comunale di Palermo e pubblicate per la prima voÌta da
Bafiolomeo Lagumina nel suo Catalogo22. Di queste due monete, solo una piùesattamente la n.l0 del Lagumina - figura nei due successivi cataloghi deìla col-lezione palermitana e, cioè, nel catalogo parziale redatto da Francesco SapioVitrano nel 1975']r e nel primo volume di quello da me curato nel 1998'z4.
16. Alla lucc di quanto dirò tra breve la lcttura di al 'Uí è erronea
17. B- Lagumìna, Catnlogo delLe nttneta Arabc esislenfi nella Biblìoteca Comurutle diPalenno, |,892 p. 133 n.6.
18. cr7lió secondo M. Abu I Faraj al-'Ui, Monuies agLahitles... cit. n. 5, p. 39 4l .
J9. B. Lagumina, Di un pregevole rípostiglio di monete Arabe trovato a Palemo, drúsArchivio Stt 'ico Siciliano, n. s., 20, 1895, p. 369 371 e T.III in basso.
20. M. Abul-Faraj al-'Uí, Monnaies allabítL,5... cit. n. 5. p. 79.2l.1rir1.p.8l enota l.22. B. Lagumina. Catalogo del[e nnnete Aralre. -. cit- n. 17, p. ] 16 nn.l0 (riprodotta nclla T. I)
e ll.23. F. Sapio Vitrano, 1l Numrnaríum íslamíco c normanno della Bíblíueca Comunate tli
PaLermo,Palerno, l 9T5, p. 105 n. 68.24. M. A. De Luca, ll moneÍe con leggendtt araba della Bib[ioteca Conunale di Pa[enno.l'
Palermo, 1998, p. 166 n. 17.
I 18 LA SICII-D DE BYZANCE À L'ISLAM
L'attuale assenza della n. I I è imputabile agli scombussolamenti e alìe deplo-revoli manomissioni2s subite dalla collezione nel cor.so del XX secolo chehanno del tutto vanifìcato il magistrale riordino del Lagumina: infatti di queìriordino come ho altrove denunziatoz6 - non rimancva che poca cosa (a parleovviamcnte il prezioso catalogo caflaceo) allorché io intrapresi il mio lavorò neiprimi anni'90 clel secolo scorso.
L'esemplare superstite. vale a dire il n.10 del Lagumina, era stato a suotempo dal grande numismatico siciÌiano datato lesrttlmente come il suogemello n. ll oggi scomparso) al 261, datazione che io stessa avallai nel1998, nonostante I'anomalia grammaticale rappresentata dal genere maschiledel numerale aftad (<tno>), in luogo della forma fèmminilc, ihdà, qLrlricl:icsta2 t lìg. .ì 1.
Michael Bates mette in discussione questa datazione2s: egli inf'atti, pur nonrigettando la legittimità della lettura della data, ritiene improbabile che questoraóa'f possa essere anteriore al 264 E. per la scgucntc motivazione. Sul D delruba't, figura il nome proprio Balagr o Balag2e, nome che, di norma, apparesulle monete di lbrahrm II solo a partire dal 264 E.: consegucntemente perBates questo ruba'l sarebbe una contraftizione dell'epoca o addiritturamoderna.
Prima di spendere qualche osservazione su questa argomentazione, ricordobrevemente al lettore che la presenza di nomi propri, non identifìcabili conquello dell'emiro, è nel D delle monete aglabite un fenomeno abbastanza fie-quente: è opinione assodata che si tratti dei nomi dei funzionari addetti allazecca, per lo più arruolati tra gli schiavi o i liberti al servizio dell'emiro. Al-'U5fbrnisce una lista complcta di questi maitres d'atelier ricca di preziose notizicstoriche a riguardoro. In questa listarr, figura anche il nostro Balàgl o BalAg e, aproposito di esso, al-'Us ripofta tutte le precedenti letture di questo nome e ledispute che esso ha suscitato tra i numismatici fin dal XIX secolo.
Il personaggio evocato dal nome Balag non è affatto uno sconosciuto per chiabbia familiarità con la biogralìa di Ibrahrm II: il suo nome ricorre più di unavolta nei repertori biografici dcgli esperti di diritto dell'epoca32 a proposito di
25. Non può csscrc, a mio avviso, casualc c incolpevole il tatto che a mancarc all'appcllo sianoproprio aìcuni dei pczzi migliori dclla collezione.
26. M. A. De Luca, Le monere con Leggerula araha... cif. n.24. Introduaione.27. Anomalia, comc vedremo tra bacvc, non infrequcntc.28. M. L. Bates, fr" /ntrodu(tion... cit.n. I p. 124 126.29. Pcr la lctfura dì questo nome vedi rirfz.30. M. Ab[ | Faraj al'U\, Monwi?s aÈlabìdes... cir. n. 5, 1t. 21 -31..tl . lbid.. p. 3).32. Abu 'l Arab. Taboqdt 'ulama' IJr,qild.M. Bcn Chcncb (ed.), A)geri, 1914. p. t62; AI
Malikl. Kitdb rí\)àd a,r arJi.r.3 vol., Beirut. l98l 3(1401 38.),p. 158 9 c nota33 Biographi?saghlabides extraites des Mudarik du Cadi 'lyatl, M. Talbi (ed.). Tunisi. 1968, biogralìe n. 52 c131 ; cfr. pure M. Talbi, L'énirat agh[abida... cit. n. 6. p. 315. 351 e 696.
TJN CONTRIBTJTO AL DII]ATTI'I'O SI]LL'INTRODTJZIONE DEL QUARTO DI DINAR II9
clue noti giuristi, Ibn Talib e Ibn al-BannA', i quali, in un modo o nelÌ'altro,ebbero a lar le spese del carattere dif'fìdente di Ibràhîm II. Nel caso del primodei due, Ibn Tàlib, nelle lúbaqdî sr lcggc che, allorché lbrahtm II salì al potere(261 E.l8'75 d.C.), uno dei suoi paggi di nome Balag, sfruttando il forte ascendente chc aveva sull'emiro, si adoperò pcr attenuare I'awcrsione che quest'ul-timo nutriva per Ibn Tàlib impedendo così al suo padronc di prendere provvedi-menti troppo severi nci confronti dcll'uomo di legge33.
Dalla biografia di Ibn Bannà' appuriamo un dettaglio ancora più interessantee curioso: quando costui fu portato in prigione a Raqqada a causa delle maiver-sazioni compiute a Qastiliya, e fu sottoposto a processo aÌ cospetto dell'Emiro,questi si rivolse al paggio BaÌag in lingua <siciliana> o, secondo un'altra ìet-tura, in lingua < saqlabiyya >ra.
Dunque è indubbio che il nostro Balag sia da annoverarsi tra i numerosi
frydn o Èilman di origine straniera che prestavano servizio come domestici neÌ-l'ambito della reggia dell'emiro, godendone della îducia, dei favori nonchédelle attenzioni scssuali, e che, talvolta, giungevano, come nel caso di Balag, adiventarne amici. confidenti e consiglieri fino a ricoprirc incarichi di prestigio edi massima rcsponsabilità nell'apparato amministrativor5.
Quale fosse il paese di origine di Balag non è dato sapere: a mio avviso, l'i-potcsi più plausibile è che sia stato uno dci tanti prigionieri fatti nel corso dellecampagne militari in Sicilia36, da lì inviato alla corte di al-Qayrawan, proprio in
33. Abù ì Arab. ldàdqiir 'ukrma lfrr.ti,-a... cil n.32. trad. p.225.34. Il primo termine ricore ,ài.1. ; il sccondo in Al M^likr, Kitah ri|ad an nufil.t. . . cif. n. 32,lI,
p- 159 e nota 34.35. Bîlag ricoprì lnche incarichi militari durante la gucÍa contro al Abbàs ibn Tùlùn. Cfi.
M. Talbi, L' é n ira I aghtabitl e... cit. n. 6. p. 35 I c nota 4.36- Prendendo come punto di rifèrimcnto la data dj nascita di Ibrahlm II, ossia il 235E./850
d.C-. e considerando probabile chc BaìaÈ sia stato piùr giovrnc dì lui di qualche anno o tutt'al piùcoetaneo. potremmo presumcrc chc cgli sia nato tra il 235 c il 240 dell'Egira e, in tenera etì,dcportato in Ifrtqiya c introdotto a cortc: qucslo ci pofa ad un'ePoca chc. guarda caso, è tra le pìir
îortunate e redditìzjc dcll'avanziLta araba in Sicilia. Infalti durante gli anni quaranta dcl III sccolo
dcll'Egira coirispondcnti grosso modo all'emiúto dì Abii lbrah]m Ahmad (242 249 E./856 863
d.C.), il valcntc gcncralc al- Abbds sfèn-ò quasì annualmentc attacchi c razzic contro la parte
bizantjna dell'isoìa: razzic che. a detta degli storici, produccvano grossi intÌoiti in denaro e
soplattLrtto in schiavi, assecondanci) la tattica di al- Abbàs consìstcnte appunk) nel <vendre lapaix à ses ennenìis à prix d'or et de captiti " (così M. Talbj, L'órrilat aghlabide... ci. n. 6. p. 462sulla basc di în NuwayrT). Gli attacchi proscguirono a scadcnza quasi annualc ncl 240 E./1t54 5d.C.,ncl 2,11 E./8556d.C.,nc1 242 F..1856 7 d.C. c ncl 241E.1851 8 d.C.. Ncl 24,1E./851J 9d.C..si rcgistra un succcsso ancora pìù clamoroso: grazic iLlla soffìatr di un priuionicro, al 'Abbàs conquista la roccafb e di Enna rìpoÍando un bollino talmenle ingeùte c1i schiavi e ricchczzc chc parlcdì esso venne invialo addirittum a Bagdàd (iàt../. p.466). Niente di strano dunque che il nostroBxleg sia giunlo jn linqiya proprio in quel lasso di tempo, confuso ncll'cnormc llusso dì prigionierj provcnicntì dalla Sicilia e sja slato daìl cmiro in carica introdotto ncl palazzo dovc poî.cbbc
essere cresciuto accanto al fuluro emiro Ibrahlm 11, al quaìc si sarcbbe legalo talmcntc intimamente da condjvidcrc con lui la sua lingua < siqilliya " (grcco l latino ?) madre.
I2O I-A SICILE DE BYZANCI À L'ISLAM
virtù della sua grazia giovanile e, magari, della sua raîfnatezza di modi e cul-tura, ma non si può escludere che sia stato uno schiavo deportato in Orientcdall'Europa latina o dalla costa dalmata.
La sua lingua, di cui anche l'emiro, a quanto pare, aveva appreso qualcheespressione, potrebbe essere stata quindi tanto di origine greca o latina cheslava; egli era sicuramentc già in auge al momento della presa di potere diIbrahlm II e potrebbe qui il condizionale è d'obbÌigo essere morto nel 279E./892 d.C. allorché I'emiro, ormai in preda alla plzzia, decise di trucidare tuttii suoi favoriti con inaudita crudeltàrt.
Questo è quanto siamo in grado di dedurre dalle fonti letterarie; pcr quantoinvecc concerne le fonti numismatiche. il suo nome ricorre sulle emissionimonetarie fin dal 261E./ Il75 d.C. (secondo Lagumina e De Luca, contestati daBates); diviene abituale dal 264 E. (871-878 d.C.) al 268 E. (881-882 d.C.) perpoi scomparire e ritornare a fìgurare in seguito nei conii del 274,276,277,280,282, 286, 288 dell' Egirars.
Nelle monete in questione, il nome di Balàg presenta dopo la gayn un vistosoprolungamento verso destra che a molti studiosire ha fatto dedurre Ia presenza diuna ya-' finale, ponandoli così a leggere Balagl in luogo del Balag ricoffentenelle fonti storiche. lo personalmente propendo proprio per la lettura con )d' e,molto timidamente, propongo qui al vagÌio degli esperti del settore Ìa remotaipotesi che possa trattarsi della traslitterazione in lingua araba del nome grecore},úyLog (lat. Pelagius). Questo nome potrebbe, nel parlato arabo, essersr semplificato in Balàg (e come tale essersi tramandato nelle fonti) mentre nellemonete, eseguite ricordiamolo - sotto la supervisione dello stesso detentoredel nomc, in qualità di moître d'atelier, potrebbe essersi conservato nella grafiapiù fedele possibile alla pronunzia originale (fig. 4).
Questa lunga digressione intorno a BalaÀ mi è parsa necessaria per contestarela diffidenza del Bates nei confronti di una datazione troppo precoce dellemonete l0 e ll del catalogo Lagumina, che portano inciso questo nome. Dalmomento che, come ho appena accennato, il personaggio appare, nei resoconti
3'/ . M. Talbi, L'énirat aghlubide... cìt. n. 6, p. 291 . Non è cscluso tuttavìa chc il nostro, omaiforsc affrancato c sicuramcnîe <invecchiato>, possa esserc scanpato alìa stragc, non faccndo piùl<tecnicamenle> paftc dclla schìcra di giovani efcbi di lbràlÌtm. Non dimcntichiamo infatti che ascatenare la carnelicina era stata una profezia fatta aìl'emir.o. secondo la qualc cgli sarebbe statoucciso da uno dei suoi.fÒar. riconoscibilc pcr l'a-eilirà dei movimenti.
38. In base iii dati (come abbiarno visto non semprc attendibili) forniti in M. Abù-l Farai al'U!, Motlúaíes aglabides... cit. n. 5. Io, da parte mia, rraìascìo qui di rncttcrc in discussionc ladiìta ultima dell'uso del nomc Balag, poiché ritcngo il soggefto ininlìucnte rìspetto al mro assunto.ll lcttorc îrovcrà comunque ampìi ragguagli in proposito in M. L. B irtes,The Introduúio1... cit. n.1. nota 40.
39. Per una panoramica sulle varie letture folnite si veda M. Abu-ì-Faraj al:UÉ, MonnaiesaÈlabídes... cit. n. 5. p. 32 e note.
UN CONTRIBUTO AL DIBATTITO SULL'INTRODUZIONE DEL QUARTO DI DINÀR I2 I
storici, al fianco dell'emiro fin dal suo primo anno di regno, niente ci autorizzaad escludere che egli, fìn da allora, si sia affiancato al7'altro maîte tl'atelier,Sakir o Sukr. in carica ai temDi di Ibrahrmlo. D'altro canto non ci sono elementia corroborare l'ipotesi di Batès di una contraffazione medievale o, tanto meno,moderna: un attento e preparatissimo catalogatore come fu il Lagumina che,ricordo, di questi quarti di drnctr risalenti al 261 ne ebbe ad esaminare ben due,non venne neppure sfìorato dal dubbioar.
La disputa tra Lagumina e Bates, circa I'esistenza o meno di tn ruha'l del261E., è comunque destinata a perdere di mordente, dal momento che mi appre-sto ad aggiungere un nuovo tassello al mosaico che stiamo faticosamente ricom-ponendo.
Nel corso della catalogazione delle monete arabe del Museo ArcheologicoSalinasa2 (già Museo Nazionale di Palermo), che ho da poco intrapreso, hoinfatti registrato un ulteriore quarto di drndr, {inora inedito, che a me sembrainconfutabilmente databile al 262 E. (quindi anteriore alla presa di Siracusa) e
che sottopongo al vaglio degli esperli (fìg. 5-6).
Il recupero di questa moneta, qualora la mia lettura della data risultasse cor-retta, farebbe definitivamente risalire f introduzione del quarto di drnar ad unadata anteriore alla caduta di Siracusa e, conseguentemente, potrebbe, a primavista, apparire in netta contraddizione con la conclusione a cui giungevaMichael Bates nel suo articolo:
[...] no Islamic quarter-dinars were minted until the very year of the Arabcapture of the byzantine mint of Sicily; and that there was a credibÌe pre-Arab Sicilian prototype for this denomination, which has no precedentotherwise in Islamic coinage. The conclusion that the quarter-dinar originatedas a continuation of the tremissis is irresistiblear.
In realtà, così non è. La teoria proposta da Michael Bates nel 2002 contieneinfatti, a mio awiso, ,,dueo diverse ipotesi: I'una è che il quarto di ùnar isla-mico sia stato coniato sul modello del îremissis bìzantino circolante in Sicilianel IX sec.; I'altra, che il quafio di dmdr islar:'rco sia stato coniato in conse-guenz.a della presa di Siracusa deìl'878. Le due ipotesi non sono indissolubili:
40. M. Abù-l Paral al'Ui, Monnaies egLabides... ctr. n. 5,p. 31.4l. Anchc a mio modcsto avviso- la contraffazionc sarcbbe, in questo caso. assolutamente da
escludere.42. Antonino Salinas (1841-191.1): lìgura di spicco della cultura siciììana, professorc di
archeologia dcll'tjnivcrsità di Palermo dal 1865 al 191,1 e, dal 1873, Direttore del MuscoNazionale tli Palermo (oggi a lui intitolato) nella cui organizzazionc proîusc tutto ìl suo impegnoc la sua competenza, coadiuvato, per quanto concernc ìl settorc islamico, dalla consulcnza conti-nua del grande Michele Amari con il quale fu in conispondenza dal l86l al 1889. anno dellamorte deì grandc storico dell'lslàm siciliano. Cfr. Lettere di Antonino Salinas d Michele Amari,G. Cimino (ed.), Paìermo,1985 (Biblioteca Centrlle della Regione Si(iliant\.
43.M.L.Bates.The Introduction... cit.n. I, p- 127.
112 LA SICILE DIT BYZANCE À L'ISLAM
per quanto mi conccrne, la prima può restare, e resta sostenibile, indipendentemente daÌla seconda.
Gli Arabi non avevano infatti nessun motivo di attcndere la caduta della capi-tale bizantina di Sicilia per venire a contatto con una moneta che circolava intutta I'isola già al Ìoro arrivo. Essi non solo dovettero costatarne l'esistenza findal primo momento del loro sbarco a Mazara nell'827 (se pur non ne avevanocontezza già attraverso antcriori sporrdici scambi commeriiali.y ma addiritturafarne-essi stessi uso con le genti locali per le quali essa era I'abituale moneta discamDro.
Una moneta lo sappiamo bene - non scompute improvvisamcntc da un ter-ritorio per il solo fatto che ne sia mutato il regime: tl tremissis sicuramente con-tinuò a circolare ìn Sicilia per molti decenni e non solo nella area bizantina del-l'isola ma anche nell'area occidentale, piÌr rapidamente <colonizzata>> dai nuovidominatori aglabiti.
Inoltre non va dimenticato che le città, lc for1rezze e i villaggi dell'isola, allor-ché soccombevano o temporaneamente o definitivanìente aì giogo degli Arabine divenivano, seppur a diverso titolo, tributari sicché dovevano versare annual-mente ai nuovi conquistatori imposte in denaro di varia entità le quali non pote-vano che essere versate, quantomeno la prima volta, in moneta indigena. Questodenaro, insieme agli altri proventi del bottino di guerra, tesori, prigionieri e der-rate alimentari, affluiva in pafte a Palermo e ìn parte ad al-Qayrawan, sicché lemonete estorte alla popolazione indigena, per quanto destinate in un secondomomento al riciclaggìo tramite fusione e riconiazione. non potevano certo risul-tare estranee né ai governatori d'Africa né, meno che mai, a quelli insediati inS ic il ia.
ln conclusione, è dalla stessa gradualità con cui si attuò la presa di possessodelf isola da pafte degli Arabo-musulmani, puntualmente testimoniata dallapoderosa storiogralìa in nostro possesso, che emerge per noi la cefezza che iconquistatori abbiano conseguito una grande dimestichezza con le monetebizantine di Sicilia, e quindi con la frazione aurea del tremissis, fin dalla primametà del secolo IX.
Da questa ceftezza consegue che cssi non ebbero alcuna necessità di conqui-stare Siracusa e di introitarne la zecca (come suggerito da Bates) peî apprezzaÍeIa versatilità del. tremissís e, soprattutto, la sua collaudata sintonia con il mode-sto /argel economico della Sicilia del tempo(.
14. Già da tempo i numismatici hanno evidenziato come I'uso di piccole frazioni sia unacaraîtcristica precipua dclla monetazionc araba di Sicilia e hanno messo talc carattcristica instr0tta rclazionc con il modesto volume dellc transazioni isolane rispetto a quello del rcstantcmondo islamico. Cfr. P. Balog. La noneta.iotle delta Sícílía araba e le sue ìnitdzioninell'ltalia meridionetlc, in A.A. Y.Y., Gti Arabi in ltalid: ethura. contafti e tradi.ioni,Miìano. 1979. D.616.
LN CONTRIBI.]TO AL DII]ATTITO SULL'INTRODUZIONI DEL QUARTO DI DINAR 12.I
Il problema, ben più importante, che ancora resta da risolvere è quando, dove.ma, soprattutto, perché qoesfo îremissis poté trasfomarsi, agli occhi degliArabo-musulmani, in un appetibile modello da ricalczLre e da impoftare nelsistema monetario islamico sotto foma di quarto di dtndr.
Per quanto concerne il quando, da quanto detto fìnora mi sembra evidenteche, una voìta scartata I'ipotesi del 264 8.1878 d.C., rimane indiscutibile che laprima data utile resta 11 262 8.1876 d.C. o, se prefèriamo, una volta svincolato1'evento dalla presa di Siracusa (e venuta meno, come credo,la pregiudiziale delProf. Bates nei confronti della datazione di Lagumina) ll 261 8.1875 d.C.. Delresto, una volm giunti a questo punto della discussione, lo stabilire con assolutaprecisione l'anno di coniazione del primo quarto di dtndr diviene una questione.il lettore ne converrà, di secondaria rilevanza: quello che conta è che, finchénon saranno pubblicati ulteriori esemplari precedenti al 261 o al 262, possiamodedune che I'innovazione ebbe luogo all'incirca alla met:ì del secolo IX e, pre-sumibilmente, sotto il governo di Muhammad Abú-l-Garanrq o di Ibrahrm lL
Per quanto invece concerne tl dove,Ia risposta è meno làcile dal momentoche sui quarti di ùnar, come in tutte le monete d'oro aglabite, non figura ilnome della zecca. Supporre che essi abbiano circolato solo in Sicilia è a mioavviso arbitrario non meno che affermarc il contrario. Le fonti letterarie non cisono di grande aiuto anche se non manca qualche debole indizio che il ruba'tpossa aver circolato alla fine della dinastia aglabita anche in Ifn-qiya. Dalla bio-grafia del dotto qayrawanese Gabala b. Hammud a5-$adaffas, ad esempio. rica-viamo che ad un debitore insolvente di questo pio personaggio, morto nel 297E./909 d.C., e quindi attivo sotto I'emirato di Ibrrhrm II, veniva imposta la resti-tuzione dell'ammontare dovuto, circa 8 dînar, mediante rate di un quarto didtnar ciascnna. Dal testo in questione però non si evince con certezza se si
alluda ad una reale moneta di un quarto di dtnar o, genericamente, ad unasomma di denaro equivalente ad un quarto di dlnar.
Io, da parte mia, consapevolc di non poter in alcun modo collegare, attraversodocumenti storici o numismatici. la coniazione e la messa in circolazione deiquarl.i di dînar aglabiti ad una precisa zecca, siciliana o africana che sia, milimiterò a proporre aìcune considerazioni allo scopo di dimostrare, quantomeno,che la loro origine potrebbe essere tanto siciliana che africana.
Innanzi tutto la presenza del nome Balagl (se, come sembra, l'identifìcazionedel personaggio è corretta) depone sicuramente a favore di una emissione africana dei ruba'î recanti tale nome: è infafti improbabile che I'influenza di questoBalagT, sia stata taìe da estendersi alla zecca palermitana mentre è del tuttoammissibile che egli, gravitando nelì'ambito della cofte di Ibrahrm, abbia svoltola mansione di addetto alla coniazione in loco, apponendo il suo nome suÌ coniodelìe monete prodotte sotto la sua direzione. Se accettiamo questa premessa vada sé che , primo ruba't, per intenderci quello contestato del 261 E., sarebbe
45. Abù I 'Arab, IdAaqat 'u[ama' lfrtqi\a...cit. n. 32, p. 230.
124 LA SICILE D[ BYZANCE À L'ISLAM
stato battuto ad al-Qayrawan e proprio dal nostro BalàÉl (e chi sa se non sia pro-prio a lui, uno straniero, da addebitare l'errata concordanza di gencrc del nume-raie con il 5oslunli\o..anno.'^ sui primi coniir.
Di contro, il rrbn't successivo deÌ 262 E. non porta questo norÌ)c €, conse-guentemente, potrebbe essere stato prodotto ovunque. Dal 264 E., comeabbiamo rilevato, i ruha'r presentano regolamente il nome proprio del favorito.L'argomento deÌ nome del funzionario è convincente ma, si badi bene, non èprobante: esso infatti non ci autorizza ad escludcre che i conii. fabbricati inIfnqiya, venissero poi spcditi, previo <nulla osta> ufficiale dell'emiro, in Siciliaper essere utilizzati nella zecca locale.
Se poi passiamo a prendere in esame il contesto economico e monetario delledue regioni, IfÍiqiya e Sicilia, che si contendono il varo del quarto di dtnar, cirenderemo conto che in entrambe, seppur per motivi notevolmente diversi, I'e-vento è da ritenere plausibile se non addiriftura oppoftuno.
In Sicilia, la frazionc aurea si imponeva per diverse ragioni. La prima è unaragione psicologica: gli abiranti dell'isola, assuefatti al tremissis, erano tenden-zialmente disponibili nei confronti di una moneta equivalente per peso e valoreall'omologa bizantina. La seconda è una ragione pratica: il quarto di dtniir eragrossomodo equipoìlente e perciò interscambiabile, senza complicate operazionidi calcoìo, con quella che non dìmentichiamolo - era ancora la moneta uffìciale di circa due terzi dell'isola. Fino alla finc del secolo infatti tutta l'area cen-tro-orientale della Sicilia gravitava ancora nell'orbita politica, culturale e com,merciale bizantina e quindi si incardinava - seppur con qualche differenza nelsistema monetario di Bisanzio. In quanto alla parle islamica dell'isola, essendodel tutto improbabile una scomparsn ex abrupto del tremissis, dobbiamo ipotiz-zare che esso vi abbia circolato ufficiosamente fino ad esaurimento. Darallela-mente alÌa moneta islamica.
La terza ragione è di carattere storico-economico: I'economia isolana fu nelcomplesso fortemente penalizzata nel primo cinquantennio della conquista, dalperenne stato di belligeranza, dalle distruzioni e dalf insicurezza imperanti inbuona paÌ1e deÌ territorio. Ampie porzioni della Sicilia precipitarono, in queltempo, in una buia spirale di violenza che ne cagionò f impoverimento e la ridu-zione ad uno stato di mera sussistenza. In un clima siffatto la pregiata monetaaurea e argentea degli invasori, dovette risultare assolutamente sproporzionatarispetto al modesto tenore di vita locale e soprattutto rispetto ai prczzi ed alvolume medio delÌe transazioni del mercato indigeno, indebolito, fino all'ago-nia, dalla conflittualità permanente.
Questo spiega la sporadicità delle emissioni d'argento aglabite in Sicilia dicui ci è rimasta testimonianza (anni 214, 220, 230, 240, 243 ?, 244, 246, Z5O
z16. Ricordo che ìa regola grammaticalc araba ìn qucstìonc chc limitî l'invcrsionc del genereallc unità superiori al tre, è per uno stranierc paficolarmente àstrusa da ricordare ed applicare.
UN CONTRIBUTO AL DIBATTITO SULL'iNTRODUZIONE DEL QUAIìTO DI DINAR I25
dell'Egira), nonché la loro perentoria riduzione di peso (daÌì'unico dirhan del214 E. si passa, nel 220 E., al 1,4 dirham per approdare infìne, dal 240 E., allafiazione di l13 di dírhum che resterà l'unica in circolazione fìno alla comoarsacli un'ulteriore frazione nel 275 E.). Questo spiega pure la quasi assoÌuta man-canza in Sicilia di ritrovamenti di esemplari aurei anteriori ai ruba'r41.
All'involuzione monetaria si sottrassero in parte le realtà urbane della costaoccidentale e il loro cntroterra e. soprattutto, ad essa dovette sottrarsi Palermo,capitale della colonia agkLbita (e, in quanto tale, sede delÌa amministrazione,dell'aristocrazia militare, dei plutocrati e di una rifiorente borghesia mercantile),dove, al termine di ogni 5a'ifa, confluivano i tributi in denaro, i tesori, glischiavi e le derrate razziate, e dove quindi i metalli preziosi tesaurizziìti si tra-sfbrmavano in moneta e si ridistribuivano sotto lbrma di prebende, di soldo c distrumento di scambio, alimentando una modesta, ma comunque vivace, econo-mia.
Al di là di questa oasi di stabilità e di benessere, tuttavia, buona parte dell'i-sola, divenuta terra di nessuno tra due opposte autorità politiche l'islamica e labizantina sopravviveva, tra una razzta e I'alîra, tra un assedio ed il successivo,in un pcrenne stato di precarietà non ccrto fàvorevole ad una ripresa del mer-cato. Appare pertanto evidente che un'area di scambio così indebolita, in cuidomanda e consumo languivano e i prezzi si manÎenevano, giocoforza, conte-nuti, una moneta del peso del lremissls era più che sufficiente per garantire latransazione medio-alta.
L'ipotesi che gli Aglabiti abbiano adottato il ruba't in Sicilia ò perciò attendi-bile: un provvedimento monetario deÌ genere sarebbe stato una soluzione per-fettamente cornpatibile con la realtà economica locale e per di più in feìice sin-tonia con gli interessi e Ìe inclinazioni dell'utente siciliano, al quale tale moneta,grazie alla familiarità acquisita con il /reml.rsis, era per così dit'c, già connatu-rau.
L'adozione del ruha't tuttavia apparc altrettanto plausibile sul suolo africanoanchc se per motivi totaÌmente diffèrenti. Dall'800 d.C., anno di inizio delladinastia aglabita, il ritmo di crescita della provincia africana si manifesta in
,17. D'altrondc, sin dai primordi delÌa grande espansione arabo islamica, la politica monetariadci califlì musulmani, cra statiÌ inÌprontata al massimo rispetto della circolazionc monetaria indigena. di cui si era evitato ogni insensato c improvviso stravolgimento. Ricordo infattì che fino irllarifoma di 'Abd al Maljk (77 E./696 d.C.), le monete pleesistenti, sia bizantinc chc sasînidì. contirruarono a circolarc cntro iconlìni del nuovo impcro umayyade. e che il varo del sistema monctàrio cosi cletto islamico altro non rappresent(ì, in realtà. che una omogenizzazione e una ottimizzazionc. seppur con opponune rettifiche, varianti ed integrazioni. dei sistemi moneteri r igenti nciteritori conquistati. L'atteggiamento adottato in Sicilia dagìi jnvasori arabo musulmani nonsarcbbe dunquc molto dissimile da qucllo adottato dai loro antenati cìrca due secoli priml: gliAglabiti, prclio atto dcllx circolazionc monctîria bizanlina, si limitarono ad intcgrtrla' quando e
dovc ncccssario. evitandole con prudcnza traumi o collassi repentìni.
126 LA SICILD DE BYZANCD À L'ISLAM
costante ascesa fino al regno di Abù-l-GaranTq, considerato dagli storici il veroapogeo della dinastia:
La. prospérité que connut l'Ifrrqiya sous le règne d'AbuJ-Garlntq fut mémetelle qr|e sa renommée fi'anchit les frontières du royaume et resta, longtempsaprès la disparition des Aghlabides, proverbiale [...] il devint le symbole deI'abondance et de la vie fàcile et agréablea8.
L'incremento della prosperità riscontrabile nell'Ilirqiya è il risultato della sta-bilità politica ed economica raggiunta dalla regione nel corso del IX secolo. Dalpunto di vista politico infatti, assistiamo al graduale assestamento di una dina-stia che, imparando a destreggiarsi, tra le minacce dei suoi innumerevoli opposi-tori, I'aristocrazia guerriera del lund,l'alta borghcsia cittadina, i capi clan bcr-beri, si conquista, pur tra continue insidie ed attacchi, una salda posizione alcomando del pacse. La laticosa presa di potere si realizza anche grazie ad unanotevole disponibilità di mezzi economici e soprattutto agli cnomri quantitativid'oro. fi'utto sia del Èiftad siciliano che del commercio con tl bildd as-suddn4e.
L'afflusso dcll'oro e la sua abbondante e regolare emissione in moneta stimo-larono, a pafiirc dal secondo quarto del secolo, I'incremento del consumo edella domanda sia di generi di prima necessità, sia di generi di lusso, alimen-tando il commercio e la circolazione monctaria a tutti i livelli della niramiclesociale con eflètti benefici per I'intera popolazione. ll processo ili iniazìone,ancora alla sua fase ìnizialc, compoftò un owio rialzo dei prezzi ed una conse-guente svalutazione della moneta aurea che divenne di uso corrente anche nellamedia transazione .Il dînar aureo e le sue frazioni perciò costituirono il princi-pale mezzo di scambio a discapito del dirham cJ'argento-
La moneta argentea infatti, registra contemporancamente un decremento diploduzione dovuto alla penuria di metallo locale e alla maggiore difficoltà diapprovvigionamento rispetto all'oro, proveniente abbondante e a prezzo vantag-
18.M.'îalbi, L'émirat aghtabide... cit. n. 6, p. 266.,19. M. Lombard. L'lslam dans sa prenière Stand?ur (VIII'-XI' siècle).Paris, 1971 (Nouyelte
bibtiothèque îìentifrEle\. p. 109; E. Ashtor, S/orid econonica e soci.le deL Vící o Oriente nelmedioeyo - Torrno, 1982 (Biblide.a di cLtLturu storica), (= A Social and econoDti( histot t- of theNeur East irr the niddle dgcs,Londra, 1976). p. 77-78, dove si tratta aìnpli{mcntc dclla via delì oro attraverso la quale il prezioso melalb giungcva allc coste settentrionali dcll Alrica e allacortc aglabita. A conferma di qucsto ìntenso tralfico M. Tdlbi, L'émimt aghlabzle... cit. r.6,p. 362 afferma: < (...) les courants d'échanges, favorisós par la coexistence somme toute pacifiquedes dcux régimes très djffórents de Kairouan et dc Tahart, avaient dú étre ìntenses ct proiitablesdans les deux sens > ; di rcccntc, due impoftanti studi. A. Gondonncau e M. F. Guera. Ire Coldfrom Chana urul îhe Muslin Etpttnsíon. A Scienîific Inquir\ Into the Middle Ages Using IC?,MSCombíned with An UV larcr, dans S. M. M. Young. A. Mark Pollard, P. Budd e R. A .Ixer, Metdlsin A tiquítJ. 1999 (Brítish Archeological Report, Int?rnationaL Sari?s. 192\. p.2622'j0:A. Condonneau e M. F. Gucrra, fàe círodation of precious metuts in the Arab Entpire: the castoÍ tha Near and Middle East,in Archeometry,44 1,2002,p. 5'73 600 (la cui proficua lettura devoalla segnalazione e alla coÍesia di V. Prigent).
UN CONTRIBLJTO AL DIBATTITO SULL'INTRODUZIONE DEL OUARTO DI DINAR I27
gioso, dai giacimenti africani e, ancor più abbondante, a ptezzo zero, dal rrci-claggio del tributo aureo in moncta c in tesori scaturito dal jlàa7 siciliano. Allaminor quantità di argento prodotto dalla zecca di stato corrispose, ovviamente,una sua leggera ma significativa rivalutazione rispetto all'oro cui si affiancò--come ebbi a sottolineare in un mio precedente saggio dedicato al viLro deldecimo di dirhamto -la tendenza dell'utente. rioortata nelle cronache deltempo5r, di frammentare le monete d'argento per utiiizzarle qualì spiccioli per lecompravendite più modeste in un'epoca in cui la moneta di rame sembra quasiuscire di scena.
Si batterono dunque molte meno monete d'argento di cui la maggior partenon è giunta fino a noi perché fu ritagliata ed usata illegalmente in luogo dellamoneta di rame resa precocemente inservibile dall'aumento del benessere e,conseguentemente, del costo della vita.
In conclusione, già alla metà del secolo, costatiamo nella monetazione agla-bita una notevole compromissione dell'equilibrio trimetallico tradizionale. TaÌecompromissione comporta, da una pafie, una moneta aurea chiamata ad assol-vere il ruolo - che le è naturale- di strumento di scambio nelle transazioni alte emedio-alte e, dal lato opposto, una moneta d'argento <ritagliata> forzata a svol-gere il ruolo illegale di strumento di scambio per le transazioni minìmeNell'area intermedia si crea un vistoso vuoto per colmare il quale urge moneta
divisionaria aurea in sostituzione deÌl'argento: così si spiegherebbe I'emissionetlí th. dîndr già softo Muhammad II (fig. 7).
Ibrahîm II si sarebbe spinto più oltre decretando l'<< invenzione >> di una nuovafrazione, ancora più piccola, il quafio di (hntir,la cui comparsa risulterebbe,dunque, perfettamente plausibile come necessario ritocco ad un impianto mone-tario obsoìeto e ormai inadatto a risoondere alle nuove esigenze del mercatolocale africano.
Resta da giustificare il fatto, non certo secondario, che la nuova fiazione nonè, aì momento, sufficientemente attestata in Ifr-rqiya. Questa lacuna potrebbe tro-vare tuttavia una spiegazione nel teffemoto politico fatimita che di lì a pocodoveva travolgere e spazzare via la dinastia aglabita e con lei i suoi simboli pit)tangibili, imponendo il ritiro dalla circolazione della moneta precedente e unasua, per quanto possibile, radicale sostituzione. Nella colonia siciliana, dove ilcoinvolgimento ideologico nella guerra civile tra sunniti e sciiti fu più blando e
dove prevalse piuttosto la spinta autonomistica, il quarto di únar aglabita potèforse sottrarsi ad una troppo draslica tlamnatio memoriae e arrivare fino a noi inouantità sufîciente.
50. M. A. De Ltca. In rforma monetaria dell'aglubita lbrdhîm 11, relazione prescntata nclcorso dcl // Simpo.rio 1tarndaíonale S. Assendni sulla monetaz.ione Islamica (Trieste, 2q3 I d8o-
sto 2008).51. rbid.
I2IJ LA SICILE Dts BYZANCE À. L'ISLAM
Comunque siano andate le cosc, rimane il fatto che la Sicilia non coslituì solola culla o il riparo momentaneo del ra.ór;'t aglabita ma tbrnì a questa moneta unhumus in cui attecchire, rigenerarsi dopo ogni successivo rivolgimento politico,etnico c confèssionale, ed attingere la linfa vitale per circolare, con iÌ trascorreredel tempo, tra le mani di Arabi, Greci, Latini, Ebrei, Normanni, Longobardi.Francesi e Tcdeschi. Del resto: pecunio non det!Meno che mai se di buonalega e il quarto di d,ndr dr buona lega lo era clavvero, se riuscì a sopravvrvereneì bacino mediterraneo fino alÌa prima metà del tredicesimo secolo, lasciandopoi in eredità ad altre monete il suo csotico, anche se ormai misterioso, appellativo di tarì.
w@Fig. I
QuaÍo di dtnarM. Abu-l-Faraj à\:U!, Mon qies aglqbides... ctt. n.5, n' l0 (AN,l database)
ffiwFig.2
vuarlo ol orntrM. Abu l-Faraj al:U\, Monnaie s (rglabítles... cit. n. 5,n" | 3 (AN.S database)
Fig. 3
vu,:tflo ut útnilF. Sapio Vitnno, 1/ Nummarirm íslttmico... cit. n. 23, n' 6lì
Fig.4Quarto di drnàr
F. Sapio Vitrano, 1/ Na m tariu r islanico... cit. n. 23, n" 68, deftaglio della data e del nome Balagr
Fio 5
Quarlo di drDàr inedito del Museo Nazionale di Palermo
L]N (]ONTIIIBTJTO AL I]IBATTITO STJI-I,'INTRODTJZIONF] DF]I- OL]ARTO DI DINAR I]9
Fig.6.Detla-qlio della data