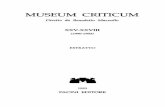2013 - Voci ebraiche sulla tolleranza religiosa
Transcript of 2013 - Voci ebraiche sulla tolleranza religiosa
ASE 30/2(2013) 393-419
Cristiana Facchini
Voci ebraiche sulla tolleranza religiosa. Pratiche e teorie nella Venezia barocca*
1. sEttE pErsonaGGi in CErCa dElla vEra rEliGionE
In un’ignota accademia veneziana si incontrano, ospitate da un frate cattolico, sei persone che, accanto all’ospite, discutono della ricerca della vera religione. Ognuno è portatore di una verità che gli appartiene e che simboleggia la diversità religiosa dell’identità culturale dell’Eu-ropa del tardo Cinquecento: un luterano, un calvinista, un cattolico, un ebreo, un musulmano e due esponenti di correnti filosofiche dominanti, ossia uno scettico e un filosofo naturale. Questo ideale incontro, in una dimora ancor più ideale e in una città ideale, prende forma in uno degli scritti attribuiti a Jean Bodin, il Colloquium Heptaplomeres, che fu composto e portato a termine verso la fine del 1588.1 Il testo circolò in forma manoscritta, in poche copie, da quanto si può ricostruire, e fu reso pubblico solo con la sua stampa nel xix secolo (1857). Come ogni
* Per la revisione di questo articolo ringrazio Costanza Bertolotti per i preziosi suggerimenti sulla composizione del testo; Alessandro Guetta per gli approfondimenti bibliografici e teorici; Asher Salah e Mauro Pesce per i loro commenti.
1 La bibliografia su Bodin è vasta, menziono qui solo alcuni lavori consultati: J. bodin, Colloquium of the Seven about the Secret of the Sublime, engl. ed., ed. by M. lEathEr kuntz, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1975; id., Colloque entre sept savants qui sont des différents sentiments: des secrets cachez, des choses rélevées, par F. bErriot – k. daviEs, Droz, Genève 1984; G. GaWliCk – F. niEWöhnEr (edd.), Jean Bodin’s Colloquium Heptaplomeres, Harrassowitz, Wiesbaden 1996; A.E. baldini (ed.), «Jean Bodin a 400 anni dalla morte. Bilancio storiografico e prospettive di ricerca», in Il pensiero politico 30/2(1997); C. vivanti, Lotta politica e pace religiosa in Francia tra Cinque e Seicento, Einaudi, Torino 1963; Y.C. zarka (éd.), Jean Bodin, nature, histoire, droit et politique, PUF, Paris 1996.
393
ASE 30-2.indb 393 23/10/13 09.44
394
manoscritto pericoloso, divenne prezioso e ricercato, e fu destinato a una complessa circolazione tra Sei e Settecento.2
Il dialogo di Bodin si presta perfettamente a introdurre il tema di questo mio intervento. Non solo per la sua collocazione ideale, quella Venezia del Rinascimento che rappresentava un modello di perfezione politica e tolleranza religiosa, in quanto città di porto e necessariamente multiculturale, ma anche per alcuni suoi contenuti e per la centralità che vi gioca il ruolo che l’autore attribuisce al perso-naggio ebreo, Salomone. Alcuni studiosi hanno sostenuto che essa vi appare come centrale, forse quella che meglio rappresenta il pensiero dell’autore. Da qui la teoria della nascosta identità ebraica di Bodin, al quale, come a Montaigne, fu attribuita un’origine «marrana».3 Questa interpretazione non ha avuto molto seguito, e per quanto sia poco attendibile, individua un problema molto preciso, ossia quello della rappresentazione della cultura ebraica nel mondo cristiano. L’altra tradizione interpretativa fa invece di Bodin uno scettico e «libertino», rappresentato meglio dalla voce delle due tradizioni filosofiche. Anche in questo senso Bodin può essere facilmente associato a Montaigne, considerato uno degli esponenti di punta della rinascita e della diffu-sione dello scetticismo rinascimentale.4
Proprio intorno agli anni ’30 alcune informazioni circa il manoscrit-to di Bodin circolarono nei carteggi di alcuni studiosi, nello specifico nella corrispondenza di Gabriel Naudè e Ugo Grozio.5 È stata più volte avanzata l’ipotesi che Paolo Sarpi possedesse una copia del manoscritto di Bodin, anche se non vi sono indizi certi in quella direzione, o che
2 F. bErriot, «La fortune du Colloquium heptaplomeres», in J. bodin, Colloque entre sept savants qui sont de différents sentiments: des secrets cachez, des choses rélevées. Traduction anonyme du Colloquium Heptaplomeres de Jean Bodin, Texte présenté et établi par F. bEr-riot, Genève 1984. L’attribuzione a Bodin di questa opera è stata più volte contestata, per le evidenti differenze tra il Colloquium e gli altri scritti di Bodin. Cf. K.F. FalChEnbaChEr, Das Colloquium Heptaplomeres und das neue Weltbild Galileis. Zur Datierung, Autorschaft und Thematik des Siebenergesprächs, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1993; id., Das Colloquium Heptaplomeres, ein Religionsgespräch zwischen Scholastik und Aufklärung. Untersuchungen zur Thematik und zur Frage der Autorschaft, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 1988; N. MalColM, «Jean Bodin and the Authorship of the Colloquium Heptaplomeres», in Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 69(2006), 95-150; D. Wootton, «Pseudo-Bodin’s Colloquium Heptaplomeres and Bodin’s Démonomanie», in Beiträge zur Romanistik 6(2002), 175-225.
3 Ipotesi che non sono accolte unanimemente dalla storiografia specialistica: P.L. rosE, Bodin and the Great God of Nature: the Moral and Religious Universe of a Judaiser, Droz, Genève 1980; nel caso di Montaigne marrano: S. jaMa, L’histoire juive de Montaigne, Flammarion, Paris 2001.
4 Per una introduzione al tema cf. R. popkin, History of Scepticism. From Savonarola to Bayle, Oxford University Press, Oxford-London 2003.
5 M. ClinE horoWitz, «French Free Thinkers in the First Decades of the Edict of Nantes», in A. lEvinE (ed.), Early Modern Skepticism and the Origin of Toleration, Lexington, Boston 1999, 77-101.
ASE 30-2.indb 394 23/10/13 09.44
395
Sarpi ne condividesse alcuni dei presupposti.6 Per ora, solamente a li-vello ipotetico, immaginiamo che il testo fosse noto, forse non tramite manoscritto ma per trasmissione orale, nella Venezia di fine Cinquecento e inizio Seicento dove collochiamo le opere che vorrei introdurre. Opere scritte da ebrei e che vorrei analizzare nella cornice del dibattito sulla tolleranza religiosa in Europa.
2. polEMisti di priMa ClassE
Il punto di partenza è costituito, come già detto, da Venezia, luo-go mitico e reale di un incontro tra cristiani ed ebrei nella prima età moderna. La storia degli ebrei di Venezia costituisce quasi un luogo fondante della storiografia ebraica. «At no period, perhaps, in the whole of recent Jewish history have so many outstanding personalities lived at the same time in one place as was the case of Venice in the seventeenth century…», scriveva Cecil Roth, uno degli studiosi più importanti della storia degli ebrei d’Italia.7 Le vicende della Venezia ebraica sono legate ad alcune eccezionali personalità che hanno costellato la vita del ghetto seicentesco. I più noti sono Leone Modena, Simone Luzzatto e la poe-tessa Sara Copia Sulam, anche se il mondo ebraico della Serenissima e dei suoi territori fu ricco di vicende interessanti, non di rado connesse con le vicende storiche europee e di altre città italiane.8
Nel corso del 1638 furono stampati a Venezia due testi ebraici redatti in italiano. Sono opere abbastanza note, di autori molto attivi sulla scena veneziana ebraica e cristiana. Il primo trattato è legato a Leone Modena (1571-1648),9 il noto rabbino che fu anche indefesso poligrafo, autore
6 Sul rapporto tra i due autori cf. J. kainulainEn, Paolo Sarpi and the Colloquium Hepta-plomeres of Jean Bodin, online paper (www.storiadivenezia.net/sito/saggi/kainulainen_sarpi); su Sarpi rimando ad alcuni classici della storiografia: G. Cozzi, Paolo Sarpi tra Venezia e l’Europa, Einaudi, Torino 1978; P. FrajEsE, Sarpi scettico. Stato e Chiesa a Venezia tra Cinque e Seicento, Il Mulino, Bologna 1994; D. Wooton, Paolo Sarpi: Between Renaissance and Enlightenment, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
7 C. roth, History of the Jews of Venice, Jewish Publication Society of America, Philadelphia 1930, 212.
8 Su Sara Copia Sulam cf. U. Fortis, La bella ebrea. Sara Copia Sulam, poetessa nel ghetto di Venezia del ’600, Zamorani, Torino 2003; S. Copia sulaM, Jewish Poet and Intellectual in Seventeenth Century Venice, transl. by D. harran, University of Chicago Press, Chicago-London 2009; su Padova e lo studio della medicina rimane ancora centrale D. rudErMan, Jewish Though and Scientific Discovery in Early Modern Europe, Yale University Press, New Haven 1995.
9 Per una biografia dell’autore rimando a H. adElMan, Failure and Success in the Sevente-enth Century Ghetto of Venice: the Life and Thought of Leon Modena, 1571-1648, PhD Disser-tation, Brandeis University 1985; The Autobiography of a Seventeenth Century Venitian Rabbi. Leon Modena’s Life of Judah, ed. by M.R. CohEn, Princeton University Press, Princeton 1988; con qualche imprecisione la voce del Dizionario biografico degli italiani: P.C. ioly zorattini, «Leone Modena», in DBI 75(2011) (http://www.treccani.it/enciclopedia/leon-modena_(Diziona-rio-Biografico)/). Interventi recenti su alcune opere di Leone Modena: Y. dWECk, The Scandal
ASE 30-2.indb 395 23/10/13 09.44
396
di importanti opere, per lo più redatte in ebraico e italiano. Tra i testi più noti va annoverata la Historia de’ riti hebraici che fu pubblicata prima a Parigi (1637) tramite l’interessamento dell’orientalista cattolico Jac-ques Gaffarel, per poi essere ristampata, dopo i controlli della censura inquisitoriale, a Venezia nel 1638.10 Questa edizione ebbe ampia fortu-na e fu ripubblicata diverse volte in Italia, dove a più riprese fu anche confutata.11 La ricezione del testo costituisce una storia affascinante e, seppur nota, mai analizzata con metodologia attenta agli effetti culturali che un testo subisce quando è recepito in un diverso momento storico o ambiente culturale.12 Mi limito a fare una breve lista che riprende ciò che è già stato osservato.13 La Historia venne tradotta in inglese (1650, 1707 e 1723), in francese (1674 e 1681), in olandese (1693 e 1746), in latino (1693) e in tedesco (1746). Le traduzioni fecero affidamen-to, nella maggior parte dei casi, su due importanti riedizioni del testo: sull’edizione di Richard Simon e sul best-seller degli ugonotti Bernard Picart e Jean Frederic Bernard, Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde (1723-1737), di cui il primo volume era dedicato al giudaismo.14
L’altra opera è costituita invece dall’altrettanto famoso Discorso circa il stato de gl’Hebrei, redatto dal più giovane studioso e anch’esso rabbino, Simone (Simcha) Luzzatto (1586-1663) e stampato proprio nello stesso anno.15 Il Discorso, così come il testo sui riti, ebbe una ricezione per certi aspetti non meno fortunata, la quale si interseca, talora, con quella della Historia.16 Il Discorso è composto da 18 «consi-derazioni» che affrontano temi molto diversi tra loro e che indicano una composizione differenziata nei tempi e, come ha dimostrato G. Veltri,
of Kabbalah. Leon Modena, Jewish Mysticism, Early Modern Venice, Princeton University Press, Princeton 2011.
10 Sulla Historia de’ riti hebraici cf. il mio recente articolo: C. FaCChini, «The City, the Ghetto and Two Books. Venice and Jewish Early Modernity», in id. (ed.), The Cities of the Jews, numero monografico della rivista Quest 2(2011), 11-44.
11 Venezia 1669, 1673, 1678, 1694, 1714; Modena 1728; Roma 1932-33; Bologna 1979. 12 Per una visione sulla ricezione della Historia de’ riti hebraici rimando al noto articolo di
R. Cohen citato in questo saggio. 13 Molto interessante leggere J.C. WolF, Bibliotheca hebraea, 4 voll., Hamburg-Lipsia 1715-
1733, III, 3, loc. 692 (496). Accanto alle opere stampate vi sono le più importanti informazioni sulla pubblicazione e la ricezione. Sono note le questioni su Gaffarel, Selden, l’importante edizione di Simon, ecc.
14 Il ruolo rilevante fu svolto da Richard Simon. Cf. R. siMon, Les juifs présentés aux chrétiens. Textes de Léon De Modène et de Richard Simon, par j. lE brun – G.G. strouMsa, Belles Lettres, Paris 1998; l. hunt – M.C. jaCob – W. Mijnhardt, The Book that Changed Europe. Picart & Bernard’s Religious Ceremonies of the World, The Belknapp Press of Harvard University Press, Cambridge-London 2010.
15 Su Simone Luzzatto cf. S. luzzatto, Scritti politici e filosofici di un ebreo scettico nella Venezia del Seicento, a cura di G. vEltri, Bompiani, Milano 2013.
16 Per questo articolo utilizzo la versione a cura di G. Veltri: luzzatto, Scritti politici e filo-sofici. Il Discorso si trova alle pp. 1-109. Per la ricezione del Discorso rimando a Karp e Veltri.
ASE 30-2.indb 396 23/10/13 09.44
397
un testo diviso nettamente in due parti distinte. La recente edizione an-notata italiana permette ora di rileggere con più precisione la cultura di questo rabbino veneziano, che scrisse in italiano e in ebraico, e che era noto come importante matematico e scienziato. «Liber est rarissimus», scriveva il bibliografo luterano Johann Christian Wolf, al quale dobbia-mo anche una sinossi e una traduzione latina di alcune parti del testo.17 Le informazioni sull’opera di Luzzatto erano giunte a Wolf tramite la rete di rapporti intrecciati dai suoi collaboratori, tra cui Ch. Teophil Un-ger, un ebraista che agli inizi del Settecento era in contatto con rabbini italiani. Le lettere di Unger costituiscono un anello di congiunzione nella trasmissione delle informazioni su testi provenienti dall’Italia. Il Discorso fu menzionato nel carteggio tra C. Unger e I. Cantarini, dove si trovano anche espliciti riferimenti alla fama di Luzzatto come astronomo e scienziato:
Voglio ricordare ai posteri l’illustre nostro maestro Simcha Luzzatto uno dei più importanti rabbini di Venezia che ho conosciuto negli anni della mia giovinezza, il quale ha accresciuto la sua grandezza tramite la conoscenza scientifica e come ha chiaramente affermato il Yashar di Candia, nella introduzione all’Elim, che non si trova in tutta l’ampiezza della diaspora […]. Ho visto due dei suoi libri: uno si intitola Il Socrate e il secondo Il stato delli Hebrei in lingua italiana.18
17 Wolf ne fa menzione in più parti. Cf. G. vEltri, «Introduzione», in luzzatto, Scritti politici e filosofici. Il terzo volume di Wolf presenta più dettagli sull’opera di Luzzatto, nel quale integra le notizie dei volumi precedenti: cf. WolF, Bibliotheca hebraea, III, 1150-1151. Oltre alle notazioni sulle varianti del nome ebraico, Simcha o Shimon, Wolf è molto utile perché indica in parte alcune delle sue fonti, come i due importanti carteggi tra Unger e Cantarini e Unger e Aboav. L’opera e l’autore sono conosciuti da Bartolocci. Qui è segnalato l’uso che ne fece Basnage nella sua recentissima edizione del nono volume dell’Histoire, IX, 1061. Wolf segnala anche il fatto che l’opera fosse nota a Wagenseil, autore del famoso Tela ignea satanae, che a sua volta era noto tra gli ebrei italiani. Sempre da questa voce si segnala che il testo fosse noto a Toland (1715), Morosini (1694) e Schudt (Memorabilia judaica). Questi sono dati su cui tornerò in altra sede. La voce si affida anche al carteggio Unger-Aboav in cui il rabbino segnala probabilmente alcune informazioni errate, soprattutto circa il testo del Socrate, che peraltro egli associa al lavoro di fra Paolo Sarpi sugli Uscocchi, nota che appare anche in Basnage. Nel medesimo volume Wolf menziona Nahmias alias Morosini. Wolf descrive l’opera, Derekh emunah (La via della fede), un testo che pubblicato nel 1683 si presenta come una confutazione sia delle opere di Leone Modena che di Simone Luzzatto. Il testo, poco studiato, è molto interessante anche per il legame affettivo tra Nahmias e i due rabbini veneziani. Rimando, per alcune interpretazioni, a B. ravid, «Contra Judaeos in Seventeenth Century Italy: Two Responses to the Discorso of Simone Luzzatto by Melchiorre Palontrotti and Giulio Morosini», in AJS 7/8(1982-83), 301-351 (repr. in BC.I. ravid, Studies on the Jews of Venice, 1382-1797, Ashgate Variorum, Aldershot 2003); P.C. ioly zorattini, «Derekh teshuvà. La via del ritorno», in L’identità dissimulata. Giudaizzanti iberici nell’Europa cristiana dell’età moderna, a cura di P.C. ioly zorattini, Olschki, Firenze 2000, 195-248.
18 Isaac Cohen Cantarini (meha-hazanim) (1644-1723) fu rabbino, predicatore e medico noto che visse e lavorò a Padova. Per la corrispondenza tra Unger e Cantarini cf. Otzar nehmad 3, Vienna 1860, 137 (ebraico).
ASE 30-2.indb 397 23/10/13 09.44
398
Importanti notazioni biografiche su Luzzatto erano presenti in un altro importante testo pubblicato nel medesimo periodo, il Sefer elim di Yosef Shelomo Delmedigo, l’allievo di Galileo a Padova.19 La pub-blicazione del Sefer elim, che contribuì certamente a diffondere certi elementi della nuova scienza, fu approvata da Leone Modena e Simone Luzzatto. Non è possibile ora soffermarsi su questi indizi, tanto meno su queste opere, ma è importante segnalare che, nella prima fase della circolazione del testo, la memoria dell’autore fu trasmessa da ebrei che erano anche scienziati. È altrettanto probabile che la copia utilizzata da J.C. Wolf provenisse da Venezia.20 Oltre a Cantarini, informazioni su Luzzatto furono trasmesse a Unger – e quindi a Wolf – da un altro rabbino veneziano, Ya’acov Aboav.21
La ricezione – o la straordinaria somiglianza – di alcuni temi del Discorso si trova nell’opera di Menasseh ben Israel, in un trattato in cui il rabbino olandese fece esplicita richiesta a Oliver Cromwell di riam-mettere gli ebrei in Inghilterra.22 Non a caso proprio ad Amsterdam, una città dove la comunità ebraica fu in stretto contatto con quella veneziana, alcuni temi del Discorso furono utilizzati negli scritti di Spinoza.23 Agli inizi del XVIII secolo, troviamo le argomentazioni di Luzzatto nella riflessione di John Toland sulla naturalizzazione degli ebrei in Gran Bretagna e Irlanda,24 nelle opere di Moses Mendelssohn tra gli illumi-nisti tedeschi e tra gli echi del dibattito sull’emancipazione degli ebrei in Francia. Più controversa, talora cupa, fu la ricezione di questi temi
19 Su questo importante autore cf. I. barzilay, Yoseph Shlomo Delmedigo (Yashar of Can-dia): His Life, Works and Times, Brill, Leiden 1974. Il Sefer elim fu pubblicato da Menasseh ben Israel ad Amsterdam nel 1628-29. Sulle opere di Delmedigo vanno segnalati alcuni recenti lavori: A. bEn-zakEn, «Bridging Networks of Trust: Practicing Astronomy in Late Sixteenth Century Salonica», in Jewish History 23(2009), 343-361; id., Cross-Cultural Scientific Exchanges in the Eastern Mediterranean, 1550-1650, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2010.
20 Carteggio Cantarini-Unger, Otzar nechmad, passim.21 Su Ya’acov Aboav (1649-1745) e questo specifico punto rimando al più recente A. salah,
La République des Lettres: rabbins, écrivains et médecins Juifs en Italie au XVIIIe siècle, Brill, Leiden 2007, 23. Wolf menziona di aver letto la corrispondenza tra Unger e Aboav, in WolF, Bibliotheca, III, 427 e 1150; FaCChini, «The City, the Ghetto», 40.
22 M. ben Israel, Humble Addresses (1655) e Vindiciae Judeorum (1656). Cf. J. karp, The Politics of Jewish Commerce. Economic Thought and Emancipation in Europe, 1638-1848, Cambridge University Press, Cambridge 2008.
23 Su Luzzatto e Spinoza si veda: B. sEptiMus, «Biblical Religion and Political Rationality in Simone Luzzatto, Maimonides and Spinoza», in i. tWErsky – b. sEptiMus (edd.), Jewish Thought in the Seventeenth Century, Harvard University Press, Cambridge 1987, 399-433; G. vEltri, «La dimensione politica filosofica dei caerimonalia hebraeorum: Baruk Spinoza e Si-mone Luzzatto», in Materia giudaica 13(2008)1-2, 81-89.
24 J. Toland, Naturalization of the Jews in Great Britain and Ireland (1714); su questa connes-sione cf. I.E. barzilay, «John Toland’s Borrowings from Simone Luzzatto: Luzzatto’s Discourse on the Jews of Venice (1638) the Major Source of Toland’s Writing on the Naturalization of the Jews in Great Britain and Ireland (1714)», in Jewish Social Studies 31(1969)2, 75-81. Più recente la riflessione di karp, The Politics of Jewish Commerce, passim.
ASE 30-2.indb 398 23/10/13 09.44
399
nel corso dell’Ottocento e del Novecento. Particolarmente interessante è quella italiana, di cui ancora si sa molto poco.25
In un lungo articolo pubblicato in altra sede ho cercato di analizzare queste due opere insieme, nel tentativo di fare emergere una comune necessità, quella cioè di caratterizzare in senso universale, comprensi-bile a un pubblico non ebraico, l’ebraismo. La necessità di comparare i due testi, cosa in sé molto più complessa di quanto immaginato, è determinata dal contesto storico e dalla prossimità degli autori e delle opere.26 La comparazione, che richiede altri affondi analitici, ha per lo meno il vantaggio di rispondere a una domanda centrale: perché due testi di questo tipo furono redatti a Venezia nel corso della primissima metà del Seicento? A quali problemi concreti risposero? Che immagine dell’ebraismo ne emerge? Quali sono le somiglianze e le differenze che li caratterizzano? In che rapporto stanno col mondo intellettuale cristiano veneziano e con quello più generale di un periodo che molti hanno descritto come «age of anxiety»?27
Non potendo rispondere a tutte queste domande in un unico arti-colo, mi concentrerò su un tema specifico che ha una certa importanza nel contesto generale della prima età moderna, ossia la questione della tolleranza religiosa. Ho già evidenziato che nelle due opere emergono due differenti strategie di descrizione dell’ebraismo secentesco e che esse sono in parte connesse alle teorie della tolleranza religiosa, mai del tutto analizzata in modo sistematico, tanto meno integrato, se non con delle recentissime eccezioni, nella storiografia sul pensiero politico e religioso di età moderna.28
3. notE sulla tollEranza rEliGiosa
La riflessione sulla tolleranza religiosa presuppose un ripensamento e una conoscenza delle religioni, sia nelle varianti cristiane che di
25 Si veda Veltri in luzzatto, Scritti politici e filosofici, LXIII-LXV, il quale segnala alcuni aspetti della ricezione novecentesca, con particolare riferimento a Werner Sombart.
26 I contatti tra i due autori furono strettissimi, anche se segnati da momenti di tensione. S. siMonsohn, «Introduzione», in Rabbi Yehudah Arieh mi-Modena, Sheelot u-teshuvot. Ziqne Yehudah, Rav Kook, Yerushalaim 1956, 46 (ebraico). Una comparazione, ma non sistematica, appare in M.R. CohEn, infra, e in A. GuEtta, «Aspekte des jüdischen Universalismus in Frankreich und Italien im 19. Jahrhundert», in C. MiEthinG (hrsg.), Judentum und Moderne in Frankreich und Italien (Romania Judaica. Studien zur jüdischen Kultur in den romanischen Ländern. Band 2), Tübingen 1998.
27 E. Muir, The Culture Wars of the Late Renaissance: Skeptics, Libertines, and Opera, Harvard University Press, Cambridge 2007.
28 Per un recente contributo sulle forme di tolleranza interna al mondo ebraico cf. M. Good-Man – j.E. david – C.r. kaisEr – s. lEvis sullaM (edd.), Toleration within Judaism, The Littman Library of Jewish Civilization, Oxford-Portland (Oregon) 2013.
ASE 30-2.indb 399 23/10/13 09.44
400
matrice biblica. Lentamente nel corso del XVII secolo si sviluppò un interesse più articolato nei confronti di religioni non bibliche, catalogate col termine generico di «paganesimo», «gentilesimo», «idolatria». L’era delle esplorazioni e delle missioni fu caratterizzata, in questa fase di prima globalizzazione, dall’espansione conoscitiva che coincise in parte con la nascita della nuova scienza. Fu in questa fase, che le religioni di popoli lontani e sconosciuti – fuori dai confini della cristianità – vennero lentamente introdotte al pubblico colto europeo. Secondo alcuni studiosi, questo processo influì in modo rilevante sullo sviluppo della teoria della tolleranza.29
Altro problema insito nel dibattito sulla tolleranza religiosa coin-volge le forme di comprensione del cristianesimo: quale cristianesimo è più vicino alla verità della rivelazione? Come si individua il luogo della verità? Una delle risposte – già in parte predisposta dal movimento evangelico – si trova nella comprensione e rilettura delle fonti, ossia del testo sacro. La verità della rivelazione si trova nel passato e nella storia. Un punto questo fondamentale sul quale non posso soffermarmi, ma che introduce il tema successivo.
In questo intricato sfondo storico, dove si collocano gli ebrei? Qual è il loro posto nel «corpo mistico» della società cristiana? Il quesito, lungi dall’essere accademico, definisce un problema centrale nella storia dei rapporti ebraico-cristiani, che non si estinse neanche dopo i processi di emancipazione. Per quanto concerne la prima età moderna, le conversioni forzate e l’espulsione dai domini iberici, così come la persecuzione dei relapsi, si intrecciano alle vicende della riforma protestante. Come risposero gli ebrei a questa sfida, come reagirono ai cambiamenti in corso? Nella mia prospettiva, i testi che presento offrono alcune delle possibili risposte che le élite ebraiche furono in grado di elaborare. Quali furono le possibilità di «dialogo» tra gli «infedeli» ebrei e i gruppi cristiani? Quali le teorie, politiche e religiose che, a differenza dell’opzione iberica, potevano essere addotte per giustificare una tolleranza o una presenza dei gruppi ebraici in seno alla cristianità?
4. i riti dEGli EbrEi
Per introdurre il tema relativo ai «riti degli ebrei», e dare un senso storico a questo piccolo e noto testo, va detto che la produzione sui riti degli ebrei vide una sistematica proliferazione nel periodo che intercorse tra la seconda metà del Cinquecento e il primo Settecento. L’espansione dell’Europa e la conquista delle Americhe spiegherebbero, secondo al-
29 Una conclusione in questa direzione si trova in hunt – jaCob – Mijnhardt, The Book that Changed Europe.
ASE 30-2.indb 400 23/10/13 09.44
401
cuni studiosi, una mutazione di sensibilità in senso etnografico verso le pratiche religiose di popolazione extra-europee e degli ebrei stessi. Le nozioni di «etnografia» e «etnografie polemiche» sono state proposte da alcuni studiosi per analizzare questi testi, anche se non esiste consenso storiografico.30 In assenza di una ricognizione sistematica dei lavori di ebraisti cristiani sui riti degli ebrei che tenga conto anche di paesi cattolici, si può per lo meno riassumere ciò che è stato finora avanzato: uno degli aspetti principali dei testi redatti da ebraisti cristiani tende a mostrare l’inaffidabilità della tradizione ermeneutica ed esegetica ebrai-ca. Nel mondo protestante – e in particolar modo quello luterano di lingua tedesca – questa motivazione si fonda sull’idea che l’ebraismo, come il cattolicesimo e la sua tradizione apostolica, non fossero vere religioni, in quanto entrambe traditrici della matrice biblica e del suo vero messaggio.
Tuttavia si può sostenere che l’interesse dei cristiani per i riti ebraici risenta di esigenze culturali e religiose diverse, in stretta relazione con la conformazione teologica del gruppo religioso. Questa tradizione di studi trovò ampio spazio in tutti i paesi europei, sia laddove erano pre-senti numerose comunità ebraiche, sia laddove non ne esisteva alcuna, come nel caso dell’Inghilterra.31 I motivi di questo profondo interesse nei confronti della vita religiosa ebraica sono molteplici, dalla volontà di denigrare l’ebraismo a quella di capirlo meglio per attuare politiche di conversione meno aggressive, dalla necessità di capire il cristianesimo dei tempi antichi attraverso la ricostruzione dettagliata della religione ebraica, al bisogno di definire norme e leggi per la regolamentazione della società coeva.32
La Historia fu quindi redatta in un momento di grande interesse per questi temi. In un certo senso, essa si presenta come una sorta di novità assoluta nel campo ebraico, dove testi sui riti erano confluiti nelle tradizioni giurisprudenziali e nelle raccolte sui minhagim, i costumi locali.33 C. Roth ha suggerito che l’opera di Leone Modena fosse stata
30 Su questo tema rimando a Y. dEutsCh, Judaism in Christian Eyes. Ethographic Descrip-tions of Jews and Judaism in Early Modern Europe, Oxford University Press, Oxford-New York 2012 (trad. dall’ebraico).
31 Il caso emblematico è rappresentato da Selden: J.P. rosEnblatt, Renaissance England’s Chief Rabbi: John Selden, Oxford University Press, Oxford 2006. Il tema coinvolge il dibattito sull’interpretazione politica della Bibbia ebraica e sulle correnti europee di «filosemitismo». La bibliografia è piuttosto ampia, ma tra i lavori importanti cf. l. CaMpos boralEvi – d. QuaGlioni (edd.), Politeia biblica, Olschki, Firenze 2002; j. karp – a. sutCliFFE (edd.), Philosemitism in History, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2011.
32 Rimando, su questo tema, ad alcuni lavori su ebraisti cristiani: A.p. CoudErt – j.s. shoul-son (edd.), Hebraica Veritas? Christian Hebraists and the Study of Judaism in Early Modern Europe, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2004.
33 Sono molteplici le pubblicazioni su specifici riti dei diversi gruppi ebraici, noti col nome di sifrei minhagim.
ASE 30-2.indb 401 23/10/13 09.44
402
redatta su richiesta di Sir Wotton, l’ambasciatore inglese a Venezia, e che una prima stesura di questo trattato fosse già pronta e circolasse nel 1614, e che fosse destinata a re Giacomo I.34 La motivazione di Modena però attribuisce la genesi del trattato ad altro motivo, alla decisione di confutare il noto lavoro sui riti ebraici composto dal teologo protestante J. Buxtorf, lo Judenschul (1603) tradotto in latino con il titolo di Synagoga judaica.35 La redazione della Historia risentì molto probabilmente degli interessi del mondo inglese, anche se la sua pubblicazione fu portata a compimento da Jacques Gaffarel, un cattolico noto per i suoi interessi nei confronti della tradizione esoterica ebraica e attratto dalle speculazioni astrologiche, scientifiche e dalla magia rinascimentale.36
Il trattato è suddiviso in cinque parti, come i cinque libri della Torah,37 e contiene 54 capitoli che indicativamente seguono la suddivisione della Torah in parashot.38 L’organizzazione dei temi e dei capitoli non segue una logica chiara, ma riti e norme ebraiche sono descritti nella loro totalità. Leone afferma, fin dalle prime pagine, che non tutti i precetti hanno eguale valore e importanza, un indizio questo molto significativo al fine di comprendere la sua polemica con Buxtorf. I riferimenti puntuali sono alla legge scritta (nella codificazione di Maimonide), alla legge orale (quella dei rabbini e in generale al Talmud) e alle tradizioni locali, cristallizzate nel corso dei secoli e riconosciute attraverso l’uso presso le comunità (le diverse norme di carattere locale minhagim). Il terzo tipo di norme, quelle di carattere locale, non è annoverabile tra i veri precetti perché esse non sono universalmente seguite da tutti gli ebrei. Su questo punto si potrebbe ipotizzare, senza entrare nei dettagli del
34 Questo quanto afferma Modena in una lettera all’ebraista cristiano Noghera. Cf. C. roth, «Leone da Modena and the Christian Hebraists of His Age», in Jewish Studies in Memory of Israel Abrahams, Press of the Jewish Institute of Religion, New York 1927, 384-401.
35 Cf. J. buxtorF, Sinagoga judaica. Das ist Jueden Schul, Basel 1603. Venne tradotto in latino nel 1604 e ripubblicato più volte, con ampliamenti e aggiunte. Sull’opera di Buxtorf ri-mando a S.G. burnEtt, «Distorted Mirrors. Antonius Margaritha, Johann Buxtorf and Christian Etnographies of the Jews», in Sixteenth Century Journal 25(1994)2, 275-287; id., From Chri-stian Hebraism to Jewish Studies: Johannes Buxtorf I (1564-1629) and Hebrew Learning in the Seventeenth Century, Brill, Leiden 1996; al recente A. GraFton – j. WEinbErG, «I have always loved the Holy Tongue». Isaac Casaubon, the Jews, and a Forgotten Chapter in Renaissance Scholarship, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge-London 2011.
36 Rimando a FaCChini, «The City, the Ghetto», passim.37 Utilizzo, per questo articolo, i seguenti testi: Historia de gli riti hebraici: dove si dà
breve e total relatione di tutta la vita, costumi, è riti e osservanze de gl’Hebrei di questi tempi, di Leon Modena, Rabi Hebreo di Venetia (Parigi 1637); l’edizione veneziana (1638): Historia de riti hebraici, vita et osservanza de gl’Hebrei di questi tempi, di Leon Modena Rabi Hebreo da Venetia (Calleoni, Venezia 1638). La ristampa del 1678 e il testo francese. È stata pubblicata una traduzione tedesca: L. ModEna, Juedische Riten, sitten un gebräuche, hrsg. und übersetz. R. arnold, Marixverlag, Wiesbaden 2007.
38 M.R. CohEn, «Leone da Modena’s Riti. A Seventeenth Century Plea for Social Toleration of Jews», in Jewish Social Studies 34(1972)4, 287-321 (296).
ASE 30-2.indb 402 23/10/13 09.44
403
caso, che Modena intendesse criticare l’uso di norme consuetudinarie come precetti universali, soprattutto da parte di ebraisti cristiani anche se lui stesso vi fece ricorso nella descrizione dell’ebraismo del suo tempo. È un punto importante che differenzia l’approccio di Modena rispetto a quello di Simone Luzzatto in riferimento alla descrizione del giudaismo.39
Nella prima sezione Modena elenca le norme relative a: case, mas-serizie, sonno e sogni, abiti, comportamenti modesti, lavaggio mani, pulizia, benedizioni, sinagoghe, preghiere, sacerdoti e leviti, agricoltura, elemosina e pietà per animali.40 La seconda parte è dedicata a: lingua, scrittura e predicazione; studi; testi rabbinici; giuramenti e voti; com-mercio e usura; contratti, scritture, giudici; cibi proibiti; bere; pane; regole sul mangiare. La terza parte è dedicata alle feste dell’anno litur-gico: Sabato; Capo mese e calendario; Pasqua, Pentecoste, Capo d’anno, Kippur, Sukkot, digiuni, Hanuccah e Purim. La quarta parte ai rapporti sessuali con donne, preparazione al matrimonio, nozze, rifiuto del marito, della donna mestruata, della gelosia e ripudio, yibbum e halitza,41 circoncisione, riscatto dei primogeniti, educazione dei figli, rispetto per genitori e precettori. La quinta e ultima parte invece è quella in cui appaiono informazioni anche sulle «credenze»: eretici e karaiti, divinazione e magia, precetti femminili, schiavi, confessione e penitenza, malattia e morte, morte e sepoltura, sui morti, paradiso inferno e purgatorio.42
Il testo di Buxtorf, suddiviso in 36 capitoli, come ha ben dimostrato Cohen, si presenta come un trattato farraginoso e dettagliato, eruditissimo e preciso nelle citazioni testuali, ma guidato dalla volontà di evidenziare la «irrazionalità» della religione ebraica, e la sua diversità rispetto al dettato biblico. Altri studiosi hanno rilevato una polemica teologica profonda, che si presenta in molti testi sui riti degli ebrei, ma che non
39 In particolare la consideratione 16 che abbiamo già discusso in altra sede. Cf. FaCChini, «The City, the Ghetto», passim.
40 Carità per il prossimo anche in Luzzatto. 41 Dt 25,5-10: «5Se dei fratelli abitano assieme e uno di essi muore senza lasciar figli, la
moglie del defunto non si mariterà a un estraneo fuori della famiglia; suo cognato entrerà da lei e la prenderà in moglie, compiendo verso di lei il dovere di cognato; 6e il primogenito che ella partorirà prenderà il nome del fratello defunto, perché il suo nome non sia cancellato in Israele. 7Ma se quell’uomo non vuole prendere sua cognata, la cognata salirà alla porta dagli anziani e dirà: “Mio cognato rifiuta di risollevare il nome di suo fratello in Israele; egli non vuole com-piere verso di me il dovere di cognato”. 8Allora gli anziani della sua città lo chiameranno e gli parleranno; e se egli persiste e dice: “Non voglio prenderla”, 9allora sua cognata gli si avvicinerà in presenza degli anziani, gli leverà il sandalo dal piede, gli sputerà in faccia e dirà: “Così sarà fatto all’uomo che non vuole edificare la casa di suo fratello”. 10E il suo nome in Israele sarà chiamato: “La casa di colui al quale è stato rimosso il sandalo”» (Nuova Diodati).
42 Si vedano la struttura dell’opera e le differenze delle diverse edizioni, indicate da CohEn, «Leone da Modena’s Riti», passim e anche G. lE brun, «Introduction», in siMon, Les juifs présentés aux chrétiens, XIII-XLIX.
ASE 30-2.indb 403 23/10/13 09.44
404
era necessariamente percepita come perniciosa o pericolosa dalle comunità ebraiche. Il testo ebbe comunque ampia diffusione e l’erudizione e precisione testuale contribuì ad aumentarne l’autorevolezza. Fu ristampato più volte e aggiornato dal figlio, che raccolse l’eredità del padre.43 Non mancano, come nel testo di Leone Modena, cenni alle credenze ebraiche, in particolare alle concezioni messianiche.44
Il lavoro di Modena, se letto come una polemica contro Buxtorf, capovolge i presupposti fondamentali dell’opera dell’ebraista protestante: nella Historia viene descritto un ebraismo sobrio, ancorato alla tradizione biblica, l’unica esplicitamente citata. Qualche polemica contro i correligionari, qualche cenno melanconico alla condizione dell’esilio che obbliga a specializzazioni professionali umilianti, come il prestito a interesse. L’analisi del sistema di credenze non è del tutto assente, ma meno evidente e conclamato. Modena sembra proporre l’idea di ebraismo unito dal sistema dei riti, quelli che definiscono gli ebrei nell’universale, e che permette l’unità nella diaspora. Le divisioni tra gruppi di ebrei, acute e diffuse, tra cabalisti e anti-cabalisti, zelanti, criptoebrei e relapsi, così come quelle tra diversi gruppi storici (caraiti e samaritani) sono eliminate, come a voler suggerire che, a differenza del cristianesimo, l’ebraismo non conosce divisioni e scismi di alcun genere.45 Un consapevole silenzio è calato anche sulla storia e sulle tante sètte che avevano costellato la vita del giudaismo del secondo tempio. Il tema era di grande interesse e Modena era a conoscenza di questi argomenti, come dimostrano i suoi responsa, le sue lettere e il suo trattato anticristiano.46 Ma nella Historia le spiegazioni di tipo storico sono eliminate quasi del tutto.
43 Burnett, «Distorted Mirrors», passim.44 Burnett, «Distorted Mirrors», passim. Il cap. 36 (venturo judaeorum Messiae) è dedicato
alle credenze messianiche. 45 I caraiti furono al centro di un grande interesse da parte del mondo cristiano nel corso
della prima età moderna. Non a caso nell’edizione francese della Historia di Modena, curata da R. Simon, l’oratoriano aggiunge due saggi su samaritani e caraiti. Nell’opera bibliografica di Wolf si fa menzione di un’opera sui caraiti redatta da Modena e Luzzatto di cui sono scomparse le tracce. La questione dei caraiti è di grande interesse per l’uso polemico che venne fatto di alcune loro opere, ma soprattutto perché erano poco conosciuti nella cultura europea dell’epoca. Rimando a Y. Kaplan, An Alternative Path to Modernity. The Sephardi Diaspora in Western Europe, Brill, Leiden 2000, 234ss; S. rosenBerg, «Emunat hakhamim», in Jewish Thought in Seventeenth Century, 285-295; M. Idel, «Differing Conceptions of Kabbalah in the Early 17th Century», in Jewish Thought in Seventeenth Century, 137-200; M. rustow, «Karaites Real and Imagined: Three Cases of Jewish Heresy», in Past and Present 197(2007), 35-74; G. stroumsa, A New Science. The Discovery of Religion in the Age of Reason, Cambridge University Press, Cambridge 2010, 73.
46 L. modena, Magen wa-herev. Hibbur neged ha-natzrut, a cura di S. sImonsohn, Gerusalemme 1960; Id., Sheelot uteshuvot, a cura di S. sImonsohn, Gerusalemme 1957; Id., Magen we-tzinnah, a cura di A. geIger, Breslau 1856.
07 - ASE 30-2.indd 404 31/10/13 12.00
405
Gli interpreti più autorevoli hanno letto la Historia de’ riti hebraici come una richiesta di «social toleration» nella società di antico regime.47 M.R. Cohen ha insistito su alcune caratteristiche del testo, osservando che, nell’eliminare dalla descrizione dell’ebraismo tutti quegli elementi rituali superflui e fortemente influenzati dalle dottrine cabbalistiche, Leone non solo polemizzava con Buxtorf che aveva deriso quegli aspetti dell’ebraismo, ma proponeva un ebraismo ideale – un progetto di ebraismo – fondato sull’interpretazione dei testi della tradizione e, in parte, sull’osservazione concreta di dati che erano condivisi. Il risultato di questa operazione si esprimeva nel tentativo di rivendicare all’ebraismo del suo tempo – e quindi alla tradizione rabbinica – una continuità biblica che, nella prospettiva ebraica, non era mai stata recisa. In questo senso Leone fu efficace se pensiamo al successo del suo lavoro. In ogni caso, se seguiamo il ragionamento di Cohen, la costruzione di un ebraismo di questo tipo, biblico e depurato dei suoi elementi «superstiziosi» e mistici, così come emerge dalla sua opera e, mutatis mutandis, anche dal testo ebraico Qol sakhal, recentemente attribuito a lui, costituirebbe un’aperta dichiarazione e richiesta di tolleranza religiosa entro le coordinate della cultura del tempo.48
Gli studi più recenti delle sue opere hanno insistito sulla moderna critica che Modena conduce nei confronti delle religioni, in particolare dell’ebraismo e del cristianesimo.49 La sua modernità nell’approccio e nella critica alla religione, la sua concezione di ebraismo «razionale», in senso maimonideo, gli permettono di intercettare possibili aperture nel mondo cristiano, in particolare le istanze culturali provenienti dagli ebraisti inglesi e olandesi. Il testo di Modena è ancorato alla tradizione maimonidea la quale, per quanto dissimulata, gli permette di condurre un’operazione di recupero della tradizione medievale utile a riconfigu-rare i rapporti tra ebrei e cristiani.50
47 Il saggio di riferimento rimane CohEn, «Leone da Modena’s Riti».48 Per qualche riflessione su questo tipo di immaginazione religiosa cf. C. FaCChini, «Una
insinuante modernità. Leone Modena e il Seicento ebraico. Rassegna di Studi», in Annali di storia dell’esegesi 19(2002)2, 467-497.
49 La polemica contro l’irrazionalità del cristianesimo si trova in Magev wa-herev, un testo composto negli anni della vecchiaia e che fu pubblicato solo nel Novecento (cf. supra). Un’ana-lisi su questi aspetti in A. GuEtta, «Leone Modena’s Magen wa-Herev as an Anti-Catholic Apologia», in Jewish Studies Quarterly 7(2000); versione aggiornata in id., «Anti-Catholic Apologetics in Leon Modena’s Magen Va-Herev: A Comparative Reading», in r. bonFil – d. MalkiEl (edd.), The Lion Shall Roar. Leone Modena and His World (Conference Supplement Series n. 1 of Italia), Jerusalem 2003.
50 Mi riferisco a John Selden, in rosEnblatt, Renaissance England’s Chief Rabbi, passim. Per il mondo olandese cf. A. katChEn, Christian Hebraists and Dutch Rabbis. Seventeenth Century Apologetics and the Study of Maimonides’ Mishneh Torah, Harvard University Center for Jewish Studies, Cambridge (Mass.) 1985. L’importanza di Maimonide nel pensiero cristiano della prima età moderna è stata esplorata, tra gli altri, da E. nElson, The Hebrew Republic. Jewish Sources and the Transformation of European Political Thought, Harvard University
ASE 30-2.indb 405 23/10/13 09.44
406
Una nota conclusiva su questa opera di Leone Modena, che serve per comprendere meglio la portata dell’operazione culturale dei due rabbini veneziani. Nella stesura del suo testo Modena introduce anche precisi dati storici – osservati da lui stesso – provenienti dal suo universo culturale e che dovrebbero essere analizzati attraverso la nozione di «etnografia», di cui ho accennato sopra. Si potrebbe parlare, in questo caso, di «auto-etnografia», se non che Modena stesso presenta il testo come «etnografia», cioè come una descrizione dei riti e costumi degli ebrei dei suoi tempi.51 Il testo però intreccia tradizione testuale, prassi ermeneutica e osservazione della realtà, che costituiscono i tre livelli di costruzione del testo sui riti. Mi pare più preciso allora utilizzare la definizione che Pagden ha individuato nel descrivere la sensibilità culturale della prima età moderna di fronte alla «scoperta» delle Americhe, ossia la nozione di «autoptic imagination»,52 la quale richiama la testimonianza visiva, e che fa di Modena un autore affidabile, in quanto osservatore interno e, come osservava egli stesso, «neutrale».53
Press, Cambridge 2010. Nessun lavoro sistematico è stato condotto su Italia e altri paesi cattolici. Richard Simon sembra prediligere l’opera di Maimonide rispetto alle tradizioni mistiche. Per quanto concerne Leone Modena, la centralità del pensiero di Maimonide si trova certamente in Ari nohem, il suo testo contro la Qabbalah: cf. dWECk, The Scandal of Kabbalah.
51 È un tema molto ampio che va trattato in separata sede. Rimando al dibattito storiografico: il primo autore a proporre questa «categoria interpretativa» fu R. Po Chia-Hsia nel 1992: r. po Chia-hsia, «Christian Ethnographies of the Jews in Early Modern Germany», in r.b. WaddinGton – a.h. WilliaMson (edd.), The Expulsion of the Jews. 1492 and After, Garland, New York 1994, 223-235; cf. burnEtt, «Distorted Mirrors»; la medesima idea si trova in strouMsa, A New Science. È utile forse ricordare che anche C. Ginzburg utilizzò, in riferimento agli inquisitori, questa nozione: C. GinzburG, «L’inquisitore come antropologo», in id., Il filo e le tracce. Vero, falso, finto, Feltrinelli, Milano 2006, 270-293. Il recente lavoro di Deutsch è segnalato infra (nota 30). Per una critica a questa impostazione: G. vEltri, Renaissance Philosophy in Jewish Garb, Brill, Leiden-Boston 2009, 169-184. Sulla nozione di «auto-etnografia» rimando a Pratt: «“Auto-ethnography” or “autoethnographic expression”… to refer to instances in which colonized subject undertake to represent themselves in ways that engage with the colonizer’s own term» (M.L. pratt, Emperial Eyes. Travel Writing and Transculturation, Routledge, London-New York 1992 [Kindle pos. 271]).
52 A. paGdEn, European Encounters with the new World, Yale University Press, New Haven 1993, 51. Per quanto concerne la problematicità della nascita dell’etnografia europea nella prima età moderna, cf. M. hodGEn, Early Anthropology in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1964; C.B. brEttEll, «Introduction: Travel Literature, Ethnography, and Ethnohistory», in Ethnohistory 33(1986)2, 127-138.
53 In entrambi i testi gli autori parlano del loro essere osservatori «neutrali». ModEna, «Proe-mio», in Riti (1678): «Nello scriver, in verità, che mi sono scordato d’esser Hebreo, figurandomi semplice, e neutrale relatore». Lo stesso scrive Luzzatto: «Mi sono proposto nell’animo formare compendioso, ma verace racconto de suoi Ritti principali, et opinioni più comuni dall’universale non dissonanti, et discrepanti, nella quale applicazione ho procurato con ogni mio potere (benché io sia della istessa natione) astenermi da qualunque affetto, et passione che dal vero deviare mi potesse» (luzzatto, Discorso, 4r; cf. FaCChini, «The City, the Ghetto», 28-29).
ASE 30-2.indb 406 23/10/13 09.44
407
5. l’utilità EConoMiCa CoME prinCipio di tollEranza rEliGiosa
In un testo inglese del 1617 sono elencati tra le nationes industriose, accanto a irlandesi, danesi e polacchi, anche un «barbarian» e un ebreo. Specializzati nel commercio di qualche prodotto, l’unico a non avere una madrepatria di riferimento è l’ebreo. «Unlike the other Nations of Middleton’s pageant, however, the Jews had no homeland to call their own. Why, then, is a Jewish “nation” on this list?».54 La domanda è pertinente, perché effettivamente gli ebrei non costituivano una nazione mercantile nel senso proprio del termine, in quanto non titolari di pri-vilegi tipici delle nationes di mercanti e stranieri.55 La trasformazione della natio ebraica in gruppo mercantile, con una funzione economica di rilievo, è da attribuirsi sia a processi di trasformazione storici che a scelte di promozione e difesa degli ebrei.
Il Discorso di Simone Luzzatto è probabilmente il testo che maggiormente ha contribuito a cristallizzare questa immagine.56 Composto da 18 considerazioni, esso è suddivisibile in due parti, come proposto da G. Veltri, con i primi dieci capitoli da leggersi come un trattato a parte, forniti di autonomia e coerenza tematiche. I dieci capitoli iniziali presentano una serie di temi centrati sulla città e il suo funzionamento: l’utilità del commercio, la presenza e il monopolio degli stranieri, l’arricchimento e impoverimento delle città, il ruolo degli ebrei nel commercio, le caratteristiche sociali degli ebrei e le forme dell’obbedienza e della loro lealtà politica, la professione mercantile, la redistribuzione delle ricchezze e quella prodotta dagli ebrei, i banchi dei pegni, la tolleranza (protetione) accordata dalle autorità civili.57 Questa parte è quella che ha ricevuto più attenzione e che ha contribuito ad alimentare un dibattito molto intenso sul tema dell’utilità economica degli ebrei e il loro ruolo nel nascente capitalismo. Si tratta dell’argomento, destinato a grande successo, della centralità economica degli ebrei e della loro utilità a questi fini.58
Il Discorso è un testo sofisticato, spesso interpretato come una delle prime richieste di tolleranza meramente moderne, poiché fondata su concezioni di carattere mercantile e utilitaristiche. Un testo che si diffe-
54 A. kitCh, «Shylock’s Sacred Nations», in Shakespeare Quarterly 59(2008)2, 131-155. 55 FaCChini, «The City, the Ghetto» e la bibliografia menzionata.56 Su Luzzatto la bibliografia è piuttosto cospicua. Su questo tema rimando ai lavori di B.
ravid, Economics and Toleration in Seventeenth Century Venice: The Background and Context of the Discorso of Simone Luzzatto, American Academy for Jewish Research, Jerusalem 1978.
57 vEltri, Renaissance Philosophy, 210. 58 Questo tema ebbe grande successo nel corso dell’Ottocento. Per una sua applicazione
anche alla minoranza ugonotta rimando a C. FaCChini, «Protestants, Jews and the Rise of the Italian Nation. Questions, Problems and New Approaches», paper presentato al convegno in-ternazionale Believers in the Nation. European Religious Minorities in the Age of Nationalism (1815-1914), Groningen, 16-17 giugno 2011 (in stampa nel 2014).
ASE 30-2.indb 407 23/10/13 09.44
408
renzia radicalmente dalla cultura medievale, come hanno ripetutamente sostenuto gli studiosi di quest’opera.59 Le sue fonti sostengono netta-mente questa interpretazione. Il Discorso fa ampio uso di Machiavelli (senza citarlo espressamente), Botero, Leonardo, Moro, Bacone, Lipsio, per menzionarne solo alcune, quelle più evidenti, accanto alle fonti anti-che, tra cui testi della tradizione classica, la Bibbia, alcuni commentari biblici ebraici, Filone Alessandrino e Flavio Giuseppe, oltre ad alcuni autori padri della Chiesa, come Origene e Tertulliano. Accanto a essi vi sono molti autori non citati, sia provenienti dalla letteratura rabbinica che dalla tradizione cristiana, di cui non abbiamo ancora una sistematica elencazione.60 Tra questi è possibile individuare alcuni autori della tradizione scettica, quasi certamente Bodin e Paolo Sarpi.61
Il tema dell’utilità economica, che si trova ampiamente discusso in questa prima parte, è una dottrina della tolleranza cattolica praticata nel corso del Cinquecento, come attestano le vicende del «ritorno» della diaspora sefardita nelle città dell’Europa occidentale.62 Luzzatto la rielabora affinando l’analisi, la quale spesso dialoga con i testi di Botero, il gesuita genovese che contribuì a elaborare la teoria della ragion di stato, in un’opera che porta il medesimo titolo.63 Di rilevante importanza, per la riflessione di Luzzatto, è anche l’altro testo di Botero, quello sulle città.64
59 Mi riferisco soprattutto a karp, The Politics of Jewish Commerce. Sulla modernità di Luzzatto e il pensiero politico della prima età moderna si rimanda anche a A. MElaMEd, «Simone Luzzatto on Tacitus. Apologetica and Ragione di stato», in I. tWErsky (ed.), Studies in Medieval Jewish History and Literature, Harvard University Press, Cambridge-London 1984, II, 143-170; id., The Philosopher King in Medieval and Renaissance Jewish Thought, State University of New York Press, New York 2002; A. GuEtta, «Le mythe du politique chez les Juifs dans l’Italie des Cités», in C. MiEthinG (hrsg.), Politik und Religion im Judentum (Romania Judaica Band 4), Tübingen 1999; V. syros, «Simone Luzzatto’s Image of the Ideal Prince and the Italian Tradition of Reason of State», paper presented at the Third Summer School in Comparative History on Political Religions: from Antiquity to Postmodernity, Jerusalem 2002 (online article).
60 Una ricostruzione delle fonti tramite le citazioni si trova ora in luzzatto, Scritti politici e filosofici, passim.
61 Manca un’analisi sistematica dei rapporti tra Sarpi e i rabbini veneziani. Si è fatto spesso riferimento a queste relazioni, e i testi sembrano confermare almeno una condivisione di un ambiente culturale comune. La bibliografia su Sarpi è estesa, e molto lavoro è stato condotto in Italia da Cozzi, che ha anche pubblicato molte delle sue opere. Su possibili tracce di contatto rimando a T. FishMan, Shaking the Pillars of Exile. Voice of a Fool’ and Early Jewish Critique of Rabbinic Culture, Stanford University Press, Stanford 1997. Sul controverso testo attribuito a Leone Modena, cf. anche E. rivkin, Leon da Modena and the Kol Sakhal, Hebrew Union College Press, Cincinnati 1952.
62 J. israEl, Diasporas within a Diaspora: Jews, Crypto- Jews, and the World of Maritime Empires (1540-1740), Brill, Leiden-Boston 2002.
63 G. botEro, Della ragion di stato, Roma 1589. Cf. W.J. bouWsMa, Venice and the Defense of Republican Liberty: Renaissance Values in the Age of the Counter Reformation, University of California Press, Berkeley 1968.
64 R. baChi, «La dottrina sulla dinamica delle città secondo Giovanni Botero e secondo Si-mone Luzzatto», in Atti dell’Accademia dei Lincei, rend. d. classe di sc. mor. I(1946), 369-378;
ASE 30-2.indb 408 23/10/13 09.44
409
L’utilità economica degli ebrei è suggerita ovviamente anche dalla presenza e dal dinamismo dei nuovi cristiani di origine iberica i quali, giunti nelle città italiane, contribuirono a fondare empori e a incentivare i commerci marittimi. Venezia attesta l’esperienza della febbrile attività di Rodrigua, il creatore della «scala di Spalato», giustamente celebrato da Luzzatto e ricordato da Menasseh ben Israel. Le attività dei nuevos cristianos, o «marrani», trovano riconoscimento nella presa di posizione di Paolo Sarpi, che sancì la protezione di questi mercanti in cambio della loro disponibilità a stabilirsi nel ghetto e vivere come ebrei.65 Le stesse garanzie di libertà di culto e di azione furono concesse a Livorno, dove era sorta alla fine del Cinquecento, grazie all’applicazione di questi principi, la comunità ebraica della città di porto del granducato di Toscana.
Si può affermare che Luzzatto cristallizzi nella sua opera teorie diffuse e utilizzate sia da nuevos cristianos che da governi cattolici, universalizzando le competenze dei gruppi di sefarditi provenienti dalla penisola iberica. Luzzatto «inventa» la natio ebraica in termini di natio mercantile.66
A fronte di un’intricata situazione storica non priva di contraddizioni anche estremamente dolorose, come la compresenza della politica dei ghetti e il principio della utilità economica, una nuova sensibilità sta-va emergendo nei confronti delle attività mercantili, mentre rimaneva altamente negativa la percezione dell’attività feneratizia, molto diffusa tra gli ebrei delle città italiane. A giustificazione di tale mutazione di sensibilità troviamo uno dei i passi più notevoli di questa prima parte del trattato, quello della «antropologia del bisogno» che a parere del rabbino veneziano si incarna perfettamente nella cultura della natio ebraica:
Et alcuna volta mi arrecò meraviglia che li Romani conforme allo loro falsa superstitione di errigere altari, e Deificare gl’inventori delle giovevoli professioni, e che infino la fortuna, stimata pure da loro cieca e temeraria, trovò in Roma particolare adoratione, et apritura di molti sontuosi Tempij, al bisogno primo stimulatore e sferzatore all’Imprese degne, e profittevoli inventioni, non si fosse giamai da essi instituito culto, ne verso di lui osservato alcun rito religioso.
id., Israele disperso e ricostruito, La Rassegna Mensile d’Israel, Roma 1952, 95-139. Anche FaCChini, «The City, the Ghetto».
65 Jonathan Israel menziona i testi di Bodin, il quale in più luoghi avanza questa teoria che appare anche in autori come Barthélémy de Laffemas, Gomes Solis, Lopes Pereira e Antoine de Montchrétien. Il riferimento a Israel si trova in kitsCh, «Shylock’s Sacred Nations», 138. Gli autori di estrazione «marrana» contribuirono notevolmente a diffondere questa teoria. Cf. N. WaChtEl, «The Marrano Mercantilist Theory of Duarte Gomes Solis», in Jewish Quarterly Review 101(2011)2, 164-188; J.I. israEl, «Manuel Lopez de Pereira of Amsterdam, Antwerp and Madrid: Jew, New Christian, and Advisor to the Conde-Duque De Olivares», in Studia Rosenthaliana 19(1985)2, 109-126.
66 Karp ha colto questo problema collegandolo allo sviluppo del concetto di «stato nello stato». Cf. karp, The Politics of Jewish Commerce (Kindle pos. 394).
ASE 30-2.indb 409 23/10/13 09.44
410
Nella scola del disaggio sotto la rigorosa disciplina di esso bisogno, sono eruditi et istruiti li Hebrei più che ogn’altra natione, essendo privi di beni stabili, senz’essercitio della Arti meccaniche, lontani da proffitti del foro, e d’altri impieghi urbani, carichi di famiglia essendoli anco per loro riti prohibito il Celibato, onde li conviene con industre diligenza, et accurata vigilanza aprirsi la via al proprio mantenimento, e sostentamento: per il che si osserva che ove sono dimorati gl’Hebrei vi fiorì il traffico et il negotio, come Livorno ne può fare attestatione, et la Città di Venezia giamai porrà in oblio la memoria del primo inventore della Scala di Spalato, che fù Hebreo di Natione, che con suoi raccordi transportò il negotio di gran (19) parte di Levante in la Città, giudicata ora detta Scala il più fermo, e solido fondamento di traffico ch’habbia la città…67
Il senso di questa impostazione è molto più rilevante di quanto non si sospetti, perché il «realismo» di Luzzatto ha delle conseguenze notevoli. Da un lato, individuare un’attività economica come quella mercantile e proporre gli ebrei come il gruppo migliore e più idoneo a praticarla, significa attribuire agli ebrei una identità nazionale definita da quelle caratteristiche e sostenere che essi sono più dinamici e affidabili delle nationes di mercanti. Nella riflessione di Luzzatto, la ricchezza degli ebrei non può essere tesaurizzata nella rendita fondiaria o nello status simbolico dell’acquisizione di titoli nobiliari, tantomeno dispersa perché spedita al gruppo di riferimento nella madrepatria. La ricchezza degli ebrei rimane svincolata, e come tale può essere proficuamente utilizzata.68 Essere contemporaneamente «servitori» di uno stato cristiano e «senza stato» – a differenza delle nationes mercantili classiche – significa essere più affidabili, perché più utili. La debolezza degli ebrei, ossia la loro mancanza di uno stato, si rivela, agli occhi del rabbino veneziano, come un vantaggio competitivo. Indubbiamente Luzzatto doveva dare senso positivo a un grave handicap del popolo ebraico, ossia la sua mancanza di politeia, la sua sopravvivenza «senza stato». Si tratta di un dato rilevante, su cui possiamo solo intrattenerci brevemente: nella riflessione cattolica dell’epoca, una religione senza stato era percepita come imperfetta, ma una religione «idolatra» con organizzazione statale perfetta attirava l’attenzione e il rispetto.69 Questo nesso, stato/religione, riappare nel trattato di Spinoza, che in sostanza discute, tra le altre cose, dell’intrinseco rapporto tra potere politico e religione (di matrice biblica).
Va detto però che, per quanto realistica possa sembrare, questa strategia è anche utopica nella misura in cui Luzzatto seleziona solo alcuni dati della realtà e precisi riferimenti teorici per costruire una
67 luzzatto, Discorso, Consideratione 4.68 luzzatto, Discorso, Consideratione 5.69 Un esempio tra i tanti si trova nella riflessione sulla Cina di Matteo Ricci. Cf. M. riCCi,
Descrizione della Cina, Quodlibet, Macerata 2011.
ASE 30-2.indb 410 23/10/13 09.44
411
teoria politica ebraica spendibile nell’immediato. I dati di realtà fanno riferimento alle politiche cattoliche (e anche calviniste) di riammis-sione dei nuovi cristiani, talvolta anche note nella nozione della «ra-gion di stato»,70 la specializzazione professionale di molti sefarditi nel commercio internazionale, la maggiore tolleranza e il pluralismo delle città di porto rispetto a quelle di altro tipo (capitali, corti, militari) e la riflessione politica su questi temi, che costituiscono le fondamenta del pensiero politico di età barocca. Rimane tuttavia sottaciuta tutta la mole di dati che contraddicono questa immagine: da un lato il fatto che molti sefarditi mantennero identità religiose di confine e che in molti casi, almeno per quanto concerne Venezia, continuarono a prestare servizio per i regni iberici, o rimasero, come nel caso dei levantini veneziani, soggetti dell’impero turco.71
6. altri ConCEtti di tollEranza
Il Discorso veicola, come abbiamo descritto, una concezione di tolleranza religiosa basata sulla utilità economica, che diffusa in altri contesti culturali divenne rilevante con il mutare della sensibilità nei confronti delle politiche e pratiche mercantili. Esso però presenta anche altri aspetti della teoria della tolleranza religiosa, in particolare, potremmo dire, un secondo aspetto fondato sui dati culturali dell’ebraismo, che Luzzatto descrive nella consideratione 16. Il capitolo, come il testo di Leone Modena sui riti ebraici, descrive in modo succinto e sintetico l’ebraismo post-biblico nelle sue manifestazioni culturali e intellettuali e va interpretato nella direzione che ho già indicato, ossia come un tentativo di rivendicare la nobiltà di una religione ritenuta obsoleta, ossia come risposta alle teologie della sostituzione.72
Alle concezioni di tolleranza di matrice economica e di matrice storico-culturale va aggiunta una terza corrente di matrice teologico-politica. Le teorie di matrice teologico-politica sulla tolleranza religiosa
70 B. ravid, «Venice, Rome, and the Reversion of New Christian to Judaism: a Study in ragione di stato», in P.C. ioly zorattini (ed.), L’identità dissimulata. Giudaizzanti iberici nell’Europa cristiana dell’età moderna, Olschki, Firenze 2000, 151-310; id., «A Tale of Three Cities and Their Raison d’état: Ancona, Venice, Livorno, and the Competition for Jewish Merchants in the Sixteenth Century», in Mediterranean Historical Review 6(1991)2, 138-162.
71 Riflessioni di questo tipo in J. israEl, European Jewry in the Age of Mercantilism 1550-1750, Clarendon Press, Oxford 11989; Y. kaplan, From Christianity to Judaism: The Story of Isaac Orobio de Castro, engl. trans., Littman Library Oxford University Press, Oxford 1898; per una prospettiva di storia economica cf. F. ruspio, La nazione portoghese: ebrei ponentini e nuovi cristiani a Venezia, Zamorani, Torino 2007.
72 Per un’analisi più dettagliata su questa questione cf. FaCChini, «The City, the Ghetto», passim. Significativa la critica di Palontrotti, un polemista cristiano della seconda metà del Seicento. Cf. ravid, «Contra Judaeos in Seventeenth-Century Italy», 301-351.
ASE 30-2.indb 411 23/10/13 09.44
412
non possono essere screditate e ritenute meno rilevanti se, come suggerisce molta storiografia, questo secolo fu intensamente religioso. Nella consideratione 10 è possibile leggere una teoria della tolleranza religiosa come espressione strutturale dello stato cristiano, laddove Luzzatto insiste sul principio biblico della protezione degli umili e dei poveri, dei «dannati della terra».73 Indubbiamente qui possono riflettersi alcune letture che non necessariamente vanno nella direzione machiavelliana, ma in quella di alcuni passi di Botero, e forse anche di Bodin. Luzzatto non cita mai le sue fonti, solo quelle antiche – da un lato Aristotele e dall’altro la Bibbia ebraica – facendo menzione però di «esperimentato Saggio Politico Ministro di Gran Principe» quando afferma, ancora una volta, che il migliore sistema politico era quello in cui si poteva osservare la pratica della giustizia nei confronti degli ebrei, proprio perché componente debole e umile della società. Riporto il passo per esteso, perché merita di essere letto con attenzione. Cosa affermava questo «Saggio Politico»?
Affermava che capitando lui in città, ove dimorano Hebrei, non sapeva ritrovare conietura più evidente per indagare li veraci, et interni sen-timenti del Prencipe, et essentiali e reali conditioni del Governo, che in essaminare, e cautamente osservare le maniere con quali si trattava con gl’Hebrei sudditi, ché se il Prencipe al suo proprio, e natio popolo mostra piacevolezza, et essercita incorrotta giustizia, può forse ciò derrivare piùttosto da fiachezza d’animo, e timore, se con forastieri è humano, chissà ciò non avvenire per servile rispetto che tiene a Pren-cipe a cui sono vassalli. Ma della giustizia, clemenza, protettione, e diffesa ch’usa verso gli Hebrei non può esserne causa, se non una virtù eroica d’animo ingenuo, naturalmente disposto in solevare gl’oppressi, e sovvenire gli deboli, essendo gl’Hebrei non solo d’animo rimesso, et humile, e sempre avvezzi nelle gravezze, et oppressioni che però sono acostumati di non esalare pur un languido lamento, com’ancor parimente, privi affatto in qualunque Regione del mondo di alcun par-ticolare Prencipe che li sia Protettore e difensore. E di più mi soggiun-ge detto Ministro, che fra molte evidentie della giustizia Venetiana, e dell’ottimo suo Governo (35v) non esser l’ultima, l’osservatione da lui fatta circa l’indifferente equità, e non esorbitante impositione, che verso gl’Hebrei era usata di fare.74
È una frase che ricorda molto da vicino un brano dell’Heptaplome-res, con cui abbiamo aperto questo articolo, anche se non pare dipendere da esso. Essa non sembra aver attirato l’attenzione degli esegeti, ma in-dubbiamente indica una particolare lettura della tolleranza che il princi-pe deve attuare nei confronti di alcuni segmenti della sua popolazione.75
73 luzzatto, Discorso, Consideratione 10. ravid, «Contra Judaeos in Seventeenth-Century Italy», 308.
74 luzzatto, Discorso, Consideratione 10. 75 Poniamo solo alcune ipotesi, che vanno certamente controllate: cf. Colloquium of the Seven
about Secrets of the Sublime, engl. ed., 3: «We reached Venice, a port common to almost all
ASE 30-2.indb 412 23/10/13 09.44
413
La consideratione 11 è focale perché contiene una riflessione – ov-viamente centralissima per la prima età moderna – sul concetto di responsabilità collettiva e responsabilità individuale, che si propone di chiarire quali siano i crimini di cui gli ebrei sono responsabili in quanto individui e quelli che invece colpiscono tutta la collettività.76 Si tratta di un tema affascinante che, nella storia ebraica, svolge un ruolo centrale fino al Novecento, riversandosi poi, dopo la Shoah, sulla responsabilità collettiva dei tedeschi.77 Ma sarebbe riduttivo leggere questo «essai» – se ci è permesso l’uso di questo termine – solo alla luce del dibattito sulla responsabilità collettiva. Il capitolo presenta un esercizio di retorica barocca, dove possiamo rinvenire tracce di una raffinata teoria antropologica degli ebrei, costruita sull’elemento dell’ambivalenza, una teoria degli opposti, che spiega i caratteri culturali della natio ebraica, oscillante tra un’indomita resistenza e una condizione di umiltà.78 Di fatto, questo saggio è da leggersi entro una cultura attenta a definire le caratteristiche fondamentali delle nationes di antico regime.79 La discussione relativa al concetto della colpa collettiva è però di estrema importanza, poiché apparirà, qualche decennio dopo, in alcuni trattati volti a criticare l’accusa del sangue.80
Il capitolo 12 risponde alle accuse contro gli ebrei, e presumibilmente alle voci che manifestavano intolleranza nei confronti della presenza ebraica nelle città e negli stati cristiani. Questa consideratione interpreta tradizioni dell’antisemitismo secentesco a cui gli storici non hanno prestato attenzione.81 In questo senso si può dire che, rispecchiando
nations or rather the whole world, not only because the Venetians delight in receiving strangers hospitably, but also because one can live there with the greatest freedom. Whereas the other cities and districts are threatened by civil wars or fear of tyrants or harsh exactions of taxes or the most annoying inquiries into one’s activities, this seemed to me to be nearly the only city that offers immunity and freedom from all these kinds of servitude. This is the reason why people come here from everywhere, wishing to spend their lives in the greatest freedom and tranquillity of spirit, whether they are interested in commerce or crafts or leisure pursuits as befit free man». Rimando anche a C.j. nEdErMan – j.C. laursEn (edd.), Difference and Dissent. Theories of Tolerance in Medieval and Early Modern Europe, Rowman & Littlefield, Boston 1996, 119-138; j.C. laursEn – C.j. nEdErMan (edd.), Beyond the Persecuting Society: Religious Toleration Before the Enlightenment, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1998.
76 luzzatto, Discorso, Consideratione 11.77 Cf. G. vEltri, «Dannare l’universale per il particolare. Colpa individuale e pena collettiva
nel pensiero di Rabbi Simone Luzzatto», in Rassegna mensile di Israel 77(2012), 65-81.78 Su questo tema rimando ad alcune annotazioni presenti in C. FaCChini, «Icone in sinagoga.
Emblemi e imprese nella predicazione barocca di Yishaq Hayyim Kohen Cantarini (1644-1723)», in Materia giudaica 7(2002)1, 124-144.
79 Cf. W. bouWsMa, The Waning of the Renaissance, Yale University Press, London-New Haven 2000, 1-5.
80 Cf. C. FaCChini, «Il “Vindex sanguinis” di Isaac Viva (Amsterdam 1681): di una polemica sull’accusa di omicidio rituale», in Annali di storia dell’esegesi 16(1999)2, ora in fase di ristampa in versione estesa e riveduta per le Edizioni Dehoniane (2014).
81 Nessun riferimento a questi temi nelle varie storie dell’antisemitismo o dell’antigiudai-smo, più attente invece a recepire i problemi relativi alla diffusione degli statuti della limpieza del sangre, ma con molte resistenze. Cf. P. stEFani, Antigiudaismo. Storia di un’idea, Laterza,
ASE 30-2.indb 413 23/10/13 09.44
414
i tratti dell’apologia, Luzzatto incorpora alcune novità che meritano di essere brevemente descritte. L’ostilità antiebraica a cui il rabbino veneziano fa riferimento viene suddivisa in base a una tipologia interessante, che definisce il discorso antiebraico in tre varianti: 1) quella religiosa-zelota; 2) quella politica; 3) quella popolare. L’intolleranza degli zelanti, ossia dei religiosi, si fonda sull’idea che non può esserci spazio nella societas christiana per il dissenso religioso: «Reclamano li zelanti che sia in dispreggio della propria religione il permettere in uno stato quelli che non prestano assenso alla comunamente approbata».82 Ironicamente, per difendere una posizione di tolleranza, Luzzatto riporta l’esempio di Roma e del papa che tollera gli ebrei nella città da lui governata. Luzzatto non fa menzione delle politiche di espulsione nelle altre città dello Stato pontificio per non indebolire la sua linea di difesa. Sembra qui pensare più specificamente a quanto era successo nei domini spagnoli e che rischiava di presentarsi in altri luoghi. I «politici» sarebbero preoccupati dalla presenza di «infedeli», sempre potenziale fonte di dissenso, disunione e odio. Nel caso degli ebrei anche la questione dell’«usura» – tra l’altro discussa da Botero ne La ragion di stato – costituisce un vero e proprio motivo di potenziale espulsione. Luzzatto si affida al concetto di separazione, attuato dalle norme ebraiche (quelle sul consumo del cibo) e dalle politiche cattoliche di separazione nei ghetti. La separazione, anche coatta, si presenta come un male minore rispetto alle politiche di espulsione o al massacro.83 I «volgari» invece sarebbero rappresentati da quelli che diffondono calunnie e menzogne, «machinazioni» e maldicenze, ossia accuse di carattere meramente «chimerico». L’odio del volgo è strettamente connesso a questo tipo di discorsi, fondati su evidenti falsità. Luzzatto segnala però solamente alcune calunnie, quella dell’accusa del sangue e quella più specifica attinente al rapporto tra ebrei e corsari che si condensa nell’accusa di tradimento.84 Segnalo in questa sede come Luzzatto contribuisca a decostruire l’accusa del sangue attraverso due argomentazioni molto importanti anche se non originali: l’uso dell’apologetica cristiana, che in tempi antichi dovette far fronte alle medesime accuse (si veda ad esempio Tertulliano), e l’analisi del testo
Roma-Bari 2004; Y.H. yErushalMi, Assimilazione e antisemitismo razziale: i modelli iberico e tedesco, trad. it., Giuntina, Firenze 2010.
82 luzzatto, Discorso, Consideratione 12.83 Per una lettura meno positiva, o meglio meno «realistica», della politica dei ghetti cf. I.C.
Cantarini, Pahad Yitshaq, Padova 1685. Su questo testo cf. C. FaCChini, «“E scese una furia fortissima…”. Il Purim di Buda. Rimembranza liturgica e narrazione storica», in Annali di storia dell’esegesi 18(2001)2, 507-532.
84 Noto che questo aspetto è forse da collegarsi al problema dei corsari nell’Adriatico, su cui intervenne anche P. Sarpi. Cf. G. Cozzi (ed.), La Repubblica di Venezia, la Casa d’Austria e gli Uscocchi, Laterza, Bari 1965.
ASE 30-2.indb 414 23/10/13 09.44
415
biblico.85 Luzzatto utilizza il trattato di Elia Delmedigo, uno dei primi testi in cui apparve una critica circostanziata all’accusa del sangue, diffusasi nel corso del XV secolo. In questa consideratione Luzzatto fa ampio uso dei trattati storici ebraici, in particolare utilizza ampiamente lo Shevet Yehudah di Ibn Verga, che costituisce una fonte letteraria e un modello centrali per ampie parti del Discorso.86
Il capitolo 13 entra più nel dettaglio e può essere letto come un esplicito intervento sul concetto di tolleranza. Si fonda sulla centralità della nozione di carità discutendo diffusamente la condizione di stra-niero nella Bibbia ebraica:
Ma la Legge d’Iddio promulgata da Moisè per tutta la nostra spetie prouide e […] e si come vna sol natura da Iddio fu instituita nel mondo che tutte le sue parti con Armonioso concetto insieme douesse vnire, e con reciproca simpatia reggesse, così decretò, che tutto il genere huma-no con vnanime amistà insieme corrispondesse, douendosi qualunque huomo Cittadino d’vna sola repubblica reputare, inestando nell’animo humano tale amore, e carità con amaestrarlo, & instruirlo che si come da vn sol Iddio fu creata & hebbe origine la sua spetie, così da vn solo Padre Adamo fu propagata, e di nuouo da Noè diramata.87
Rimanendo sempre a un livello analitico di superficie, al fine di non addentrarci in un’analisi della «legge naturale» di matrice tomista e di matrice ebraica, delle sue riletture nella prima età moderna in ambito protestante, il capitolo offre un’esegesi di alcuni passi biblici sulla scia delle interpretazioni di Filone Alessandrino e altri autori, volta a dimostrare che gli ebrei non sono nemici dell’umanità e dei gentili che li ospitano nelle loro città. Il brano introduce un tema di derivazione medievale, che sarà destinato a grande successo, ossia quello della tolleranza religiosa come espressione dell’idea di un’intima e diretta parentela tra gli uomini, figli di un unico di padre.88
Il capitolo 14 prosegue su questa linea e affronta il tema del rapporto tra guerra e religione, cercando di rispondere a coloro che insistevano sul tema dell’odio degli ebrei nei confronti dei gentili fino a riprendere il tema dell’usura. Luzzatto usa la Bibbia come un testo politico – alla stregua dei suoi contemporanei e della trattatistica politica rinascimen-
85 FaCChini (2014), in corso di pubblicazione. 86 S. ibn vErGa, Shevet Yehudah, Adrianopoli 1554. Una versione latina fu approntata nel
XVII secolo da G. Gentius: S. ibn vErGa, Tribus Judae, Amsterdam 1680. Si tratta di un testo che ebbe ampia risonanza e diffusione, e indubbiamente di una fonte molto importante per i trat-tatisti ebrei del Seicento. Per un inquadramento su questo tema: Y.H. yErushalMi, Zakhor: Storia ebraica e memoria ebraica, trad. it., Giuntina, Firenze 2011; id., «Servitori di re e non servitori di servitori». Alcuni aspetti della storia politica degli ebrei, trad. it., Giuntina, Firenze 2013.
87 luzzatto, Discorso, Consideratione 13, 40r.88 Questa idea riappare, articolata attorno al discorso dei tre monoteismi, nel famoso brano
teatrale di G.E. lEssinG, Nathan il saggio, trad. it., Garzanti, Milano 2007. È un tema su cui è necessario ritornare, è una concezione più inclusiva delle tante altre circolanti nella prima età moderna.
ASE 30-2.indb 415 23/10/13 09.44
416
tale – operando però un’esegesi differente rispetto a quella che troviamo altrove. È un uso classico del testo biblico che si riscontra per tutto il secolo, anche laddove si comincia a separare la sfera politica da quella teologica. Nella consideratione 15 Luzzatto discute e decostruisce le argomentazioni di Tacito contro gli ebrei elaborando, sempre attraver-so l’esegesi biblica, una critica sistematica delle accuse. È un capitolo che merita un’analisi separata perché, come il successivo, ha dei fini molto complessi. In particolare, Luzzatto esamina le accuse di magia e superstizione, molto diffuse nei confronti dell’ebraismo dell’epoca, svolgendo anche una riflessione sui miracoli. Anche qui possiamo indi-viduare delle somiglianze con l’opera di Leone Modena, ma una strate-gia retorica radicalmente diversa.
7. notE ConClusivE
Il dibattito sulla tolleranza religiosa ha suscitato, a più riprese, un intenso interesse da parte di storici delle religioni, della Chiesa, di politologi e scienziati sociali. Il tema, ancora molto discusso nella storiografia anglosassone, ha spesso accompagnato gli studi sulla nascita dello stato moderno, in particolare della sua variante liberale. In anni più recenti, questo argomento è quasi scomparso nella storiografia italiana – dopo una felice apparizione agli inizi del Novecento – per lasciare spazio al dibattito più centrato sul rapporto tra Stato e Chiesa.89 Il tema però rimane centrale, tanto più in un paese come l’Italia, dove la diversità religiosa fu combattuta in modi sistematici, e dove non sorse, per certi aspetti, una seria riflessione teorica su questo tema.90
La richiesta di tolleranza religiosa nei primi decenni del Seicento è tema centrale nella riflessione cristiana. Essa è conseguenza dello stato precario e del conflitto generatosi in Europa con la frattura protestante, anche se i suoi fondamenti sono certamente più antichi. Il conflitto intra-cristiano produsse, per un certo periodo, un intensificarsi dell’idea di uniformità religiosa, impossibile da perseguire con coerenza se non con altissimi costi umani. Tuttavia, più che la sensibilità nei confronti
89 Opere che segnarono certamente un importante risultato nel dibattito internazionale furono F. ruFFini, La libertà religiosa. Storia di un’idea, Feltrinelli, Milano 1991 (1a ed. 1901); L. luzzatti, Dio nella libertà, Zanichelli, Bologna 1926; id., Libertà di coscienza e di scienza, Treves, Milano 1909 (entrambe tradotte in inglese); M. Firpo, Il problema della tolleranza religiosa nell’età moderna: Dalla riforma protestante a Locke, Loescher, Firenze 1978. Vastissima la bibliografia in altre lingue che rimando ad altra sede.
90 Per alcune note su questo tema rimando a C. FaCChini, «Luigi Luzzatti, Dio nella libertà (1926): the Rise of Religious Tolerance Between East and West», relazione presentata al con-vegno internazionale Confini della intolleranza e della intolleranza religiosa (gennaio 2007, Bologna) e id., «Un ebreo liberale. Note sull’opera di Luigi Luzzatti, Dio nella libertà (I)» (in fase di stampa).
ASE 30-2.indb 416 23/10/13 09.44
417
degli «eretici e infedeli» fu il costante pericolo di guerra civile ad ali-mentare il bisogno di trovare una soluzione alla diversità religiosa.91 Quel conflitto alimentò antiche utopie di armonia universale di matrice pichiana o utopiche visioni di redenzione apocalittica, tra cui lentamente prese forma una sensibilità più attenta alla differenza, come appunto nell’Heptaplomeres di Bodin. Contemporaneamente, l’intensità del con-flitto religioso produsse forme di «ritorno al testo» che contribuirono a fondare quelle che sono state denominate «comunità testuali». La Bibbia divenne luogo privilegiato di riflessione, producendo comunità religiose e diverse identità cristiane. Essa si trasformò – come ha sostenuto E. Nelson – in luogo di intensa riflessione politico-teologica, ispirando in parte l’acceso dibattito sulle caratteristiche della «repubblica degli ebrei».92 Lo studio sulla Bibbia si intensificò, l’esegesi si raffinò e autori come Flavio Giuseppe e Filone Alessandrino, i commentari biblici ebraici e l’opera di Maimonide furono estesamente riletti e utilizzati, così come i testi dei padri della Chiesa.93
Queste tendenze possono essere semplificate in diversi modelli di tolleranza religiosa. 1) Un primo modello si potrebbe far risalire all’idea di «concordia» derivante dalle concezioni utopiche di periodo rinascimentale. Essa fa perno sull’idea dell’esistenza di un cristianesimo universale che contiene in sé tutte le possibili – e conosciute – tradizioni religiose. La matrice di questo modello è rinvenibile, in parte, nel progetto pichiano e nelle sue varianti europee. Esso però non lascia spazio agli «infedeli», ma li scioglie nella concezione universalista cristiana.94 2) Un secondo modello, ancorato alle diverse tradizioni religiose e filosofiche della prima età moderna, deriva da Bodin o dall’autore dell’Hepta plomeres con cui si apre questo saggio. In questo modello, di carattere dialogico, si trovano espresse le posizioni di diverse tradizioni esistenti e conosciute, in una sorta di dialogo che se pure non riconosce a tutte le voci la medesima importanza, pare
91 La storiografia è in parte concorde sul fatto che il dibattito su questo tema sia strettamente connesso alla dimensione del conflitto e della guerra civile: B.J. kaplan, Divided by Faith. Religious Conflict and the Practice of Toleration in Early Modern Europe, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge-London 2007. Kaplan integra la questione degli «infedeli» – ebrei e musulmani – nel dibattito dell’Europa cristiana della prima età moderna.
92 nElson, The Hebrew Republic.93 Si veda a questo riguardo l’uso di Origene nella prima età moderna. Cf. A. CoudErt,
Religion, Magic and Science in Early Modern Europe and America, Praeger, Santa Barbara 2011 (Kindle pos. 1971).
94 La tradizione pichiana ebbe una sua circolazione europea, che selezionò temi e argomenti. In particolare anche alcune parti della Oratio de homini dignitate fu recepita in alcuni ambienti ebraici, sia sefarditi che italiani. Su questo testo rimando a P.C. bori, Pluralità delle vie: alle ori-gini del Discorso sulla dignità umana di Pico della Mirandola, Feltrinelli, Milano 2000; G. piCo dElla Mirandola, Pico della Mirandola: Oration on the Dignity of Man: A New Translation and Commentary, ed. by F. borGhEsi – M. papio – M. riva, Cambridge University Press, Cambridge 2012; CoudErt, Religion, Magic and Science in Early Modern Period in Europe and America.
ASE 30-2.indb 417 23/10/13 09.44
418
almeno attento alla molteplicità. 3) Un terzo modello politico è quello ispirato da editti, che sono il frutto di pragmatismo o prassi concrete, ma non di riflessione teologica approfondita. 4) Un ulteriore modello, che prenderà lentamente corpo, sarà quello della separazione delle sfere, teologica e politica, ben esemplificato, se pure con valenze quasi antitetiche, dai lavori di Hobbes, Spinoza e Locke. Questo modello, su cui si è riflettuto a lungo, sorse lentamente nel corso della seconda metà del Seicento, imponendosi solo nei secoli successivi e tramite la rivoluzione francese. Esso tuttavia prende forma dopo un intenso dibattito influenzato dalle correnti erastiane, che sostenevano il primato dello stato nelle questioni ecclesiastiche. 5) Infine, un modello apocalittico/redentivo, di carattere utopico, svolse un ruolo ambivalente ma fondamentale nell’immaginazione politica della prima età moderna, soprattutto in riferimento al ruolo degli ebrei nella societas christiana. Esso ha lasciato tracce di lungo periodo che si protraggono fino alla seconda guerra mondiale.95 Ovviamente i modelli aumentano e si differenziano nel corso del tempo, integrando tradizioni del passato e inventando nuove formule. Per ora questo schema permette una migliore comprensione dello status ambivalente degli ebrei nel mondo cristiano.
In questo contributo ho cercato di analizzare questo tema attraverso lo sguardo di una minoranza, dell’«infedele», per utilizzare un lemma del lessico politico-teologico del tempo. I due testi che ho presentato aprono a molteplici questioni che qui non ho potuto affrontare, come il complesso intreccio tra autori e testi redatti da cristiani ed ebrei in età rinascimentale e barocca. Questo contributo intende mostrare diverse opzioni relative al dibattito sulla tolleranza religiosa e che rispecchiano le diverse sensibilità di due studiosi cresciuti entro i perimetri del ghetto veneziano. L’intensa riflessione sulla tradizione teologica, sulla Bibbia e la storicizzazione dei fenomeni religiosi contribuirono notevolmente ad aumentare l’interazione tra ebrei e cristiani, anche se in una cultura strutturalmente gerarchica e ineguale. La centralità della Bibbia, sia essa generatrice dei riti o fondamento della politeia ebraici, rimase un terreno centrale nella riflessione politica della prima età moderna. Il linguaggio del confronto si gioca attorno a questo polo, e non esclusivamente nel realismo politico che Luzzatto sembra prediligere. Se da un lato Modena intercettò la sensibilità biblica di alcuni ambienti protestanti, in particolare nell’adattamento maimonideo, la sua opera fu recepita e trasmessa attraverso il lavoro di cattolici scomodi, come Jacques Gaffarel e Richard Simon. Il trattato barocco di Simone Luzzatto predilige invece il linguaggio della trattatistica politica dell’epoca,
95 Su questa tradizione cf. R. popkin, The Third Force in Seventeenth-Century Thought, Brill, Leiden 1992; id., Millenarianism and Messianism in Early Modern Culture, 4 vols., Kluwer, Dordrecht 2001. Cenni utili in karp – sutCliFFE (edd.), Philosemitism in History.
ASE 30-2.indb 418 23/10/13 09.44
419
alternando autori proibiti e autori permessi, in un realismo che modifica e seleziona i dati della realtà, tanto da proporre un’immagine nuova di ebraismo. In esso, però, appaiono, talvolta dissimulate, anche altre proposte, a cui gli storici non hanno prestato sufficiente attenzione, ma che furono accolte in altre opere ebraiche.
Nella loro estrema differenza, entrambi gli autori condivisero la certezza che la Bibbia fosse il luogo della verità più antica, la voce dell’uni versale, la fonte principale dell’ebraismo e il luogo di un’alleanza mai recisa. Entrambi cercarono un’interpretazione positiva dell’esilio, difendendo la condizione diasporica da tensioni messianiche e apocalittiche che diromperanno violentemente nei decenni successivi. Ce li possiamo immaginare, Luzzatto e Modena, nella dimora di Coroneo a discettare, come Salomone, sulle venerabili verità del giudaismo e sul suo diritto di partecipare attivamente alla riflessione sulla tolleranza religiosa.
Cristiana Facchini Università di Bologna
ASE 30-2.indb 419 23/10/13 09.44